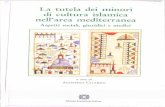l'arbitrato nel diritto amministrativo
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of l'arbitrato nel diritto amministrativo
INDICE SOMMARIO
VOLUME III
PARTE QUINTA
APPROFONDIMENTI
SEZIONE PRIMA
L’arbitrato amministrato
CAPITOLO PRIMO
ARBITRATO AMMINISTRATOE ISTITUZIONI ARBITRALI PERMANENTI
Ferdinando Emanuele e Milo Molfa
1.1. Introduzione: arbitrato ad hoc e arbitrato amministrato . . 51.2. Arbitrato ad hoc e rinvio a «regolamenti precostituiti» . . 71.3. Arbitrato amministrato: caratteristiche . . . . . . . . . . . . 91.3.1. Istituzioni arbitrali permanenti, generiche e settoriali . . . 121.3.2. Il ruolo dell’istituzione arbitrale permanente . . . . . . . . 171.3.3. Le clausole modello dell’istituzione arbitrale permanente . 221.4. I pro e contra dell’arbitrato amministrato rispetto all’arbi-
trato ad hoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231.4.1. Il rinvio a un corpus (certo) di norme precostituite . . . . . 251.4.2. La presenza di un’istituzione stabile a garanzia del proce-
dimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251.4.3. I costi del procedimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301.4.4. I tempi del procedimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321.4.5. Il controllo formale sull’operato del tribunale arbitrale . . 331.5. L’arbitrato amministrato con sede in Italia . . . . . . . . . . 341.6. Lo svolgimento del procedimento arbitrale amministrato . 381.6.1. L’avvio del procedimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391.6.2. In particolare: la costituzione del tribunale arbitrale . . . . 411.6.3. La trattazione e istruzione della causa . . . . . . . . . . . . . 431.6.4. La conclusione del procedimento e la pronuncia del lodo . 48
CAPITOLO SECONDO
RUOLO E TUTELA DELLA VOLONTÀ DELLE PARTINELL’ARBITRATO AMMINISTRATO
Adriana Neri
2.1. Rilievi introduttivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512.2. La relatio ai «regolamenti precostituiti» da parte della
convenzione arbitrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562.3. La prevalenza delle determinazioni delle parti sul regola-
mento in caso di disposizioni contrastanti . . . . . . . . . . 592.4. Il ruolo dell’istituzione che amministra l’arbitrato . . . . . 612.5. La natura dell’attività svolta dall’istituzione . . . . . . . . . 642.6. La successione nel tempo dei regolamenti arbitrali . . . . . 752.7. Il rifiuto dell’istituzione di amministrare l’arbitrato e la
perdurante efficacia della convenzione arbitrale . . . . . . 782.8. Osservazioni conclusive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
SEZIONE SECONDA
I modelli speciali di arbitrato
CAPITOLO PRIMO
L’ARBITRATO IN MATERIA DI LAVORO(PARADOSSI E PROBLEMI IRRISOLTI)
Valentina Bertoldi
1.1. Il paradosso dell’arbitrato in materia di lavoro . . . . . . . 871.2. L’emersione della forma irrituale . . . . . . . . . . . . . . . . 921.3. La progressiva stratificazione delle fonti e la disciplina di
alcuni nodi critici alla luce della l. 11 agosto 1973, n. 533(monopolio sindacale, volontà compromissoria indivi-duale, impugnazioni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
1.4. La duplice riforma del 1998 (d.lgs. 30 marzo 1998, n. 80 ed.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
1.5. Le principali linee guida della riforma di cui alla l. 4 novem-bre 2010, n. 183. In particolare: la compromettibilità dellecontroversie di lavoro e le convenzioni di arbitrato . . . . 124
1.6. La pluralità di modelli procedimentali risultanti dallanovella del 2010. Spiragli per il giudizio secondo equità . 137
INDICE SOMMARIOVI
1.7. Il (non risolto dilemma del) trattamento processuale deilodi in materia di lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
CAPITOLO SECONDO
L’ARBITRATO COMMERCIALE
Carola Corrado
2.1. L’arbitrato commerciale. Rapporti con l’arbitrato didiritto comune. Arbitrato irrituale . . . . . . . . . . . . . . . 153
2.2. Le controversie arbitrabili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1592.2.1. Ambito oggettivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1592.2.2. Ambito soggettivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1632.3. La nomina degli arbitri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1652.4. Il procedimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
CAPITOLO TERZO
L’ARBITRATO NEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
Emanuele Odorisio
3.1. La convenzione di arbitrato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1773.1.1. La volontarietà dell’arbitrato ed il problema dell’«effetti-
va» volontarietà. La «ricusazione» della clausola compro-missoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
3.1.2. Potere di ricusare la «clausola compromissoria» e conven-zione d’arbitrato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
3.2. Arbitrato di diritto comune ed arbitrato speciale . . . . . . 1803.2.1. Il rapporto tra la disciplina di cui agli artt. 241 e ss. c.c.p.
e quella di cui agli artt. 806 e ss. c.p.c. . . . . . . . . . . . . 1803.2.2. La legittimità costituzionale della disciplina speciale del-
l’arbitrato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1823.3. Arbitrato amministrato ed arbitrato libero . . . . . . . . . . 1833.3.1. L’arbitrato amministrato previsto dall’art. 243 c.c.p. . . . . 1833.3.2. L’arbitrato libero previsto dall’art. 241 c.c.p. . . . . . . . . 1883.3.3. Il rapporto tra le parti e la Camera arbitrale. Il contratto
di amministrazione di arbitrato . . . . . . . . . . . . . . . . . 1923.3.4. Il rapporto tra le parti e gli arbitri. Il contratto di arbitrato . 1973.3.5. Il rapporto tra la Camera arbitrale e gli arbitri . . . . . . . 200
INDICE SOMMARIO VII
3.3.6. Legittimità costituzionale della diversità di disciplina disvolgimento del giudizio arbitrale fondata sulle differentimodalità di nomina del terzo arbitro . . . . . . . . . . . . . . 201
3.4. Il procedimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2033.4.1. Composizione del collegio e modalità di nomina degli
arbitri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2033.4.2. La legittimità costituzionale dell’attribuzione alla Camera
arbitrale del potere di nominare il terzo arbitro . . . . . . . 2053.4.3. La nomina degli arbitri di parte e la fase introduttiva del
procedimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2093.4.4. La nomina del terzo arbitro da parte della Camera arbi-
trale: la valutazione di amministrabilità dell’arbitrato . . . 2113.4.5. Il provvedimento della Camera arbitrale di accoglimento
o di rigetto della richiesta di nomina del terzo arbitro . . . 2133.4.6. Gli arbitri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2173.4.7. La sede dell’arbitrato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2263.4.8. L’istruzione probatoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2293.4.9. Il segretario del collegio arbitrale nell’arbitrato ammini-
strato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2313.4.10. Il segretario del collegio arbitrale nell’arbitrato libero . . . 2343.5. Il lodo arbitrale e le impugnazioni . . . . . . . . . . . . . . . 2353.5.1. Gli effetti del lodo arbitrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2353.5.2. Il deposito del lodo arbitrale presso la Camera arbitrale . 2413.5.3. La comunicazione del lodo arbitrale . . . . . . . . . . . . . . 2463.5.4. L’impugnazione per nullità del lodo arbitrale: i termini e
la sospensione dell’efficacia del lodo . . . . . . . . . . . . . . 2483.5.5. Segue: il rito abbreviato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2513.6. I costi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2573.6.1. Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2573.6.2. I costi del giudizio arbitrale di diritto comune . . . . . . . . 2573.6.3. I costi del giudizio arbitrale negli arbitrati amministrati . . 2633.6.4. I costi del giudizio arbitrale libero . . . . . . . . . . . . . . . 2663.6.5. I costi del giudizio arbitrale amministrato . . . . . . . . . . 2733.6.6. L’anticipazione degli onorari e delle spese . . . . . . . . . . 2773.6.7. La somma da corrispondere entro quindici giorni dalla
pronuncia del lodo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
INDICE SOMMARIOVIII
CAPITOLO QUARTO
L’ARBITRATO BANCARIO FINANZIARIO
Virginia Petrella
4.1. L’ABF nel sistema degli strumenti di risoluzione dellecontroversie nel settore bancario e finanziario . . . . . . . . 287
4.2. L’ABF come strumento sui generis rispetto al pur vastopanorama delle ADR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
4.3. Funzione e ratio normativa dell’ABF . . . . . . . . . . . . . 2994.4. Caratteri peculiari del procedimento . . . . . . . . . . . . . . 3024.5. L’efficacia della decisione dell’ABF . . . . . . . . . . . . . . 3044.6. Rimedi avverso la decisione ABF . . . . . . . . . . . . . . . . 311
CAPITOLO QUINTO
L’ARBITRATO SPORTIVO
Fabrizio Zerboni
5.1. L’arbitrato sportivo in Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3135.1.1. Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3135.1.2. Giustizia sportiva e giurisdizione statale . . . . . . . . . . . 3155.1.2.1. Le materie riservate all’ordinamento sportivo e la rile-
vanza per l’ordinamento statale delle situazioni giuridichesoggettive connesse con l’ordinamento sportivo . . . . . . . 316
5.1.2.2. Il riparto della giurisdizione statale sulle controversiesportive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
5.1.3. Arbitrato sportivo, giurisdizione statale e Costituzione . . 3285.1.4. Giustizia sportiva e arbitrato sportivo . . . . . . . . . . . . . 3305.1.4.1. Il vincolo di giustizia sportiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3315.1.4.2. Le clausole compromissorie nell’ordinamento sportivo:
generalità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3345.1.5. L’arbitrato nello statuto del CONI: il Tribunale Nazio-
nale di Arbitrato per lo Sport (TNAS) . . . . . . . . . . . . 3365.1.5.1. Le caratteristiche principali del TNAS . . . . . . . . . . . . 3375.1.5.2. I presupposti dell’arbitrato presso il TNAS . . . . . . . . . 3385.1.5.3. I soggetti dell’arbitrato presso il TNAS . . . . . . . . . . . . 3405.1.5.3.1. Le parti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3405.1.5.3.2. Gli arbitri: nomina, ricusazione e sostituzione . . . . . . . . 3425.1.5.4. L’oggetto dell’arbitrato presso il TNAS . . . . . . . . . . . . 3475.1.5.5. Le norme applicabili nell’arbitrato presso il TNAS . . . . 3515.1.5.6. Il procedimento presso il TNAS . . . . . . . . . . . . . . . . 3525.1.5.6.1. La fase introduttiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
INDICE SOMMARIO IX
5.1.5.6.2. La fase di trattazione/istruzione . . . . . . . . . . . . . . . . . 3555.1.5.6.3. Le misure cautelari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3575.1.5.6.4. La fase decisoria: il lodo e l’impugnazione . . . . . . . . . . 3585.1.6. L’arbitrato negli statuti e nei regolamenti delle Federa-
zioni sportive nazionali e delle Discipline sportive asso-ciate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
5.1.6.1. L’arbitrato nella Federazione Italiana Giuoco Calcio(FIGC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
5.1.6.2. L’arbitrato nella Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) . 3695.1.6.3. L’arbitrato nella Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) . 3725.1.6.4. L’arbitrato negli altri statuti e regolamenti federali . . . . . 3735.1.6.5. Sintesi delle caratteristiche dell’arbitrato negli statuti e nei
regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delleDiscipline sportive associate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
5.1.7. Considerazioni conclusive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3765.2. L’arbitrato sportivo internazionale: cenni . . . . . . . . . . . 3805.2.1. Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3805.2.2. Il Tribunal Arbitral du Sport/Court of Arbitration for Sport
(TAS/CAS) di Losanna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3825.2.3. Lo speciale arbitrato per i Giochi Olimpici . . . . . . . . . 388
CAPITOLO SESTO
L’ARBITRATO PER LE CONTROVERSIEDI LAVORO SPORTIVO
Leo Piccininni
6.1. L’elaborato ventaglio di fonti ed il problema dei limiti diammissibilità dell’arbitrato per le controversie di lavorosportivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
6.1.1. Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3916.1.2. L’arbitrato previsto ex lege per le controversie di lavoro
sportivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3966.1.3. L’arbitrato per le controversie di lavoro sportivo autoriz-
zato da accordi collettivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4026.2. L’arbitrato di lavoro sportivo ai sensi dell’art. 4 l. 23
marzo 1981, n. 91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4036.2.1. L’ambito di applicazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4046.2.2. La devoluzione delle controversie ad arbitri e le regole del
procedimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408
INDICE SOMMARIOX
CAPITOLO SETTIMO
LA GIUSTIZIA DEI PRIVATINEL SISTEMA DELL’AUTODISCIPLINA PUBBLICITARIA
Antonio Punzi
7.1. Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4157.2. L’autodisciplina pubblicitaria nella crisi del legicentrismo
e dello statalismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4167.3. L’autodisciplina pubblicitaria come ordinamento giuri-
dico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4187.4. Soggetti e oggetto del sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4247.5. La risoluzione delle controversie: il procedimento ordina-
rio e i poteri del Giurì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4297.6. Il procedimento monitorio e i poteri del Comitato di con-
trollo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4377.7. Il procedimento autodisciplinare è un arbitrato? . . . . . . 4407.8. Il controllo dell’autorità giudiziaria sulle pronunce del
Giurì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4507.9. Giurì di autodisciplina pubblicitaria e Autorità garante
della Concorrenza e del Mercato . . . . . . . . . . . . . . . . 4557.10. Il Cross Border Complaints System e il futuro dell’autodi-
sciplina pubblicitaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463
SEZIONE TERZA
Arbitrato e procedure concorsuali
CAPITOLO UNICO
RAPPORTI TRA ARBITRATOE PROCEDURE CONCORSUALI
Nicola Sotgiu
1. Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4692. Limiti derivanti dall’oggetto del giudizio arbitrale o del
patto compromissorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4733. Il patto compromissorio come contratto: sua opponibilità
alla procedura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4814. Opponibilità ratione temporis . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4835. Poteri del curatore sul patto compromissorio già con-
cluso. In particolare: il compromesso . . . . . . . . . . . . . 484
INDICE SOMMARIO XI
6. Segue: la clausola compromissoria . . . . . . . . . . . . . . . 4857. Segue: la convenzione di arbitrato in materia non contrat-
tuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4878. Subentro del curatore nel patto compromissorio e nomina
degli arbitri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4889. Effetti dello scioglimento del patto compromissorio sui
giudizi arbitrali in corso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48910. Conseguenze dello scioglimento del contratto sui crediti
derivanti dal patto compromissorio . . . . . . . . . . . . . . 49211. Procedure concorsuali e lodo ancora impugnabile . . . . . 49412. Compromettibilità delle controversie derivanti dal falli-
mento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497
SEZIONE QUARTA
Arbitrato e pubblica amministrazione
CAPITOLO UNICO
L’ARBITRATO NEL DIRITTO AMMINISTRATIVO
Jacopo Polinari
1. Ambito dell’indagine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5032. La compromettibilità delle controversie su diritti sogget-
tivi rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudiceamministrativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508
3. L’art. 6, comma 2o, l. n. 205/2000, oggi confluito nell’art.12 del codice del processo amministrativo . . . . . . . . . . 520
4. L’effettivo ambito della compromettibilità alla luce delcodice del processo amministrativo, in particolare il pro-blema della pregiudiziale amministrativa . . . . . . . . . . . 528
5. La compromettibilità delle situazioni giuridiche soggettivedi diritto pubblico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531
6. La disponibilità del potere amministrativo e suoi limiti . . 5317. La disponibilità dell’interesse legittimo . . . . . . . . . . . . 5388. Arbitrabilità delle situazioni giuridiche soggettive di
diritto pubblico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5439. Ricostruzione sistematica dell’ammissibilità dell’arbitrato
sulle situazioni giuridiche di diritto pubblico e della pote-stà degli arbitri di annullamento dei provvedimenti ammi-nistrativi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560
INDICE SOMMARIOXII
SEZIONE QUINTA
L’arbitrato estero
CAPITOLO PRIMO
LA PROCEDURA ITALIANA PER IL RICONOSCIMENTOE L’ESECUZIONE DEI LODI STRANIERI
Giuseppe Ruffini
1.1. La Convenzione di New York del 1958 per il riconosci-mento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere:osservazioni preliminari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573
1.2. Il sistema italiano per il riconoscimento e l’esecuzione deilodi esteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577
1.3. Segue: le ragioni della scelta e le possibili alternative . . . . 5831.4. Interesse ad agire e oggetto della domanda di riconosci-
mento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5861.5. Il procedimento di cui agli artt. 839 e 840 c.p.c. . . . . . . 5881.6. Osservazioni conclusive de iure condito e prospettive de
iure condendo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591
CAPITOLO SECONDO
IL RICONOSCIMENTO E L’ESECUZIONEDEI LODI ARBITRALI STRANIERI
Elisa Picozza
2.1. Premessa: il «riconoscimento» e l’«esecuzione» del lodoestero e la sfera di operatività del procedimento discipli-nato dagli artt. 839 e 840 c.p.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . 599
2.2. La fase unilaterale disciplinata dall’art. 839 c.p.c. . . . . . . 6032.2.1. Considerazioni introduttive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6032.2.2. L’instaurazione del procedimento . . . . . . . . . . . . . . . 6062.2.3. Gli adempimenti imposti al ricorrente . . . . . . . . . . . . . 6132.2.4. L’oggetto del procedimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6242.3. Il decreto conclusivo della fase unilaterale . . . . . . . . . . 6302.3.1. Il contenuto del decreto presidenziale . . . . . . . . . . . . . 6302.3.2. L’efficacia del decreto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6332.3.3. La conoscibilità del decreto in funzione del giudizio di
opposizione e la sorte del decreto non opposto . . . . . . . 6392.4. La fase di opposizione prevista dall’art. 840 c.p.c. . . . . . 646
INDICE SOMMARIO XIII
2.4.1. L’instaurazione e l’oggetto del giudizio . . . . . . . . . . . . 6462.4.2. La disciplina processuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6502.4.3. La conclusione del giudizio di opposizione . . . . . . . . . 6542.4.4. Le singole circostanze ostative al riconoscimento . . . . . . 6582.4.4.1. L’incapacità delle parti e l’invalidità della convenzione
arbitrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6582.4.4.2. La violazione del diritto di difesa . . . . . . . . . . . . . . . . 6622.4.4.3. Il vizio di extra o ultra petizione del lodo . . . . . . . . . . . 6652.4.4.4. Il vizio nella costituzione del collegio arbitrale o nel pro-
cedimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6682.4.4.5. L’assenza di vincolatività del lodo ed il suo annullamento
o sospensione nel paese di origine . . . . . . . . . . . . . . . 6712.4.4.5.1. La sospensione del giudizio di opposizione . . . . . . . . . 6762.4.4.6. Il riesame delle circostanze ostative rilevabili d’ufficio e la
clausola di salvezza delle convenzioni internazionali . . . . 679
SEZIONE SESTA
Profili storici dell’arbitrato
CAPITOLO UNICO
L’ARBITRATO LIBERONELLA STAGIONE DEI CODICI OTTOCENTESCHI.
UN EMBLEMA DELLA NATURA NEGOZIALEDELL’ISTITUTO ARBITRALE?
Giordano Ferri
1. Alcuni cenni sugli approdi della dottrina giuridica odierna . 6851.1. La dicotomia tra arbitro rituale e arbitro irrituale nella cul-
tura giuridica del Novecento: i termini della questione . . 6892. I confini dell’istituto arbitrale nell’Ancien Régime: le
figure dell’arbiter iuris e dell’arbitrator al tramonto del-l’ordo iudiciarius medievale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 703
2.1. L’arbiter iuris communis, l’arbiter ex necessitate statuti egli arbitri compromissarij nei pratici del Seicento: unadistinctio non concorde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 716
3. Il panorama d’Oltralpe del XVI-XVII secolo ed il pen-siero giuridico francese: l’Ordonnance de Moulins, il CodeMichaud e l’impronta «giurisdizionalizzatrice» del CodeLuis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720
INDICE SOMMARIOXIV
3.1. Il fenomeno arbitrale nella dottrina giuridica francese delSei-Settecento: tentativi di sintesi tra la «vecchia» e la«nuova» disciplina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 724
3.2. L’arbitrage nella Francia rivoluzionaria: il contributo diCondorcet e la testimonianza di Robespierre . . . . . . . . 728
4. La disciplina dell’arbitrage nel Code de procédure civile del1806: un’inversione di tendenza? . . . . . . . . . . . . . . . . 733
4.1. L’interpretazione della dottrina e della giurisprudenza . . 7385. L’arbitro nei codici di rito degli Stati italiani successori:
un’eccezione all’influenza d’Oltralpe . . . . . . . . . . . . . 7446. Il Codice di procedura civile del 1865 e la nuova disci-
plina del compromesso: il ragionamento di Pisanelli . . . . 7477. Conclusioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750
SEZIONE SETTIMA
Profili di diritto comparato
CAPITOLO PRIMO
NATURA ED EFFETTI DEL LODO ARBITRALEIN FRANCIA, BELGIO, SPAGNA E BRASILE
Giovanni Bonato
1.1. Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7551.2. L’arbitrato in generale nel diritto francese . . . . . . . . . . 7641.3. La sentenza arbitrale nel diritto francese: regime generale . 7681.4. La natura dell’arbitrato e della relativa sentenza nel diritto
francese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7771.5. Le specificità della sentenza arbitrale rispetto al regime
del jugement statale nel diritto francese . . . . . . . . . . . . 7891.6. I limiti oggettivi della sentenza arbitrale e la sua opposabi-
lité nel diritto francese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7931.7. Gli altri effetti della sentenza arbitrale nel diritto francese . 8001.8. La sentenza arbitrale nel diritto belga: regime generale . . 8041.9. La natura e gli effetti della sentenza arbitrale nel diritto
belga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8071.10. Il lodo nel diritto spagnolo: regime generale . . . . . . . . . 8131.11. La natura e gli effetti del lodo nel diritto spagnolo . . . . . 8191.12. Il lodo nel diritto brasiliano: regime ed effetti . . . . . . . . 8271.13. La dottrina brasiliana favorevole ad una identità di effetti
tra lodo e sentenza statale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 832
INDICE SOMMARIO XV
1.14. Segue: le prospettive diverse sulla natura e sull’efficaciadel lodo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 836
1.15. Conclusioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 841
CAPITOLO SECONDO
NATURA ED EFFETTI DEL LODO ARBITRALEIN GERMANIA E AUSTRIA
Marco Gradi
2.1. La querelle dottrinale sull’«efficacia di sentenza» del lodo,non sopita dall’introduzione dell’art. 824 bis c.p.c. . . . . . 845
2.2. Le ragioni del dibattito italiano e gli aspetti controversi . . 8482.3. La disciplina dell’arbitrato in Germania e in Austria: pro-
fili generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8622.4. Gli effetti del lodo arbitrale nella legislazione tedesca ed
austriaca, secondo la quale «der Schiedsspruch hat unterden Parteien die Wirkungen eines rechtskräftigen gerichtli-chen Urteils» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 870
2.5. Le opinioni della dottrina tedesca ed austriaca in ordine alparallelo fra lodo arbitrale e sentenza statale . . . . . . . . . 873
2.6. Il lodo reso su materia non compromettibile e il lodo con-trario all’ordine pubblico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 875
2.7. La natura e il regime di rilevabilità dell’eccezione di pre-cedente lodo non più impugnabile . . . . . . . . . . . . . . . 884
2.8. La questione dei limiti oggettivi del lodo arbitrale . . . . . 8852.9. Il problema degli effetti del lodo arbitrale nei confronti
dei terzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8872.10. Osservazioni conclusive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 891
Indice analitico dell’opera (a cura di Francesco Cordopatri) . . . . . . 893
INDICE SOMMARIOXVI
Capitolo Unico
L’ARBITRATO NEL DIRITTO AMMINISTRATIVO
Jacopo Polinari
Dottore di ricerca nell’Università LUISS di Roma
1. – Ambito dell’indagine. – Con la locuzione «arbitrato nel dirittoamministrativo» si suole fare riferimento, in maniera non proprio rigo-rosa, a situazioni spesso estremamente lontane tra loro, che vanno dal-l’arbitrato su situazioni giuridiche soggettive di diritto pubblico finoalle controversie in materia di contratti pubblici, passando dall’arbi-trato su diritti nelle materie rientranti nella giurisdizione esclusiva delgiudice amministrativo.
Ciò che unisce tutte queste diversissime figure è la constatazioneche il legislatore ha previsto – o sembra aver previsto – per tali situa-zioni regole ulteriori o comunque diverse da quelle che disciplinanol’arbitrato nei rapporti tra privati.
Ecco allora che, per capire il perché si ponga il problema dell’arbi-trato nelle controversie di diritto amministrativo, occorre capire, pri-mariamente, cosa si intenda per «controversie di diritto amministra-tivo» o «controversie amministrative», al fine di sgomberare il campoda equivoci, quale quello in cui parte della dottrina è incorsa (ancherecentemente) limitando il significato dell’arbitrato nel diritto ammini-strativo alle controversie arbitrali in cui sia parte un soggetto pubblicoo una pubblica amministrazione (1).
(1) V. Perfetti, Sull’arbitrato nelle controversie in cui sia parte un’amministra-zione pubblica, la necessaria ricerca dei presupposti teorici e dei profili sistematici, inRiv. arb., 2009, p. 589 ss.; Caia, Arbitrati e modelli arbitrali nel diritto amministrativo,i presupposti e le tendenze, Milano, 1989, pp. 1, 31, che riprende la definizione di LaTorre, L’arbitrato nel diritto amministrativo, in Riv. dir. pubbl., 1935, I, p. 327.
Detto criterio «soggettivo» non pare dirimente. In senso lato,infatti, che la pubblica amministrazione sia semplicemente parte inuna controversia non crea di per sé questioni particolari, se non –eventualmente – l’applicazione delle disposizioni riguardanti la rap-presentanza in giudizio e il foro competente (2). Inoltre, una defini-zione meramente soggettiva lascia fuori dal novero delle controversieamministrative tutte quelle liti tra privati in cui rilevi un provvedi-mento amministrativo o la spendita di un pubblico potere, nonchéquelle controversie in cui un soggetto privato è chiamato ad applicaredisposizioni di diritto pubblico (3).
Le controversie che riguardano la pubblica amministrazione esclu-sivamente quale soggetto privato e senza spendita di potere pubblico,come le controversie riguardanti la proprietà dei beni e la responsabi-lità del proprietario per danni (dissesto del manto stradale, rovina diedificio, danni cagionati da animali appartenenti alla p.a.) sono con-troversie schiettamente di diritto privato, devolute alla giurisdizionedel giudice ordinario.
Ecco allora che eventuali controversie che potrebbero scaturiredell’essere o dall’agire della pubblica amministrazione come un sog-getto privato, al di fuori delle sue incombenze istituzionali, rientranotout court nel diritto privato.
Da questa assimilazione non può che discendere che dette contro-versie sono liberamente arbitrabili come lo sono quelle tra privati,ferme restando tuttavia le disposizioni inerenti la responsabilità perdanno erariale ex art. 28 Cost.
Discorso analogo, in linea con quanto appena riferito, va fattoanche per le controversie riguardanti i danni subiti dal privato percausa di un’attività «reale» dell’amministrazione, ossia quei danniderivanti al privato nell’ambito di scelte di mera opportunità tecnica,al di fuori di ogni valutazione afferente a discrezionalità amministra-tiva: «vi sono più modi per abbattere un edificio pericolante, eseguireuna disinfezione, eseguire un’analisi chimica e simili. Queste scelte
(2) V. sull’argomento Amorth-Tomasicchio, Il giudizio civile con lo Stato,Padova, 1963, passim.
(3) V. Gasparini Casari, in Aa.Vv., L’arbitrato. Profili sostanziali, rassegnacoordinata da Alpa, Torino, 1999, p. 1010.
PARTE V - SEZ. IV - ARBITRATO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE504
non hanno a oggetto la ponderazione di interessi pubblici, ma l’appli-cazione di tecniche. Se l’azione è sbagliata e ha esiti di danno ingiusto,l’amministrazione o l’autore della scelta rispondono per fatto illecitocivile o altro» (penale) (4).
Se pertanto ciò che ha prodotto danni al privato è la scelta del-l’amministrazione fondata su parametri esclusivi di opportunità tec-nica, al di fuori dell’esercizio del pubblico potere (ancorché nell’occa-sione), le relative controversie, sottratte al sindacato di legittimità delgiudice amministrativo (salvi i casi tassativi di giurisdizione di merito)avranno ad oggetto diritti soggettivi e saranno transigibili e arbitrabilialla stregua del diritto comune.
Parimenti non rientrano strictu sensu tra le controversie ammini-strative quelle che possono venire in essere quando l’amministrazioneagisce per l’attuazione dei suoi fini istituzionali non già avvalendosidella sua posizione di supremazia, ma servendosi degli strumenti didiritto privato che danno luogo a rapporti contraddistinti da dirittisoggettivi perfetti (5).
Un caso a parte è rappresentato dalle controversie in materia dicontratti pubblici. Come noto, l’art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a.devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte lecontroversie, incluse quelle risarcitorie, relative alle procedure di affi-damento di lavori, servizi e forniture svolte da soggetti (pubblici o pri-vati) comunque tenuti all’applicazione della normativa comunitariaovvero al rispetto delle procedure di evidenza pubblica. Fino a chenon sia avvenuta la stipulazione del contratto l’intera vicenda è rego-lata dal diritto amministrativo (6) e, in particolare, dalle norme in temadi evidenza pubblica: il contraente può vantare nei confronti della sta-zione appaltante solo posizioni di diritto amministrativo ed eventuali
(4) Così Giannini, Istituzioni di diritto amministrativo2, Milano, 2000, p. 270.(5) V. Capaccioli, L’arbitrato nel diritto amministrativo. Le fonti, I, Padova,
1957, p. 3 ss.; Cass. 2 febbraio 1966, n. 372, a proposito della compromettibilità perarbitri delle controversie relative alle forniture.
(6) Lo spartiacque tra la giurisdizione del giudice ordinario e quella del giudiceamministrativo, e prima ancora tra la fase di diritto pubblico e quella disciplinatadalle regole del diritto civile, è rappresentata dalla stipulazione del contratto. In dot-trina, v. Daleffe-Spaccapelo, Le disposizioni processuali del nuovo codice dei con-tratti pubblici, in Riv. dir. proc., 2007, p. 955.
CAP. UNICO - L’ARBITRATO NEL DIRITTO AMMINISTRATIVO 505
liti sono rimesse alla giurisdizione di legittimità del giudice ammini-strativo (7).
A valle della stipulazione del contratto si entra nella fase privati-stica dei rapporti tra il contraente e la stazione appaltante; eventualicontroversie rientrano pertanto nella giurisdizione del giudice ordina-rio (8), essendo inerenti a rapporti di diritto privato.
Pertanto, se ciò è vero, se ne dovrebbe ricavare che anche le liti inmateria di contratti pubblici, dal momento che ineriscono a rapportidi diritto privato e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario,siano arbitrabili alla stregua del diritto comune e seguano le regole delcodice di procedura civile (9). Eppure così non è. Infatti l’arbitrato inmateria di contratti pubblici è stato da sempre oggetto di una disci-plina particolarmente analitica e – soprattutto in passato – limitativadell’autonomia delle parti, senza contare che più volte il legislatore neha espressamente vietato l’utilizzo (10).
(7) Sembra fare eccezione la posizione dell’aggiudicatario nel caso in cui la sta-zione appaltante rifiuti di stipulare il contratto, al di fuori delle ipotesi di autotutela.Occorre infatti domandarsi, in tale situazione, di quale tipo sia la posizione soggettivadell’aggiudicatario, se interesse legittimo o diritto soggettivo. A nostro modo divedere non sembra seriamente contestabile che la situazione giuridica soggettiva chesi crea in capo all’aggiudicatario sia un vero e proprio diritto soggettivo (Cass., sez.un., 11 giugno 1998, n. 5807, in Riv. Corte Conti, 1998, II, p. 240). Ritenere infattiche, a fronte dei poteri in capo alla amministrazione di non stipulare il contratto inesercizio di autotutela, la posizione dell’aggiudicatario presenti la consistenza di uninteresse legittimo al corretto uso del potere, pare contrastare, sul piano sistematico,con l’affermata configurabilità di una responsabilità precontrattuale della p.a. difronte al legittimo affidamento dell’aggiudicatario alla stipulazione del contratto (v.,ex multis, T.a.r. Lazio, sez. I, 7 luglio 2003, n. 5991, in Foro amm.-T.a.r., 2003, p. 2297ss., con riferimento alla mancata stipula del contratto per sopravvenuta carenza difondi; Cons. Stato 7 marzo 2005, n. 920, in Foro amm. – Cons. Stato, 2005, p. 738 ss.;Cons. Stato, ad. plen., 5 settembre 2005, n. 6, in Foro amm.-Cons. Stato, 2005, p.2515). Sull’argomento, v., se vuoi, Polinari, Le fasi della formazione del contrattopubblico: brevi note a prima lettura sugli artt. 11 e 12 del codice dei contratti pubblici, inRass. avv. Stato, 2006, 185, spec. 189 s.
(8) Ad eccezione delle controversie relative al divieto di rinnovo tacito dei con-tratti e quelle relative alla revisione dei prezzi, che restano appannaggio della giurisdi-zione esclusiva del giudice amministrativo.
(9) Così precisamente Delsignore, La compromettibilità in arbitrato nel dirittoamministrativo, Milano, 2007, pp. 208, 212.
(10) Per l’evoluzione legislativa in materia, v. supra, parte III, sez. IV, cap. III; per
PARTE V - SEZ. IV - ARBITRATO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE506
Peraltro, va osservato che le cautele che il legislatore ha introdottonella disciplina dell’arbitrato scompaiono del tutto nel caso in cui lamedesima lite sia invece devoluta, per quanto di sua competenza, allagiurisdizione ordinaria. Le norme del codice dei contratti pubblicinon dettano infatti alcuna disciplina per le liti che si svolgono apudjudicem.
L’osservazione che si può trarre è che il legislatore, pur non disco-noscendo affatto la natura eminentemente ed innegabilmente privati-stica delle controversie in questione, non ha potuto non rilevare chel’intera materia dei contratti pubblici attiene ad un settore dell’econo-mia fortemente permeato di interesse pubblico, vuoi perché il com-mittente ha quasi sempre natura pubblica (e così anche le risorseimpiegate), vuoi perché l’esecuzione del contratto, che si tratti dellarealizzazione di un’opera pubblica ovvero dell’esecuzione di un servi-zio o di una fornitura, risponde sempre e comunque all’esigenza diperseguimento dell’interesse pubblico. Ecco allora che sotto questaluce si giustificano non solo le limitazioni all’autonomia negozialedelle parti nella costruzione negoziale del contratto d’appalto, maanche le disposizioni in tema di arbitrato.
Il fatto poi che il legislatore non abbia dettato alcuna norma per leliti che si svolgono davanti al giudice ordinario significa solo che nonha ravvisato le stesse esigenze di cautela per il caso in cui la lite vadaad incardinarsi davanti ad un organo appartenente all’organizzazionegiudiziaria, ritenendo che la sua posizione istituzionale dia garanziesufficienti anche con riguardo alla salvaguardia dell’interesse pub-blico, diversamente da quanto potrebbe invece attendersi quando lalite sia affidata all’autonomia privata delle parti.
Quindi, anche se nelle liti in materia di contratti pubblici, unavolta varcato il momento dell’aggiudicazione, non si pongono que-stioni circa l’esercizio – legittimo o meno – del pubblico potere, ilfatto che l’oggetto della controversia, e prima ancora del contratto, siafortemente permeato di pubblico interesse, se non muta la natura emi-nentemente privatistica del rapporto sostanziale, può comunque giu-
l’esposizione della disciplina vigente dell’arbitrato nei lavori pubblici, v. supra, l’ap-profondimento di Odorisio, parte V, sez. II, cap. III.
CAP. UNICO - L’ARBITRATO NEL DIRITTO AMMINISTRATIVO 507
stificare l’imposizione di una disciplina che, per il caso di composi-zione e/o risoluzione alternativa, limiti in qualche modo l’autonomiaprivata delle parti (11).
Con quest’ultima osservazione si ritiene di aver sgomberato ilcampo da questioni che, ai fini dell’inquadramento sistematico dell’ar-bitrato tra gli strumenti di risoluzione delle controversie amministra-tive, non generano particolari problemi ma si pongono a valle dellaquestione principale della arbitrabilità stessa, nonché del modo diessere dell’arbitrato, una volta che lo si sia ammesso.
Oggetto del presente studio saranno, pertanto, le controversie incui viene in gioco l’esercizio di un pubblico potere, che si estrinsechi omeno nell’adozione di un provvedimento amministrativo, e quelle che,riguardando diritti soggettivi fortemente connessi o comunque legatiall’esercizio del potere amministrativo, ovvero connessi intimamente asituazioni giuridiche soggettive di diritto pubblico, siano pertantodevolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Non ci si dedicherà, invece, alle controversie in materia di con-tratti pubblici che, per le loro caratteristiche peculiari, sono stateoggetto di un’autonoma trattazione (12).
2. – La compromettibilità delle controversie su diritti soggettivi rien-tranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. – Finoalla l. n. 205/2000 le controversie relative a diritti soggettivi rientrantinella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo erano tradizio-nalmente ritenute materia non arbitrabile vuoi dalla giurisprudenzacivile, vuoi dalla giurisprudenza amministrativa assolutamente domi-nanti.
Prevalentemente l’incompromettibilità veniva desunta dalla consi-derazione, alquanto opinabile, che voleva l’arbitrato strumento «alter-nativo» alla sola giurisdizione civile ordinaria, sicché quando la lite
(11) Il contratto d’appalto di opere pubbliche è considerato paradigmatico dei«contratti di diritto privato speciale» che in dottrina si sono distinti dai «contratti didiritto pubblico», quali concessioni, convenzioni urbanistiche, convenzioni in materiasanitaria, servizi: Greco, I contratti dell’amministrazione tra diritto pubblico e privato,Milano, 1986, p. 105 ss.
(12) V. supra, parte III, sez. IV, cap. III, nonché l’approfondimento di Odorisio,parte V, sez. II, cap. III.
PARTE V - SEZ. IV - ARBITRATO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE508
fosse rientrata tra quelle devolute alla giurisdizione esclusiva del giu-dice amministrativo, il ricorso all’arbitrato avrebbe significatoun’inammissibile deroga al rapporto tra le giurisdizioni voluto dal legi-slatore (13), e pertanto la clausola compromissoria o il compromessoeventualmente stipulati erano considerati irrimediabilmente nulli (14).
Sotto un altro profilo, l’inarbitrabilità veniva ricondotta allasopravvenuta indisponibilità dei diritti soggettivi che il legislatoreaveva ricondotto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministra-tivo. In altre parole, l’attribuzione da parte del legislatore alla giurisdi-zione esclusiva di singole materie avrebbe natura di provvedimento diordine pubblico, capace di superare, o quantomeno limitare, la dispo-nibilità delle situazioni giuridiche soggettive coinvolte. Inoltre, l’in-timo intreccio con le posizioni di interesse legittimo (date per indispo-nibili) avrebbe avuto l’effetto di limitare anche la disponibilità dellesituazioni di diritto soggettivo.
Ancora, se si fosse ammessa l’arbitrabilità delle controversie inmateria di diritto soggettivo, ciò avrebbe significato anche il ripristinodella distinzione tra le due situazioni giuridiche soggettive, che pro-prio la norma che le attribuiva entrambe al giudice amministrativoaveva voluto superare (15).
(13) A titolo di esempio, v. Cass. 4 luglio 1981, n. 4360, in Foro it. 1981, I, 1860,con nota di Barone; Cass. 10 dicembre 1981, n. 6517, in Foro it., 1982, I, c. 684 ss.;Cass. 24 settembre 1982, n. 4934, in Giur. it., 1983, I, 1, c. 755 ss.; Cass. 12 ottobre1983, n. 5924, in Rass. avv. Stato, 1983, I, p. 879 ss.; Cass. 18 gennaio 1984, n. 404, inRep. Foro it., 1984, voce Arbitrato, n. 58; Cass. 18 gennaio 1984, n. 406, in Rep. Foroit., 1984, voce cit., n. 77; Cass. 9 aprile 1987, n. 3490, in Rep. Foro it., 1987, voce cit.,n. 54; Cass. 16 ottobre 1989, n. 4145, in Rass. avv. Stato, 1989, I, p. 327 ss.; Cass. 29agosto 1989, n. 3818, in Giur. agr. it., 1990, p. 281; Cass., sez. un., 3 dicembre 1991,n. 12966, in Foro it., 1993, I, c. 3367 ss.; Cass. 10 luglio 1995, n. 7643, in Rep. Foro it.,1995, voce Arbitrato, n. 72. Nello stesso senso anche la prevalente giurisprudenzaamministrativa: v. Cons. Stato 20 dicembre 1997, n. 1872, in Cons. Stato, 1997, I, p.1728 ss.; Cons. Stato 12 febbraio 1996, n. 148, in Foro it., 1996, III, c. 492 ss.
(14) V. Cons. Stato 4 maggio 2004, n. 2726, in Foro amm.-Cons. Stato, 2004, p.1418 ss.; Cass., sez. un., 10 dicembre 1993, 12166, in Foro it., 1994, I, c. 2472 ss.;Cons. Stato 13 febbraio 1996, n. 148, cit.; Cass., sez. un., 19 febbraio 1999, n. 79, inForo it., 1999, I, c. 1857 ss.; Cass., sez. un., 10 maggio 2001, n. 190, in Giur. it., 2001,p. 2377 ss.; T.a.r. Lazio 2 novembre 1983, in Trib. amm. reg., 1983, I, p. 3447.
(15) Così Cass., sez. un., 11 aprile 1990, 3075, in Riv. arb., 1991, p. 275 ss., laquale precisa che ammettere la deferibilità ad arbitri delle controversie relative a
CAP. UNICO - L’ARBITRATO NEL DIRITTO AMMINISTRATIVO 509
Altro argomento ritenuto preclusivo alla arbitrabilità aveva,invece, carattere tecnico e riguardava il problema del coordinamentodelle competenze giurisdizionali collegate all’arbitrato, non solo conriferimento alla impugnazione del lodo, ma anche a tutte le altresituazioni in cui la disciplina dell’arbitrato prevede l’intervento delgiudice.
Si affermava che, una volta ammessa la compromettibilità di con-troversie su materie deferite alla giurisdizione esclusiva del giudiceamministrativo, «l’eventuale impugnazione per nullità del giudizioarbitrale e della relativa sentenza, ove accolta dal giudice ordinariocompetente, imporrebbe che questi provvedesse anche nel meritodella controversia deferita agli arbitri (art. 830 c.p.c.), conseguenzanon solo in contrasto con la coerenza generale del sistema, ma anchecon la norma istitutiva della giurisdizione esclusiva del giudice ammi-nistrativo» (16).
Le conclusioni cui giungeva la giurisprudenza prevalente eranocondivise anche da parte della dottrina: «tanto la istituzione di unagiurisdizione speciale costituisce deroga alla ordinaria competenza, mache, per essere la questione della competenza degli arbitri solo unaspetto della competenza del giudice ordinario, quando questa siaesclusa, è conseguentemente esclusa la competenza degli arbitri e l’ef-ficacia del compromesso» (17); e ancora «la legge che istituisce la giuri-sdizione speciale abbraccia tutta una determinata categoria di interessiregolando la materia ed istituendo un apposito giudice avente perunico compito di esercitare la giurisdizione proprio in ordine a quelladeterminata materia con esclusione del giudice ordinario e, a maggiorragione, del giudice particolare “arbitro-pretore”», e ciò soprattuttoperché la legge istitutiva della giurisdizione speciale «è un provvedi-
diritti, che si pretendono lesi dal provvedimento concessorio, non soltanto impor-rebbe che la distinzione tra diritti e interessi permanga nella materia in violazione del-l’art. 5 l. n. 1034/1971, che è provvedimento d’ordine e di interesse pubblico, maautorizzerebbe una deroga alla concentrazione di tutte le controversie nella giurisdi-zione amministrativa che è stata dal legislatore ritenuta la più idonea.
(16) In questo modo, v. Cass., sez. un., 10 dicembre 1993, 12166, in Corr. giur.,1994, p. 599 ss.
(17) Così Vecchione, L’arbitrato nel sistema del processo civile, Milano, 1971, p.232.
PARTE V - SEZ. IV - ARBITRATO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE510
mento di ordine pubblico che supera il carattere di disponibilità inmateria di diritto attribuito alle parti» (18).
Altri autori, pur non condividendo la posizione della giurispru-denza sulla impossibilità di derogare con l’arbitrato la giurisdizioneamministrativa né l’assunto secondo cui la devoluzione al giudiceamministrativo avrebbe reso indisponibili le situazioni giuridiche sog-gettive coinvolte, per negare l’arbitrabilità dei diritti soggettivi devo-luti alla giurisdizione esclusiva ritenevano addirittura decisivo l’argo-mento secondo cui la devoluzione alla corte d’appello dell’impugna-zione del lodo darebbe luogo ad un’inammissibile deroga al riparto digiurisdizione voluto dal legislatore (19).
Tuttavia, non sono mancate pronunzie, soprattutto del giudiceamministrativo, che, affrontando il problema in materia di contrattiaccessivi a rapporti di concessione, hanno ammesso la validità dellaclausola compromissoria, con deroga alla giurisdizione esclusiva delgiudice amministrativo, quando si trattasse di questioni aventi adoggetto situazioni di diritto soggettivo perfetto suscettibili di transa-zione (20).
Ma la presa di posizione più importante nel senso della compromet-tibilità dei diritti soggettivi rimessi ad una giurisdizione speciale, risale aduna sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 1948 (21). La con-
(18) V. Schizzerotto, Dell’arbitrato3, Milano, 1988, 65. Nel senso degli AA.citati, v. anche Carleo, Controversie non compromettibili, in Aa.Vv., Dizionario del-l’arbitrato, a cura di Irti, Torino, 1997, p. 265.
(19) Così Caia, Arbitrati e modelli arbitrali nel diritto amministrativo, cit., p. 205,secondo il quale «laddove la legge prevede la giurisdizione esclusiva, ogni interventodell’autorità giudiziaria ordinaria risulta precluso perché norme di legge siffatte sonoformulate in modo da non autorizzare il “ritaglio” di competenza a favore del giudiceordinario per quanto riguarda ipotetiche sentenze arbitrali e loro impugnazioni».Nello stesso senso, v. anche Acquarone-Mignone, voce Arbitrato nel giudizioamministrativo, in Dig., disc. pubbl., Torino, 1987, I, p. 371.
(20) T.a.r. Lombardia, sez. Brescia, 2 settembre 1993, in Giust. civ., 1994, I, p.1727 ss.; T.a.r. Lombardia, sez. Brescia, 25 marzo 1980, in Foro amm., 1980, I, p.1019; T.a.r. Piemonte 28 giugno 1978, in Giust. civ., 1979, II, p. 154 ss., che ritienerilevante la distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi nonostante in materiadi concessione, l’art. 5 l. 1034/71 rimettesse tutto alla giurisdizione esclusiva del giu-dice amministrativo dal momento che solo i primi possono essere rimessi alla cogni-zione degli arbitri.
(21) V. Cass., sez. un., 5 agosto 1948, n. 1384, in Foro it. 1948, I, c. 820 ss.
CAP. UNICO - L’ARBITRATO NEL DIRITTO AMMINISTRATIVO 511
troversia decisa dalla Suprema Corte aveva ad oggetto la revisione prezziin un contratto misto tra concessione e appalto, rimessa dall’art. 4 r.d. 13giugno 1940, n. 901 alla giurisdizione esclusiva del Ministro della Guerra.
Secondo le Sezioni Unite «si potrebbe obbiettare che non sonocompromettibili le vertenze, per la cui risoluzione sia stato, dal legisla-tore, predisposto un organo giurisdizionale speciale, come nel casoattuale. Ciò non è esatto. Non esiste, né nel nostro diritto processuale,né nel nostro diritto sostanziale, un principio generale, in base al qualedovrebbe escludersi la compromettibilità delle vertenze devolute adun organo giurisdizionale speciale». Se peraltro detto principio nonesiste, ne esiste invece uno diverso: «dall’art. 806 c.p.c., per contro, sideduce un principio generale diverso; e, cioè, che sono comprometti-bili tutte le controversie, eccettuate quelle tassativamente indicate nel-l’art. 806; ed, in particolar modo, quelle non transigibili, perché rela-tive a diritti indisponibili» (22).
La chiarezza e la semplicità del ragionamento delle Sezioni Unite,che sostanzialmente individuano gli unici effettivi limiti alla compro-mettibilità nella lettera e nei principi ricavabili dall’art. 806 c.p.c.,hanno gettato le basi per l’elaborazione dottrinaria prevalente che nonritiene che dalla norma attributiva della giurisdizione siano ricavabililimiti ulteriori alla compromettibilità in arbitrato dei diritti soggettivi.
Già Andrioli ricordava che la «fondamentale dicotomia» tra dirittisoggettivi e interessi legittimi informa il riparto di giurisdizione tragiurisdizione civile e giurisdizione amministrativa, affondando le sueradici nel diritto sostanziale, e non si esaurisce solamente nella riparti-
(22) Il revirement delle Sezioni Unite, che apriva alla compromettibilità dei dirittisoggettivi ancorché rientranti in materia rimesse alla cognizione di un giudice speciale,non è durato neanche lo «spazio di un’estate». Infatti, con Cass., sez. un., 26 agosto1948, in Foro it., 1949, I, c. 136 ss., le stesse Sezioni Unite sono tornate sui loro passi:«(...) deve dirsi che è inammissibile la deroga della clausola compromissoria conven-zionale dalla giurisdizione speciale. La legge che questa istituisce abbraccia infattitutta la materia: e l’organo giurisdizionale, che ne deriva funzioni e disciplina, assorbee generalizza, nella sua essenza, anche il principio dell’arbitrato: cioè lo esclude».
Va peraltro segnalato che in tempi più remoti la questione de qua non si ponevaneanche: v. Cass. 20 maggio 1936, Foro it., 1936, I, c. 977 ss. e Cons. Stato 2 febbraio1938, Foro it., 1938, III, c. 57 ss., con nota di Forti, che giungono a conclusioniopposte circa il giudice competente per l’impugnazione del lodo in controversie rien-tranti nella giurisdizione esclusiva, senza porsi il problema della compromettibilità.
PARTE V - SEZ. IV - ARBITRATO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE512
zione dei poteri tra giudici appartenenti ad un diverso ordine; nesegue che «l’assegnazione di classi di controversie alle superstiti giuri-sdizioni speciali civili non incide in alcun modo sulla qualifica didiritto, propria della res in judicium deducta, allo stesso modo che lasituazione subbiettiva del cittadino non cessa di essere interesse legit-timo sol perché la cognitio ne è affidata ad una giurisdizione specialeamministrativa e non al Consiglio di Stato, quale giudice esclusi-vo» (23).
In altre parole, quale che sia il giudice cui il legislatore ha ritenutodi devolvere la controversia, questa non muta per ciò solo natura. Ed èproprio alla natura dell’oggetto della controversia che occorre fareriferimento per individuare i limiti dell’arbitrabilità; infatti, «chirivolga attenzione agli artt. 806 e 808, rileva che queste norme consi-derano, nel valutare la validità del compromesso, la res in judiciumdeducta (...) e ne induce che il carattere inderogabile della competenzadel giudice, significando non già che il diritto fatto valere sia sottrattoalla disponibilità delle parti, sibbene che un giudice è preferito adogni altro per la cognizione della causa, non incide negativamentesulla validità del compromesso». Il parametro per la validità del com-promesso quindi non può essere dato dall’art. 37 c.p.c., che è normache regola i rapporti tra le giurisdizioni ed è estraneo alla materia arbi-trale, ma va ricercato nell’art. 806 c.p.c. (24).
(23) V. Andrioli, Procedura arbitrale e regolamento di giurisdizione, in Foro it.,1956, I, c. 484 ss.
(24) V. Andrioli, Commento al codice di procedura civile3, IV, Napoli, 1964, p.761 s.; nello stesso senso ritengono che l’attribuzione di una vertenza ad una giurisdi-zione speciale non ne comporti l’indisponibilità e che il limite alla compromettibilitàvada cercato nella indisponibilità sostanziale della res in judicium deducta: Satta,Commentario al codice di procedura civile, IV, 2, Milano, 1971, p. 199 ss.; Amorth,Annotazioni sull’arbitrato nelle controversie amministrative, in Id., Scritti giuridici,Milano, 1999, IV, p. 2173; Domenichelli, Giurisdizione amministrativa e arbitrato:riflessioni e interrogativi, in Dir. proc. amm., 1996, p. 238; Fazzalari, L’arbitrato nel-l’attività della Regione, in Riv. dir. proc., 1974, p. 370; Id., L’arbitrato, Torino, 1997,p. 123; Selvaggi, L’arbitrato nelle controversie devolute alla giurisdizione amministra-tiva, in Riv. arb., 1992, p. 455; Consolo, Sul «campo» dissodato della compromettibi-lità per arbitri, in Riv. arb., 2003, p. 249; Cecchella, L’arbitrato, Torino, 1991, p. 15;Cassese, L’arbitrato nel diritto amministrativo, in Riv. trim. dir. pubbl., 1996, p. 325;Pugliese, Poteri del collegio arbitrale e provvedimenti amministrativi, in Aa.Vv., Arbi-trato e pubblica amministrazione, Milano, 1999, p. 71; Scoca, La capacità della pub-
CAP. UNICO - L’ARBITRATO NEL DIRITTO AMMINISTRATIVO 513
Ma soprattutto non può essere condivisa l’affermazione della giuri-sprudenza secondo cui l’arbitrato sarebbe strumento alternativo alla solagiurisdizione civile e non anche ad altre giurisdizioni, e che la deroga allagiurisdizione – in che consiste l’arbitrato – è possibile solamente nei con-fronti della giurisdizione civile, e non anche quando la giurisdizione spettial giudice amministrativo. Né che l’arbitrato non sarebbe possibile per-ché al momento della impugnazione del lodo si opererebbe un trasferi-mento di competenza ad un giudice che, se non ci fosse stato il patto com-promissorio, sarebbe stato privo di giurisdizione.
Il problema dell’impugnabilità del lodo, insieme a quello dellealtre competenze giurisdizionali collegate all’arbitrato, ancora oggi èlungi dall’avere una soluzione condivisa, ma non sarà possibile affron-tare le questioni ex professo in questa sede (25). Per il momento, bastidire che certamente il problema di individuare il giudice che saràdotato di giurisdizione per l’impugnazione del lodo è un inconve-niente squisitamente tecnico e certamente non può essere usato comeargomento per dimostrare la diminuita compromettibilità di una situa-zione giuridica soggettiva. Come si è visto il parametro della compro-mettibilità va ricercato nelle disposizioni che la disciplinano, nonaltrove; adducere inconvenientes non est producere consequentias (26).
Va d’altro canto rilevato che l’arbitrato non è un modo di solu-zione delle controversie alternativo alla «giurisdizione civile» in séconsiderata. Occorrerebbe infatti primariamente dimostrare che lagiurisdizione civile, nel nostro sistema, costituisca in effetti lo stru-mento ordinario di soluzione delle controversie. E allora, se così fosse,certamente l’arbitrato sarebbe uno strumento di deroga ad una fun-zione esclusiva dello Stato.
blica amministrazione di compromettere in arbitri, in Aa.Vv., Arbitrato e pubblicaamministrazione, Milano, 1991, p. 105; Barrella, Incompatibilità tra giurisdizioneamministrativa e arbitrato, in Riv. arb., 2000, p. 203 ss.; Vaccarella M., Arbitrato egiurisdizione amministrativa, Torino, 2004, p. 10.
(25) Al riguardo, sia consentito rinviare a Polinari, Arbitrato nelle controversieamministrative, in Aa.Vv., Commentario breve al diritto dell’arbitrato nazionale e inter-nazionale, a cura di Benedettelli, Consolo e Radicati di Brozolo, Padova, 2010, p. 522ss.
(26) V. Verde, L’arbitrato e la giurisdizione ordinaria, in Aa.Vv., Diritto dell’arbi-trato3, a cura di Verde, Torino, 2005, 37.
PARTE V - SEZ. IV - ARBITRATO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE514
È stato giustamente osservato che il rapporto tra giurisdizione earbitrato è rapporto conflittuale nella misura in cui il giudice delloStato è abituato a considerare la giurisdizione un «monopolio» delloStato, che pertanto non può essere né derogata né delegata ad altri.Vale a dire che anche il concetto stesso di «deroga alla giurisdizione»,ovvero di «strumenti alternativi» alla giurisdizione per la risoluzionedelle controversie, muta a seconda del ruolo che il potere giurisdizio-nale occupa nell’ordinamento; e, più precisamente, se la giurisdizionevenga considerata un potere dello Stato, requisito ed effetto della suaSovranità, ovvero un servizio che lo Stato stesso offre ai cittadini (27).
In altre parole, fermo restando che l’amministrazione della giusti-zia resta pur sempre espressione di un potere dello Stato, quest’ultimoha un dovere, costituzionalmente previsto (artt. 24, 102 e 111 Cost.), enon una prerogativa. Tanto è vero che le norme della Costituzioneattribuiscono ai cittadini il «diritto» di azione e individuano nellamagistratura l’apparato attributario del potere giurisdizionale, noncreano prerogative, privilegi o monopoli, pure conosciuti nella sto-ria (28).
Ne consegue che l’arbitrato è alternativo alla giurisdizione non nelsenso che vi deroga perché questa è il normale modo di risoluzionedelle controversie, ma nel senso che è semplicemente uno strumento
(27) Così Verde, Nuove riflessioni su arbitrato e pubblica amministrazione, inAa.Vv., Studi in onore di Carmine Punzi, II, Torino, 2008, 695 s. Sull’evoluzione esulla mutevolezza del concetto di «giurisdizione» come potere dello Stato, v.Giannini-Piras, voce Giurisdizione amministrativa, in Enc. dir., XIX, Milano, 1970,p. 229 ss.; Satta, voce Giurisdizione (nozioni generali), in Enc. dir., XIX, Milano,1970, p. 218 ss.; Picardi, La giurisdizione all’alba del terzo millennio, Milano, 2007,passim, spec. p. 105 ss.; Id., La vocazione del nostro tempo per la giurisdizione, in Riv.trim. dir. proc. civ., 2004, p. 41 ss.; Verde, Sul monopolio dello Stato in tema di giuri-sdizione, in Riv. dir. proc., 2003, p. 371 ss.
(28) L’amministrazione della giustizia era, tra il medioevo e l’età moderna, primache un servizio, un affare. Non sono mancati casi in cui il monopolio della giurisdi-zione era funzionale non già alla salvaguardia della sovranità del potere di riferimento,ma della rendita che dalla giurisdizione conseguiva. Per un excursus storico, v.Ascheri, Tribunali, giuristi e istituzioni, Bologna, 1999, passim; Id., I diritti delmedioevo italiano, Roma, 2000, passim; Marani, Aspetti negoziali e aspetti processualidell’arbitrato, Torino, 1966, passim; Martone, Arbiter-Arbitrator. Forme di giustiziaprivata nell’età del diritto comune, Napoli, 1984, passim; nonché Picardi, La giurisdi-zione all’alba del terzo millennio, cit., passim.
CAP. UNICO - L’ARBITRATO NEL DIRITTO AMMINISTRATIVO 515
lecito per risolvere le controversie, al pari di tutti gli altri strumentileciti, che siano negoziali o che si fondino sulla semplice fiducia.
Altrimenti si dovrebbe affermare che anche con la transazione siespropria lo Stato di un suo potere, e lo stesso quando una lite vienecomposta amichevolmente «tra galantuomini».
È allora evidente che le parti, scegliendo l’arbitrato, decidono dinon avvalersi del servizio che lo Stato (deve) mette(re) a loro disposi-zione – ossia l’apparato giurisdizionale – per litigare secondo regoleche loro stesse si danno mantenendo la controversia al di fuori dellagiurisdizione statale. E lo Stato, tanto riconosce questa loro libera econsapevole scelta, che la favorisce disciplinandola; ossia seppure l’ar-bitrato è un quid di diverso e antitetico rispetto alla «giurisdizio-ne» (29), nondimeno non è irrilevante per lo Stato (30).
Ecco allora che la concezione, viva in giurisprudenza, dell’arbi-trato come strumento alternativo rispetto alla sola giurisdizione civileè priva di qualsiasi fondamento logico sistematico. L’arbitrato è unostrumento di risoluzione delle controversie fondato sull’autonomiaprivata. Come tale l’ordinamento lo riconosce e lo disciplina, e attri-buisce sanzione (ossia vincolatività) tanto all’accordo compromissorioquanto al lodo – sempreché la controversia abbia ad oggetto situazionigiuridiche soggettive disponibili – esattamente come attribuisce san-zione a tutti gli atti di autonomia privata che in qualche modo inci-dono su situazioni giuridiche soggettive disponibili. Ponendosi fuoridella giurisdizione statale l’arbitrato è certamente alternativo vuoi allagiurisdizione civile, vuoi alla giurisdizione amministrativa (31).
Si è anche autorevolmente sostenuto che le questioni legate alladifficoltà di ammettere che la via arbitrale nelle materie devolute alla
(29) V. ad esempio Cass. 25 giugno 2002, n. 9281, in Foro it., 2002, I, c. 2299 ss.,con nota di Barone, che proprio in ragione della antinomia tra arbitrato e giurisdi-zione ritiene inammissibile l’esperimento del regolamento di competenza.
(30) Sul punto, e sui rapporti tra la «giurisdizione arbitrale» e la «giurisdizionestatale», nonché sui significati del termine «giurisdizione», v. Verde, Pubblico e pri-vato nel processo arbitrale, in Riv. arb., 2002, p. 633 ss.
(31) Così anche Verde, Arbitrato e pubblica amministrazione, in Riv. arb., 2001,p. 414: la deroga alla giurisdizione operata dall’arbitrato sarebbe «una deroga indi-retta, perché, le parti manifestano soltanto la volontà di deferire la controversia al giu-dice privato e di escludere il giudice statale».
PARTE V - SEZ. IV - ARBITRATO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE516
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo avrebbe inammissi-bilmente riaperto spazi al giudice ordinario, si sarebbero agevolmentepotute superare ammettendo patti in deroga alla giurisdizione (32). Èincontestabile che rispetto alla impostazione originaria del codice,nella quale giurisdizione e competenza costituivano una materia nellaquale era escluso ogni profilo di disponibilità dal momento che eranodisciplinate da norme di ordine pubblico, la questione della derogabi-lità della giurisdizione e della competenza non poteva nemmeno porsi.L’unica eccezione in tal senso era data dall’art. 6 c.p.c., che indivi-duava margini di derogabilità della competenza; viceversa, l’art. 2c.p.c. espressamente colpiva con la nullità ogni patto di deroga allagiurisdizione del giudice italiano nei confronti di un giudice o di unarbitro estero, quando parte in causa fosse un cittadino residente (33).
Le modifiche all’art. 38 c.p.c. apportate nel 1990, che di fattohanno reso derogabili anche i criteri forti di competenza (salva la rile-vabilità d’ufficio entro la prima udienza), e soprattutto l’avvenutaabrogazione dell’art. 2 c.p.c. – che costituiva sostanzialmente l’unicadisposizione da cui fosse espressamente desumibile l’inderogabilitàconvenzionale della giurisdizione – la cui disciplina è stata sostituitada una normativa sul diritto internazionale privato (l. 31 maggio 1995,n. 218) che ammette in numerosi casi la deroga (espressa o tacita) allagiurisdizione italiana, non possono non aver mutato il quadro.
A maggior ragione, dopo che gli ultimi sviluppi giurisprudenziali elegislativi hanno ravvicinato le due giurisdizioni, facendo caderedogmi, come quello della impossibilità della translatio judicii tra giu-
(32) La tesi è sostenuta da Verde, Arbitrato e pubblica amministrazione, in Dir.proc. amm., 1996, p. 223 e dallo stesso A. ribadita più volte: v. Id., Ancora su arbitri ePubblica Amministrazione (in occasione della L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 6), in Riv.arb., 2000, p. 387 ss.; Id., Arbitrato e pubblica amministrazione, cit., 2001, p. 407; Id.,Nuove riflessioni su arbitrato e pubblica amministrazione, cit., p. 697 ss. La tesi registral’adesione di Pugliese, Potere del collegio arbitrale e provvedimenti amministrativi,cit., p. 83.
(33) L’abrogato art. 2 c.p.c. disponeva: «Inderogabilità convenzionale della giuri-sdizione. La giurisdizione italiana non può essere convenzionalmente derogata afavore di una giurisdizione straniera, né di arbitri che pronuncino all’estero, salvo chesi tratti di causa relativa ad obbligazioni tra stranieri o tra uno straniero e un cittadinonon residente ne domiciliato nella Repubblica e la deroga risulti da atto scritto».
CAP. UNICO - L’ARBITRATO NEL DIRITTO AMMINISTRATIVO 517
dice ordinario e giudice amministrativo, che fino a pochi anni addietroerano considerati intoccabili (34).
Si è insomma osservato che i mutamenti profondi cui si è assistito
(34) L’eco di Corte cost. 6 luglio 2004, n. 204, in Foro it., 2004, I, c. 2594 ss. –con cui la Corte Costituzionale ha ritenuto non conforme all’art. 103 Cost. l’attribu-zione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di controversie «per bloc-chi di materie», senza che si faccia questione dell’esercizio del pubblico potere, nonessendo a tal fine sufficiente che la lite sia pervasa di pubblico interesse – avrebbecondotto la Suprema Corte ad affermare il principio della translatio judicii tra giudiceordinario e giudici speciali (e viceversa): v. Cass., sez. un., 22 febbraio 2007, n. 4109,in Foro it., 2007, I, c. 1009 ss., con nota di Oriani, È possibile la translatio iudicii neirapporti tra giudice ordinario e giudice speciale: divergenze e consonanze tra corte di cas-sazione e corte costituzionale; in Riv. dir. proc., 2007, p. 1577 ss., con nota di Acone,Giurisdizione e translatio iudicii ... aspettando Godot; in Dir. proc. amm., 2007, p. 796ss., con nota di Sigismondi, Difetto di giurisdizione e translatio iudicii. Decisionequesta in seguito contestata espressamente da un’ulteriore sentenza della Corte Costi-tuzionale che, nel non ravvisare nell’ordinamento norme che consentano la translatiojudicii tra giudici appartenenti ad ordini diversi, ha tuttavia cassato l’art. 30 l. 6 dicem-bre 1971, n. 1034 nella parte in cui non prevedeva che gli effetti, sostanziali e proces-suali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione si conservino,a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudicemunito di giurisdizione, contribuendo all’avvicinamento, ormai inesorabile, tra ladisciplina delle questioni di giurisdizione a quella delle questioni di competenza (v.Corte cost. 17 marzo 2007, n. 77, in Foro it., 2007, I, c. 1009, con la citata nota diOriani; in Riv. dir. proc., 2007, p. 1577 ss., con la citata nota di Acone; e in Dir. proc.amm., 2007, p. 796 ss., con la citata nota di Sigismondi).
Un ulteriore passo verso l’avvicinamento delle questioni di giurisdizione alle que-stioni di competenza è rappresentato da Cass., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883, pub-blicata, fra l’altro, in Foro it., 2009, I, c. 806 ss., con nota di Poli G., Le sezioni unite el’art. 37 c.p.c., dove la Suprema Corte, promovendo un’interpretazione adeguatricedell’art. 37 c.p.c. alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevoledurata del processo (asse portante della nuova lettura della norma), ha statuito che ildifetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti in primo grado (e solo in primogrado) anche dopo la scadenza dei termini previsti dall’art. 38 c.p.c., e la sentenza diprimo grado di merito può sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione, aprescindere che le parti abbiano o meno sollevato la relativa eccezione; viceversa lesentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione, e il giudice può sol-levare d’ufficio la questione, soltanto se sul punto non si è formato il giudicato impli-cito o esplicito, operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità.
Infine, con l’art. 59 l. 18 giugno 2009, n. 69, il legislatore ha disciplinato positiva-mente le descritte evoluzioni giurisprudenziali introducendo un termine di tre mesidal passaggio in giudicato della sentenza o dell’ordinanza che dichiara il difetto di giu-risdizione e che indica il giudice competente, perché il processo possa proseguirenella nuova sede, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda.
PARTE V - SEZ. IV - ARBITRATO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE518
e si assiste tuttora spingono a ritenere non più attuale il pregiudiziosecondo cui tutto ciò che concerne il processo e i rapporti tra le giuri-sdizioni formi materia indisponibile: «si guarda piuttosto alla naturadegli interessi tutelati e le norme sulla giurisdizione, e ancor più quellesulla competenza, servono a garantire in primo luogo il rispetto delprincipio del giudice naturale, così che quando tale principio non siamesso in pericolo, non c’è ragione per negare rilevanza all’accordodelle parti» (35).
A questa tesi si è obiettato, da un lato, che l’abrogazione dell’art. 2c.p.c. non sarebbe un argomento determinante dal momento che secertamente la l. n. 218/95 ha posto fine al principio «ottocentesco»dell’inderogabilità della giurisdizione statale, ciò non potrebbe avereriflessi immediati anche nell’ambito del riparto di giurisdizione nazio-nale, e, dall’altro, che l’indisponibilità della materia attinente alla giu-risdizione sarebbe ricavabile dall’art. 37 c.p.c., che consente la rileva-bilità d’ufficio del difetto di giurisdizione (36).
La prima obiezione è senza dubbio incontestabile, ma è anche veroche con l’art. 2 c.p.c. è venuto definitivamente meno l’unico appiglioletterale al quale aggrappare la tesi della inderogabilità convenzionaledella giurisdizione (37). Il secondo argomento, invece, non coglie nelsegno, perché la rilevabilità d’ufficio può ben convivere con patti dideroga alla giurisdizione (38).
La tesi della derogabilità convenzionale della giurisdizione è senzadubbio dirompente e soprattutto è difficile trovare argomenti in sensocontrario che non si fondino proprio sull’indimostrata inderogabilitàdelle norme che presiedono al riparto di giurisdizione e alla lororiconduzione all’ordine pubblico. Soprattutto, si presenta sempre piùcondivisibile e coerente con il mutato assetto dei rapporti tra le giuri-
(35) V. Verde, Arbitrato e pubblica amministrazione, cit., 1996, p. 222; analoga-mente, v. Pugliese, Potere del collegio arbitrale e provvedimenti amministrativi, cit., p.83.
(36) V. Consolo, L’oscillante ruolo dell’arbitrato, in Aa.Vv., Arbitrato e pubblicaamministrazione, cit., 1999, p. 152.
(37) V. Verde, Nuove riflessioni su arbitrato e pubblica amministrazione, cit., p.699.
(38) V. Verde, Arbitrato e pubblica amministrazione, cit., 1996, p. 222; Id., Arbi-trato e pubblica amministrazione, cit., 2001, p. 414.
CAP. UNICO - L’ARBITRATO NEL DIRITTO AMMINISTRATIVO 519
sdizioni ordinaria e amministrativa, sempre meno caratterizzati da unarigida separatezza, mentre le questioni di giurisdizione sembranoormai declassate al rango di dispute interne ad un sistema giurisdizio-nale unitario.
Eppure la giurisprudenza e la dottrina amministrativiste – cheavrebbero avuto l’onere di ricostruire sistematicamente una afferma-zione, per il momento in cui fu avanzata, quasi rivoluzionaria – hannomantenuto un atteggiamento ingiustificatamente miope, non prenden-dola in considerazione né per confutarla né per avallarla, se si eccet-tuano l’adesione autorevole di Franco Pugliese (39) e altre aperturenon meno autorevoli (40).
3. – L’art. 6, comma 2o, l. n. 205/2000, oggi confluito nell’art. 12 delcodice del processo amministrativo. – La questione dell’arbitrabilità deidiritti soggettivi rientranti nella giurisdizione esclusiva è stata risoltadal legislatore con un intervento gordiano. L’art. 12 c.p.a. – nel qualeè confluito l’art. 6, comma 2o, l. 205/2000 – dispone: «le controversie
(39) V. Pugliese, Potere del collegio arbitrale e provvedimenti amministrativi, cit.,p. 83.
(40) V. Linguiti-Pluchino, Arbitrato e pubblica amministrazione: diritti sogget-tivi e poteri autoritativi, in Rass. avv. Stato, 2004, p. 1356 s.; Villata, Conclusioni, inAa.Vv., Arbitrato e pubblica amministrazione, cit., 1999, p. 170 s.
In senso fortemente contrario – tra gli amministrativisti – v. Antonioli, Arbi-trato e giurisdizione amministrativa dopo la l. n. 205 del 2000, in Dir. proc. amm., 2002,p. 352, i cui argomenti appaiono però deboli e si sostanziano praticamente solo nellaconsiderazione che il riparto «tra autorità giudiziaria e giudice amministrativo costi-tuisce oggetto di una pluralità di disposizioni di rango costituzionale (artt. 24, 102,103, 111, 113 Cost.), la cui portata verrebbe sostanzialmente vanificata dalla derogabi-lità della giurisdizione» e nell’osservazione secondo cui – dal momento che la compe-tenza sarebbe derogabile solo nei casi previsti dalla legge – sarebbe trattata meno rigi-damente della giurisdizione.
L’argomento fondato sulle norme costituzionali non convince: quelle norme fis-sano un sistema sul piano del «dover essere», creando un diritto del cittadino ad otte-nere tutela anche nei confronti della pubblica amministrazione e individuando i giu-dici davanti ai quali domandare tutela, ma non vi si possono trarre argomenti perescludere a priori la derogabilità della giurisdizione. Il secondo argomento è fondatosu un’osservazione di carattere sistematico quantomeno opinabile: da un lato, non sidanno ragioni irrinunciabili per cui il legislatore dovrebbe fissare regole più restrittiveper la derogabilità della giurisdizione rispetto alla competenza; dall’altro, il sistemadelle eccezioni del difetto di competenza – per come è strutturato – dovrebbe spin-gere a ritenere esattamente l’opposto.
PARTE V - SEZ. IV - ARBITRATO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE520
concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudiceamministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale didiritto».
La disposizione è nata evidentemente per venire incontro alleistanze della dottrina che, come si è visto, aveva segnalato l’incon-gruenza della posizione restrittiva della giurisprudenza (41), ma difatto risolve solo quel problema, lasciando aperte molte delle que-stioni che si ponevano nel silenzio del precedente sistema, e crean-done di nuove e impellenti.
E così si pone, prima di ogni altra cosa, il problema della portatadella disposizione: essa si è limitata a rendere esplicita la facoltà dicompromettere per arbitri i diritti soggettivi rimessi al giudice ammi-nistrativo, ovvero ha una portata innovativa che rende oggi possibileciò che prima non poteva ritenersi ammesso? La domanda, come sivedrà subito, non è oziosa perché dalla risposta dipende la validitàdelle convenzioni d’arbitrato stipulate prima dell’entrata in vigoredella nuova disposizione.
Inoltre, il riferimento espresso ai soli «diritti» sembrerebbe altresìescludere la possibilità di compromettere in arbitri le posizioni di inte-resse legittimo. Si vedrà meglio oltre come detta esclusione apparentenon sia decisiva ma rifletta semmai lo scopo immediato che il legisla-tore si era prefigurato di raggiungere con la disposizione.
Quanto al primo problema, in un primo momento la giurispru-denza – coerentemente al suo tradizionale atteggiamento restrittivo –ha assegnato alla nuova disposizione il significato di norma innovativache eccezionalmente consentiva ciò che prima era precluso. Il ragiona-mento è semplice e lineare: prima dell’entrata in vigore dell’art. 6 l. n.205/2000 l’arbitrato non era possibile e le clausole erano nulle; lanuova norma non ha disposto la sanatoria delle precedenti clausole,ma ha esplicitato una facoltà pro futuro. Ne conseguiva la nullità delle
(41) V. Verde, Nuove riflessioni su arbitrato e pubblica amministrazione, cit., p.700; Di Martino, Arbitrato e pubblica amministrazione: brevi cenni sulla problematicainerente la compromettibilità delle controversie in cui è parte una pubblica amministra-zione, in Riv. trim. appalti, 2001, p. 126; Delsignore, La compromettibilità in arbi-trato, cit., p. 225; Caia, Gli arbitrati e la giurisdizione del giudice amministrativo, inGiornale dir. amm., 2002, p. 948; Antonioli, Arbitrato e giurisdizione amministrativadopo la l. n. 205 del 2000, cit., p. 326 ss., spec. p. 336.
CAP. UNICO - L’ARBITRATO NEL DIRITTO AMMINISTRATIVO 521
convenzioni d’arbitrato e dei procedimenti arbitrali eventualmenteiniziati prima dell’entrata in vigore della norma (42).
Parte della dottrina ha condiviso la posizione della giurisprudenzaaggiungendo che una clausola compromissoria nata in contrasto anorme imperative – quali quelle che sovrintendono al riparto di giuri-sdizione – non potrebbe divenire valida in seguito alla abrogazione diquelle, salvo che ciò non sia espressamente previsto da norme transito-rie (43).
La disposizione, cioè, non avrebbe innovato il panorama delriparto di giurisdizione, ma piuttosto avrebbe dovuto leggersi come
(42) V. Cass., sez. un., 6 maggio 2003, n. 6856, in Foro amm.-Cons. Stato, 2003, p.1528 ss.; Cass., sez. un., 10 maggio 2001, n. 190, in Giur. it., 2001, p. 2377 ss.; Cons.Stato 8 aprile 2002, n. 1902, in Giornale dir. amm., 2002, p. 946 ss., con nota di Caia,Gli arbitrati e la giurisdizione del giudice amministrativo; Cons. Stato 4 maggio 2004,n. 2726, in Foro amm.-Cons. Stato, 2004, p. 1418; Cons. Stato 31 gennaio 2001, n. 353,in Danno e resp., 2001, p. 302, con nota di Carbone V., Provvedimento illegittimo edannoso: il nuovo orientamento della giustizia amministrativa; Cons. Stato 31 gennaio2003, n. 472, in Foro amm.-Cons. Stato, 2003, p. 144; T.a.r. Lombardia 6 novembre2002, in Trib. amm. reg., 2002, I, p. 3317; T.a.r. Veneto 1o marzo 2003, n. 1583, inTAR, 2003, I, p. 81 ss.; T.r.g.a. Trentino Alto Adige, 17 dicembre 2003, in Trib. amm.reg., 2004, I, p. 641 ss.; Cons. Stato 30 aprile 2004, n. 5652, in Foro amm.-Cons. Stato,2004, p. 2225; Cons. Stato 1o luglio 2005, n. 3672, in Cons. Stato, 2005, I, p. 1194;Cons. Stato 13 settembre 2005, n. 4698, in Foro amm.-Cons. Stato, 2005, p. 2616;Cons. Stato 15 dicembre 2005, n. 7124, in Foro amm.-Cons. Stato, 2005, 3642 ss.
(43) V. Caia, Gli arbitrati e la giurisdizione del giudice amministrativo, cit., p. 949.Va peraltro rilevata la contraddizione in cui cade detto A., che prima dell’introdu-zione dell’art. 6 l. n. 205/2000 sosteneva l’infondatezza dell’opinione della giurispru-denza e rilevava invece l’assoluta disponibilità dei diritti soggettivi rientranti nella giu-risdizione esclusiva del giudice amministrativo e poi afferma che la clausola contrat-tuale nel previgente sistema sarebbe stata «contraria a norme imperative»: v. Caia,Arbitrati e modelli arbitrali nel diritto amministrativo, cit., p. 211.
In senso analogo sostengono la portata innovativa della disposizione: Carac-ciolo La Grotteria, Profili dell’arbitrato nel diritto amministrativo, in Dir. proc.amm., 2007, p. 733; Vaccarella M., Arbitrato e giurisdizione amministrativa, cit., p.102 ss.; Zito, La compromettibilità per arbitri con la pubblica amministrazione dopo lal. n. 205 del 2000: problemi e prospettive, in Dir. amm., 2001, p. 343 ss., spec. p. 348;Antonioli, Arbitrato e giurisdizione amministrativa dopo la l. n. 205 del 2000, cit., p.336; v. anche Mignone, Arbitrato nelle controversie devolute al giudice amministra-tivo e riparto della giurisdizione, in Foro amm.-T.a.r., 2003, p. 2516, il quale addiritturala configura come una norma di convalida della tesi prevalente in giurisprudenza:«l’art. 6, comma 2, tuttavia, nello stesso tempo supera tale tesi, disponendo che, per ilfuturo, siano arbitrabili anche le controversie su diritti soggettivi attribuiti alla giuri-sdizione amministrativa».
PARTE V - SEZ. IV - ARBITRATO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE522
una norma di diritto sostanziale e, più precisamente, di diritto contrat-tuale.
Essa infatti acconsente alla stipulazione di convenzioni d’arbitratosu oggetti che prima ne erano esclusi: non avendo carattere proces-suale, alla disposizione si sarebbe dovuta applicare non la normativain tema di successione di leggi processuali, ma di quelle che regolanola successione di norme di diritto contrattuale.
La natura contrattuale dell’arbitrato avrebbe in definitiva impeditoche l’art. 6 l. n. 205/2000 potesse rendere ammissibili e procedibili gliarbitrati in corso, promossi in un’epoca in cui la giurisdizione ammini-strativa non era in tal modo derogabile: «non si può cioè applicare ilprincipio processuale per cui nel giudizio iniziato dinanzi ad un giu-dice che difetta di giurisdizione, quest’ultimo applicherà la normasopravvenuta e potrà decidere la controversia, se la giurisdizione siastata a lui attribuita dalla nuova (sopravvenuta) disposizione di carat-tere processuale» (44).
Né, si è sostenuto, l’art. 6 l. n. 205/2000 avrebbe avuto i caratteridi disposizione di interpretazione autentica, né portata abrogativadella normativa precedente, ciò che avrebbe consentito di ritenere ilprincipio in essa recato applicabile anche per il passato (45).
Sennonché l’orientamento è stato superato da un più recente indi-rizzo della Suprema Corte che ha sostenuto l’applicazione dell’art. 6
(44) V. Caia, Gli arbitrati e la giurisdizione del giudice amministrativo, cit., p. 950.In giurisprudenza, v. Cass., sez. un., 10 dicembre 2001, n. 15608, in Foro it., 2002, I,c. 1738 ss.: «Alla verifica della validità del patto compromissorio vanno applicati iprincipî in materia di successione delle norme nel tempo proprie dei contratti, di talche tale verifica deve essere effettuata in riferimento alle norme vigenti al momentodella perfezione del patto, salvo che la norma sopravvenuta non rechi espressa previ-sione circa la sua applicazione retroattiva (nella specie, si chiarisce che l’art. 6, 2o
comma, l. 205/00, il quale ora ammette la compromettibilità ad arbitri delle contro-versie attinenti a diritti devolute al giudice amministrativo, non contiene una clausoladi retroattività, sicché non realizza alcuna sanatoria dell’originaria invalidità dellaclausola compromissoria che, nel regime precedente, prevedeva la compromettibilitàad arbitri di quelle medesime controversie)».
(45) V. Caracciolo La Grotteria, Profili dell’arbitrato nel diritto amministra-tivo, cit., p. 733. Se pare difficile questionare di efficacia abrogativa del sistema prece-dente, dal momento che un sistema non v’era, la natura di legge di interpretazioneautentica – che l’A. esclude senza addurre precise ragioni – sembrerebbe costituireinvece, come si vedrà, la reale portata della disposizione.
CAP. UNICO - L’ARBITRATO NEL DIRITTO AMMINISTRATIVO 523
anche agli arbitrati precedentemente iniziati. Le Sezioni Unite (46),pur ribadendo la portata innovativa della disposizione e la consequen-ziale irretroattività della norma, hanno ritenuto che ciò, in mancanzadi disposizione contraria, non valga ad «ad escluderne l’operativitànelle cause pendenti, ove sia in discussione dinanzi al giudice ordina-rio la validità del lodo, con cui sia stato negato ingresso al giudizioarbitrale sul rilievo dell’inerenza del dibattito a diritti tutelabilidinanzi al giudice amministrativo e della connessa invalidità del com-promesso (o della clausola compromissoria) in base alla legge deltempo della sua stipulazione (art. 806 c.p.c.)».
Al riguardo, opinano le Sezioni Unite, «è da considerarsi che laquestione della validità o meno del compromesso, in dipendenza delladevoluzione della domanda alla cognizione del giudice ordinarioovvero del giudice amministrativo, viene sostanzialmente a coincidere,e comunque è strettamente connessa, con la questione di giurisdi-zione, di modo che non può non risentire del mutamento in propositodel quadro normativo, tenendosi anche conto che lo ius superveniensincide sulla sussistenza del potere-dovere della corte d’appello (giudi-ce ordinario), ove accolga l’impugnazione per nullità del lodo, di sta-tuire sul merito, ai sensi ed in presenza delle condizioni dell’art. 830,comma 2, c.p.c.».
Quindi, «la legge sopraggiunta, per il tramite dell’allargamento deiconfini dell’arbitrato, amplia pure la sfera della cognizione del giudiceordinario cui è affidata l’impugnazione del lodo, e, quindi, ricade nellaregola dell’influenza dell’innovazione normativa che attribuisca lacausa al giudice davanti al quale sia già in corso o debba essere ripresao riattivata».
Le Sezioni Unite così facendo sostanzialmente aggirano il pro-blema della retroattività o meno della disposizione dell’art. 6 l. n. 205/2000 e della sua applicabilità alle convenzioni d’arbitrato concluseprecedentemente alla sua entrata in vigore.
Nondimeno, con un’argomentazione senza dubbio poco coerente
(46) V. Cass., sez. un., 12 luglio 2005, n. 14545, in Foro amm.-Cons. Stato, 2006,p. 403 ss., con nota di Antonioli, Arbitrato e giurisdizione esclusiva: luci e ombre intema di ius superveniens. Nello stesso senso, v. anche Cass., sez. un., 14 novembre2005, n. 22903, in Rep. Foro it., 2005, voce Opere pubbliche, n. 657.
PARTE V - SEZ. IV - ARBITRATO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE524
sul piano sistematico (ancorché efficace), hanno ritenuto sussistente lagiurisdizione della corte d’appello dal momento che – di fatto – lanuova norma avrebbe avuto l’effetto di attribuirle, seppur in sede diimpugnazione del lodo, la giurisdizione che prima non aveva (47).
L’incoerenza della soluzione prospettata dalla Suprema Corte èpalese: la convenzione d’arbitrato è invalida, nondimeno la corte d’ap-pello, ove venga investita della impugnazione del lodo in cui gli arbitrisi affermano privi di potestas judicandi, dovrà decidere nel merito per-ché l’art. 6 l. n. 205/2000, «determinando la compromettibilità dellalite per il mero fatto della sua inerenza a diritti soggettivi (ancorchésussista giurisdizione esclusiva)», ha avuto l’effetto di attribuirle lagiurisdizione sull’impugnazione, della quale prima era priva. Edallora, dichiarata la nullità del lodo per nullità del patto compromisso-rio, dovrà giudicare nel merito, in spregio alla volontà compromissoriadelle parti, e privando loro di un grado di giurisdizione (48).
In realtà, a sommesso avviso di chi scrive, ragioni di coerenza siste-matica escludono già in thesi che la questione di diritto intertemporaleabbia ragione di porsi. Seppure il legislatore avrebbe potuto meditareassai meglio il testo della disposizione in parola, non può negarsi che
(47) Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale il principio dellaperpetuatio iurisdictionis di cui all’art. 5 c.p.c. non si applica nel caso in cui la giurisdi-zione o la competenza, insussistenti al momento della proposizione della domanda,sopravvengano nel corso del processo. Ciò significa che il giudizio proposto davanti aun giudice privo di competenza o di giurisdizione, prosegue validamente, qualora ilgiudice stesso divenga competente o munito di giurisdizione, per effetto del modifi-carsi della situazione di fatto o di diritto (si parla, al riguardo, di regola della giurisdi-zione o della competenza sopravvenuta): v. in tal senso ex multis, Cass. 17 gennaio2008, n. 857, in Giust. civ., 2010, I, p. 209 ss.; T.a.r. Piemonte 22 maggio 2007, inForo amm.-T.a.r., 2007, p. 1517; Cass. 20 settembre 2006, n. 20322, in Dir. e giust.,2006, fasc. 38, p. 21 ss.; T.a.r. Lazio, sez. Latina, 11 maggio 2006, in Foro amm.-T.a.r.,2006, p. 1774; Cass., sez. un., 28 novembre 2005, n. 25031, in Rep. Foro it., 2005,voce Tributi in genere, n. 1166; Cass., sez. un., 14 novembre 2005, n. 22903, cit.
(48) Critico nei confronti della pronuncia è Antonioli, Arbitrato e giurisdizioneesclusiva: problemi e prospettive, in Dir. proc. amm., 2007, p. 685 ss., ove rileva che latesi della Cassazione è in disarmonia con l’affermazione secondo cui il rapporto traarbitri e giurisdizione sarebbe di radicale alterità e antinomia, per cui l’accertamentodella validità dell’accordo compromissorio sarebbe da considerarsi una questione dimerito; ciò che impedirebbe altresì l’applicazione dell’art. 5 c.p.c. V. Cass. 21 luglio2004, n. 251, in Riv. dir. proc., 2005, p. 250 ss., con nota critica di Capponi, Arbitratoe perpetuatio jurisdictionis.
CAP. UNICO - L’ARBITRATO NEL DIRITTO AMMINISTRATIVO 525
questa abbia proprio la natura di disposizione interpretativa. Essasemplicemente accoglie le censure con cui la dottrina aveva bersa-gliato l’indirizzo della giurisprudenza, rendendo esplicito – con unadisposizione appunto «interpretativa» – quello che prima avrebbedovuto desumersi dalla sola disponibilità della situazione giuridicasoggettiva controversa (49).
(49) Così T.a.r. Veneto 1o marzo 2003, in Trib. amm. reg., 2003, I, p. 81. Secondoil T.a.r. veneziano, prima di ogni altra cosa, la norma che attribuisce la giurisdizionead un giudice che prima ne era privo non può che avere efficacia ex tunc: «comesegnalato dalla giurisprudenza, la nullità della clausola compromissoria che derividalla violazione di una norma imperativa sulla giurisdizione e non da vizi intrinsecidell’atto negoziale deve ritenersi sanata ex tunc dalla sopravvenienza di una disposi-zione legislativa (nella specie si trattava dell’art. 31 bis della legge 109/1994 ma il prin-cipio appare trasponibile all’art. 6, comma 2o, della legge 205/2000) che modificandola disciplina anteriore preveda la competenza giurisdizionale dell’autorità giudiziariadavanti alla quale sia pendente il processo (cfr. sul punto Cass., sez. un., 3 aprile 2000,n. 88; idem 10 agosto 1999, n. 580), ciò è vero a fortiori qualora di tratti di norma chestabilisce la compromettibilità in arbitri di controversie già rientranti nella giurisdi-zione del giudice adìto».
Nondimeno, fermo restando ciò, la risma della disposizione va cercata altrove:«inoltre va rilevato che lo scopo perseguito dal legislatore con l’art. 6, comma 2, dellalegge n. 205/00 è quello di interpretare autenticamente le norme precedenti sui pre-supposti del giudizio arbitrale e in particolare l’art. 806 c.p.c., nella parte in cuiesclude dalle controversie che le parti possono far decidere dagli arbitri anche “lealtre che non possono formare oggetto di transazione” in relazione all’art. 1966comma 2 c.c., secondo cui “la transazione è nulla se tali diritti, per loro natura o perespressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti”».
E pertanto «va riconosciuto carattere interpretativo alla legge che, fermo il tenoretestuale della norma interpretata, ne chiarisce il significato normativo ovvero privile-gia una delle tante interpretazioni possibili, di guisa che il contenuto precettivo èespresso dalla coesistenza delle due norme (quella precedente e l’altra successiva chene esplicita il significato) (Corte cost. sentt. n. 155 del 1990 e n. 233 del 1988)»; inol-tre, «sulla natura interpretativa della disposizione, diretta a risolvere tale antinomia,depongono anche i lavori parlamentari, dai quali si evince che l’attuale formulazionedella disposizione trae origine da un emendamento 5.8, il cui presentatore (on.Acquarone) così ne chiariva la predetta natura interpretativa nella seduta del 21marzo 2000 della II Commissione della Camera: «“(...)questo è stato presentato al finedi ribadire in un atto normativo di grado primario l’interpretazione della dottrinasecondo cui la natura della posizione soggettiva vantata deve essere assunta come cri-terio di ammissibilità della procedura arbitrale. Nel caso in esame, pertanto, la dispo-nibilità del diritto soggettivo da parte del titolare legittimerebbe la facoltà attribuita acostui di scegliere lo strumento giurisdizionale diretto a risolvere quelle controversieche vedano coinvolta quella posizione soggettiva. La Corte di cassazione ha inveceaffermato più volte che tale criterio deve essere individuato in riferimento alla natura
PARTE V - SEZ. IV - ARBITRATO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE526
Il legislatore non ha voluto ampliare l’ambito della compromettibi-lità, ma ha esplicitamente riaffermato un principio di cui la dottrinapiù avveduta non aveva mai avuto ragione di dubitare, insieme a piùrisalenti e condivisibili opinioni della Suprema Corte: l’arbitrato trovalimite solamente nella disponibilità della situazione giuridica sogget-tiva cui la lite si riferisce e non gli sono di ostacolo norme che preve-dono giurisdizioni speciali né procedimenti differenziati. E ciò a pre-scindere da un espresso riconoscimento legislativo; riconoscimentoche, nella fattispecie, ha avuto il solo scopo di porre rimedio ad undiuturno e ostinato orientamento della giurisprudenza, tramite unadisposizione meramente interpretativa.
Semmai alla norma si potrebbe riconoscere una portata fortementerestrittiva dell’ambito della compromettibilità, se veramente il riferi-
del giudice, alla cui giurisdizione è attribuita la competenza della materia oggettodella controversia. Secondo tali tesi, nel caso in cui sia devoluta alla giurisdizioneesclusiva del giudice amministrativo la competenza di materie attinenti a diritti sog-gettivi sarebbe precluso il ricorso alla procedura arbitrale, salvo che la legge non loconsenta espressamente, come ad esempio nel caso degli appalti pubblici. L’emenda-mento in esame è pertanto diretto a superare tale interpretazione giurisprudenziale,che tra l’altro determina una disparità di trattamento tra situazioni uguali, quali quellerelative alle controversie in materia di appalti pubblici, per le quali è ammesso il com-promesso arbitrale, e quelle relative alle concessioni, in quanto per queste ultime nonè prevista alcuna disposizione legislativa di tenore simile a quella vigente per gli appal-ti”».
In dottrina, v. Consolo, Sul «campo» dissodato della compromettibilità per arbi-tri, cit., p. 250; Verde, Nuove riflessioni su arbitrato e pubblica amministrazione, cit.,p. 700, il quale, oltre a ciò, afferma che, anche ove non si ritenesse decisivo l’argo-mento nel testo, l’art. 6 l. n. 205/2000 avrebbe rimosso il presunto e non dimostratodivieto di patti in deroga alla giurisdizione con una disposizione dal contenuto pro-cessuale, così che, «fossero o non valide le convenzioni d’arbitrato anteriori, la nuovadisposizione ha avallato la scelta del giudice arbitrale operata dalle parti, non diversa-mente da ciò che avverrebbe se, adito un giudice originariamente sfornito di giurisdi-zione, sopravvenisse una legge che gliela riconoscesse»; Delsignore, La comprometti-bilità in arbitrato nel diritto amministrativo, cit., p. 249 ss., la quale peraltro ritiene diindividuare un ulteriore motivo a sostegno della validità delle clausole in virtù dell’ef-ficacia sanante che all’art. 6 l. n. 205/2000 dovrebbe attribuirsi argomentando intornoad un orientamento della Cassazione che ha ritenuto sanate le clausole compromisso-rie al momento della loro stipulazione nulle in quanto inerenti controversie in materiadi giurisdizione esclusiva, nel caso di sopravvenienza di una norma che attribuiva lagiurisdizione al giudice ordinario (Cass., sez. un., 3 aprile 2000, n. 88, in Foro it. 2001,I, c. 206 ss.).
CAP. UNICO - L’ARBITRATO NEL DIRITTO AMMINISTRATIVO 527
mento ai soli diritti sarebbe da interpretarsi nel senso di escludere gliinteressi legittimi dal novero delle controversie arbitrabili, e il riferi-mento all’arbitrato «rituale di diritto» serva ad escludere la possibilitàdi compromettere in arbitrato irrituale o di equità (50).
Gli istituti e le situazioni giuridiche soggettive nascono per daresoddisfazione agli interessi che il legislatore ritiene di tutelare, maneanche l’onnipotenza del legislatore può mutarne la natura: al con-trario, la qualificazione degli istituti discende necessariamente dallaloro natura sostanziale. Dalla natura sostanziale degli istituti giuridicie delle situazioni giuridiche soggettive discendono naturaliter le conse-guenze che la legge gli riconosce e si dipartono le loro potenzialità. Seuna situazione giuridica soggettiva è naturalmente disponibile, la com-promettibilità per arbitri discende dalla sua natura, a meno che lalegge espressamente non la privi della disponibilità o della possibilitàdi ricorrere all’arbitrato (51). Certamente, se «purtroppo – o fortunata-mente – non spetta al legislatore determinare la natura di un istitu-to» (52), a maggior ragione il solo fatto che la legge attribuisca la giuri-sdizione su diritti ad un giudice speciale non può anche incidere sullanatura dei diritti medesimi, con l’esito di renderli indisponibili, né suimetodi per risolvere le controversie che li riguardano.
Visto l’atteggiamento di chiusura della giurisprudenza, il legisla-tore, per riportare rigore sistematico alla materia, ha semplicementevoluto rendere espresso ciò che avrebbe dovuto darsi per implicito.
4. – L’effettivo ambito della compromettibilità alla luce del codice delprocesso amministrativo, in particolare il problema della pregiudiziale
(50) In senso analogo, v. Verde, Le azioni risarcitorie dopo la decisione n. 204/2004 della corte costituzionale e l’arbitrato, in Corr. giur., 2004, p. 1675; Polinari,Limiti alla compromettibilità per arbitrato irrituale delle controversie con la pubblicaamministrazione, in Riv. dir. proc., 2010, p. 218 ss.
(51) Si pensi ai diritti naturalmente disponibili ma resi indisponibili per legge (suiquali v. ampiamente Delsignore, La compromettibilità in arbitrato, cit., p. 91 ss.),ovvero ai diritti disponibili rispetto ai quali l’arbitrato è vietato espressamente dallalegge (come consente il nuovo art. 806 c.p.c. e come è avvenuto con la recente aboli-zione dell’arbitrato come strumento di soluzione delle controversie nei contratti pub-blici).
(52) Così Satta, Commentario, IV, 2, cit., p. 163, il quale aggiunge: «anche se diquello che egli fa si deve, sul piano positivo, tenere conto».
PARTE V - SEZ. IV - ARBITRATO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE528
amministrativa. – Altra questione – di carattere eminentemente pra-tico – è quella relativa all’effettivo ambito di compromettibilità deidiritti rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo alla lucedel nuovo codice del processo amministrativo e dei recenti orienta-menti giurisprudenziali.
Sul punto, una delle poche innovazioni del nuovo codice del pro-cesso amministrativo in fatto di arbitrato consiste – oltre che nell’averespressamente previsto la possibilità del ricorso per ottemperanza deilodi arbitrali (art. 112, comma 2o, lett. e), c.p.a.) – nell’aver indivi-duato un elenco tendenzialmente esaustivo delle materie rientrantinella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Occorrerà,pertanto, scorrere l’elenco riportato dall’art. 133 c.p.a. per verificarein concreto quali, tra le controversie elencate, si prestino ad esserecompromesse per arbitri.
L’ambito della arbitrabilità, peraltro, non sembra debba necessa-riamente coincidere con l’elenco dell’art. 133 c.p.a.; l’art. 12 c.p.a.,infatti, fa riferimento alla «giurisdizione» del giudice amministrativotout court e non alla sola «giurisdizione esclusiva». Va inoltre osser-vato che nell’elenco di cui all’art. 133 c.p.a. non rientra il risarcimentodel danno causato dall’azione amministrativa illegittima (53).
Come noto, il terzo comma dell’art. 30 c.p.a. sembra aver definiti-vamente sancito la fine del mito della pregiudiziale amministrativa. Laformulazione della disposizione schiude la possibilità di proporreinnanzi agli arbitri l’azione risarcitoria per lesione di interessi legittimientro «il termine di decadenza di centoventi giorni decorrenti dalgiorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provve-dimento se il danno deriva direttamente da questo».
Prima del nuovo codice si era osservato – prestando adesione allaregola della pregiudizialità – che l’art. 6 l. n. 205/2000 «finisce col per-dere valore precettivo, posto che, sia nel caso di c.d. lesione di inte-ressi legittimi sia nel caso di violazione di diritti soggettivi (pregiudica-
(53) In ciò dovendosi vedere l’intenzione degli estensori del codice di considerarel’azione risarcitoria quale forma di tutela ulteriore dell’interesse legittimo, accantoall’azione costitutiva e di accertamento. Così Del Signore, Rapporti tra giudizioamministrativo e arbitrato, in Aa.Vv., Il nuovo processo amministrativo, diretto daCaranta, Bologna, 2011, p. 178.
CAP. UNICO - L’ARBITRATO NEL DIRITTO AMMINISTRATIVO 529
ti, però, dal provvedimento amministrativo illegittimo), l’azionedavanti al giudice statale non è imposta, ma solamente resa possibile;e, perciò, ammettere l’arbitrato solamente dopo che il giudice ammini-strativo ha deciso la controversia amministrativa finisce con lo ‘sfon-dare una porta aperta’, non potendosi escludere, in base ai normaliprincipi, tale facoltà delle parti» (54).
Inoltre, se gli arbitri potevano conoscere della questione risarcito-ria solo dopo la pronuncia (passata in giudicato) di annullamento del-l’atto illegittimo da parte del giudice amministrativo (perché primasemplicemente non esiste il diritto al risarcimento), e rientrava tra ipoteri di quest’ultimo disporla (art. 7 l. n. 1034/1971), l’arbitratofiniva con l’essere quantomeno «antieconomico» (55): perché le partidovrebbero voler compromettere in arbitri la sola vicenda risarcitoria,iniziare con una nuova istruttoria e pagare gli arbitri, quando la que-stione può essere risolta dal giudice che, per avere conosciuto dellaquestione pregiudiziale, già ha piena contezza dei fatti di causa (56)?
Il nuovo sistema sembra invece aprire spazi alla possibilità di com-promettere per arbitri la sola questione risarcitoria, passando per l’ac-certamento (solo) incidentale della legittimità dell’atto amministrati-vo (57), purché la domanda d’arbitrato sia notificata entro il termine didecadenza previsto dall’art. 30 c.p.a. (58).
(54) V. Verde, Le azioni risarcitorie dopo la decisione n. 204/2004 della corte costi-tuzionale e l’arbitrato, cit., p. 1765: anzi, «per paradosso, l’art. 6 cit. finirebbe col pre-vedere una limitazione – la necessità dell’arbitrato rituale di diritto – che non trove-rebbe un’adeguata giustificazione, essendo la controversia compromettibile una nor-male controversia patrimoniale da cui è stata ormai espunta, per forza di cose,l’amministrazione-autorità».
(55) Ma non per questo si può ritenere che sia «evidente che, in tal caso, l’arbi-trato non avrebbe senso in quanto la soluzione arbitrale è, per sua natura, funzionalead una definizione rapida delle controversie»: v. Stevanato, Arbitrato e deroga al giu-dizio amministrativo, in Dir. proc. amm., 2004, p. 122 ss., spec. p. 130. Occorrerebbeinfatti dimostrare prima che l’arbitrato, per sua natura, sia funzionale alla risoluzionerapida delle liti.
(56) Così, anche se riferendosi ad un contesto in parte diverso, Vitale, L’assoluti-smo del Consiglio di Stato in tema di arbitrato e P.A., in Riv. arb., 2003, p. 738.
(57) V. Del Signore, op. ult. cit.(58) V., peraltro, la recente decisione resa da Cons. Stato, ad. plen., 23 marzo
2011, n. 3, che offre una lettura dell’art. 30 c.p.a. alla luce dell’art. 1227 c.c., che avràl’effetto di limitare notevolmente il (già limitato) ambito che, all’alba dell’entrata in
PARTE V - SEZ. IV - ARBITRATO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE530
5. – La compromettibilità delle situazioni giuridiche soggettive didiritto pubblico. – Passando alle controversie aventi ad oggetto situa-zioni giuridiche soggettive di diritto pubblico, un tentativo di ricostru-zione del fenomeno che sia «sistematico» impone, prima di ogni altracosa, una larga premessa circa le categorie dogmatiche dalle qualinascono o nelle quali vanno ad inserirsi le situazioni giuridiche sogget-tive coinvolte. Ciò specie con riferimento a questioni «limite» comequella che ne occupa, che hanno una portata di fatto solo teorica,visto l’atteggiamento di forte chiusura che oggi mostrano giurispru-denza e dottrina.
I problemi da affrontare sono essenzialmente due: a) la disponibi-lità, ai sensi dell’art. 806 c.p.c., del potere amministrativo e dell’inte-resse legittimo: b) il potere degli arbitri di incidere sui provvedimentiamministrativi, pronunziandone l’annullamento, ovvero di condan-nare l’amministrazione alla adozione di un provvedimento.
Perché infatti le situazioni giuridiche soggettive di diritto pubblicopossano essere oggetto di compromesso occorre, ai sensi dell’art. 806c.p.c., che siano disponibili, mentre il ricorso all’arbitrato su dettesituazioni non consentirebbe una tutela «effettiva» dell’interesse legit-timo del provato se agli arbitri fosse preclusa la possibilità di incideresulla manifestazione del potere amministrativo – ossia sul provvedi-mento amministrativo – o di imporre all’amministrazione di provve-dere quando ne accertino l’obbligo secondo la legge.
6. – La disponibilità del potere amministrativo e suoi limiti. – Tradi-zionalmente, la dottrina, soprattutto quella anteriore alla l. n. 241/
vigore del codice, sembrava potersi riconoscere all’arbitrato in subjecta materia: «ladisciplina recata dal nuovo codice del processo amministrativo (in specie, dagli artt.30, comma 3, e 124), pur negando la sussistenza di una pregiudizialità di rito, dimo-stra di apprezzare, sul versante sostanziale, la rilevanza eziologica dell’omessa impu-gnazione come fatto valutabile al fine di escludere la risarcibilità dei danni che,secondo un giudizio causale di tipo ipotetico, sarebbero stati presumibilmente evitatiin caso di tempestiva reazione processuale nei confronti del provvedimento potenzial-mente dannoso. Peraltro, l’ipotetica incidenza eziologica non è propria soltanto dellamancata impugnazione del provvedimento dannoso, ma riguarda anche l’omessa atti-vazione di altri rimedi potenzialmente idonei ad evitare il danno, quali la via deiricorsi amministrativi e l’assunzione di atti di iniziativa finalizzati alla stimolazione del-l’autotutela amministrativa (cd. invito all’autotutela)».
CAP. UNICO - L’ARBITRATO NEL DIRITTO AMMINISTRATIVO 531
1990, ha riferito l’indisponibilità del potere amministrativo, senzaperaltro fornire una qualsivoglia motivazione a questo assunto quasidogmatico (59).
Il potere amministrativo è unilaterale (60), attribuito dalla legge allepubbliche amministrazioni in casi tassativi e tipici (61) per la tutela e ilperseguimento dell’interesse pubblico.
Proprio perché attribuito in vista di uno scopo, se ne inferisce chedetto potere sia «vincolato» e «doveroso», ossia vincolato alla soddi-sfazione dell’interesse pubblico quando e se viene esercitato, e dove-roso nel senso che, laddove ne ricorrano i presupposti, l’amministra-zione ha l’obbligo di esercitarlo (62).
Ne deriva che l’interesse pubblico condiziona doppiamente ilpotere amministrativo: questo è conferito all’amministrazione dallalegge «solo» per la soddisfazione dell’interesse pubblico, e può (edeve) essere esercitato «solo» per la soddisfazione dell’interesse pub-blico.
Corollario necessario di queste affermazioni è che l’attribuzionedel potere – ossia la funzione amministrativa intesa come soddisfa-zione dell’interesse pubblico – è per l’amministrazione indisponibi-le (63). Il potere è attribuito per il perseguimento di interessi che nonsono «dell’amministrazione», ma ne costituiscono il fine istituzionale:in questo caso nemmeno si può parlare di interessi coincidenti e con-correnti con quelli dell’amministrazione, dal momento che nemmenoviene in rilievo un interesse «proprio» della struttura amministrativa;questa infatti è stata creata e si giustifica solo per l’esigenza di soddi-sfare il pubblico interesse tramite l’esercizio del potere.
(59) V. Caia, Arbitrati e modelli arbitrali nel diritto amministrativo, cit., p. 199;Id., Materie compromettibili in arbitrato con la pubblica amministrazione, in Aa.Vv.,Arbitrato e pubblica amministrazione, cit., 1999, p. 18; De Lise, L’arbitrato nel dirittoamministrativo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1991, p. 1196.
(60) Ossia di fonte non contrattuale: Corso, Manuale di diritto amministrativo3,Torino, 2010, p. 140.
(61) V. Corso, L’attività amministrativa, Torino, 1999, p. 122.(62) V. ancora Corso, Manuale di diritto amministrativo3, cit., p. 140 ss.(63) Così De Lise-Delfino, Arbitrato e pubblica amministrazione, in Arch. giur.
oo. pp., 2000, p. 2053; De Lise, L’arbitrato nel diritto amministrativo, cit., p. 1196;Goisis, La giustizia sportiva tra funzione amministrativa ed arbitrato, Milano, 2007, p.261 s.; Verde, Nuove riflessioni su arbitrato e pubblica amministrazione, cit., p. 698.
PARTE V - SEZ. IV - ARBITRATO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE532
In altre parole, l’amministrazione non può certamente vincolarsiverso i privati spogliandosi del potere, obbligandosi cioè a non farneuso per il futuro o attribuendolo ad un altro soggetto (64): da un lato,violerebbe la legge; dall’altro, verrebbero meno i presupposti stessidella sua istituzione sul piano dell’organizzazione (65).
La presenza dell’interesse pubblico e la necessità della sua soddi-sfazione, «causa» del potere amministrativo (66), lo configurano – dalpunto di vista dell’attribuzione – come assolutamente indisponibile,dal momento che è proprio quella attribuzione di potere a giustificarel’esistenza dell’amministrazione.
Ciò posto, occorre verificare se, una volta che il potere è statoattribuito all’amministrazione, anche il suo concreto esercizio sia indi-sponibile.
La legge si limita ad individuare l’interesse pubblico da perseguiree soddisfare e ad attribuire il potere relativo, ma la determinazionedegli atti concreti per l’attuazione dell’interesse pubblico è rimessaall’amministrazione.
Salvo che la legge stessa preveda analiticamente ogni momentodella concretizzazione, per modo che l’amministrazione ha il solocompito di chiudere un sillogismo perfetto (67), l’attività di persegui-
(64) V. Goisis, op. loc. ult. cit.; Chirulli-Stella Richter, voce Transazione(diritto amministrativo), in Enc. dir., XLIV, Milano, 1992, p. 870.
(65) La norma che attribuisce il potere è infatti norma di organizzazione: v.Nigro, Giustizia amministrativa6, Bologna, 2002, p. 99.
(66) V. Greco, Accordi amministrativi. Tra provvedimento e contratto, Torino,2004, pp. 118, 144.
(67) Nel qual caso si ha attività vincolata, che taluno ritiene estranea addiritturaall’attività amministrativa propriamente detta (Corso, Manuale di diritto amministra-tivo3, cit., p. 147 s.), dal cui esercizio deriverebbero posizioni di diritto soggettivo enon già di interesse legittimo. Sarebbe corretto parlare di potere solamente se l’ammi-nistrazione nell’agire debba compiere una scelta quanto all’assetto degli interessi ingioco; viceversa quando è esclusa ogni possibilità di scelta in relazione a ciascunodegli aspetti del provvedere ma siano riscontrabili solamente posizioni di obbligo, l’at-tività dell’amministrazione diverrebbe meramente esecutiva di quanto già deciso dallalegge. In tal senso, v. Capaccioli, Manuale di diritto amministrativo, Padova, 1980, p.279; Orsi Battaglini, Attività vincolata e situazioni soggettive, in Aa.Vv., Studi inricordo di Enzo Capaccioli, Milano, 1988, p. 267.
In senso contrario, altri ha peraltro osservato che da un lato anche l’attività vinco-lata presuppone comunque margini valutativi, quantomeno relativamente ai presup-
CAP. UNICO - L’ARBITRATO NEL DIRITTO AMMINISTRATIVO 533
mento dell’interesse pubblico in concreto è discrezionale, ossia l’am-ministrazione è lasciata libera di scegliere tra diverse modalità diazione, quella che ritiene più opportuna.
Ebbene, ferma restando l’indisponibilità dell’interesse pubbli-co (68) e della attribuzione del potere in astratto, che afferiscono avalutazioni di esclusiva competenza del legislatore, le concrete moda-lità di esercizio del potere discrezionale sono invece disponibili perl’amministrazione in virtù dell’espresso riconoscimento legislativodella categoria dei «contratti di diritto pubblico» (69).
Come noto, infatti, l’art. 11 l. n. 241/1990 consente all’amministra-zione la conclusione di accordi con gli interessati per determinare ilcontenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero in sostitu-zione di questo. Detti accordi, che debbono essere stipulati periscritto sotto pena di nullità e sono soggetti ai principî del codice civilein materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili, non pos-sono pregiudicare l’interesse di terzi e sono soggetti alla clausola rebussic stantibus, dal momento che, «per sopravvenuti motivi di pubblico
posti (Caringella, Corso di diritto amministrativo6, Milano, 2005, II, p. 1862 ss., acui si rimanda per l’ampia giurisprudenza rassegnata), e dall’altro, in ogni caso, l’ef-fetto non deriverebbe direttamente dalla legge, ma il potere amministrativo resterebbetale ancorché predeterminato nel contenuto (Casetta, Compendio di diritto ammini-strativo8, Milano, 2008, p. 232).
Quest’ultima posizione sembra condivisa dalla giurisprudenza: Cons. Stato 10dicembre 2007, n. 6344, in Vita not., 2007, p. 1157 ss.: «anche in relazione a procedi-menti finalizzati alla adozione di provvedimenti di natura sostanzialmente vincolata,come le autorizzazioni in materia edilizia, sussistono fasi in cui l’amministrazione deveesercitare poteri discrezionali, quanto meno sotto il profilo tecnico (attinenti al quan-tum, al quomodo ed al quando degli adempimenti da eseguire); di conseguenza, anchein relazione a questi procedimenti è ammissibile la stipulazione di un accordo proce-dimentale, ai sensi dell’art. 11 l. 7 agosto 1990, n. 241, atteso che si tratta di uno stru-mento di semplificazione, idoneo a far conseguire a tutte le parti un’utilità ulteriorerispetto a quella che sarebbe consentita dal provvedimento finale».
(68) Non appare pertanto corretta l’affermazione di Antonioli, Arbitrato e giuri-sdizione esclusiva, Milano, 2004, p. 68, secondo il quale il mutato quadro normativoavrebbe reso disponibile l’interesse pubblico e non già solo il concreto esercizio delpotere.
(69) Nel senso della disponibilità del concreto esercizio del potere pubblico,ferma restando l’indisponibilità dell’attribuzione del potere, v. Verde, Nuove rifles-sioni su arbitrato e pubblica amministrazione, cit., p. 698; Romano Tassone, Giurisdi-zione amministrativa e arbitrato, in Riv. arb., 2000, p. 249 ss.
PARTE V - SEZ. IV - ARBITRATO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE534
interesse l’amministrazione recede unilateralmente dall’accordo, salvol’obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazioneagli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato». Inoltre, lapubblica amministrazione, nel concludere gli accordi, deve sempretenere in considerazione la necessità del perseguimento del pubblicointeresse (70).
La disposizione ha un’importanza fondamentale nell’economia deldiscorso che si sta affrontando perché consente di lasciar cadere ognidubbio circa la possibilità per l’amministrazione di vincolarsi nel-l’esercizio del suo potere, pur con tutti i limiti che la particolarità del-l’oggetto impone (71). Ciò significa che, qualora l’interesse pubblico
(70) Sulla figura, limitandosi alle opere monografiche, oltre già citato saggio diGreco, Accordi amministrativi, cit., passim, v. Sticchi Damiani, Attività amministra-tiva consensuale e accordi di programma, Milano, 1992, passim; Bruti Liberati, Con-senso e funzione nei contratti di diritto pubblico (tra amministrazione e privati), Milano,1996, passim; Civitarese, Contributo allo studio del principio contrattuale nell’attivitàamministrativa, Torino, 1997, passim; Fracchia, L’accordo sostitutivo, Padova, 1998,passim.
(71) Così anche Verde, Arbitrato e pubblica amministrazione, cit., 1996, p. 220:«ai nostri fini può essere sufficiente rilevare che nel settore in cui è ammessa la rile-vanza degli accordi non è più possibile dire, senza entrare in una vistosa contraddi-zione con se stessi, che le situazioni coinvolte nel contrasto e definite consensualmenterientrano nell’area dell’indisponibile giuridico». Nello stesso senso, v. anche Greco,Accordi amministrativi, cit., p. 293: «orbene, il tradizionale principio invocato in pas-sato per escludere la compromettibilità in arbitrato delle controversie in tema dipotestà-interesse legittimo è sempre stato rinvenuto nella non negoziabilità e nellacorrelativa intransigibilità del potere. Ma tale principio non può essere più fatto valereora che, con gli accordi – di cui pure gli accordi di programma sono espressione – talenegoziabilità è un dato ormai acquisito». V. ancora Goisis, La giustizia sportiva trafunzione amministrativa ed arbitrato, cit., p. 246: «più di recente, al limite dalla indi-sponibilità delle controversie pubblicistiche, si è opposto che il dettato dell’art. 11 l.241/1990 presupporrebbe la normale negoziabilità del potere amministrativo: il chedovrebbe quantomeno indirizzare verso una rimeditazione della sua supposta indi-sponibilità». Nello stesso senso, v. anche Domenichelli, Giurisdizione amministra-tiva e arbitrato: riflessioni e interrogativi, cit., p. 240; Pugliese, Potere del collegioarbitrale e provvedimenti amministrativi, cit., p. 65.
In giurisprudenza, v. T.a.r. Lazio 3 giugno 2005, in Trib. amm. reg., 2005, I, p.1779: «anzitutto, non è vero e, anzi, smentito dalla più recente formulazione dell’art.11 della l. 241/1990 – e, più in generale, degli accordi tra P.A. e privati su questioniattinenti a funzioni autoritative e non soltanto paritetiche – l’assunto attoreo secondocui non sarebbe compromettibile per arbitri la tutela di interessi legittimi. È assodatoin base ai dati testuali che, pure fuori dalla materia sportiva, l’ordinamento generale
CAP. UNICO - L’ARBITRATO NEL DIRITTO AMMINISTRATIVO 535
per il quale l’amministrazione ha avuto in attribuzione il potere possaessere pienamente perseguito secondo diverse modalità, l’amministra-zione può convenire con l’interessato una modalità determinata diesercizio del potere, vincolandosi in tal senso, e l’ordinamento ricono-scerà tale vincolo (72).
Se pertanto all’amministrazione è riconosciuta questa possibilitàsignifica che il potere amministrativo è comunque situazione giuridica
non solo non esclude, ma anzi incoraggia accordi che coinvolgono siffatte situazionisoggettive, sostituendo la volizione unilaterale della P.A. con assetti negoziati che, purse rivolti a soddisfare interessi privati, mirano comunque alla massimizzazione diquello pubblico con risultati di pari dignità ed efficacia dell’azione amministrativa dilivello pari a quanto si potrebbe ottenere con un provvedimento. Anzi, tali procedurenegoziate, già assai comuni in materia concessoria o urbanistica, trovano la loro mas-sima utilizzabilità proprio in vicende contenziose, ove la qualità degli interessi coin-volti, la vasta diffusione delle questioni e la necessità di componimenti ante causam odi risoluzione anche in via equitativa delle stesse impongono formule deflative e/oalternative alla giurisdizione, indipendentemente dal tipo di posizioni soggettive fattevalere in via di tutela».
In senso contrario, v. Chiti, voce Arbitrato, in Aa.Vv., Dizionario di diritto pub-blico, diretto da Cassese, Milano, 2006, p. 406; De Lise-Delfino, Arbitrato e pubblicaamministrazione, cit., p. 2053, secondo i quali dalle norme in questione non sarebbepossibile ricavare il principio della generale disponibilità del potere amministrativo, senon in una prospettiva evolutiva, mentre le ipotesi in cui gli accordi sono possibilisarebbero tassative e di stretta interpretazione.
(72) V. Cons. Stato 20 gennaio 2000, n. 264, in Foro amm., 2000, p. 114 ss.: «qua-lora la p.a. utilizzi lo strumento contrattuale in luogo di quello provvedimentale, aisensi della l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 11, comma 1, per determinare il contenuto diproprie determinazioni o per sostituire provvedimenti amministrativi, l’amministra-zione è vincolata al contratto, salva la possibilità dell’esercizio del recesso unilateraleper sopravvenuti motivi di pubblico interesse, giusta le indicazioni del 4 comma del-l’art. 11 l. n. 241 cit.».
Non è condivisibile quanto affermato da Delsignore, La compromettibilità inarbitrato nel diritto amministrativo, cit., p. 165, secondo la quale «perché si realizzi ladisposizione del potere, è necessario che l’amministrazione riconosca in capo ad unsoggetto terzo ed estraneo la capacità di esercitare il potere che le è attribuito». Comesi è visto supra nel testo, infatti, la disponibilità non si concreta in altro se non nelfatto che l’ordinamento riconosca e dia sanzione – vincolando il giudice – ad un deter-minato assetto di interessi che le parti si danno. Che poi detto assetto si inserisca omeno in un più ampio rapporto non aggiunge nulla alla nozione di disponibilità. Ilpotere è disponibile nel senso che l’amministrazione può vincolarsi a sue determinateesplicazioni, cosa che peraltro è la ratio degli accordi di diritto pubblico ex art. 11 l. n.241/1990. In nessun modo l’amministrazione riconosce ad altri la capacità di eserci-tare il proprio potere.
PARTE V - SEZ. IV - ARBITRATO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE536
soggettiva disponibile «in sé» (73), anche quando l’amministrazioneagisce autoritativamente, purché l’interesse pubblico – nel quale l’at-tribuzione del potere si giustifica – sia in concreto perseguito. L’am-ministrazione «può» concludere accordi, ma anche qualora nonritenga di farlo il potere resta comunque nella sua disponibilità, nelsenso che non solo ha la possibilità di determinare «per contratto»l’esercizio del suo potere per il futuro, ma anche che – una volta eser-citato il potere – può convenire con l’interessato una nuova sistema-zione dell’assetto di interessi che ha concretizzato con l’edizione delprovvedimento (74). In altre parole, una volta esercitato il potere que-sto resta nella signoria dell’amministrazione e non è preclusa la possi-bilità di revocarlo, modificarlo o integrarlo d’accordo con l’interes-sato, sempre con i limiti indicati dall’art. 11 l. n. 241/1990 (75).
Ecco allora che, per concludere, se certamente l’attribuzione perlegge del potere amministrativo è indisponibile dal momento chetrova la sua ratio nel perseguimento dell’interesse pubblico, il con-creto esercizio del potere amministrativo rientra pienamente nelladisponibilità dell’amministrazione (76), che può vincolarsi a non eser-
(73) Così anche Verde, Arbitrato e pubblica amministrazione, cit., 1996, p. 215ss.; Id., L’arbitrato e la giurisdizione ordinaria, Aa.Vv., Diritto dell’arbitrato3, a cura diVerde, cit., p. 41, il quale afferma che dove è ammessa la rilevanza degli accordi nelcorso del procedimento amministrativo, in sostituzione del provvedimento finale,ovvero al fine di determinarne il contenuto, «non è più possibile affermare che lesituazioni coinvolte nel contrasto rientrino nell’area dell’indisponibile giuridico»,almeno nei casi in cui l’interesse pubblico sia stato interamente prevalutato e nonsiano successivamente sorte situazioni che ne abbiano successivamente imposto unanuova valutazione.
(74) Non così Pugliese, Poteri del collegio arbitrale e provvedimenti amministra-tivi, cit., p. 74 ss., secondo il quale il limite della disponibilità del potere sarebbe datoproprio dal ricorso ai moduli consensuali di esercizio del potere, mentre già l’eserciziodel diritto di recesso «con la sua carica di interesse pubblico sopravvenuto farebberiemergere un provvedimento autoritativo (ormai residuale) e discrezionale, la cuisanzione di illegittimità (mediante l’annullamento) non potrebbe che passare attra-verso la valutazione del giudizio amministrativo di legittimità (rimanendo sullo sfondose si tratti o meno di giurisdizione esclusiva)».
(75) Attività ammessa anche in sede processuale: v. Romano Tassone, Giurisdi-zione amministrativa e arbitrato, cit., p. 261.
(76) V. Pugliese, Poteri del collegio arbitrale e provvedimenti amministrativi, cit.,p. 77; Greco, Contratti e accordi della pubblica amministrazione con funzione transat-tiva (appunti per un nuovo studio), in Dir. amm., 2005, § 4; Goisis, Compromettibilità
CAP. UNICO - L’ARBITRATO NEL DIRITTO AMMINISTRATIVO 537
citarlo, ad esercitarlo in un certo modo piuttosto che in un altro,ovvero in un dato momento, purché – in concreto – l’interesse pub-blico per il quale il potere era stato attribuito risulti perseguito e sod-disfatto. Ancora, non si vedono ragioni ostative ad accordi tra ammi-nistrazioni e privati per l’esercizio dei poteri di revoca, annullamentod’ufficio e convalida di provvedimenti amministrativi (artt. 21 quin-ques e 21 nonies l. n. 241/1990).
Certo il vincolo tra amministrazione e privato non può essere iden-tico ad un vincolo contrattuale tra privati: la natura del potere ammi-nistrativo e il suo scopo impongono la necessità per l’amministrazionedi perseguire il pubblico interesse, che sta fuori dell’accordo (77), eche si porrà sempre come condizione risolutiva dello stesso, che cadrànon appena l’assetto di interessi cristallizzato si rileverà – per causesopravvenute – inidoneo al suo perseguimento.
7. – La disponibilità dell’interesse legittimo. – Dopo un ampio dibat-tito che, per tutta la durata del secolo appena trascorso, ha contribuitoalla costruzione del concetto di interesse legittimo, oggi si concordanel senso di individuarne l’autentica cifra nella posizione di vantaggioche la legge riconosce al privato nei confronti dell’agire amministra-tivo in generale.
in arbitri e transigibilità delle controversie relative all’esercizio del potere amministra-tivo, in Dir. proc. amm., 2006, p. 251.
Condivisibilmente si è notato in Chirulli-Stella Richter, Transazione (dirittoamministrativo), cit., p. 870 che non è, di regola, dato, con la transazione, rinunciareall’esercizio del potere anche per il futuro, in relazione all’eventuale mutare delle cir-costanze, ovvero, addirittura, con riguardo a fattispecie diverse (seppure connesse aquella oggetto di transazione). L’amministrazione, infatti, non può spogliarsi delleproprie attribuzioni, ma solo decidere se e come esercitarle in un caso concreto, rebussic stantibus. V. anche Paolantonio, Contributo sul tema della rinuncia nel dirittoamministrativo, Napoli, 2003, p. 95: «quel che è inesauribile, oltre che irrinunciabile,è la funzione non il potere, l’idea della inesauribilità pare riferibile ad entità pura-mente oggettive, astratte dalla sfera di disponibilità del soggetto giuridico nonpotendo comunque estendersi tale attribuzione alla teorica delle situazioni giuridichesoggettive per definizione inesauribili... La funzione è correlata non certo ad unasituazione soggettiva di potere o potestà sibbene a un dovere giuridico vero e pro-prio».
(77) Non è né causa né motivo; cfr. Greco, Contratti e accordi della pubblicaamministrazione con funzione transattiva, cit., § 4.
PARTE V - SEZ. IV - ARBITRATO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE538
Posizione che gli dà la possibilità di non essere mero spettatore edestinatario del provvedimento, ma di influire sul corretto eserciziodel potere e nel perseguimento dell’interesse pubblico, vuoi parteci-pando al procedimento ed ivi esercitando i poteri previsti dalla legge,vuoi chiedendo al giudice un sindacato sul corretto esercizio delpotere mediante l’impugnazione giudiziale del provvedimento, al finedi provocarne l’espunzione dal sistema qualora ne venga accertata l’il-legittimità, ma anche provocando l’esercizio dei poteri di revoca,annullamento o convalida (78).
Si tratta, in altre parole, di una posizione di cui il privato gode finda quando all’amministrazione è dalla legge attribuito il potere e checonserva fino a quando lo stesso potere residua e può essere eserci-tato, anche in via di autotutela o di ripensamento, in caso di sopravve-nuti motivi di interesse pubblico o diversa valutazione dell’interessepubblico originario.
A far data dalla nota pronunzia delle Sezioni Unite della Cassa-zione n. 500 del 1999 (79), alla lesione dell’interesse legittimo si accom-
(78) Così Nigro, Giustizia amministrativa6, cit., p. 103, che muta e perfeziona ilsuo precedente avviso: secondo il quale l’interesse legittimo è «la posizione di vantag-gio fatta ad un soggetto dell’ordinamento in ordine ad una utilità oggetto di potereamministrativo e consistente nell’attribuzione al medesimo soggetto di poteri atti adinfluire sul corretto esercizio del potere, in modo da rendere possibile la realizzazionedella pretesa utilità». Così anche Cons. Stato, ad. plen., 23 marzo 2011, n. 3, cit., cheribadisce la definizione elaborata da Nigro: «L’interesse legittimo va, quindi, intesocome la posizione di vantaggio riservata ad un soggetto in relazione ad un bene dellavita interessato dall’esercizio del potere pubblicistico, che si compendia nell’attribu-zione a tale soggetto di poteri idonei ad influire sul corretto esercizio del potere, inmodo da rendere possibile la realizzazione o la difesa dell’interesse al bene. Anche neiriguardi della situazione di interesse legittimo, l’interesse effettivo che l’ordinamentointende proteggere è quindi sempre l’interesse ad un bene della vita che l’ordina-mento, sulla base di scelte costituzionalmente orientate confluite nel disegno codici-stico, protegge con tecniche di tutela e forme di protezione non più limitate allademolizione del provvedimento ma miranti, ove possibile, alla soddisfazione completadella pretesa sostanziale».
(79) Cass., sez. un., 22 luglio 1999, n. 500, in Foro it., 1999, I, c. 2487 ss., con notadi Palmieri-Pardolesi; in Giornale dir. amm., 1999, p. 832 ss., con nota di Tor-chia, La risarcibilità degli interessi legittimi: dalla foresta pietrificata al bosco di Bir-nam; in Urb. e app., 1999, p. 1067 ss., con nota di Protto, È crollato il muro della irri-sarcibilità delle lesioni di interessi legittimi: una svolta epocale?; in Danno e resp., 1999,p. 965 ss., con nota di Carbone V.-Monateri-Palmieri-Pardolesi-Ponzanelli-
CAP. UNICO - L’ARBITRATO NEL DIRITTO AMMINISTRATIVO 539
pagna anche il risarcimento del danno, che non avrebbe natura didiritto soggettivo, ancillare rispetto alla tutela dell’interesse legittimo,ma di momento ulteriore di tutela rispetto al mero annullamento (80).
Alla luce di ciò appare evidente la piena disponibilità dell’interesselegittimo (81).
Si tratta infatti di una posizione di vantaggio che è collegata esclu-sivamente alla salvaguardia degli interessi del titolare, che può rinun-
roppo, La Cassazione riconosce la risarcibilità degli interessi legittimi; in Corr. giur.,1999, p. 1367 ss., con note di Di Majo, Il risarcimento degli interessi «non più sololegittimi» e Mariconda V., «Si fa questione d’un diritto civile...».
(80) Pur con le forti limitazioni previste dall’art. 30 c.p.a. e di Cons. Stato, ad.plen., 23 marzo 2011, n. 3, cit.
(81) V. Goisis, La giustizia sportiva tra funzione amministrativa ed arbitrato, cit.,p. 277; Id., Compromettibilità in arbitri e transigibilità delle controversie relativeall’esercizio del potere amministrativo, cit., p. 251; Scoca, La capacità della pubblicaamministrazione di compromettere in arbitri, cit., p. 106: «non c’è dubbio che l’inte-resse legittimo sia disponibile. Il problema non è se esso sia disponibile, il problema èsemmai se sia disponibile la situazione soggettiva contrapposta all’interesse legittimo,cioè il potere dell’Amministrazione»; Caia, Arbitrati e modelli arbitrali nel dirittoamministrativo, cit., 199; Id., Materie compromettibili in arbitrato con la pubblicaamministrazione, cit.: «il limite è rappresentato dalla esistenza nelle fattispecie di unasituazione di potere amministrativo, il quale è di per sé inesauribile ed irrinunciabile»;Romano Tassone, L’arbitrato, in Aa.Vv., Il processo avanti al giudice amministrativo,commento sistematico alla l. 205/20002, Torino, 2004, pp. 525 ss., 532; Villata S.A.,Controversie di pubblico impiego, arbitrato e disapplicazione degli atti amministrativiillegittimi, in Riv. dir. proc., 2000, p. 803 s.
In senso contrario, ritiene l’interesse legittimo indisponibile in quanto collegatoall’esercizio del potere amministrativo Amorth, Annotazioni sull’arbitrato nelle con-troversie amministrative, cit., p. 2170; sempre in senso contrario, v. Laschena, voceArbitrato (arbitrato nelle controversie amministrative), in Enc. giur., II Roma, 1988, p.1, il quale afferma l’indisponibilità tout court delle posizioni di interesse legittimo,senza peraltro offrire la spiegazione alcuna.
La stessa Cassazione si è espressa ripetutamente nel senso della transigibilità del-l’interesse legittimo (inteso come diritto d’azione o comunque di ricorso) in liti «edili-zie» tra privati, perché «nessuna disposizione vieta che si possa disporre di detto inte-resse personale, e che quindi lo stesso possa essere oggetto di transazione, qualifican-dosi o come aliquid datum o aliquid retentum»: così Cass., sez. un., 22 gennaio 1982,n. 427, in Riv. giur. edilizia, 1982, I, p. 611 ss.: conformemente, v. Cass. 11 luglio1978, n. 3479, in Foro it. 1979, I, c. 820 ss.; Cass. 7 maggio 1981, n. 2979, in Rep. Foroit., 1981, voce Edilizia e urbanistica, n. 516; Cass. 2 aprile 1982, n. 2030, in Rep. Foroit., 1982, voce Transazione, n. 3; Cass., sez. un., 27 luglio 2004, n. 1409, in Giur. it.,2004, p. 2292 ss., in motivazione, che pure ritiene l’art. 6 l. n. 205/2000 preclusivodell’arbitrabilità degli interessi legittimi.
PARTE V - SEZ. IV - ARBITRATO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE540
ciarvi senza ledere l’interesse pubblico, o interessi coincidenti o con-correnti di privati. Del resto l’ordinamento riconosce e tutela l’inte-resse legittimo nell’esclusivo interesse del titolare, ben potendo l’am-ministrazione agire efficacemente anche senza riconoscere alcuna rile-vanza alle posizioni del privato. Nel sistema postunitario, infatti, lapreoccupazione maggiore del legislatore era proprio nel senso di det-tare le «guarentigie dell’amministrazione nei confronti dell’ammini-strato» (82). Considerazioni di efficienza dell’agire amministrativohanno consigliato di coinvolgere i privati (83), addirittura rendendoeccezionale l’esercizio autoritativo del potere (84), ma certo anchesenza l’intervento di questi gli scopi dell’amministrazione sarebberocomunque perseguibili.
Va peraltro segnalato che la disponibilità dell’interesse legittimo siconcreta nella possibilità di disporre di tutte le prerogative che discen-dono dalla posizione di vantaggio nella fase procedimentale e, dopoche il provvedimento è stato reso, anche nella fase successiva, finchérevoca, annullamento e convalida sono possibili.
Se pertanto il cittadino rinunciasse alle sue prerogative nel corsodel procedimento, o si obbligasse nei confronti dell’amministrazione anon impugnare un provvedimento che ritiene illegittimo o magari arinunziare al giudizio, o, ancora, favorisse la convalida del provvedi-mento, non si vedrebbero ostacoli al riconoscimento della vincolativitàdi tale accordo.
Quanto alla fase procedimentale, le possibilità di impulso e parte-
(82) La scarsa considerazione che il legislatore aveva per gli interessi legittimi èrappresentata efficacemente dalle parole di Pasquale Stanislao Mancini, pronunciatenel corso dei lavori parlamentari che hanno portato all’approvazione della legge del1865 di abolizione dei tribunali del contenzioso amministrativo: «(...) sia pure chel’autorità amministrativa abbia fallito la sua missione, che non abbia provveduto conopportunità e saggezza, sia pure che essa abbia, e forse anche senza motivi, rifiutatoad un cittadino una permissione, un vantaggio, un favore, che ogni ragione di pru-denza e di buona economia consigliasse di accordargli, sia pure che esso cittadino èstato di conseguenza ferito, e forse anche gravemente, nei propri interessi: che perciò?Che cosa ha sofferto il cittadino in tutte le ipotesi testè discorse? Semplicemente unalesione degli interessi? Ebbene che vi si rassegni».
(83) V. Gasparini Casari, Arbitrato e controversie amministrative, cit., p. 1021.(84) V. Cons. Stato 28 febbraio 2005, n. 727, in Foro amm.-Cons. Stato, 2005, p.
402.
CAP. UNICO - L’ARBITRATO NEL DIRITTO AMMINISTRATIVO 541
cipazione che sono riconosciute al privato non sembrano altro che ilcompletamento della riconosciuta possibilità dei «contratti di dirittopubblico»: se l’ordinamento riconosce all’amministrazione la possibi-lità di vincolarsi nei confronti del privato nell’esercizio del suo potere,a fortiori deve riconoscersi a quest’ultimo la possibilità di far valere isuoi interessi nel procedimento anche mediante accordi con l’ammini-strazione.
È vero poi che l’interesse legittimo trova la sua ragion d’essere nelpotere. Abbiamo visto infatti che questo sorge come posizione di van-taggio con riferimento ad un’utilità oggetto di potere amministrativo.Ma le sue relazioni col potere finiscono in questa coessenzialità; ossia,l’interesse legittimo come situazione giuridica soggettiva sorge sola-mente se è in gioco il potere amministrativo e trova il suo epilogo nel-l’esaurirsi di questo (85), ma non partecipano l’uno dell’altro.
Ossia, per il resto, si tratta di due posizioni autonome e distinteperché autonoma e distinta ne è la fonte e l’ambito di operatività.Anche se l’interesse legittimo consente al privato di incidere sulla con-creta esplicazione del potere, ciò rientra solo nelle prerogative che laposizione di interesse legittimo conferisce al titolare: significa parteci-pazione al procedimento e non partecipazione alla attribuzione delpotere (86).
Questo significa anche che l’interesse legittimo si trova in unaposizione di alterità rispetto all’interesse pubblico: certamente è possi-bile che interesse legittimo e interesse pubblico coincidano, ed anziciò avviene nella fisiologia delle cose, ma l’interesse legittimo è pursempre una posizione di vantaggio riferita ad interessi personali deltitolare, che può liberamente rinunciarvi senza che l’interesse pub-blico ne risenta (87).
(85) Si pensi ad esempio al vincolo espropriativo posto sopra un bene immobile.Fino a che perdura il vincolo sul bene il proprietario ha una posizione di interesselegittimo nei confronti dell’autorità espropriante. Ma una volta che il potere ammini-strativo sia venuto meno per qualunque ragione, e con esso il vincolo espropriativo,verrà meno anche l’interesse legittimo del proprietario.
(86) V. in proposito Greco, Contratti e accordi, cit., n. 4; nonché Giannini,Corso di diritto amministrativo, III, 2, Milano, 1967, p. 103, ove si sottolinea che lasola amministrazione è titolare del potere-dovere di perseguire l’interesse pubblico.
(87) Non appare pertanto condivisibile, perché apodittica, l’affermazione di De
PARTE V - SEZ. IV - ARBITRATO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE542
8. – Arbitrabilità delle situazioni giuridiche soggettive di diritto pub-blico. – Dopo che si è indagata la natura delle situazioni giuridichesoggettive di diritto pubblico, appaiono in concreto quali sono lepotenzialità e i limiti della loro arbitrabilità.
Si è detto sopra che la relazione tra l’interesse legittimo e il potereamministrativo è di coessenzialità, nel senso che il primo sorgequando il secondo è dalla legge attribuito all’organo amministrativoche dovrà spenderlo. Al di là di questa coessenzialità si tratta di dueposizioni autonome e distinte, perché autonoma e distinta ne è lafonte e l’ambito di operatività.
In ogni caso: se esiste l’interesse legittimo, esiste il potere ammini-strativo legittimamente dato all’amministrazione (88) e ogni lesionedell’interesse legittimo deriva da un non corretto uso (o non uso) diquel potere. Ne consegue che ogni volta che il giudice – o l’arbitro –conosce di una posizione di interesse legittimo, è anche l’uso delpotere amministrativo ad essere al centro dell’accertamento (89).
Ecco allora che le controversie relative ad interessi legittimi invol-gono necessariamente due situazioni giuridiche distinte che, ai finidell’arbitrabilità, debbono essere – e, come abbiamo visto, sono –disponibili, ciascuna per parte del suo titolare.
Ed infatti la dottrina maggioritaria, anche quando riconosce ladisponibilità dell’interesse legittimo, ritiene che le liti che lo riguar-
Lise, L’arbitrato nel diritto amministrativo, cit., p. 1196, secondo il quale gli interessilegittimi non sarebbero disponibili «stante la stretta connessione tra queste posizioni el’interesse pubblico. Manca in questo caso il requisito della disponibilità della res liti-giosa, non potendosi ritenere disponibile, dalla pubblica amministrazione o dal pri-vato, la legittimità dell’esercizio della pubblica funzione, su cui l’interesse legittimofonda la propria tutela».
(88) Se il potere non esistesse la posizione del privato sarebbe di diritto soggettivopieno.
(89) In senso analogo, v. Goisis, La giustizia sportiva tra funzione amministrativaed arbitrato, cit., p. 262: «ora, la lite con il cittadino non nasce in relazione all’astrattaattribuzione del potere. Il cittadino, tramite l’interesse legittimo, mira a salvaguardareun suo interesse relativo ad una certa concreta vicenda, e non si preoccupa (o comun-que non ha titolo di curarsi) del potere che l’amministrazione si vede attribuito perincidere su diversi e futuri episodi-beni della vita». Sul carattere «relativo» o «relazio-nale» dell’interesse legittimo, in quanto posizione soggettiva non già di tipo assoluto,ma correlata all’esercizio del potere da parte dell’amministrazione, ovvero a questo«speculare», v. Travi, Lezioni di giustizia amministrativa5, Torino, 2002, p. 52 ss.
CAP. UNICO - L’ARBITRATO NEL DIRITTO AMMINISTRATIVO 543
dano non sarebbero arbitrabili perché l’indisponibilità riguarderebbequantomeno la situazione ad esso contrapposta, vale a dire il potereamministrativo (90). Altri ritengono che proprio la coessenzialità con ilpotere amministrativo renda indisponibile anche l’interesse legitti-mo (91). Altri ancora sostengono l’indisponibilità tout court dell’inte-resse legittimo, senza peraltro offrine spiegazione alcuna della loroposizione (92).
Queste conclusioni, come si è visto supra, non possono essere con-divise. Della disponibilità dell’interesse legittimo non può infatti dubi-tarsi; lo stesso per quanto riguarda il concreto esercizio del pubblicopotere, dal momento che l’ordinamento espressamente riconosceall’amministrazione, nei limiti in cui sussistono margini di discreziona-lità, la possibilità di vincolarsi nell’esercizio del potere.
Si è sostenuto anche che l’incompromettibilità del binomio inte-resse legittimo-potere amministrativo sarebbe comunque deducibiledalla lettera dell’art. 6 l. n. 205/2000. La disposizione, infatti, espressa-
(90) Così Gasparini Casari, Arbitrato e controversie amministrative, cit., p. 1024;Caia, Arbitrati e modelli arbitrali nel diritto amministrativo, cit., p. 199; Id., Materiecompromettibili in arbitrato con la pubblica amministrazione, cit., p. 18, nota 15; Vil-lata S.A., Controversie di pubblico impiego, arbitrato e disapplicazione degli atti ammi-nistrativi illegittimi, in Riv. dir. proc., 2000, p. 803 s.; Rubino Sammartano, Dirittodell’arbitrato6, Padova, 2010, I, p. 224 ss.; De Lise, L’arbitrato nel diritto amministra-tivo, cit., p. 1196; De Lise-Delfino, Arbitrato e pubblica amministrazione, cit., p.2051 ss., i quali peraltro sottolineano la prospettiva evolutiva secondo cui al modellodi amministrazione autoritativa e unilaterale starebbe gradualmente sostituendosi unmodello consensuale e condiviso; in senso analogo, v. Chiti, Arbitrato, cit., p. 406,secondo il quale il potere amministrativo è e resta una situazione indisponibile nono-stante la legge sul procedimento e il t.u.e.l. consentano accordi sul potere; ritieneinfatti l’Autore che tali ipotesi siano tassative e di stretta interpretazione. In giurispru-denza, v. T.a.r. Lombardia 6 novembre 2002, in Trib. amm. reg., 2002, I, p. 3317.
(91) V. Amorth, Annotazioni sull’arbitrato nelle controversie amministrative, cit.,p. 2170. Questo A. ritiene che l’inarbitrabilità sia da desumere anche dalla incompati-bilità dei tempi di costituzione del collegio arbitrale con il breve termine di decadenzaper l’impugnazione dei provvedimenti amministrativi.
(92) V. Laschena, Arbitrato (arbitrato nelle controversie amministrative), cit., p.1. In giurisprudenza, v. Cons. Stato 17 giugno 2003, n. 3447, in Cons. Stato 2003, I,1359 ss., secondo la quale, semplicemente, «deve ritenersi inammissibile il deferi-mento all’arbitrato di questioni attinenti ad interessi legittimi e, cioè, a posizioni sog-gettive lese da atti autoritativi dell’Amministrazione, dal momento che trattasi disituazioni soggettive non disponibili, che non possono formare oggetto di transazione(cfr. art. 806 c.p.c.)».
PARTE V - SEZ. IV - ARBITRATO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE544
mente ammette la devoluzione in arbitrato delle sole «controversieconcernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudiceamministrativo», con ciò escludendo l’arbitrabilità degli interessi legit-timi (93).
(93) In giurisprudenza, v. Cass., sez. un., 30 novembre 2006, n. 25508, in Rep.Foro it., 2006, voce Arbitrato, n. 127, secondo cui «l’art. 6, comma secondo, dellalegge 21 luglio 2000, n. 205, prevede la possibilità che le controversie concernentidiritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo siano risoltemediante arbitrato rituale di diritto, mentre resta preclusa la compromettibilità inarbitri delle controversie su interessi legittimi (nella specie, la Suprema Corte ha con-fermato la sentenza di merito di annullamento del lodo arbitrale in materia di revi-sione delle tariffe del servizio di illuminazione elettrica delle lampade votive del cimi-tero affidato in concessione, sulla base della qualificazione – non specificatamente eadeguatamente censurata da parte del ricorrente – della posizione soggettiva dellaconcessionaria come di interesse legittimo)»; Cass., sez. un., 27 luglio 2004, n. 14090,in Rep. Foro it., 2004, voce cit., n. 97, secondo cui «l’art. 6, comma secondo, dellalegge 21 luglio 2000, n. 205, nel prevedere che le controversie concernenti diritti sog-gettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risoltemediante arbitrato rituale di diritto, è norma di stretta interpretazione, posto che l’ac-cordo delle parti, espresso nel patto compromissorio, indirettamente comporta unaderoga alla giurisdizione, avendo l’effetto di affidare al giudice ordinario, in sede diimpugnazione del lodo, la cognizione di controversie che, in assenza dell’arbitrato,sarebbero devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Stante ilcarattere eccezionale della citata norma, essa, in presenza di devoluzione al giudiceamministrativo quale titolare esclusivo della tutela giurisdizionale, è applicabile soloquando la posizione azionata abbia consistenza di diritto soggettivo, sicché non è suf-ficiente la mera idoneità della pretesa a formare oggetto di transazione. Ne consegue,pertanto, che l’art. 6, comma secondo, legge cit. non è applicabile quando la situa-zione giuridica azionata abbia natura di interesse legittimo (come in materia di revi-sione prezzi, finché non vi sia stato riconoscimento esplicito o implicito della revisionemedesima da parte della pubblica amministrazione)»; Cass. 14 novembre 2005, n.22903, cit.; per la giurisprudenza amministrativa, sostengono l’inarbitrabilità dellecontroversie in tema di interessi legittimi: Cons. Stato 13 settembre 2005, n. 4698, inForo amm.-Cons. Stato, 2005, p. 2616; Cons. Stato 28 giugno 2004, n. 4791, in Cons.Stato, 2004, I, p. 1332.
In dottrina, v. Antonioli, Arbitrato e giurisdizione esclusiva: problemi e prospet-tive, cit., p. 704 s.; Id., Arbitrato e giurisdizione esclusiva, cit., p. 70 s.; CaraccioloLa Grotteria, Profili dell’arbitrato nel diritto amministrativo, cit., p. 725 ss.; Chiti,Arbitrato, cit., p. 406; Pajno, voce Arbitrato (arbitrato nelle controversie amministrati-ve), in Enc. giur., II, Roma, 2005, p. 14; in maniera dubitativa, v. invece Romano Tas-sone, Giurisdizione amministrativa e arbitrato nella l. 205/2000, cit., p. 632 s.; Zito,La compromettibilità per arbitri con la pubblica amministrazione dopo la l. n. 205 del2000: problemi e prospettive, cit., p. 352 ss.; Zucconi Galli Fonseca, in Aa.Vv.,Riforma del diritto arbitrale, in Nuove leggi civ. comm., 2007, p. 1158 ss.
CAP. UNICO - L’ARBITRATO NEL DIRITTO AMMINISTRATIVO 545
Peraltro, come si è visto anche per l’arbitrabilità dei diritti soggettivirientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non sipuò dare soverchia importanza agli argomenti testuali agganciati ad unadisposizione qual è l’art. 6 l. n. 205/2000. La disposizione infatti – giàabbondantemente criticabile sotto altri aspetti – nasce col precipuo scopodi porre fine all’orientamento della giurisprudenza che negava l’arbitra-bilità delle controversie su diritti rientranti nella giurisdizione esclusiva;alla base della disposizione manca qualsivoglia presa di posizione di carat-tere sistematico da parte del legislatore su questioni diverse rispetto aquella che espressamente aveva di mira, ciò che del resto risulta chiara-mente proprio dall’esame dei lavori parlamentari (94).
Peraltro, altra parte della dottrina ha posto in rilievo come il citatoart. 6, se si riferisce espressamente solo alle situazioni di diritto sogget-tivo, non esclude affatto gli interessi legittimi dall’ambito delle situa-zioni compromettibili (95).
(94) V. sul punto T.a.r. Veneto 1o marzo 2003, in Trib. amm. reg., 2003, I, p. 81:«sulla natura interpretativa della disposizione, diretta a risolvere tale antinomia,depongono anche i lavori parlamentari, dai quali si evince che l’attuale formulazionedella disposizione trae origine da un emendamento 5.8, il cui presentatore (on.Acquarone) così ne chiariva la predetta natura interpretativa nella seduta del 21marzo 2000 della II Commissione della Camera: “(...) questo è stato presentato al finedi ribadire in un atto normativo di grado primario l’interpretazione della dottrinasecondo cui la natura della posizione soggettiva vantata deve essere assunta come cri-terio di ammissibilità della procedura arbitrale. Nel caso in esame, pertanto, la dispo-nibilità del diritto soggettivo da parte del titolare legittimerebbe la facoltà attribuita acostui di scegliere lo strumento giurisdizionale diretto a risolvere quelle controversieche vedano coinvolta quella posizione soggettiva. La Corte di cassazione ha inveceaffermato più volte che tale criterio deve essere individuato in riferimento alla naturadel giudice, alla cui giurisdizione è attribuita la competenza della materia oggettodella controversia. Secondo tali tesi, nel caso in cui sia devoluta alla giurisdizioneesclusiva del giudice amministrativo la competenza di materie attinenti a diritti sog-gettivi sarebbe precluso il ricorso alla procedura arbitrale, salvo che la legge non loconsenta espressamente, come ad esempio nel caso degli appalti pubblici. L’emenda-mento in esame è pertanto diretto a superare tale interpretazione giurisprudenziale,che tra l’altro determina una disparità di trattamento tra situazioni uguali, quali quellerelative alle controversie in materia di appalti pubblici, per le quali è ammesso il com-promesso arbitrale, e quelle relative alle concessioni, in quanto per queste ultime nonè prevista alcuna disposizione legislativa di tenore simile a quella vigente per gli appal-ti”».
(95) V. Lubrano, Arbitrato e pubblica amministrazione, in Aa.Vv., Studi in onoredi Carmine Punzi, II, cit., p. 492.
PARTE V - SEZ. IV - ARBITRATO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE546
Né argomenti si possono trarre dal nuovo testo dell’art. 806 c.p.c.,che pure fa riferimento ai soli «diritti», senza menzionare affatto gliinteressi legittimi. Come la dottrina ha già rilevato a proposito dell’art.1966 c.c., il riferimento ai diritti ha, anche nel codice di proceduracivile, il significato neutro di «posizione giuridica soggettiva di vantag-gio» (96).
Ora, se quanto precede è vero, la disponibilità sostanziale sia del-l’interesse legittimo che del potere amministrativo, potrebbe agevol-mente lasciar concludere per la arbitrabilità delle liti che li riguardano.Ma altri due importanti ordini di argomenti a favore della inarbitrabi-lità degli interessi legittimi e del potere amministrativo riguardano nonla loro disponibilità, ma l’ambito dei poteri degli arbitri nei confrontiproprio del potere e della sua forma di manifestazione, vale a dire ilprovvedimento.
Ossia, a prescindere da ogni considerazione circa la disponibilitàdel binomio interesse legittimo-potere amministrativo, da un lato, sinega che l’amministrazione possa essere sostituita da un terzo – ossiadall’arbitro – nello svolgimento della sua attività e, dall’altro, sirespinge l’idea che agli arbitri sia in qualche modo consentito di inci-dere sugli atti amministrativi, annullandoli o comunque provocandonein qualche modo l’espunzione dall’ordinamento.
Sotto il primo profilo già Guicciardi (97), che pure teorizzava l’am-missibilità delle transazioni sugli atti amministrativi, negava che alcompromesso potesse riconoscersi, nel diritto pubblico, un ambitoaltrettanto ampio. Secondo l’Autore, seppure nel campo del dirittoprivato l’ambito della transazione e quello del compromesso coinci-dono, «questa coincidenza, (...), non sembra affatto conservabile neldiritto pubblico, per il fondamento ben diverso che la transazione hain questo rispetto al diritto privato»; con il compromesso le parti siaccordano nell’evitare la decisione della loro lite da parte del giudicenon fissando loro stesse i termini per la soluzione della controversia,bensì deferendola ad un terzo, l’arbitro. Ed è proprio questo deferi-
(96) V. Scoca, La capacità della pubblica amministrazione di compromettere inarbitri, cit., p. 106; Goisis, La giustizia sportiva tra funzione amministrativa e arbitrato,cit., p. 254 s.
(97) V. Guicciardi, Le transazioni degli enti pubblici, cit., 216/103, nota 2.
CAP. UNICO - L’ARBITRATO NEL DIRITTO AMMINISTRATIVO 547
mento ad un terzo della decisione della lite che sarebbe preclusoall’amministrazione: infatti, quando questa si risolve ad una soluzionenon giurisdizionale di una controversia, deve sempre tenere come farodella propria attività il perseguimento dell’interesse pubblico (98); ora,se nel transigere è l’amministrazione stessa che ne predispone oaccetta le condizioni, «questo essa non può fare nel giudizio arbitrale,il quale potrebbe anche chiudersi coll’accoglimento, totale o parziale,della pretesa della controparte, e colla relativa soccombenza dell’am-ministrazione».
In altre parole, secondo Guicciardi (99), la decisione stragiudizialedelle controversie sarebbe ammessa solamente quando è l’amministra-zione stessa a definirne o accettarne i termini, mentre non sarebbe maipossibile la delega a terzi dell’individuazione della soluzione della litesul provvedimento.
Questa opinione è stata criticata da Amorth e da Cassese (100),secondo i quali la discriminazione ipotizzata da Guicciardi tra transi-gibilità e compromettibilità degli interessi legittimi non convince-rebbe: se il problema fosse solo quello di non delegare, generica-mente, a terzi la cura dell’interesse pubblico, allora non sarebbe, perassurdo, nemmeno ammissibile la decisione giurisdizionale di questecontroversie (anche il giudice, infatti, è un terzo); mentre, d’altrocanto, ad evitare i rischi della cattiva gestione dell’interesse pubblicobasterebbe accordarsi per una adeguata composizione dell’organoarbitrale.
Nondimeno si tratta di obiezioni che non colgono nel segno e,soprattutto, che non interpretano correttamente il pensiero di Guic-ciardi.
La decisione giurisdizionale della controversia, infatti, non è unadecisione purchessia, affidata ad un terzo qualunque, ma rappresentala decisione «giusta» offerta dall’ordinamento; altrimenti non si com-
(98) Interesse «che, normalmente, è quello del mantenimento dell’atto impugna-to», con la conseguenza che, «quando essa transige, il suo punto di partenza deveessere quello che il suo atto rimarrà in piedi»: v. Guicciardi, op. loc. ult. cit.
(99) E degli altri che hanno ritenuto di seguirlo: v. Antonioli, Arbitrato e giuri-sdizione esclusiva, cit., p. 70 ss.
(100) V. Amorth, Annotazioni sull’arbitrato nelle controversie amministrative,cit., p. 2167 ss.; Cassese, L’arbitrato nel diritto amministrativo, cit., p. 325 s.
PARTE V - SEZ. IV - ARBITRATO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE548
prenderebbe per quale ragione solo al giudice dello Stato è consentitala decisione delle liti su diritti indisponibili. Dicendo che l’amministra-zione non può consentire che sia l’arbitro a definire la controversia colprivato – senza una sua partecipazione attiva – Guicciardi non vuoldire che in ogni caso la soluzione della controversia non può esseredeferita ad un terzo, ma che questo terzo non può essere altri che ilgiudice dello Stato.
Il vizio del ragionamento di Guicciardi va individuato altrove,ossia nella assimilazione tra transazione e arbitrato. La transazione èinfatti un accordo con cui le parti prevengono o risolvono una litefacendosi reciproche concessioni, mentre con l’arbitrato devolvono adun terzo non la composizione della lite, ma la sua decisione.
Se pertanto nella transazione le parti direttamente agiscono sullasituazione sostanziale, modificandola al fine di addivenire al concilium,col patto compromissorio l’accordo verte solamente sulla persona chesarà chiamata a dettare la regola che risolverà il caso concreto: l’arbi-tro e non il giudice.
Ecco allora che la funzione dell’arbitro sarà proprio quella di «giu-dicare», ossia trovare la regola di diritto che – applicata al caso con-creto – risolverà la questione attribuendo la ragione e il torto, nonquella di «comporre» la controversia. Ecco che le preoccupazioni diparte della dottrina secondo cui «dei mandatari, quali sono gli arbitri,possano disporre dell’interesse pubblico» (101) vengono meno: gli arbi-tri sono investiti dalle parti di un «ufficio», che – come si è detto – è digiudicare e decidere la controversia, non di operare quali meri manda-tari, per disporre degli interessi che sono propri delle parti (102).
Vale anche osservare che l’arbitro è chiamato a pronunciarsi in unmomento in cui la scelta dell’amministrazione relativa al perseguimentodell’interesse pubblico è già stata compiuta. L’arbitro non viene chiamatoa valutare preventivamente la congruità della scelta dell’amministrazionecon l’interesse pubblico, né a indicarle un comportamento diretto al suoperseguimento, ma solo a verificare ex post se la scelta dell’amministra-zione è stata legittima o abbia leso l’interesse legittimo del privato. L’in-
(101) V. Antonioli, Arbitrato e giurisdizione esclusiva, cit., p. 69 s.(102) V. supra, parte III, sez. I, n. 2.1.
CAP. UNICO - L’ARBITRATO NEL DIRITTO AMMINISTRATIVO 549
teresse pubblico non rientra nell’oggetto dell’indagine degli arbitri e restanell’esclusiva competenza dell’amministrazione.
Viceversa, nella transazione, soprattutto quando questa ha adoggetto l’esercizio del potere, le concessioni dell’amministrazione alprivato debbono essere sostenute dalla necessità di perseguire l’inte-resse pubblico, e la transazione trova la sua ratio e il suo limite proprionella maggior adeguatezza all’interesse pubblico rispetto alla litedavanti al giudice: l’amministrazione, transigendo, di fatto esercita ilproprio potere allo scopo di meglio soddisfare l’interesse pubblico.
Si può dire che l’amministrazione non potrebbe «delegare a terzi»le scelte sulle concessioni transattive che fa al privato, perché signifi-cherebbe delegare l’esercizio di una funzione che le spetta per leg-ge (103), ma «dinanzi agli arbitri viene portata una controversia chenon è diversa da quella che verrebbe sottoposta all’attenzione dei giu-dici e che riguarda non il potere o la funzione nella sua proiezionefutura, ma una vicenda del passato che deve essere valutata sulla basedi criteri predeterminati, che sono quelli normalmente adoperati dalgiudice amministrativo e che devono essere adoperati dall’arbitro,qualora sia chiamato a giudicare il caso» (104).
(103) Peraltro, nemmeno pare potersi condividere appieno questa affermazione,quantomeno con riferimento all’attività discrezionale dell’amministrazione. Se è veroinfatti che l’attività discrezionale può formare oggetto di accordi tra l’amministrazionee l’interessato, non si vedono motivi per escludere la rimessione a terzi della determi-nazione di taluni elementi di quello che sarà il provvedimento finale, anche se il prov-vedimento in questione sia una transazione. L’amministrazione certamente non potràrimettere al terzo «l’attribuzione» astratta del potere che le è conferito per legge –ossia la sua funzione istituzionale – ma non si vedono le ragioni per cui non potrebbeconferire ad un terzo la determinazione delle modalità concrete di attuazione di unavolizione discrezionale la cui congruenza con il perseguimento dell’interesse legittimoè già stata valutata a monte. Il provvedimento finale che il terzo potrebbe eventual-mente essere chiamato ad adottare sarà un provvedimento comunque riconducibilealla volontà dell’amministrazione, sempre che questa gli abbia all’uopo conferito irelativi poteri, indicando contestualmente i precisi limiti. In sostanza l’amministra-zione esercita il potere attribuitole dalla legge individuando le diverse modalità attra-verso le quali l’interesse pubblico è perseguibile, affidando al terzo la facoltà di sce-gliere la via che ritiene migliore in relazione al caso concreto.
(104) Così Verde, Nuove riflessioni su arbitrato e pubblica amministrazione, cit., p.698; Vaccarella M., Arbitrato e giurisdizione amministrativa, cit., p. 39. Nello stessosenso, v. anche Gasparini Casari, Arbitrato e controversie amministrative, cit., p.1025; Pugliese, Arbitrato e p.a., in Contratti, 1993, p. 652, secondo i quali la clausola
PARTE V - SEZ. IV - ARBITRATO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE550
Pertanto, ostacoli all’ammissibilità di impiego di arbitrati per larisoluzione delle controversie amministrative non possono derivaredalla circostanza che la pubblica amministrazione sia estranea alla for-mazione della pronuncia arbitrale, in quanto la stessa, anche se pro-viene da un terzo, è regolata nei suoi effetti dalla legge e non deter-mina un nuovo assetto di interessi, perché – lo si ripete – intervienesulla base di un accertamento rispetto ad una situazione giuridica con-troversa la cui disciplina esiste già (105).
Resta infine da chiarire quali potrebbero essere i poteri degli arbi-tri nei confronti dei provvedimenti amministrativi, le forme di manife-stazione del potere amministrativo e la più frequente causa di lesionedegli interessi legittimi.
Quanto al potere degli arbitri di provocare, in qualunque modo,l’espunzione dei provvedimenti amministrativi – annullandoli, revo-candoli o condannando l’amministrazione alla loro rimozione – leposizioni della dottrina, salvo qualche rara e autorevole eccezione,sono tutte decisamente schierate in senso negativo.
In primo luogo, non si è ritenuto che il riconoscimento delladisponibilità del potere amministrativo possa anche fondare la com-promettibilità delle controversie amministrative relative al binomiointeressi legittimi-potere amministrativo, poiché limite fondamentale einsuperabile all’arbitrabilità di queste controversie sarebbe dato dallapresenza del provvedimento autoritativo, sul quale gli arbitri nonpotrebbero intervenire.
Il provvedimento sarebbe infatti «una manifestazione dell’autoritàdi carattere normativo, affine alla legge e ancor più alla sentenza (...), ecostituisce, come tale, patrimonio della collettività, fondamentalmenteindisponibile per il suo autore» (106).
arbitrale non incide sul potere che, nel momento in cui viene apposta, è già stato inte-ramente esercitato. Il lodo arbitrale non impone un certo doveroso esercizio delpotere, non sceglie soluzioni che l’amministrazione non voglia o non abbia già voluto,ma si limita a dire in quale direzione ed in quale misura il potere, già esercitato, si siaimpegnato; a quali obblighi l’amministrazione sia sottoposta e sia impegnata.
(105) Nello stesso senso, v. Caia, Arbitrati e modelli arbitrali nel diritto ammini-strativo, cit., pp. 189 ss., 196.
(106) V. Romano Tassone, Giurisdizione amministrativa e arbitrato, in Riv. arb.,2000, 264 ss.
CAP. UNICO - L’ARBITRATO NEL DIRITTO AMMINISTRATIVO 551
Il carattere di indisponibilità viene – in questa ricostruzione – attri-buito non al potere amministrativo in sé, ma alla sua manifestazione«ancorché a base consensuale»: il provvedimento amministrativo,infatti, come la sentenza del giudice, una volta adottato, cessa di rima-nere nella disponibilità del suo autore per divenire patrimonio dellacollettività. Ecco allora che, se gli arbitri mutuano i propri poteri dalleparti, il provvedimento amministrativo, intangibile per il suo autore,risulta intangibile anche per essi.
Questa ricostruzione lascia adito a perplessità perché contrastacon la disciplina dell’annullabilità, revocabilità e modificabilità deiprovvedimenti amministrativi prevista dalla l. n. 241/1990, come inte-grata dalla l. n. 15/2005, e, più in generale, con la natura e la funzionedel provvedimento amministrativo e del potere.
Come è noto, la pubblicazione della sentenza, che si perfezionacon il suo deposito in cancelleria (art. 133, comma 1o, c.p.c.), ne com-porta l’uscita dalla materiale disponibilità del giudice, che non puòpiù mutarla o disconoscerla (107). Anche se la sentenza è palesementeingiusta, il giudice non può tornare sui suoi passi e le parti non hannoaltra via dell’impugnazione giudiziale per evitarne il passaggio in giu-dicato.
Lo stesso non si può dire del provvedimento amministrativo.Prima di tutto, il provvedimento altro non è se non la manifestazionedell’esercizio del potere amministrativo, che è attribuito all’ammini-strazione al solo e inevitabile scopo di perseguire l’interesse pubblico.Se veramente con la sua adozione il provvedimento amministrativouscisse dalla disponibilità dell’organo che lo ha posto in essere, si ver-rebbe a cristallizzare un assetto di interessi che potrebbe contrastarecon sopravvenuti motivi di interresse pubblico o con un’eventualenuova valutazione dell’interesse pubblico originario.
Ed è proprio in considerazione di ciò che il legislatore del 2005 ha,
(107) In proposito, v. Punzi, Il processo civile. Sistema e problematiche2, Torino,2010, II, p. 226, dove si ribadisce che il perfezionamento della pubblicazione si ha conil mero atto di deposito effettuato dal giudice e si precisa che l’attività del cancellieresi svolge solo all’esterno e con funzione certificativa. Infatti, il cancelliere, a normadell’art. 133 c.p.c., «dà atto del deposito» e tale certificazione rileva a determinatieffetti, come il dies a quo per il decorso del termine annuale di decadenza di cuiall’art. 327 c.p.c.
PARTE V - SEZ. IV - ARBITRATO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE552
con l’introduzione dell’art. 21 quinquies l. n. 241/1990 (revoca delprovvedimento), reso esplicito ciò che prima poteva trarsi dai principiche sorreggono l’attività amministrativa. Allo stesso modo, l’ammini-strazione può, sempre nell’ottica del perseguimento dell’interessepubblico, annullare d’ufficio o convalidare il provvedimento illegit-timo (art. 21 nonies l. n. 241/1990).
Ne consegue che il provvedimento – legittimo o non – resta perdefinizione nella signoria dell’amministrazione. E non potrebbe esserediversamente, dal momento che, diversamente dalla sentenza, è unodegli strumenti con cui l’amministrazione persegue ed insegue lamutevolezza dell’interesse pubblico. Deve quindi trattarsi di uno stru-mento dotato della necessaria elasticità per potersi adattare ad esi-genze sopravvenute o a rivalutazioni e mutamenti.
Altri limiti alla potestà degli arbitri di incidere sui provvedimentiamministrativi deriverebbero dalle norme costituzionali.
Un primo limite costituzionale alla cognizione degli arbitri vieneindividuato nell’art. 103, comma 1o, Cost., che sembrerebbe riservarela tutela degli interessi legittimi nei confronti della pubblica ammini-strazione al Consiglio di Stato e agli altri organi di giurisdizione ammi-nistrativa (108).
L’argomento è di quelli che provano troppo. Se fosse vero che l’art.103 Cost. riserva al solo giudice amministrativo la tutela degli interessilegittimi, allora l’intero fenomeno arbitrale sarebbe irrimediabilmenteincostituzionale, dal momento che l’art. 102 Cost. rimette la funzione giu-risdizionale – ossia la tutela dei diritti – ai «magistrati ordinari istituiti eregolamentati secondo le norme dell’ordinamento giudiziario» (109); nési spiegherebbe la contraddizione in cui sarebbe incorso il legislatore pre-costituzionale che, da un lato, attribuisce all’autorità giudiziaria la tutelagiurisdizionale dei diritti (art. 2907 c.c. e art. 1 c.p.c.) e, dall’altro, con-sente che le parti facciano decidere da arbitri le controversie tra di loroinsorte che vertano su diritti disponibili.
(108) Così Acquarone-Mignone, Arbitrato nel giudizio amministrativo, cit., p.372; Gasparini Casari, Arbitrato e controversie amministrative, cit., p. 1026.
(109) V. Cassese, L’arbitrato nel diritto amministrativo, cit., p. 314; Goisis, Lagiustizia sportiva tra funzione amministrativa e arbitrato, cit., p. 287 s. In proposito, v.anche supra, parte I, n. 3.5.
CAP. UNICO - L’ARBITRATO NEL DIRITTO AMMINISTRATIVO 553
Inoltre, se veramente l’art. 103 Cost. riservasse al giudice ammini-strativo in via esclusiva la tutela degli interessi legittimi nei confrontidell’amministrazione, non si comprenderebbe per quale ragione il suc-cessivo art. 113 Cost. afferma che la tutela dei diritti «e degli interessilegittimi» è sempre ammessa dinanzi agli organi di giurisdizione «ordi-naria e amministrativa», senza distinzione; senza contare che l’ultimocomma di detta disposizione non riserva affatto al solo giudice ammi-nistrativo la potestà di annullamento degli atti amministrativi, marimette al legislatore di individuare, caso per caso, il giudice dotato ditale potere.
Altri limiti per negare il potere degli arbitri di annullare i provve-dimenti amministrativi vengono tratti dall’art. 113 Cost. Il terzocomma di questa disposizione, infatti, riserva al legislatore il potere dideterminare quali «organi di giurisdizione» possono annullare gli attidella pubblica amministrazione (110).
Secondo una parte della dottrina, gli arbitri, non potendo esserequalificati come «organi di giurisdizione», non potrebbero per questovedersi attribuiti dalla legge il potere di annullare gli atti amministrati-vi (111); secondo un’altra prospettiva, è stato invece ritenuto che «èvero che il collegio arbitrale o l’arbitro unico non sono classificabili tragli organi giurisdizionali, ma è pur vero che il lodo integrato daldecreto del pretore acquista sicuramente natura di sentenza (...) sic-ché, ove il lodo-sentenza contenesse in ipotesi l’annullamento di unatto amministrativo, tale annullamento equivarrebbe a quello dispostodal giudice, ma in quanto investito per legge di una siffatta potestà diannullamento», potestà di annullamento che «non sussiste nel nostroordinamento» (112).
Secondo altri, agli arbitri – cui non potrebbe riconoscersi la qualità
(110) Così, ma con posizioni in parte diverse tra loro, Amorth, Annotazioni sul-l’arbitrato nelle controversie amministrative, cit., p. 2172; Acquarone-Mignone,Arbitrato nel giudizio amministrativo, cit., p. 372; Antonioli, Arbitrato e giurisdi-zione esclusiva, cit., p. 73 ss.; Gasparini Casari, Arbitrato e controversie amministra-tive, cit., p. 1026;
(111) V. Antonioli, Arbitrato e giurisdizione esclusiva, cit., p. 74.(112) V. Amorth, Annotazioni sull’arbitrato nelle controversie amministrative,
cit., p. 2172, secondo cui «neanche si potrebbe inferirla per interpretazione estensivao analogia di norme del provvedimento giurisdizionale avanti ai giudici amministra-
PARTE V - SEZ. IV - ARBITRATO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE554
di organi di giurisdizione – sarebbe applicabile l’art. 4, comma 2o, l. n.2248/1865, che vieta al giudice ordinario di modificare o annullare attiamministrativi, muovendo dalla premessa della fungibilità del giudiziodegli arbitri con quello civile ordinario; sebbene peraltro l’ultimocomma dell’art. 113 Cost. consentirebbe al legislatore di attribuire lapotestà di annullamento anche ad «organi di giurisdizione» diversi dalgiudice amministrativo, la deroga «non è di certo suscettibile di esten-dersi apud arbitros», proprio in quanto questi non sarebbero organi digiurisdizione (113).
In senso contrario si è peraltro fatto notare che l’ultimo commadell’art. 113 Cost. non potrebbe rappresentare un ostacolo alla potestàdegli arbitri di annullare provvedimenti amministrativi: «qualunquesia la tesi che si preferisca in ordine alla natura giuridica degli arbi-trati, la norma citata non potrà dirsi preclusiva per quello che qui inte-ressa: se si segue la tesi della natura giurisdizionale dell’arbitrato que-sto si pone su di un piano sostitutivo rispetto al giudice ordinario (...);se – all’opposto – si segue la tesi contrattualistica, visto che l’arbitratosi fonderebbe così esclusivamente sull’autonomia delle parti (la vinco-latività del lodo deriverebbe cioè dalla volontà delle parti) che inten-dono rinunciare alla giurisdizione e quindi all’azione, le norme costi-tuzionali in materia di giurisdizione non rilevano» (114).
Sempre in senso contrario si è anche affermato che il legislatoredel 2006, nell’attribuire al lodo l’efficacia della sentenza pronunciata
tivi, la citata disposizione costituzionale [l’art. 113 Cost.] richiedendo un’espressaattribuzione al riguardo».
(113) V. Antonioli, Arbitrato e giurisdizione esclusiva, cit., pp. 73, 82. V. anchesupra, parte I, n. 3.8 ss.
(114) Così Caia, Arbitrati e modelli arbitrali nel diritto amministrativo, cit., p. 186,il quale comunque giunge per altra via a negare l’arbitrabilità delle controversie inmateria di interressi legittimi. Va comunque rilevato che le argomentazioni dell’A.,che portano a non vedere nell’art. 113 Cost. un ostacolo al potere degli arbitri diannullare gli atti amministrativi, non convince appieno: quanto al secondo argomento– vale a dire che la natura negoziale dell’arbitrato comporta l’inapplicabilità dellenorme destinate alla giurisdizione – non si ha nulla da eccepire, ed anzi, come si vedràinfra, in questo paragrafo, costituisce proprio l’argomento attraverso il quale arrivarea negare l’applicabilità dell’art. 113 Cost. all’arbitrato; al primo argomento si puòinvece opporre che – proprio se si afferma che gli arbitri si pongono sullo stesso pianodel giudice ordinario – a loro sarebbe applicabile l’art. 4 della legge abolitrice del con-tenzioso amministrativo.
CAP. UNICO - L’ARBITRATO NEL DIRITTO AMMINISTRATIVO 555
dall’«autorità giudiziaria», abbia con ciò conferito agli arbitri gli stessipoteri di cui gode quest’ultima; quanto al fatto che la legge espressa-mente non conferisca agli arbitri la potestà annullatoria, questa vienedesunta dal nuovo art. 824 bis c.p.c., che parla genericamente di«autorità giudiziaria», senza specificare se si tratti di autorità giudizia-ria ordinaria o amministrativa. Ora, dal momento che il legislatore del2006 certo non ignorava l’esistenza dell’art. 6 l. n. 205/2000, con cui«si è espressamente riconosciuta l’arbitrabilità di controversie, altri-menti, devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, nonsembra nemmeno facilmente sostenibile che il legislatore delegatoabbia in realtà, con l’espressione autorità giudiziale, voluto far riferi-mento alla sola giurisdizione ordinaria» (115).
Chi scrive ritiene che le superiori argomentazioni in effetti prestinoil fianco a diverse critiche.
Che l’ultimo comma dell’art. 113 Cost. non precluda affatto agliarbitri la potestà di annullare provvedimenti amministrativi si puòdesumere dalla sua collocazione sistematica di norma nata e pensata,come l’art. 4, comma 2o, l. n. 2248/1865 allegato E, a presidio delprincipio di divisione dei poteri dello stato. Si tratta, infatti, di unanorma rivolta esclusivamente al potere giurisdizionale – come delresto appare evidente dalla sua collocazione topografica tra le normeche fissano i principi cui deve ispirarsi l’esercizio della giurisdizio-ne (116) – e nasce come norma volta a sancire al livello costituzionalel’eccezionalità e la tassatività dei casi in cui il potere giurisdizionalepuò incidere sugli atti del potere esecutivo: di regola il potere esecu-tivo è tutelato nella sua autonomia nei confronti del potere giurisdizio-nale, salvi i casi in cui il legislatore determini «quali organi giurisdizio-nali possono annullare gli atti della pubblica amministrazione».
La reale natura di norma posta a presidio della separazione deipoteri risulta ancora più chiara se si analizzano le linee evolutive e i
(115) Così Goisis, La giustizia sportiva tra funzione amministrativa e arbitrato, cit.,p. 288 s. Anche questo A., peraltro, giunge a negare che gli arbitri possano annullare iprovvedimenti amministrativi sulla base di argomentazioni di ordine sistematico, purdopo avere affermato l’inesistenza di preclusioni a tale potere né sul piano sostanzialené su quello costituzionale.
(116) La disposizione si trova nel libro IV, sezione II, rubricata appunto «Normesulla giurisdizione».
PARTE V - SEZ. IV - ARBITRATO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE556
dibattiti che – in sede costituente – hanno portato al testo attuale.Come è noto, con l’art. 1 l. n. 2248/1865, all. E si abolirono «i tribu-nali speciali attualmente investiti della giurisdizione del contenziosoamministrativo», devolvendo «alla giurisdizione ordinaria tutte lecause per contravvenzioni e tutte le materie nelle quali si faccia que-stione di un diritto civile o politico, comunque vi possa essere interes-sata la pubblica amministrazione». Definiti così i limiti esterni alla giu-risdizione del giudice ordinario, gli artt. 4 e 5 della stessa legge indivi-duarono i cd. limiti interni, ossia le azioni esperibili innanzi al giudicestesso e i relativi suoi poteri, cercando di contemperare le esigenze delcittadino col principio di separazione dei poteri: ed allora il giudiceordinario, investito di una controversia riguardante un diritto che sipretendeva leso da un atto dell’autorità amministrativa, doveva limi-tarsi a conoscere «degli effetti dell’atto stesso in relazione all’oggettodedotto in giudizio», ma non poteva revocarlo o modificarlo, essendoquesta potestà riservata alle competenti autorità amministrative. Pernon vanificare del tutto la portata precettiva delle sentenze del giudiceordinario, fu stabilito che le amministrazioni «si uniformeranno al giu-dicato dei tribunali in quanto riguarda il caso deciso» (anche se taleobbligo era, nel sistema del 1865, del tutto sprovvisto di sanzione).
A chiudere il sistema, vista l’intangibilità degli atti amministrativi daparte del giudice, l’attribuzione allo stesso del c.d. potere di disapplica-zione: «le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed iregolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi».
Ben presto, peraltro, vista l’inadeguatezza pratica dell’attribuzionedella tutela dei soli diritti al giudice ordinario (117), la l. 31 marzo1889, n. 5992, con l’istituzione della IV sezione del Consiglio di Statoe l’attribuzione a quest’ultimo del potere di «decidere per incompe-tenza, per eccesso di potere, o per violazione di legge contro atti epoteri di un’autorità amministrativa», all’art. 17 ha stabilito che, incaso di accoglimento del ricorso, la IV sezione «annulla l’atto o ilprovvedimento», così dotandola di quei poteri costitutivi di cui era edè privo il giudice ordinario.
(117) Unita alla «alla notevole timidità nell’esercizio delle attribuzioni che parevalimitassero la libertà del potere esecutivo»: v. Orlando, in Primo trattato completo didiritto amministrativo italiano, a cura di Orlando, Milano, 1907, p. 636.
CAP. UNICO - L’ARBITRATO NEL DIRITTO AMMINISTRATIVO 557
Questo sistema venne sostanzialmente conservato nel successivoordinamento costituzionale. In sede costituente, sulle perdurantiistanze di Calamandrei, che prefigurava la soppressione della giurisdi-zione amministrativa onde affidare al solo giudice ordinario la tutela,anche costitutiva, nei confronti della pubblica amministrazione, pre-valsero le posizioni di Mortati e Ruini. Quest’ultimo in particolarepaventava, proprio un un’ottica di separazione dei poteri, che «ogniautorità giudiziaria, anche un pretore, potesse annullare gli atti del-l’amministrazione» (118).
In sostanza, quindi, la preoccupazione del costituente non eraquella di riservare «al giudice» – seppure in casi tassativi – la potestàdi annullamento dei provvedimenti amministrativi (altrimenti lanorma sarebbe stata preclusiva anche della potestà di annullamento daparte della stessa amministrazione), ma al contrario di impedire che alpotere giurisdizionale fosse attribuito un generale potere di incideresull’attività dell’amministrazione.
Nell’art. 113 Cost. non si può, pertanto, rinvenire la fonte delpotere di annullamento dei provvedimenti, ma – al contrario – unalimitazione nei confronti del potere giurisdizionale. In sostanza, è pro-prio la qualità di «organo di giurisdizione» che rende necessario ilconferimento espresso da parte del legislatore del potere di annullare iprovvedimenti amministrativi.
Qualora, quindi, chi è richiesto dell’annullamento del provvedi-mento amministrativo non sia un organo di giurisdizione, l’art. 113Cost. non pare poter rappresentare per lui un limite (119).
Ecco allora che anche i presunti limiti costituzionali alla potestàdegli arbitri di annullare gli atti amministrativi vengono meno proprio
(118) V. la seduta del 22 dicembre 1947, in A.C., V, 4584. Sull’art. 113 Cost. esulle esigenze che ne sono alla base, v. Saitta, in Aa.Vv., Commentario alla Costitu-zione, a cura di Bifulco, Celotto e Olivetti, III, Torino, 2007, sub art. 113, p. 2136 ss.;Berti, in Aa.Vv., Commentario della Costituzione, a cura di Branca, IV, La magistra-tura, Bologna, 1987, sub art. 113, p. 85 ss. Sempre in argomento, v. Verde, L’unitàdella giurisdizione e la diversa scelta del costituente, in Dir. proc. amm., 2003, p. 343 ss.
(119) In questo senso, se ben ne intendo il pensiero, v. anche Caia, Arbitrati emodelli arbitrali nel diritto amministrativo, cit., p. 187, laddove afferma che «se (...) sisegue la tesi contrattualistica, visto che l’arbitrato si fonderebbe esclusivamente sul-l’autonomia delle parti (...) che intendono rinunciare alla giurisdizione e quindiall’azione, le norme costituzionali in materia di giurisdizione non rilevano».
PARTE V - SEZ. IV - ARBITRATO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE558
grazie ad una lettura sistematica delle norme, coerente con la loro sto-ria e la ratio che le ispira.
Nondimeno, detto potere è stato escluso, in dottrina, anche da chi– come chi scrive – ritiene non solo compromettibili le controversiecoinvolgenti interessi legittimi e potere amministrativo, ma anche chenon siano individuabili nell’ordinamento norme che espressamenteimpediscano agli arbitri di annullare i provvedimenti amministrati-vi (120).
La posizione si fonda su argomentazioni di ordine sistematico.Come è noto, il lodo arbitrale di annullamento di un provvedimentoamministrativo avrebbe efficacia costitutiva. È altrettanto noto che, adifferenza del lodo di condanna, la pronunzia arbitrale costitutiva è«autoesecutiva», ossia produce i suoi effetti a prescindere dall’omolo-gazione del tribunale (121), richiesta invece per l’esecuzione dei lodiaventi contenuto di condanna (122).
Ebbene, secondo questa tesi, sarebbe «stonato» – sul piano siste-matico – che il legislatore richiedesse, per i lodi di condanna, il vagliodel tribunale, mentre consentisse che una pronunzia costitutiva su diun oggetto tanto delicato come un provvedimento amministrativo siaself executing (123).
L’argomento non coglie nel segno. Tra gli effetti naturali del lodoarbitrale, riconducibili alla sua efficacia vincolante, rientrano certa-mente anche quelle modificazioni sostanziali che le parti avrebbero
(120) V. Goisis, op. loc. ult. cit.(121) V. in tal senso Ruffini-Boccagna, in Aa.Vv., Codice di procedura civile
commentato4, diretto da Consolo, Milano, 2010, III, sub art. 825, p. 1972; Monte-sano, Sugli effetti del nuovo lodo arbitrale e sulle funzioni della sua omologazione, inRiv. trim. dir. proc. civ., 1994, 821 ss.; nonché supra, parte III, sez. I, n. 7.4.5.1; e, ingenerale, sugli «effetti naturali» del lodo che conseguono alla mera sottoscrizione daparte degli arbitri e indipendentemente dal suo deposito e dal decreto di esecutivitàex art. 825 c.p.c., v. Punzi, Il processo civile2, III, cit., p. 237 ss., nonché supra, parteIII, sez. I, n. 7.4.5 e n. 8.3.
(122) Nonché per l’esecuzione dei lodi a contenuto costitutivo cui non sia seguitolo spontaneo adeguamento delle parti al dictum arbitrale; cfr. Cavallini, Alcune con-siderazioni in tema di efficacia del lodo, in Riv. arb., 1997, p. 711, spec. p. 725 ss.
(123) Ciò che peraltro, se è vero sul piano dell’accertamento, non lo è altrettantosul piano sostanziale, dovendosi distinguere tra gli effetti costitutivi sul piano giuri-dico, che si producono automaticamente, e le loro conseguenze sostanziali, che invecenecessitano di un’attività esecutiva; cfr. ancora Cavallini, op. loc. ult. cit.
CAP. UNICO - L’ARBITRATO NEL DIRITTO AMMINISTRATIVO 559
potuto raggiungere pure sul piano della loro autonomia privata (124).Se pertanto la modificazione che si richiede non rientra tra quelle digiurisdizione costitutiva necessaria, non si vedono ostacoli a che gliarbitri offrano alle parti quella modificazione, pur senza dover passareattraverso il vaglio del controllo giurisdizionale.
Che non sia necessario alcun intervento del giudice per le pro-nunce meramente costitutive discende direttamente da un altro deicorollari fondamentali in materia di arbitrato, ossia che monopoliodello Stato non è la decisione delle controversie, ma l’uso della forza(esecutiva) (125). Le parti possono pertanto scegliere di far decidere leloro controversie ad un giudice privato o anche di risolverle in viatransattiva, ma l’esecuzione coattiva della pronuncia del giudice pri-vato o dell’accordo transattivo deve necessariamente passare per ilvaglio di un organo giurisdizionale. Se però la pronuncia degli arbitriha contenuto meramente costitutivo – e si è al di fuori delle ipotesi digiurisdizione costitutiva necessaria – come le parti possono dare luogoalla modificazione sulla base della loro semplice autonomia, così pos-sono anche gli arbitri, senza necessità di alcun vaglio statale.
Ed allora, se effettivamente rientra tra i poteri dell’amministra-zione anche l’annullamento del proprio provvedimento, senza che sianecessario il vaglio di una giurisdizione statale, non si vede per qualeragione l’eventuale lodo con cui gli arbitri annullano un provvedi-mento amministrativo non sia ammissibile (126).
9. – Ricostruzione sistematica dell’ammissibilità dell’arbitrato sullesituazioni giuridiche di diritto pubblico e della potestà degli arbitri diannullamento dei provvedimenti amministrativi. – Sin qui la pars
(124) V. Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile7, Torino, 2010, I, p. 107ss.; nonché supra, parte III, sez. I, n. 7.4.5.1.
(125) V. Satta, Commentario, IV, 2, cit., p. 162; Satta-Punzi, Diritto processualecivile13, Padova, 2000, p. 876; Punzi, Il processo civile2, III, cit., p. 156; nonché supra,parte I, n. 3.4 e 3.5.
(126) Sempre Goisis, op. loc. ult. cit. trae argomento dalla non trascrivibilità dellodo non depositato – intesa come esigenza dell’ordinamento di tutelare la certezzadel diritto di fronte all’inserimento nei pubblici registri di un atto non vagliato inalcun modo dal giudice – per negare coerenza sistematica alla possibilità di una pro-nuncia costitutiva autoesecutiva su di un oggetto tanto delicato quanto un provvedi-mento amministrativo.
PARTE V - SEZ. IV - ARBITRATO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE560
destruens. Si sono passati in rassegna tutti gli argomenti ritenuti pre-clusivi vuoi della compromettibilità delle situazioni giuridiche sogget-tive di diritto pubblico, vuoi della potestà degli arbitri di annullare iprovvedimenti amministrativi.
Si è visto che nessuna delle argomentazioni regge di fronte ad uncorretto inquadramento sistematico delle vicende relative al potereamministrativo e all’interesse legittimo. Situazioni, la prima soprat-tutto, delle quali ormai – nel nuovo tessuto normativo apparecchiatodalla l. n. 241/1990 – non può più affermarsi l’indisponibilità.
Ora, se il potere amministrativo – nei limiti che si sono sopra visti– è disponibile e lo è anche l’interesse legittimo, le eventuali contro-versie che li riguardano sono arbitrabili almeno finché una norma dilegge espressamente non lo escluda.
La nuova formulazione dell’art. 806 c.p.c., infatti, pone comeunico criterio per l’arbitrabilità di una controversia la disponibilitàdella situazione giuridica che ne costituisce l’oggetto, salvo espressodivieto di legge (127), divieto espresso che non esiste, né è dato rica-varlo argomentando dalla lettera dell’art. 12 c.p.a.
Per ciò solo, sul piano sostanziale, non può che ammettersi l’arbitra-bilità delle situazioni soggettive di diritto pubblico, come del resto siammette la loro transigibilità (128). Transazione e arbitrato, come si è dettopiù volte, hanno entrambi fondamento nella autonomia privata e nelladisponibilità delle situazioni che ne costituiscono oggetto, per cui quando«la transazione è possibile, anche il giudizio arbitrale è possibile» (129),ancorché la funzione dei due istituti sia profondamente diversa (130).
(127) Dal nuovo testo dell’art. 806 c.p.c. si ricava infatti che – in fatto di situazionidisponibili – «l’arbitrabilità è la regola, la non arbitrabilità l’eccezione: il che com-porta che la sottrazione di determinate controversie alla cognizione arbitrale deverisultare in modo esplicito e non può essere frutto di un’interpretazione analogica»;così Ruffini, in Aa.Vv., Codice di procedura civile commentato4, diretto da Consolo,III, cit., sub art. 806, p. 1530, nonché Id., Patto compromissorio, in Riv. arb., 2005, p.711 ss.; in proposito, v. anche supra, parte III, sez. I, n. 1.5.3.
(128) Come ha ampiamente dimostrato Greco, Contratti e accordi della aubblicaamministrazione con funzione transattiva, cit., passim, spec. § 4.
(129) Cass. 25 ottobre 1969, n. 3505.(130) V. Amar, Dei giudizi arbitrali2, Torino, 1878, p. 69; Consolo, Sul «campo»
dissodato della compromettibilità per arbitri, cit., p. 241 ss.; Caia, Arbitrati e modelliarbitrali nel diritto amministrativo, cit., pp. 189 ss., 196.
CAP. UNICO - L’ARBITRATO NEL DIRITTO AMMINISTRATIVO 561
Certo, se è indiscutibile la disponibilità del potere amministrativo,il fatto che questo sia attribuito all’amministrazione al solo scopo diperseguire l’interesse pubblico lo contraddistingue e lo rende assaidiverso dalle situazioni giuridiche private, che invece sono caratteriz-zate da una libertà piena e totale.
Peraltro, la presenza ingombrante dell’interesse pubblico non vasopravvalutata. L’amministrazione, al momento della stipula del pattocompromissorio ne deve tenere conto in modo da non attribuire agliarbitri un potere eccessivo, che ne potrebbe pregiudicare il persegui-mento; anzi, la stipulazione del patto compromissorio potrebbe essereproprio lo strumento attraverso il quale l’amministrazione perseguel’interesse pubblico.
E così il compromesso o la clausola compromissoria sarebberonulli per violazione di norme imperative se agli arbitri fosse concesso,ad esempio, di adottare un provvedimento riservato alla discreziona-lità dell’amministrazione (131), cosa che – ad eccezione dei limitati casidi giurisdizione di merito – non è ammessa nemmeno nei giudiziamministrativi apud judices (132).
Ma al di là di questo, se veramente quello che si potrebbe doman-dare agli arbitri altro non sarebbe che l’accertamento della legittimitàdel concreto esercizio del potere amministrativo in relazione all’inte-resse legittimo del privato, l’interesse pubblico resterebbe fuori dal-l’oggetto dell’accertamento.
Agli arbitri, in sostanza, non sarebbe richiesto di verificare se l’ammi-nistrazione – con il provvedimento impugnato – ha o meno raggiunto loscopo di perseguire l’interesse pubblico o se il provvedimento adottatoera idoneo a farlo, ma solo se il concreto atto di esercizio del potere è statoposto in essere secondo le regole che lo disciplinano e perciò se ha con-cretamente leso l’interesse legittimo del privato, a prescindere da ogni con-siderazione relativa all’interesse pubblico.
(131) A meno, direi, di non determinare ex ante i limiti minimi e massimi chegarantiscano, mercé una valutazione ex ante dell’amministrazione, il perseguimentodell’interesse pubblico; limiti entro i quali la decisione degli arbitri dovrebbe mante-nersi.
(132) Analogamente v. Romano Tassone, Poteri del collegio arbitrale e provvedi-menti amministrativi, in www.judicium.it, 2001, § 9.
PARTE V - SEZ. IV - ARBITRATO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE562
La necessità dell’amministrazione di tutelare l’interesse pubblico vapertanto intesa sotto un altro profilo e anticipata al momento della con-clusione del patto compromissorio. L’interesse pubblico, infatti, potrebbeben consistere proprio nel mantenere in vita il provvedimento: in tal casopotrebbero riaffacciarsi le preoccupazioni di Guicciardi (133), secondo ilquale, in sostanza, l’arbitro potrebbe – accogliendo la domanda di annul-lamento – vanificare il perseguimento dell’interesse pubblico.
Si pensi, ad esempio, al provvedimento viziato che ordini la demo-lizione di un fabbricato pericolante. L’amministrazione ha certamenteinteresse a che il provvedimento, ancorché illegittimo, non vengaannullato. In tal caso, l’amministrazione semplicemente eviterà la sti-pulazione del patto compromissorio e agirà in maniera autoritativa ocercherà di raggiungere un accordo transattivo.
L’amministrazione, in sostanza, è libera di concludere il pattocompromissorio secondo le sue proprie valutazioni. Se ritiene la viadell’arbitrato contraria al perseguimento del suo fine istituzionale,semplicemente non vi farà ricorso e si orienterà su altre strade.
Ed allora l’amministrazione, al momento di scegliere la via arbi-trale, dovrà sostanzialmente compiere una valutazione ex ante sullarispondenza all’interresse pubblico dell’eventuale annullamento delproprio atto. Ad esempio, potrebbe non essere certa della legittimità omeno del suo provvedimento ed essere indifferente circa la sua sorte:essa infatti potrebbe ritenere che il provvedimento, se illegittimo, nonsarebbe idoneo al perseguimento del pubblico interesse, mentre losarebbe la sua rimozione. In tal caso, il deferimento agli arbitri delpotere di accertare la legittimità dell’atto, pronunziandone eventual-mente l’annullamento, non potrebbe in nessun caso porsi contro ilperseguimento dell’interesse pubblico.
In sostanza, l’amministrazione potrebbe compiere un ragiona-mento secondo cui l’interesse pubblico è perseguito dal provvedi-mento in quanto legittimo; se invece si accerta che non lo è, l’interessepubblico è perseguito col suo annullamento; pertanto, qualunque siala decisione degli arbitri relativamente alla legittimità del provvedi-mento, l’interesse pubblico non è posto in pericolo.
(133) V. Guicciardi, Le transazioni degli enti pubblici, cit., 216/103, nota 2.
CAP. UNICO - L’ARBITRATO NEL DIRITTO AMMINISTRATIVO 563
Sul piano sostanziale, la situazione che si verrebbe a creare nonsarebbe molto diversa da quella descritta dall’art. 21 nonies l. n. 241/1990, in base al quale l’amministrazione può annullare d’ufficio ilprovvedimento amministrativo illegittimo se ne sussistono le ragioni dipubblico interesse, entro un termine ragionevole e tenendo contodegli interessi dei destinatari e dei controinteressati.
Sul piano sistematico, questa norma ha un’importanza somma. Perannullare il proprio provvedimento: a) l’amministrazione deve accer-tarne l’illegittimità; b) l’annullamento deve rispondere ad interessepubblico, in relazione all’illegittimità; c) l’annullamento deve perve-nire entro un termine ragionevole; d) si deve tenere inoltre conto degliinteressi dei destinatari e dei controinteressati.
Quando ricorrono tutti questi presupposti, l’amministrazione«può» annullare il provvedimento che essa stessa ha posto in essere:orbene, se l’amministrazione riscontra che, qualora il proprio provve-dimento fosse illegittimo, sarebbe conforme all’interesse pubblico ilsuo annullamento, non si vede per quali ragioni non potrebbe – d’ac-cordo con la controparte privata – rimettere ad arbitri l’accertamentodell’illegittimità, conferendo loro anche il potere di porlo nel nulla.Ella ha già prevalutato che l’interesse pubblico si atteggia in manieradiversa a seconda che l’atto sia o meno illegittimo; agli arbitri è chiestosolamente di accertare sul piano fattuale l’illegittimità ed eventual-mente di annullare il provvedimento facendo uso di un potere chederiva direttamente dalla p.a.
L’accertamento non riguarda l’interesse pubblico – che è statointeramente prevalutato al momento della stipula del patto compro-missorio – né si risolve di fatto nell’esercizio del pubblico potere, ma èlimitato ad una vicenda del passato significativa per l’amministrazionee per la sorte del provvedimento. Questa non si spoglia del propriopotere, né ne trasferisce l’esercizio ad un terzo, ma semplicemente –d’accordo con i destinatari e i con controinteressati – rimette agli arbi-tri il compito di accertare una situazione di fatto e di prendere provve-dimenti che, a seconda dell’esito dell’accertamento, avrebbe presoanch’essa.
Ecco allora che l’amministrazione rimetterebbe agli arbitri unpotere che rientra nella sua piena disponibilità, a seconda dell’esitodell’accertamento, mentre le valutazioni che riguardano l’interesse
PARTE V - SEZ. IV - ARBITRATO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE564
pubblico – indisponibile per l’amministrazione e legato all’attribu-zione del potere – sono state valutate a monte. Lo stesso vale, a mag-gior ragione, per il privato.
È pertanto rispettato il principio secondo cui gli arbitri derivano iloro poteri direttamente dalle parti, che dunque non possono ottenereper mezzo del dictum arbitrale risultati che sarebbero preclusi alla loroautonomia privata (134).
Lo stesso discorso vale anche nel caso di silenzio dell’amministra-zione: qualora il privato lamenti nei confronti dell’amministrazione lalesione di un interesse pretensivo, l’amministrazione – valutato che,ove il suo silenzio sia illegittimo, risponderebbe ad interesse pubblicol’emissione del provvedimento richiesto dal privato – potrebbe anchein questo caso rimettere agli arbitri l’accertamento della illegittimità,impegnandosi ad emettere il relativo provvedimento. In tal caso,peraltro, il provvedimento alla cui emissione gli arbitri potrebberocondannare l’amministrazione deve da questa essere stato previamenteindividuato in tutti i suoi aspetti, in modo che agli arbitri sia concessaesclusivamente la deliberazione circa i presupposti dell’an.
Si tratterà senza dubbio di un giudizio arbitrale sui generis, con unoggetto assai diverso da quello tradizionale. In genere gli arbitri sonoinfatti chiamati a stabilire la ragione e il torto in una controversia su«diritti» e la disciplina codicistica è stata pensata per quel genere dicontroversie.
(134) Quella degli arbitri è infatti una «giurisdizione privata» nella quale l’autonomiadelle parti non opera soltanto quale condizione necessaria per il legittimo esercizio delpotere dell’arbitro, ma svolge il ruolo di fonte attributiva di tale potere, che non può con-seguentemente esercitarsi relativamente ad un rapporto sottratto alla disponibilità delleparti; in tal senso, v.Andrioli, Commento3, IV, cit., 749 s.; Fazzalari, L’arbitrato, cit.,pp. 20, 74 s.; Id., Lodo e sentenza (ancora sulla «natura» negoziale del lodo), in Riv. dir.proc., 1990, p. 377 ss.; Id., I processi arbitrali nell’ordinamento italiano, in Riv. dir. proc.,1968, p. 459 ss., spec. p. 467;LaChina, L’arbitrato. Il sistema e l’esperienza4, Milano, 2011,p. 26;Monteleone, Ancora sull’efficacia del lodo rituale, in Riv. arb., 1991, p. 727 ss., spec.p. 735 ss.; Montesano, «Privato» e «pubblico» nell’efficacia e nell’esecutorietà del lodoarbitrale, in Riv. arb., 1998, p. 7 ss.;Punzi, Conciliazione e arbitrato, in Riv. dir. proc., 1992,p. 1028 ss., spec. pp. 1030, 1033;Rescigno, Manuale del diritto privato italiano11, Napoli,1997, p. 782; Id., Arbitrato e autonomia contrattuale, in Riv. arb., 1991, p. 13 ss.;Ruffini,Il nuovo arbitrato per le controversie societarie, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2004, p. 495 ss.,spec. p. 508; Satta, Commentario, IV, 2, cit., p. 176. V. anche supra, parte III, sez. I, n.1.5.3.2.
CAP. UNICO - L’ARBITRATO NEL DIRITTO AMMINISTRATIVO 565
Nondimeno, che l’oggetto verta su questioni relative a provve-dimenti amministrativi e che tocchi materie in cui è forte la pre-senza – seppur latente – dell’interesse pubblico non significa chel’istituto debba seguire una disciplina diversa da quella prevista dalcodice di rito, anche se una disciplina ad hoc sarebbe tuttavia quanto-meno opportuna, soprattutto per risolvere una volta per tutte le que-stioni relative alle competenze giurisdizionali collegate all’arbitra-to (135).
Una differenza fondamentale tra l’arbitrato tradizionale e l’arbi-trato su situazioni giuridiche di diritto pubblico probabilmente esistesolo al livello di patto compromissorio.
Come si è visto, infatti, nella stipulazione del patto compromisso-rio l’amministrazione deve valutare la rispondenza della via arbitraleall’interresse pubblico, rispetto alla scelta della via transattiva o del-l’annullamento d’ufficio. Potrebbe anche ritenere il suo atto piena-mente legittimo e rispondente all’interesse pubblico, e conseguente-mente non ascoltare le istanze del privato.
E proprio perché il patto compromissorio diventa momento diesercizio dell’interesse pubblico, acquista la natura sostanziale dell’ac-cordo sostitutivo di un provvedimento. L’amministrazione, infatti,avrebbe potuto agire autoritativamente, non tenendo conto delleeventuali osservazioni e proposte del privato, ma ha preferito accor-darsi con questi perché fosse un terzo ad accertare la situazione fat-tuale ed a prendere i conseguenti provvedimenti (ovvero, in caso disilenzio, ad indicare quelli da prendere).
Se così è, al patto compromissorio dovranno applicarsi in via ana-logica anche le disposizioni dell’art. 11 l. n. 241/1990, in quanto com-patibili. E così certamente sarà applicabile il comma 4o, che consenteall’amministrazione di recedere unilateralmente dall’accordo, salvoindennizzo, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. Sembraimprescindibile l’applicazione di questa disposizione anche alle con-venzioni d’arbitrato stipulate dall’amministrazione su situazioni didiritto pubblico, dal momento che la scelta di ricorrere all’arbitrato
(135) Sul punto si rinvia a Polinari, Arbitrato nelle controversie amministrative,cit., p. 522 ss.
PARTE V - SEZ. IV - ARBITRATO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE566
non può risolversi in un impedimento al perseguimento dell’interessepubblico (136).
Alcune considerazioni vanno fatte in merito al coordinamento tral’art. 817 c.p.c. – che disciplina il regime delle eccezioni relative allavalidità, contenuto e ampiezza della convenzione d’arbitrato – e ilquinto comma dell’art. 11 l. n. 241/1990, che rimette alla giurisdizioneesclusiva del giudice amministrativo le liti in materia di formazione,conclusione ed esecuzione degli accordi amministrativi. Se, come si èipotizzato, il patto compromissorio in materia di situazioni giuridichesoggettive di diritto pubblico si atteggia come un accordo ex art. 11 l.n. 241/1990, le due norme sembrano sovrapporsi quasi perfettamente.
Il primo comma dell’art. 817 c.p.c. recepisce il principio secondo ilquale spetta agli arbitri decidere sulla propria potestas judicandi inrelazione alla validità, contenuto ed ampiezza della convenzione d’ar-bitrato (137). Nel concetto di «validità» sembrano da ricomprendersitutte le ipotesi di «inesistenza, invalidità o inefficacia» contemplate dalcomma 2o della stessa disposizione (138), secondo il quale la parte chenon le eccepisce nella prima difesa successiva all’accettazione degliarbitri non può per questo motivo impugnare il lodo. Secondo l’ul-timo comma dell’art. 11 l. n. 241/1990 questo genere di eccezioni (for-mazione e conclusione) spetterebbero alla giurisdizione esclusiva delgiudice amministrativo.
Questa apparente contraddizione può essere agevolmente risoltase si riconosce la natura di disposizioni speciali alle norme del codicedi procedura civile. Il quinto comma dell’art. 11 l. n. 241/1990 attri-buisce infatti, in via generale, le controversie in tema di formazione econclusione dell’accordo alla giurisdizione esclusiva del giudice ammi-
(136) Non per una nuova valutazione dell’originario interesse pubblico. CfrCasetta, Compendio di diritto amministrativo8, cit., p. 374.
(137) V. in proposito Ruffini, in Aa.Vv., Riforma del diritto arbitrale, cit., sub art.817, p. 1308; Luiso, Rapporti fra arbitro e giudice, in Aa.Vv., La riforma della disci-plina dell’arbitrato, a cura di Fazzalari, Milano, 2006, p. 116; Verde, Lineamenti didiritto dell’arbitrato, cit., 21; per la dottrina precedente, v. Mattirolo, Trattato didiritto giudiziario civile5, I, Torino, 1902, p. 703; Andrioli, Commento3, IV, cit., p.834 s.; Vecchione, L’arbitrato nel sistema del processo civile, cit., p. 326.
(138) V. Ruffini, op. loc. ult. cit.; Polinari, Pluralità di parti e pluralità di conven-zioni d’arbitrato, in Riv. arb., 2006, p. 547, testo e nota 31.
CAP. UNICO - L’ARBITRATO NEL DIRITTO AMMINISTRATIVO 567
nistrativo, ma la scelta della via arbitrale comporta l’applicazione –come lex specialis – delle disposizioni che regolano quello strumentoe, quindi, anche dell’art. 817 c.p.c.
Un’importante conseguenza del fatto che le basi sistematiche dellacompromettibilità in arbitrato delle situazioni giuridiche di dirittopubblico e della potestà degli arbitri di incidere sui provvedimentiamministrativi siano ricavate dai principi recati dall’art. 21 nonies l. n.241/1990 consiste nella mancanza di un termine di decadenza perottenere l’annullamento del provvedimento amministrativo. Nessuntermine di decadenza è infatti previsto dalla disposizione citata perl’esercizio del potere di annullamento d’ufficio, essendo sufficienteche intervenga entro un «termine ragionevole» a tutela del legittimoaffidamento del destinatario.
Questa osservazione consente anche di superare le obiezioni diAmorth, secondo il quale il breve termine perentorio cui è sottoposto ildiritto di impugnativa dei provvedimenti davanti al giudice amministra-tivo non sarebbe compatibile con i tempi di formazione del collegio arbi-trale o di scelta degli arbitri (139). Infatti, quello che si svolge davanti agliarbitri non è un omologo del giudizio che si svolgerebbe avanti al giudiceamministrativo; la stessa struttura impugnatoria di quello non è certamentecompatibile con le caratteristiche dell’arbitrato.
L’oggetto dell’accertamento che si chiede agli arbitri è identico aquello che si svolgerebbe innanzi al giudice amministrativo, e cosìanche l’oggetto della pronuncia, ma diverso è il fondamento del giudi-zio. Il giudizio dinanzi al giudice amministrativo trae infatti fonda-mento nelle norme costituzionali che garantiscono il diritto di azioneper la tutela degli interessi legittimi (art. 24 Cost.) e, in particolare,contro gli atti amministrativi (art. 113 Cost.); viceversa, il giudizio pri-vato trae fondamento da una manifestazione di volontà delle parti e,in particolare, dalla volontà dell’amministrazione che – nell’ottica delperseguimento dell’interesse pubblico – mette autonomamente indiscussione la legittimità del proprio operato, affidando la questione agiudici privati.
(139) V. Amorth, Annotazioni sull’arbitrato nelle controversie amministrative,cit., p. 2172.
PARTE V - SEZ. IV - ARBITRATO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE568
Né si può obiettare che il ricorso all’arbitrato rappresenti, per laparte privata, un mezzo per eludere il termine perentorio di deca-denza entro cui domandare l’annullamento del provvedimento ammi-nistrativo che ritiene illegittimo. Infatti, senza la concorde volontà del-l’amministrazione, il privato non avrebbe la possibilità di provocarealtrimenti l’annullamento del provvedimento. È solo grazie all’ammi-nistrazione e all’esistenza di ragioni di interesse pubblico che potreb-bero giustificare l’annullamento del suo atto ove illegittimo che lavicenda torna in discussione.
In definitiva, l’arbitrato su situazioni giuridiche di diritto pubblicova inteso come un luogo di incontro delle volontà dell’amministra-zione e del privato interessato dall’esercizio del potere, nel quale l’esi-stenza del provvedimento viene fatta dipendere dall’esito dell’accerta-mento degli arbitri circa la sua legittimità.
Questo incontro di volontà, dal lato dell’amministrazione, rappre-senta altresì lo strumento per il miglior perseguimento dell’interessepubblico, grazie al quale – in luogo di imporre le proprie determina-zioni – acconsente a rimettere ad un soggetto terzo e imparziale l’ac-certamento delle situazioni di fatto in base alle quali avrebbe eserci-tato il suo potere. L’arbitrato finirebbe pertanto con l’inquadrarsi – insenso lato – negli schemi di amministrazione condivisa, tanto cara allegislatore dell’ultimo decennio, senza peraltro perdere le sue caratte-ristiche contenziose: la lite infatti esiste e, esattamente come avvienenel giudizio davanti al giudice amministrativo, è limitata all’accerta-mento dell’illegittimità del provvedimento, cui seguono le note conse-guenze, anche risarcitorie.
Semplicemente in tal caso è l’amministrazione che acconsente arimettere in discussione la questione che – ove sia spirato il termine diimpugnazione – sarebbe rimasta preclusa al privato, ma continua arestare pienamente nella sua disponibilità (140).
(140) Non sembra pertanto un’eresia qualificare l’arbitrato, o quantomeno il pattocompromissorio, come un accordo procedimentale di secondo grado finalizzato allarimozione di un provvedimento amministrativo solo se sé ne accerta la sua illegitti-mità. In senso analogo, seppur fortemente dubitativo, opinava – prima che la l.15/2005 introducesse l’art. 21 nonies nella l. n. 241/1990 – Romano Tassone, Giuri-sdizione amministrativa e arbitrato, cit., p. 265, secondo il quale «solo se l’amministra-
CAP. UNICO - L’ARBITRATO NEL DIRITTO AMMINISTRATIVO 569
zione ritenesse di pervenire ad un accordo ex art. 11 l. n. 241/90 in sede di procedi-mento di secondo grado, sarebbe quindi possibile, ma in via mediata e non per virtùpropria, che un ipotetico lodo arbitrale su tale ultimo accordo finisse con l’incideresul provvedimento originario». In senso analogo, v. addirittura il risalente, ma tuttorafondamentale, scritto di La Torre, L’arbitrato nel diritto amministrativo, cit., p. 340,che pure sostanzialmente immagina la potestà di annullamento del provvedimentocome un procedimento di secondo grado. L’A., infatti, seppure propende per l’esclu-sione della potestà di annullamento, ritiene ipotizzabile una pronuncia di illegittimitàda parte degli arbitri, alla quale l’amministrazione potrebbe prestare acquiescenza invia preventiva, impegnandosi così, eventualmente, ad agire in autotutela per l’annulla-mento dell’atto, dopo l’emanazione del lodo che lo abbia ritenuto illegittimo.
PARTE V - SEZ. IV - ARBITRATO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE570