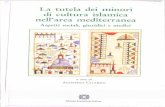La tutela del diritto dautore nel web 2 0
Transcript of La tutela del diritto dautore nel web 2 0
Indice
Introduzione………………………………………………………………………………………p.3
1. Il dibattito ideologico sul diritto
d’autore……………………………………………….......p.5
2. La nascita e la natura del diritto
d’autore…………………………………………………..p.6
3. Dalla pirateria al peer-to-peer…………………………………………………………...…..p.7
4. Esempi di enforcement della protezione del diritto
d’autore……………………………...p.8
5. Copyleft, l’altra faccia del
copyright………………………………………………………...p.9
6. Creative Commons: un copyright flessibile per le opere
creative………………………..p.10
7. CC e SIAE: la situazione italiana…………………………………………………………..p.15
8. Copyzero: cos’è e come funziona…………………………………………………………..p.16
Conclusioni………………………………………………………………………………………p.18
1
Bibliografia……………………………………………………………………………………....p.19
Introduzione
Il presente lavoro vuole essere un contributo al dibattito sempre
più pressante circa il complesso tema del diritto d’autore in
Internet. Con gli sviluppi tecnologici verificatosi soprattutto
negl’ultimi anni, l’accostamento di questi due termini sembra
essere sempre più problematico, stravolgendo completamente gli
equilibri. Un inquadramento sulle norme vigenti, sugl’enti e sulle
trasformazioni che stanno segnando il diritto d’autore, possono
aiutare a capire meglio perché questo tema è tanto vivo nel
dibattito contemporaneo e soprattutto perché in continuo work in
progress.
Prima di passare in rassegna gli argomenti che verranno trattati
nel paper è necessario dare una definizione teorica del diritto
d’autore, e del copyright che verranno più volte citati nel testo e
che non sono propriamente la stessa cosa.
2
Per diritto d'autore si intende la posizione giuridica soggettiva
dell'autore di un'opera, al quale si riconosce la facoltà
esclusiva di diffusione e sfruttamento, attraverso ordinamenti
nazionali e convenzioni internazionali. Nel linguaggio e nel
pensiero comune spesso si tende a confondere le espressioni
copyright e diritto d'autore ma, nonostante alcune similitudini,
tra i due termini vi sono importanti differenze. Il diritto
d’autore è un modello appartenente ai Paesi di civil law, tra cui
l’Italia, mentre il copyright appartiene agli ordinamenti di
common law, come ad esempio Inghilterra e Stati Uniti, e nasce con
lo scopo di promuovere l'industria culturale americana. Se
guardiamo al significato etimologico del termine, copyright
significa “diritto di copiare”, e fa riferimento al diritto di
riprodurre un’opera, tutelando gli interessi dei soggetti che
investono sulla sua commercializzazione. Per quanto riguarda
invece il diritto d’autore, è chiaro già che l’attenzione è
maggiormente rivolta all'autore, che infatti nel nostro
ordinamento può rivendicare i suoi diritti, anche con la
cessazione dei diritti patrimoniali. Il lavoro si struttura in
otto paragrafi, ognuno dei quali ha approfondito determinati
aspetti circa il tema molto delicato della tutela del diritto
d’autore nell’era del Web 2.0.
Il primo paragrafo introduce le posizioni ideologiche circa la
questione, che vede schierarsi da un lato i “progressisti” e
dall’altro “gli estremisti della proprietà” intellettuale.
Nel secondo paragrafo si affronta in un quadro storico la nascita
e l’evoluzione del diritto d’autore, e la differenza che vige con
il concetto di brevetto. Nel mondo antico la riproduzione e la3
diffusione delle opere rappresentavano dei procedimenti che
costavano soprattutto molto tempo, problema che venne poi superato
grazie all’introduzione della stampa a caratteri mobili. E’ nel
‘500, che si identificano i primi tratti del diritto d’autore, con
la concessione dei cosiddetti “privilegi” alle tipografie, a
all’imprimetur per le autorità ecclesiastiche.
Nel terzo paragrafo si analizza il fenomeno di pirateria, che da
sempre rappresenta un grosso problema per la violazione di tale
diritto, e di come sia diventata ancora più ingestibile
soprattutto in seguito alla diffusione di Internet e della
condivisione peer- to-peer. Il caso che ha dato inizio molto
probabilmente alla lotta alla pirateria in Internet è stato
Napster, subito sostituito da Emule, che ha eluso le regole sul
copyright, basandosi su un software applicativo open source dedicato
alla condivisione file che si appoggia su una rete peer to peer.
Negli Stati Uniti e in alcuni paesi europei, come la Francia, la
Spagna, La Gran Bretagna, la Svezia, il Belgio e la Germania, sono
stati attuati dei provvedimenti a tutela del diritto d’autore, che
vengono presentati nel dettaglio nel quarto paragrafo.
Nel quinto paragrafo è stato trattato il concetto di copyleft, che
nasce da un gioco di parole sul termine copyright, e si identifica
come risposta, su iniziativa di Richard Stallman, alla rigidità
dei modelli di copyright.
In un momento in cui i contenuti sono sempre più generati
dagl’utenti e resi disponibili a tutti, nasce l’esigenza di
istituire nuove modalità di tutela del diritto d’autore, senza
“soffocare” la creatività degli utenti. La risposta a questo è
stata data da Lawrence Lessig, con le licenze di Creative Commons,4
che da il nome anche all’ente no profit, di cui ne è il fondatore.
Le licenze di Creative Commons rappresentano dunque un’alternativa di
copyright flessibile per le opere creative, dove l’autore, o meglio
il licenziatario, decide quali diritti concedere.
Nel sesto paragrafo ne vengono elencate e discusse la struttura,
le tipologie e il procedimento di produzione.
Il settimo paragrafo affronta invece la situazione italiana.
Mentre per molti Paesi europei la tutela dei diritti d’autore
viene affidata a società esterne, in Italia l’unica società che
garantisce tali diritti è la SIAE, un ente pubblico che ne detiene
il monopolio e che ha la peculiarità di tutelare sia gli autori
sia gli editori. L’ottavo ed ultimo paragrafo tratta invece di
Copyzero, un’idea che nasce a Milano, e che ha lo scopo di garantire
il diritto d’autore a costo zero.
1.Il dibattito ideologico sul “diritto d’autore”
La controversa questione della regolazione di Internet, con
particolare attenzione all’offerta e alla fruizione di opere
culturali oltre ad avere una rilevante dimensione giuridica ha
anche dimensioni economiche e sociali.
Nel quadro del capitalismo contemporaneo, fortemente
caratterizzato dai fenomeni di globalizzazione e digitalizzazione,5
assumono particolare importanza la tutela del “diritto d’autore” e
la lotta alla pirateria. Intorno alla questione, si sono
sviluppati numerosi dibattiti, identificabili come due estremi di
un continuum ideologico. Da una parte infatti troviamo i cosiddetti
“progressisti” che identificano la Rete come una sorta di panacea
per la democrazia, per la cultura ma anche per l’economia,
dall’altro lato, invece, si posizionano i cosiddetti “estremisti
della proprietà intellettuale” che vedono il copyright come
strumento perverso dei poteri forti, delle multinazionali e delle
major, di sistemi chiusi, e antidemocratico.
Nella prima schiera ritroviamo autori come Pierre Levy, filosofo
francese, che interessandosi allo studio dell’impatto di Internet
sulla società, ha approfondito il concetto di “intelligenza
collettiva”, un particolare modo di funzionamento
dell’intelligenza, che permetta alla comunità di cooperare
mantenendo prestazioni intellettuali affidabili. Tra questi
pensatori ritroviamo anche Henry Jenkins che ha sviluppato il
concetto di “cultura partecipativa”, definendola come una cultura con
barriere relativamente basse per l’espressione artistica e l’impegno civico, che dà un forte
sostegno alle attività di produzione e condivisione delle creazioni e prevede una qualche
forma di menthorship informale, secondo la quale i partecipanti più esperti condividono
conoscenza con i principianti. (Jenkins, 2008). Dall’altra parte, invece,
tra i pensatori definiti “estremisti della proprietà
intellettuale”, ritroviamo Lawrence Lessig un giurista americano
noto per le sue critiche all’estensione del diritto d’autore e che
ha inoltre formalizzato il concetto di “cultura libera”, dove per
“libera” egli intende lo stesso concetto presente in “libertà
d’espressione, libero mercato, libero commercio, libertà di6
impresa, libera volontà e libere elezioni” Per Lessig infatti una
cultura libera deve tutelare i creatori ma anche gli innovatori, e
i diritti di proprietà intellettuale tutelano i primi, ma
restringono i secondi, limitando l’accesso alla conoscenza. Ad una
cultura libera si contrappone una “cultura del permesso”, dove
coloro che creano possono farlo solo con il permesso dei potenti o
creatori del passato. (Lessig, 2004)
2.La nascita e la natura del diritto d’autore
Nel mondo antico la riproduzione fisica di un testo, avveniva
grazie ad un procedimento molto dispendioso sia di tempo che di
costi, grazie agli amanuensi, e che per queste ragioni portava
alla produzione di pochissime copie. Ma questa pratica non veniva
considerata un illecito, in quanto rappresentava l’unico modo per
poter diffondere la conoscenza.
Nell’antica Roma, non venivano riconosciuti diritti patrimoniali
sull’opera, in quanto la trascrizione su di un manoscritto
rappresentava un semplice supporto materiale, che consentiva
l’accesso alla conoscenza del pubblico. Il compenso che gli autori
ne traevano era di tipo pubblicistico, per così dire, in quanto
consentiva loro di esibire il loro sapere ed attrarre così
l’attenzione dei mecenati, che riconoscendone il valore e
l’esperienza in determinati ambiti, avrebbero commissionato loro
altri lavori. Gli autori, dunque, si sostentavano economicamente
grazie ai rapporti clientelari con i mecenati.
7
Con l’avvento della stampa a caratteri mobili, dovuta al tipografo
tedesco Johann Gutenberg nel 1455, soprattutto grazie alla
diffusione di questa a livello industriale e all’invenzione della
rotativa, ad opera di Hyppolite Marinoni, che permetteva la stampa
di migliaia di copie su un nastro continuo di carta.
Nel ‘500, alle tipografie venivano concessi i privilegi, trattandosi di
enti laici, mentre l’imprimatur1 per le autorità ecclesiastiche. E’
da questo momento che iniziano a delinearsi i tratti fondamentali
nell’ambito del diritto d’autore, così come lo intendiamo oggi, e
a istituirsi le figure soggettive che interagivano nella materia,
come l’autore, a cui spettava l’edizione dell’opera, l’editore a
cui spettava la trasformazione dell'opera in bene di mercato, la
(ri)produzione industriale e la commercializzazione dell'opera;
infine il fruitore, che acquistava e utilizzava l'opera.
L’interazione di questi soggetti iniziò a consolidare una serie di
rapporti economici sempre più considerevoli, tali da rendere
necessaria la creazione di regole per tutelare gli interessi di
tutti i soggetti, determinando così la nascita del diritto
d’autore.
E’ doveroso a questo punto fare una distinzione tra diritto
d’autore e brevetto, infatti sono due strumenti di tutela
differenti sia nelle caratteristiche sia nei campi d’applicazione.
Il primo riguarda infatti le opere d’ingegno, mentre il secondo
attiene alle invenzioni industriali.
Il diritto d’autore si occupa di tutelare le opere di carattere
creativo, e dura fino a 70 anni dalla morte dell’autore. Cosa1 Da Nihil obstat quominus imprimatur, espressione latina che si traduce “non esiste alcun impedimento al fatto di essere stamapato” , ed era l’espressione utilizzatadalla Chiesa Cattolica che autorizzava la riproduzione dell’opera.
8
diversa è ciò che riguarda il brevetto, in quanto esso tutela
invenzioni e modelli di utilità, e viene costituito a seguito di
una concessione, ottenibile solo dopo aver fatto un iter di
registrazione2; per essere tutelabile l’opera deve essere un’attività
inventiva, una novità, deve avere applicazione industriale, deve
possedere il carattere della leicità.
3.Dalla pirateria al peer to peer
Con l'avvento dei riproduttori e la diffusione dei computer e
degli accesi ad Internet, nel XX secolo, è stato sempre più
difficile regolamentare la tutela del copyright, come
tradizionalmente intesa. Uno dei casi che ha avuto maggiore
clamore, che ha avuto eco internazionale, è stato la chiusura di
Napster, uno dei primi sistemi di condivisione gratuita di file
musicali, oggetto di enorme successo a cavallo tra il XX ed il XXI
secolo. La chiusura di Napster, avvenuta nel 2002 e generata dalle
denunce dagli editori che vedevano nel sistema un concorrente ai
propri profitti, non ha risolto se non per breve tempo gli
attriti.
2 Le fasi della concessione di un brevetto variano a seconda dell’ufficiobrevetti competente anche se, in maniera generale, esse tendono a seguire unoschema comune che consiste in: (1)un esame informale in cui l’ufficio brevettiesamina la richiesta per assicurarsi che la stessa contenga tutti i requisitiamministrativi e formali richiesti, (2) una ricerca d’anteriorità sullo statodell’arte esistente, (3) un esame sostanziale per assicurarsi che la domandasoddisfi i requisiti di brevettabilità, (4) la pubblicazione della domanda dibrevetto che avviene 18 mesi dopo il primo deposito della stessa, (5) infine sela procedura d concessione si conclude positivamente l'Ufficio Brevetti concedeil brevetto ed emette il relativo certificato di concessione. La nota informativa è reperibile dal sito http://www.sviluppoeconomico.gov.it/
9
Subito dopo Napster sono nati dei nuovi programmi di file sharing
a titolo gratuito, rimpiazzando l'originale Napster e vanificando
gli scopi della chiusura.
Secondo gli operatori del mercato dell'intrattenimento, la
costante diminuzione delle vendite di cd musicali è scaturita
dalla diffusione di questi sistemi.
Il file sharing (scambio e condivisione di file) di materiale protetto
dal copyright, si è sviluppato e diffuso con l'imporsi delle
tecnologie informatiche e del web, e in particolar modo grazie al
sistema del peer-to-peer. La velocità di questa diffusione e
sviluppo, ha reso difficile per il diritto industriale
internazionale aggiornarsi con la medesima prontezza.
La guerra contro la pirateria esiste fin dalla nascita di una
legislazione atta a regolare la proprietà creativa. Dunque, oggi
con questi nuovi presupposti, sorti soprattutto grazie al potente
strumento Internet, ci troviamo nel bel mezzo di un’altra guerra
contro la pirateria, che consente la diffusione di innumerevoli
contenuti in modo semplice, veloce e soprattutto legale. Il
problema allora dove sorge? Nel momento in cui vengono condivisi
contenuti, che non sempre rispettano il diritto d’autore, in
quanto la Rete non attua una discriminazione tra contenuti
tutelati e non tutelati del diritto d’autore. Dunque la
preoccupazione riguarda i detentori del copyright, in quanto la
condivisione può defraudarli del loro profitto. Il dato di fatto è
che la pirateria rappresenta un illecito, e con l’introduzione
delle nuove modalità di condivisione del peer-to-peer la tutela del
diritto d’autore è diventata ancora più ingestibile.
10
4.Esempi di enforcement della protezione del diritto
d’autore
In molti Paesi europei, ma anche negli Stati Uniti, sono stati
adottati alcuni piani enforcement per la protezione del diritto
d’autore in Internet. In Francia esiste un’istituzione, la
cosiddetta HADOPI (acronimo di Haute Autorité pour la diffusion
des oeuvres et la protection des droits sur l'Internet) che si
occupa che venga applicata e rispettata la legge dedicata al
diritto d’autore in Internet entrata in vigore nel 2010, che è
stata al centro di numerose polemiche. E’ un modello cosiddetto a
tre step, in quanto dal momento in cui viene scoperta una
violazione del copyright, vengono inviati due avvisi, il primo per
email, il secondo tramite raccomandata postale, nell’arco
temporale di 6 mesi, dopodiché l’Autorità segnala il caso al
pubblico ministero, che può decidere anche di portarlo in Corte
penale nei casi più gravi. La sanzione può essere la sospensione
dell’accesso alla rete per un anno, sanzioni pecuniarie fino a 300
mila euro, e nei casi più gravi addirittura fino a 3 anni di
detenzione.
Nel Regno Unito vige, invece, il Digital Economy Act, approvato
nel 2010, che può essere definito come un modello a due step. Un
primo step è definibile pedagogico, e si caratterizza per
l’obbligo di inviare un messaggio di avviso agli utenti sospettati
di download illegale, da parte di coloro che forniscono l’accesso
alla risorsa. Il secondo step prevede invece l’intervento del
giudice con la possibilità di blocco della connessione. Dunque, la
11
differenza con il modello francese, sta nel fatto che si è deciso
di intervenire sull’operatore di Rete piuttosto che sul fruitore.
Per quanto riguarda la Spagna è stata approvata una legge
denominata di “economia sostenibile”, che permette al Comitato per
la proprietà intellettuale (IPC), un ente che dipende dal
Ministero della Cultura, ed approvata nel 2011, di poter
richiedere la rimozioni entro 48 ore di contenuti che violano il
copyright a siti web sospettati di violazione. Il comitato viene
contattato da chi ritiene violati i propri diritti, e dopo le
opportune verifiche emana un’ingiunzione al responsabile del sito
Internet di ritirare i contenuti giudicati illeciti. Colui che
viene accusato ha diritto a difendersi ed il Comitato ha tre
giorni per sottoporre l’istanza all’attenzione del giudice che
dovrà poi deliberare, una soluzione alla controversia. Nel caso in
cui invece, non c’è risposta da parte del responsabile del sito,
il comitato può interromperne le attività.
In Svezia, nel 2009 è stata approvata la cosiddetta legge IPRED
che obbliga i fornitori di accesso a comunicare i dati
identificativi dell’utente che ha commesso atti di pirateria,
scoperto attraverso l’indirizzo IP, agli aventi diritto, sempre su
richiesta del giudice. Essi possono mandare un avvertimento
all’utente, chiedendogli di interrompere la pratica, oppure
procedere attraverso mezzi giudiziari.
In Belgio è ancora in discussione una proposta di legge del 2011
che prevede un modello a tre fasi: una prima fase è caratterizzata
da un avviso, una seconda fase è costituita dal pagamento di una
somma pecuniaria per evitare l’azione giudiziaria, ed una terza
12
fase costituita dal pagamento di una multa e limitazione di
accesso a Internet).
In altri Paesi europei, in primis Germania, il dibattito
legislativo-regolamentativo è ancora in corso.
Nel 2013 negli Usa, in seguito alla proposta e al successivo
ritiro del 2010 delle proposte Sopa e Pipa, che prevedevano un
intervento normativo forte, è stato introdotto un modello definito
dei “6 colpi”: il Copyright Alert System (Cas), che vede prevalere la
funzione educativa, informativo-dissuasivo-preventiva, su quella
punitiva, promossa da 5 internet provider (Verizon, Time Warner,
Cablevision, Comcast, At&t). Colui che è sospettato di violare il
copyright riceverà prima 6 warning: i primi due hanno un intento
educativo, i successivi due avvisi richiedono una risposta, ed
infine gli ultimi due, inviati nel caso di mancata cessazione del
comportamento lesivo della proprietà intellettuale, con una
riduzione di banda e/o di reindirizzamento verso un’apposita
pagina di ulteriore allerta.
5.Copyleft, l’altra faccia del copyright
La dicitura copyleft, che tradotto in italiano significa “permesso
d'autore”, prende spunto da un gioco di parole sul termine
copyright. “Right” infatti significa diritto, in senso giuridico, ma
può significare anche “destra”. Right nel gioco di parole viene
dunque scambiata con “left”, che tradotto significa appunto
“sinistra”. Esso rappresenta un modello di gestione di diritti
d’autore alternativo, in quanto adotta un sistema di licenze con
13
le quali è l’autore a decidere le modalità di fruizione della sua
opera.
Il copyleft nasce in risposta all'irrigidirsi del modello
tradizionale di copyright, grazie a Richard Stallman, il quale
stava lavorando ad un software che interpretasse un particolare
linguaggio di programmazione. Un’azienda, la Symbolics, lo
avvicinò e gli chiese una versione del software a cui stava
lavorando, e Stallman gliela fornì senza alcuna esitazione. La
Symbolics apportò delle migliorie al software, ma quando Stallman
chiese di poter accedere al nuovo software, l’azienda non mostrò
la stessa disponibilità che aveva mostrato lui nel cedergliela.
Vittima di questa ingiustizia, e consapevole delle difficoltà che
avrebbe incontrato nel combattere le norme vigenti in materia di
copyright, iniziò a lavorare alla creazione di una propria licenza.
Ne venne fuori la GNU general public licence, una prima licenza di
copyleft. La licenza garantiva al detentore del copyright la tutela
dei suoi diritti, imponendoli anche a coloro che usufruivano del
programma, a prescindere dalle modifiche apportate al programma
originale. In poche parole il programma poteva essere modificato,
da chiunque volesse, mantenendo il diritto di paternità. Oltre
alla GNU, un altro esempio di licenze copyleft è costituito dalle
Creative Commons, con la clausola “share alike”. Il copyleft,
sfruttando i principi di base del diritto d’autore per definire le
modalità di diffusione dell’opera, non può esistere senza il
copyright.
Una licenza di copyleft si basa sul principio che chiunque possegga
una copia dell'opera, deve rispettare i diritti propri dell’autore
14
nella diffusione. Questi diritti sono identificati da Stallman
nelle quattro libertà:
Libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo.
Libertà di studiare il programma e modificarlo.
Libertà di ridistribuire copie del programma in modo da
aiutare il prossimo.
Libertà di migliorare il programma e di distribuirne
pubblicamente i miglioramenti, in modo tale che tutta la
comunità ne tragga beneficio.
Dunque, un programma è software libero se la licenza consente tutte
queste libertà.
Va però a questo punto che, nel diritto d'autore italiano,
l'assenza di una norma specifica che regolamenti queste
possibilità, può creare problemi di validità giuridica,
analogamente a quanto accade per altri modelli di gestione
"aperta" del diritto d'autore come Creative Commons.
6.Creative commons: un copyright flessibile per le
opere creative
Nell’odierno scenario del Web 2.0, la cultura è continuamente
generata dagli utenti. Questa è definita per l’appunto user generated
content, in quanto prende vita da una continua contaminazione di
forme, linguaggi e opere differenti. Dunque, appare sempre più
rilevante la questione circa la regolamentazione giuridica della
creatività e dei suoi metodi. Ci troviamo nell’era del continuo
15
ReMix, ReCut up, MashUp e melting pot culturale, che pongono numerose
questioni sul rapporto tra le normative del diritto d’autore e la
fruizione del sapere. Secondo Lawrence Lessig, “la cultura libera
rappresenta il nostro passato, ma sarà il nostro futuro solo se
riusciremo a cambiare la strada che stiamo percorrendo ora” , e
che “la creatività sarebbe maggiormente favorita, se la componente
legale del processo creativo diventasse più lineare”. (Lessig,
2004)
Una risposta alla questione è stata data dalla Creative Commons
Public Licenses (CCPL), licenze di diritto d'autore che si basano
sul principio “alcuni diritti riservati”.
In sostanza, le CCPL consentono al titolare dei diritti d’autore
di poter dare in modo esplicito il permesso alla fruizione,
riproduzione e diffusione delle loro opere. Il funzionamento è
semplice: il licenziante, cioè il titolare dei diritti, concede i
diritti, o parte di essi, al licenziatario, cioè il fruitore
dell’opera.
Va però puntualizzato, che queste licenze, non costituiscono le
fonti del diritto d’autore, ma rappresentano solo lo strumento
attraverso cui il licenziatario concede alcuni permessi, cosa
diversa dalla legge, che è invece fonte di tale diritto.
Il progetto Creative Commons nasce nel 2001, per volontà di alcuni
giuristi esperti della Rete e della proprietà intellettuale, tra
cui il massimo esponente Lawrence Lessig.
Le Creative Commons si pongono come mission quella di porsi come
baricentro tra i due estremi, costituiti da un lato dal Copyright,
con “tutti i diritti sono riservati”, e dall’altro Il Pubblico
16
dominio dove “nessun diritto è riservato”, come riportato dal
seguente schema grafico:
L’obiettivo principale delle CC è, dunque, quello di “fornire ad autori
e titolari di diritti oggetto della licenza un semplice modo per comunicare quali libertà
vogliono associare alla propria opera. Ciò rende semplice la condivisione o la creazione di
opere derivate. Rende possibile agli autori e ai licenzianti conservare alcuni diritti. Questa
è fondamentalmente la nostra missione. Il diritto d’autore dà agli autori certi diritti.
Vogliamo rendere semplice agli autori esercitare quei diritti in modo che gli altri possano
capire i loro intenti”.3 Una licenza Creative Commons si esprime in tre
forme: il Legal Code (lett. codice legale), il Commons Deed (lett.
atto per persone comuni), in un formato che le persone comuni
possano leggere, ed il Digital code (i metadati).
Il Legal Code, un testo di licenza con valenza legale, che si
compone di alcune premesse e di otto articoli, che disciplinano
l’applicazione e la distribuzione. E’ caratterizzato dunque da un
linguaggio e da una formattazione giuridica, per cui non è
comprensibile a tutti. Per questa ragione, è stato realizzato il
Commons Deed, un testo scritto in un linguaggio chiaro e
accessibile a tutti, corredato da loghi di identificazione e icone
intuitive atte a facilitare la comprensione del contenuto delle
3 Fonte: http://creativecommons.it/17
singole licenze. E’ offerto, inoltre, in moltissime lingue diverse
e presenta dei link per eventuali approfondimenti. In esso è
comunque presente un collegamento al Codice legale, l’unico in
grado di identificare la licenza e le sue norme e la nota di
“Limitazione di responsabilità”, che recita: “Il Commons Deed non
è una licenza. È semplicemente un utile riferimento per capire il
Codice Legale (ovvero, la licenza completa), di cui rappresenta un
riassunto leggibile da chiunque, di alcuni dei suoi concetti
chiave. Lo si consideri come un'interfaccia amichevole verso il
Codice Legale sottostante. Questo Deed in sè non ha valore legale
e il suo testo non compare nella licenza vera e propria.
L'associazione Creative Commons non è uno studio legale e non
fornisce servizi di consulenza legale. La distribuzione, la
pubblicazione o il collegamento tramite link a questo Commons Deed
non instaura un rapporto avvocato-cliente”.
Il Digital Code rappresenta infine, la terza forma in cui si esprime
una licenza CC e non è altro che la codifica della licenza in un
formato digitale, che può essere inserita all’interno dell’opera
attraverso procedimento di incorporazione, di poche righe di
codice, e leggibile dai computer. Di seguito è riportata un
immagine, atta a semplificare quanto detto circa la Commons Dead.
18
Fonte www.creativecommons.org
Dalla combinazione di quattro clausole fondamentali si ottengono
sei tipologie di Creative Commons, ciascuna conforme alle esigenze
e agli usi che il licenziante vuole concedere ai suoi fruitori. Di
seguito è riportato, uno schema grafica che sintetizza questi sei
modelli:
19
Per comprendere queste sei tipologie, è necessario a questo punto
andare a definire le quattro clausole, rappresentate dai quattro
simboli:
Attribuzione (Attribution, BY): rappresenta la clausola che
richiede di citare in modo chiaro l’autore dell’opera; anche
quando si tratta di un opera derivata persiste l’obbligo di citare
autore e fonte di partenza persiste.
Condividi allo stesso modo (Share Alike, SA): rappresenta la
clausola per cui le opere derivate da un’opera registrata con
licenza CC in cui è presente questa stessa clausola, possono
essere distribuite solo con la stessa identica licenza dell’opera
originaria. Questo principio si deve mantenere per ciascuna opera
20
che derivi da quella originaria con tale licenze, ma anche per la
derivata della derivata e così via.
Non commerciale (Non-commercial, NC): è la clausola che pone
la condizione per cui chi distribuisce o copia l’opera, non può
farlo a scopi commerciali, né per trarre un compenso economico.
L’autore concede alcuni diritti, ma si riserva quello di
sfruttamento commerciale dell’opera, lasciando solo a lui la
decisione di come commercializzare l’opera, cedendo il diritto ad
un soggetto imprenditoriale che sia esso un editore, o un
discografico, in cambio di un compenso economico.
Non opere derivate (No derivative Works, ND: è la clausola
per cui l’opera non può essere alterata e non ne sono concesse
modifiche. L’opera deve essere riprodotta integralmente. E nel
caso in cui si intendesse modificare, tradurre o correggere
l’opera, è necessario richiederne il permesso all’autore.
A questo punto, una volta che sono state definite le quattro
clausole di base possiamo identificare le sei licenze, con la
descrizione delle caratteristiche di ciascuno.
21
Fonte: www.cretivecommns.it
7.CC e SIAE: la situazione italianaMolti autori, in molti Paesi del mondo,per la gestione dei diritti
delle proprie opere, si affidano a società di gestione
collettiva. Molte di queste società richiedono il trasferimento di
questi diritti, diventandone esse stesse titolari, e li gestiscono
per conto dell’autore che vi è iscritto. Creative Commons è
impegnata con le società di gestione collettiva di numerosi paesi
22
per risolvere il problema di compatibilità tra le libertà proprie
dell’autore, che le licenze CC permettono di gestire in maniera
semplice e immediata, e l’amministrazione delle stesse delegate a
queste società.
Per quanto riguarda l’Italia, esiste una sola società che si
occupa di questo, detenendone il monopolio, ed è la SIAE.
La Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) 4 è un ente
pubblico economico a base associativa, fondato nel 1882, che si
occupa della protezione e dell'esercizio dei diritti d'autore
(copyright) e nello specifico di:
- concedere licenze e autorizzazioni per lo sfruttamento economico
di opere, per conto e nell'interesse degli aventi diritto
- percepire i proventi derivanti dalle licenze/autorizzazioni
- ripartire i proventi tra gli aventi diritto
- come prescritto dagli articoli 180-183 della legge sul diritto
d'autore, agire come ente intermediario tra il pubblico e i
detentori dei diritti
- esercitare inoltre altri compiti connessi con la protezione
delle opere dell'ingegno e assumere, per conto dello stato, di
enti pubblici o privati, servizio di accertamento e di percezione
di tasse, contributi, diritti.
La peculiarità è che la SIAE rappresenta l’unica società in Italia
che tutela sia gli autori che gli editori. Né la SIAE né le
licenze CC creano il diritto d’autore, ma questo si istituisce nel
momento in cui un’idea, viene resa esplicita su di un supporto
fisico. Da questo momento l’opera è protetta dal diritto d’autore.
L’autore italiano che si iscrive alla SIAE, cede a quest’ultima i
4Cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Siae23
diritti delle sue opere, affidandosi sia per la concessione di
licenze e utilizzazioni delle proprie opere sia per la riscossione
e la distribuzione dei compensi e accettando di non accordare
libertà a terzi. Dunque non potrà neanche licenziare le proprie
opere con la licenza Creative Commons.
8.Copyzero: cos’è e come funziona
In molti casi, chi si affida alla SIAE, per la tutela della
propria opera, non percepisce alcun ritorno economico, ed è anche
obbligato a versare delle cifre per ricevere tale tutela, che non
sempre tutti possono versare (per il deposito di un'opera SIAE
chiede all'associato euro 65,00 e al non associato euro 131,81 e
da corrispondere ogni 5 anni per il rinnovo). Il diritto d'autore
comprende il diritto morale d'autore (in primis, il diritto alla
paternità intellettuale) e il diritto allo sfruttamento economico
dell'opera. Per queste ragioni, nasce Copyzero, che tutela il
diritto d’autore ad un costo di 0,36 euro, garantendo così a tutti
prima di tutto il diritto alla persona. Questo progetto è stato
promosso dal Movimento Costozero, un’associazione no profit, la cui
mission è incentrata principalmente sulla gratuità del diritto alla
comunicazione. Copyzero, un’idea nata a Milano, ma che rapidamente
ha investito l’intero web, nasce con lo scopo di tutelare il
diritto d'autore (copyright), l’open content e soprattutto il permesso
d’autore (copyleft) a costo zero. Il meccanismo su cui si basa
essenzialmente è la firma elettronica qualificata e la marca
temporale, fondamentale per attestare la prova della creazione di
24
una determinata opera in un dato momento, e quindi riuscire a
posizionarla in un ordine cronologico rispetto alle altre. Questa
marca vale circa 20 anni dalla data d’emissione.
La firma elettronica ha invece lo scopo di attestare la paternità
dell’opera, tutelandone i diritti patrimoniali dell’opera.
Rappresenta dunque una modalità di certificazione, molto
vantaggiosa, se paragonata alla procedura della SIAE.
Il procedimento appare abbastanza semplice. L’autore deve per
prima cosa, trasformare la sua opera in formato digitale.
Successivamente, inserisce i dati di copyright ed eventualmente la
licenza. Infine, inserisce la firma e la marca con l’utilizzo di
una smart card, il relativo lettore ed uno specifico software. La smart
card può essere acquistata solo presso l’Ente Certificatore, che
rilascia un certificato digitale di sottoscrizione, con tutti i
dati del titolare dalla smart card, l’attribuzione di una chiave
pubblica e informazioni circa il periodo di validità. A questo
punto, il titolare entra a far parte di un elenco pubblico,
consultabile anche online, dove chiunque può verificare la validità
dl certificato.
25
Conclusioni
Il presente lavoro ha toccato diversi aspetti circa la questione
del diritto d’autore, su alcuni più in profondità, su altri meno,
e di certo non aveva la presunzione di rispondere alle questioni
circa il dibattito venutosi a creare intorno ad esso, ma fornire
spunti di riflessioni soprattutto in conseguenza del fatto che
oggi rappresenta, e lo sarà sempre più, una questione molto
delicata.
La questione del diritto d’autore non tocca solo l’ambito
giuridico, ma anche quello sociale e soprattutto di tipo
economico.
Secondo alcuni la produzione di opere proprie è il miglior
antidoto per sconfiggere la pirateria in quanto produrre opere
proprie fa rendere conto dello sforzo che c’è dietro la creazione
di cultura. Esiste una produzione culturale creata dagli utenti
stessi, che cooperano e che diffondono all’interno della Rete.
Possiamo rilevare che il sistema del diritto d'autore, come noi lo
conosciamo oggi, è stato segnato da profondi cambiamenti storici e
sociali, a partire dalla nascita della stampa massiva a livello
industriale e dall'avvento della cosiddetta società
26
dell'informazione, a seguito delle profonde trasformazioni portate
dalle tecnologie digitali e dalla diffusione globale di Internet.
Un punto in comune tra questi due eventi storici è il radicale
cambiamento della fruibilità e della circolazione delle opere,
prima con la carta stampata e successivamente con il supporto
digitale attraverso la Rete, che ha imposto alla società di
adottare nuovi strumenti legislativi per rimanere al passo con i
tempi e con le logiche economiche mutate a seguito di questi
fatti. Ciò ha determinato un progressivo mutamento normativo,
introdotto dalle convenzioni internazionali e dalle direttive
comunitarie in ambito europeo, a cui l'Italia si è man mano
adeguata seguendo l'orientamento comune degli Stati europei. In
questo scenario di rivoluzione digitale ed evoluzione della
società, la vera sfida sarà andare oltre le consuetudini e i
pregiudizi odierni, e non soffocare più le grandi opportunità che
le tecnologie digitali offrono per incoraggiare la creatività e la
collaborazione.
La differenza che determinerà il futuro, sarà incentrata su come i
detentori dei diritti comunicheranno i loro intenti agli altri,
eliminando l’ostacolo di leggi complicate e barriere tecnologiche
che fino ad oggi hanno portato molti ad ignorare le regole o a non
esercitare la propria creatività.
Bibliografia,27
- Aliprandi S., Capire il copyright, Piacenza, PrimaOra, 2007
- Aliprandi S., Creative Commons: manuale operativo. Guida all’uso delle licenze e
degli altri strumenti CC, Stampa Alternativa, Viterbo, 2008.
- Aliprandi S., Teoria e pratica del copyleft. Guida all’uso delle licenze
opencontent, NDA
press, Rimini, 2006
- Aliprandi S., Copyleft & opencontent. L'altra faccia del copyright,
PrimaOra/Copyleft-Italia.it, 2005
- Beccaria A., Permesso d’Autore: percorsi per la produzione di cultura libera,
Stampa Alternativa, Viterbo, 2006
- Jenkins H., Fan, blogger e videogamers. L'emergere delle culture partecipative
nell'era digitale, FrancoAngeli, Milano, 2008
- Lessig L., Code and Other Laws of Cyberspace, Basic Books, New York,
NY, 1999
- Lessig L., The Future of Ideas, Random House, New York, NY, 2001;
trad. it. Il
Futuro delle Idee, Feltrinelli, Milano 2006
- Levy P., L'intelligenza collettiva:per un'antropologia del cyberspazio, Feltrinelli,
Milano, 2002
- Thompson J. B., Mezzi di comunicazione e modernità. Una teoria sociale dei
media, Il
28