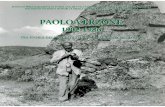Diritto medievale e moderno
Transcript of Diritto medievale e moderno
Diritto medievale e moderno
Lezione 1
La storia del diritto fin dal suo nascere è stata sempre insegnata nelle facoltà di giurisprudenza,
questo vuol dire che l’influsso dei giuristi positivi sull’analisi del fatto storico è stato un ‘influsso
determinante. La prima cattedra di s.d.d. è stata istituita nel 1837, non c’è una distinzione tra diritto
romano e diritto medievale. L’Italia è divisa ma la spinta nazionalistica porta a chiedersi qual è
l’identità giuridica di questa formazione che vuole nascere. Non conoscendo la storia è difficile
costruire un’identità. Noi siamo il portato di tutta una serie di accadimenti che riguardano il nostro
passato. La storia del diritto oggi ha un ruolo piuttosto scomodo, ossia quello di fornire al futuro
giurista un sapere critico. Il giurista riceve da altre materie un sapere tendenzialmente dogmatico,
siamo stati inquadrati a pensare il diritto per istituti, nessuno mette in discussione il concetto di
proprietà o di stato,nessuno tra i giuristi positivi, mentre lo storico afferma che questa è la
situazione attuale, ma non è l’unica possibile. Il diritto è un’espressione della società e in quanto
tale cambia con il cambiare della società.
Il sistema giuridico che abbiamo oggi è il sistema giuridico dei nostri giorni, andando in dietro nel
tempo possiamo constatare che esistevano altri sistemi giuridici, perfettamente funzionanti, basati
su presupposti diversi rispetto a quello nostro, eppure funzionanti. Lo storico non valuta nel merito,
non è compito dello storico il giudizio, il suo compito è la conoscenza, poiché solo attraverso la
conoscenza noi possiamo veramente capire che se è esistito altro rispetto a quello che abbiamo oggi,
dobbiamo guardare l’oggi con la stessa prospettiva e così potendo capire cosa che sta per succedere.
Se il nostro sistema afferma di basarsi sui codici, la dottrina più avvertita parla della nostra come
un’età della decodificazione. Il fatto noi lo capiamo se sappiamo che la grande tradizione giuridica
dell’Europa, fino alla codificazione napoleonica, è un epoca in cui non ci sono i codici , eppure è un
epoca profondamente giuridica. Il ruolo della s.d.d. è quello di dare un sapere formativo, di
smontare le certezze che vengono fornite dalle discipline dogmatiche, nella convinzione che le
soluzione giuridiche sono soluzioni contingenti e locali. La storia del diritto ha avuto anche altre
funzioni, il diritto è un sistema di legittimazione del potere, il potere è legittimato ad essere tale
perché si fonda su regole giuridiche. Questo pone un problema: se il diritto legittima il potere, chi
legittima il diritto? Max Weber individua tre sistemi di legittimazione dei poteri politici.
Il primo è la tradizione, il potere è legittimo perché è così da tanto tempo. Esiste un momento nella
storia dell’umanità in cui il potere si legittima in funzione dell’antico.
Il secondo sistema è il carisma, il potere è legittimo perché è ispirato da Dio. I sovrani medievali
sono tutti dei gracia rex, re per grazia di Dio. È Dio che vuole quel sovrano.
Il terzo sistema di legittimazione è la razionalizzazione, un sistema è legittimo perché e razionale,
dove razionale vuol dire anche efficiente. Il potere politico oggi è legittimato da una serie di regole
che non sono regole della tradizione, né dettate da Dio, ma da una serie di regole che ci sembrano le
più efficienti, quindi il sistema poggia sulla razionalità.
Che c’entra la storia con tutto questo, c’entra ad esempio per il primo sistema, la storia nel prima
sistema è fortemente legittimante. Se ci pensiamo la funzione storica in funzione legittimante viene
utilizzata anche dalla dogmatica giuridica per dimostrare che certe figure giuridiche sono esistite da
sempre. Naturalmente lo storico del diritto non accetta queste impostazioni poiché il legame col
passato è un legame soltanto terminologico. Ad esempio la famiglia romana non ha nulla a che
vedere con la famiglia attuale. Noi possiamo utilizzare questi termini solo perché non hanno lo
stesso significato giuridico che avevano a quel tempo.
La faida e il guidrigildo sono tipici della legislazione longobarda, la faida è la legge disciplinata
molto severamente dalla legge del taglione, oggi ha una valenza molto negativa e sicuramente
contra legem. Le continuità sono possibili sono a patto che il termine indichi una cosa diversa dal
passato. Il professor Albanese dice che il diritto è fatto di parole, quindi è necessario
contestualizzare le parole. La continuità col passato è solamente terminologica, mentre c’è una
discontinuità semantica, questo significa che non esistono concetti giuridici validi universalmente,
non esiste una atemporalità del diritto, ma le soluzioni del diritto sono contingenti, hanno una
durata, esistono finché la società li riterrà validi.
Questa prospettiva di continuità non è del tutto innocente, l’atteggiamento genealogico del diritto
del passato e il diritto attuale non è un atteggiamento dovuto solo a una ingenuità di prospettiva, ma
ha uno scopo preciso. La continuità è una delle strade per consolidare una situazione presente, che
riguarda il potere politico. Per potere politico si intende il sistema generale del potere politico,
nonché la legittimazione di questo potere che viene visto come un diritto naturale, razionale,
atemporale, un diritto che consentirebbe di istaurare un dialogo interrotto tra i giuristi antichi e
quelli attuali. È indubitabile che categorie come stato, persona , famiglia e testamento sono sempre
esistite, però non sono sempre esistite come categorie oggettive, ma perché l’uomo le ha sempre
cercate.
Dobbiamo fermarci sul concetto di indagine storica. Il passato non è un’entità oggettiva, ma è,
esiste soltanto in funzione delle domande che noi poniamo. Noi prendiamo dal passato quello ce ci
serve. Ciò significa che la storia non è sempre la stessa. Anche il tempo è determinato dalle
circostanze, però non si tratta di percezione soggettivo, ma dipende dalle domande che lo storico si
pone. Il tempo della cronaca dei nostri giorni è un tempo velocissimo.
I tempi della storia possono avere una variabile estensione, che dipende dalla lontananza
dell’oggetto rispetto a noi, più vado indietro nel tempo e meno fonti avrò a disposizione. Si pensi
alla preistoria, divisa in ere talmente lunghe da non essere quantificabili, nonostante ciò le
informazioni sono pochissime. Più ci avviciniamo più c’è un informazione dettagliata.
Elemento fondamentale per avere una scansione cronologica dettagliata è l’oggetto del nostro
studio. Vi sono cioè fenomeni di breve durata e fenomeni di lunga durata. Il fenomeno di breve
durata è tipico della storia politica.
Lo statuto della ricerca storica ha dei parametri invalicabili. Ecco perché la ricostruzione storica non
è oggettiva ma scientifica. Nella ricostruzione della storia si può scegliere un aspetto o un altro, si
possono avere delle prospettive diverse.
L’altro tipo di prospettiva è quella progressista,un percorso che da una fase buia va verso la
perfezione. L’esperienza porta l’uomo da una fase buia ad una fase evoluta.
Il “buio” medioevo non è poi così buio, impareremo a conoscere il medioevo come un epoca di
straordinaria civiltà, e acume giuridico. In questa prospettiva di evoluzione l’elemento legittimante
è proprio il passaggio dal passato imperfetto e il presente perfetto. Il punto di arrivo sono le
codificazione. Entrambi i modelli esposti si basano su un presupposto comune, tentano di risolvere
problemi giuridici contemporanei. Il passato viene strumentalizzato per dimostrare una tesi che col
passato non ha nulla a che vedere. Quello che noi dobbiamo fare è guardare al passato cercando di
dare al passato la specificità che merita. Il concetto di verità storica è un concetto che va trattato con
cautela. Lo statuto scientifico dello storico si pone come oggetto dell’indagine la produzione del
diritto come processo sociale. Se si astrae la norma dal contesto sociale in cui si trova, essa perde di
significato. Noi studieremo il diritto come prodotto sociale, partendo però dal diritto e non dalla
società. Un dato fondamentale è la lunga durata del diritto, è un fenomeno di lunga durata.
L’anno 476, anno di caduta dell’impero romano, e l’anno 1804, anno della codificazione
napoleonica, sono le coordinate storiche del nostro studio.
Le trasformazioni del sistema giuridico sono trasformazioni lente, il diritto resiste ai cambiamenti
della politica e della cronaca.
Cercheremo di individuare alcuni connotati che sono significativi di un percorso che non è lineare,
non è necessario e non è escatologico, non porta cioè alla salvezza, è un percorso che si caratterizza
per rotture per cambiai rotta. Questo concetto della storia come percorso di rottura e di discontinuità
non è affatto condiviso dai giuristi che negano le discontinuità facendo così della storia un uso
strumentale. Per il giurista positivo il diritto è un’ininterrotta tradizione aggregativi in cui le nuove
soluzioni nascono per perfezionare le soluzioni precedenti. Per lo storico invece la tradizione
giuridica non è un bagaglio ininterrotto, ma è piuttosto la disponibilità di un enorme massa di
strumenti che utilizza per produrre nuove norme.
La tradizione giuridica è una sorta di grande laboratorio dove il giurista prende degli strumenti e
crea delle norme nuove. Il nostro compito è quello di controllare questo strumentario per fare in
modo che il passato riacquisti spessore e autonomia.
Il diritto è importato della società, ma è vero anche il contrario, esso crea delle categorie sulle quali
la società si organizza. Il diritto crea valori sui quali si fondano le istanze della società. Genera
modelli mentali che appatengono al gruppo e all’individuo. L’idea del contratto o della persona
sono delle invenzioni del diritto sulle quali la società si modella.
Il diritto pensa la società, la organizza e a questa si organizza di conseguenza. La società senza il
diritto non potrebbe modificare la tradizione. Il diritto recepisce le istanze e dal canto suo forma la
società.
PANORAMICA GENERALE
Il medioevo è un epoca si pluralismo giuridico, c’è un pluralismo di sistemi normativi. Santi
Romano nella teoria degli ordinamenti giuridici afferma che lo stato non è l’unico ordinamento
giuridico, sosteneva che anche una fila all’ufficio postale può diventare un ordinamento giuridico.
Per diventare un ordinamento giuridico è necessario che si verifichino alcuni elementi, deve esserci
una condivisione dell’aggregato, devono esserci delle regole che il gruppo si da e condivide e che se
trasgredisce sa di andare contro alle sanzioni.
Nel medioevo il pluralismo degli ordinamento giuridici è l’essenza stessa della società. Altra
caratteristica del medioevo e della prima età moderna (1492-1789) è che non c’è lo stato, non esiste
un sistema detentore del monopolio della produzione della legge.
Se è possibile pensare ad una società senza stato, è impossibile pensare ad una società senza diritto.
Siamo abituati a pensare al diritto come qualcosa che viene dall’alto, ma in mancanza di stato chi è
a far rispettare le regole? Allora le norme prima di essere imposte dall’alto devono essere
condivisibili. Tanto più le regole sono condivise tanto più il soggetto le seguirà spontaneamente.
2 Lezione
Incontro romano germanico: nei territori dell’Europa occidentale entrano a contatto due civiltà
molto differenti che si trovano a convivere nello stesso territorio dopo il crollo dell’impero romano
d’occidente (476 d.C.). Questo è l’anno in cui le insegne dell’impero d’occidente vengono mandate
in oriente. Questa data segna l’inizio del medioevo. L’incontro romano germanico è il momento in
cui queste due civiltà entrano in contatto e creano qualcosa di originale.
Il filone germanico: i regni romano germanici sono delle fondazioni che si collocano nei territori
dell’ex impero romano d’occidente tra il 5 e il 6 sec.
Delle tribù germaniche si stanziano in questo territorio e si affiancano alle popolazioni latine,
sancendo il passaggio dal nomadismo alla sedentarietà. I rapporti tra le popolazioni germaniche e
quelle latine sono diversi a seconda del territorio e non sono sempre idilliaci. I nomadi non
conoscevano molti elementi tipici della società romana, non conoscevano ad esempio il concetto di
proprietà privata. Il diritto germanico conosce l’uso delle terre ma non la proprietà. Il diritto delle
popolazioni germaniche hanno delle caratteristiche comuni che ritroviamo nella descrizione che ne
aveva fatto Tacito. Tacito afferma che i germanici sono una popolazione dedita alla guerra, i
guerrieri sono gli unici a godere in tempo di pace alla pienezza dei diritti. La maggiore età non è
legato ad un dato anagrafico, ma ad una cerimonia pubblica dinnanzi all’assemblea. Questa decide
della vita della comunità, è formata dai guerrieri che battendo la lancia sugli scudi approva le
proposte degli anziani. L’assemblea è l’organo che decide anche della punizione dei crimini più
gravi, in qualche modo amministra la giustizia. All’interno della società sono fortissimi i legami
familiari, il gruppo familiare rappresenta una compagine dell’esercito. Il capo famiglia giuda il
gruppo in battaglia, in tempo di pace regola i conflitti all’interno del gruppo familiare.
La forma giuridica conosciuta e utilizzata dalle popolazioni germaniche è la consuetudine,
d'altronde è una popolazione che non conosce la scrittura e le consuetudini vengono tramandate
oralmente di generazioni in generazioni.
I clan compongono la popolazione, retta da consuetudini.
Tra il V e il VI sec assistiamo ad un primo stanziamento delle popolazioni germaniche all’interno
del territorio dell’ex impero romano d’occidente.
Per primi i vosigoti si stanziano nei territori della gallia e nella penisola iberica, è un regno duraturo
che va dal 418 al 711 quando i visigoti vengono sconfitti dai musulmani.
Altro regno germanico è quello degli ostrogoti, regno che durerà circa 60 anni, dalla fine del 400
alla metà del 500, quando verranno soppiantati dai longobardi.
Questi regni romano-germanici producono delle compilazioni di norme conosciute come leggi
romano-barbariche. La prima e più importante è la lex romana visigothorum emanata nel 506 da
Alarico II re dei visigoti, questa è una compilazione di iura e leges, contiene norme romane ma è
emanata da un re germanico. Si è a lungo creduto che questa lex romana visigothorum fosse stata
emanata in osservanza al principio della personalità del diritto, a sostegno di questa teoria veniva
affermato che la lex romana visigothorum che era stata emanata da Alarico II per i romani residenti
nel regno, e la lex visigothorum era destinata soltanto ai visigoti. In realtà le cose non stanno così
veniva seguito il principio di territorialità del diritto le due legge stavano il un rapporto di genus e
species. La lex romana visigothorum era il genus e la lex visigothorum la species. La popolazione
Visigota avrà difficoltà ad utilizzare la lex romana visigothorum e quindi utilizzerà la sua
specificazione. Il contenuto era uguale mentre la forma era diversa. La loro complessità era però
diversa infatti è probabile che i visigoti facessero uso della lex romana visigothorum per risolvere
situazioni complesse mentre utilizzavano l’altra lex per risolvere situazioni più semplici.
Come detto si tratta di una raccolta di due delle tre fonti romane, tra le leges troviamo un sesto del
codice Teodosiano e alcune novelle post teodosiane,mentre nella parte degli iura troviamo alcune
costituzioni tratte dai codici gregoriano ed ermogeniano, messi tra gli iura perché si tratta raccolte
private, si trova inoltre l’epitome gai o liber gai, riassunto delle istituzioni di gaio, ancora troviamo
brani delle pauli recepte sententie massime tratte dal pensiero del giurista Paolo, ancora un
frammento dei libri responsorum di Papiniano.
Volgarizzazione del diritto è un fenomeno che i romanisti dipingono come il momento della
decadenza, ossia quando gli iura si semplificano e si adattano alle esigenze della prassi. Tutto ciò
avviene nel periodo del basso impero, quando la cittadinanza viene estesa a tutti i sudditi
dell’impero,e quando il diritto è sempre più appannaggio della decisione dell’imperatore. Gli iura
perdono la loro carica innovatrice, la perdono perché da un parte i giuristi non hanno più
quell’autonomia politica che avevano nel periodo del diritto romano classico, e dall’altra perché le
dimensione dell’impero non consentono più la loro divulgazione.
Le leggi romano germaniche rappresentano una testimonianza del primo medioevo, non segna una
cesura profonda, se vogliamo trovare un momento di trapasso più concretamente percepibile
dobbiamo spostarci al 568 quando cioè i longobardi scendono in Italia. I longobardi sono quelli che
Gregorio magno definisce i più barbari dei barbari, terribili e feroci, a causa della potenza militare
straordinaria di questa popolazione; questi si stanziano nella parte centro-settentrionale dell’Italia e
poi nella parte meridionale, accerchiando lo stato della chiesa. Da molti l’arrivo dei longobardi è
visto come la definitiva cesura dell’Italia. I longobardi riproducono in forma stanziale un assetto
che era tribale, militare. La società è divisa in fare che corrispondono ai clan, ogni fara ha a capo un
guerriero. L’assetto longobardo nel territorio si struttura in ampi aggregati di fara che prendono il
nome di ducati. I duchi sono tendenzialmente refrattari ad assoggettarsi ad un solo capo, il rex è tale
solo in tempo di guerra, solo nel 643 con l’editto di Rotari ci sarà la prima testimonianza di una
normazione regia presso i longobardi. Questo è il primo monumento legislativo di età longobarda, è
un opera fondamentale perché contiene consuetudini del popolo longobardo, non contiene diritto
romano. L’editto è scritto in latino, poiché i longobardi non conoscevano la scrittura. Rotari dice
nel proemio del suo editto: sto soltanto mettendo per iscritto le consuetudini che mi hanno
tramandato gli anziani del mio popolo. Certamente questo è vero solo in parte, Rotari certamente
mette del suo. Quando le consuetudini sono messe per iscritto vuol dire che non sono più sentite
come prima. Le norme poste nell’editto tratteggiano alcune caratteristiche della società longobarda.
La faida viene disciplinata dall’editto, questa è la vendetta ossia il modo per vendicare l’inimicizia
tra fare diverse, la fare dell’offeso ha il diritto di restituire un offesa uguale a quella ricevuta. La
faida è regolata dalla legge del taglione. Alla faida è affidata la risoluzione della conflittualità
sempre all’interno a rapporti tra privati. Una volta che interviene un soggetto pubblico, questo
cercherà di controllare il fenomeno. Nell’editto di Rotari si cerca di arginare il fenomeno attraverso
la compisitio, tariffario nel quale ogni offesa ha un prezzo, la fara dell’offensore potrà corrispondere
alla fara dell’offeso il prezzo corrispondente così l’offesa sarà sanata.
Il giudrigildum è il prezzo da pagare per l’uccisione di un soggetto. Questo prezzo varia a seconda
dello status del soggetto (l’estimatio corporis).
Rotari dice di aver messo nell’editto tutto ciò che ha trovato sulle leggi dei padri, e si riserva di
modificarlo esclusivamente se trova nuove leggi dei padri. L’editto viene donato all’assemblea,
contiene prevalentemente un minuziosissimo tariffario delle offese. Tale tariffario rispecchia la
caratteristica delle leggi situate, deriva dal latino si cuis indicando che le leggi longobarde non
arriveranno mai alla disciplina del principio generale, ma disciplinano caso per caso.
Il tariffario prevede minuziosamente ogni offesa ricevuta. Il valore della persona che determina il
guidrigildo trova una certa difficoltà ad essere applicata per quei soggetti che non hanno questo
valore, ad esempio le donne. Questa ha capacità giuridica ma non di agire, viene tutelata tramite il
mundio che riguarda sia una tutela protettiva della donna sia l’ambito patrimoniale. Il mundio è
affidato ad un soggetto di sesso maschile che è detto mindualdo, è solitamente il padre o comunque
un consanguineo della donna, e al momento del matrimonio il mundio può essere acquistato dal
marito. Si è detto che il matrimonio longobardo è in realtà una compravendita ma in realtà il marito
non acquista la donna ma il suo mundio. Il marito potrà amministrare il patrimonio della moglie.
Ecco al momento della stipula del contratto matrimoniale il mindualdo e il futuro sposo possono
accordarsi per la vendita del mundio.
La donna ha una dote e una volta consumato il matrimonio, il marito deve pagare alla famiglia della
sposa una somma di denaro pari ad una controdate detto morghen gaab o dono del mattino.
L’ultimo elemento che analizzeremo è il processo, il processo longobardo è stato paragonato ad un
gioco, perché il sistema di risoluzione del conflitto in uno spazio pubblico non avviene attraverso
l’azione di un giudice che deve scoprire la verità. Il giudice ha il compito di stabilire il sistema
probatorio che i due contendenti dovranno seguire nello svolgimento del processo. Il processo è di
tipo ordalico, che supererà la prova sarà innocente, chi non la supererà sarà colpevole, poiché è Dio
a giudicare. Dio giudica e manda un segno agli uomini.
L’accusato veniva sottoposto ad una particolare forma probatoria, ad esempio i carboni ardenti,
oppure lo si immergeva in una pentola di acqua bollente, se il soggetto viveva era innocente, se
moriva era colpevole. In alcune prove se il soggetto sopravviveva era il diavolo e quindi veniva
puntualmente ucciso. L’ordalia poteva anche essere bilaterale e in tal caso era un duello. Il giudice
controlla la regolarità del duello e alla fine dichiara il vincitore.
Questo tipo di procedura è la forma embrionale di publicizzazione del conflitto, primo passo per
una giustizia pubblica dovuta anche all’influenza cristiana.
Sotto il regno di Liutprando, primo sovrano cristiano e successore di Rotari, vi è una mitigazione
della faida e all’eliminazione dell’ordalia.
Un secondo passo delle leggi germaniche ci porta alla legislazione carolingia, i carolingi sono una
dinastia di maestri di palazzo, poi re e poi imperatori. Maestri di palazzo sono i primo ministri dei
Re franchi merovingi detti re fannulloni, sono i re taumaturghi a metà tra l’umano e il divino. Al
loro posto agiscono i maestri di palazzo, tra questi Pipino il breve, padre di Carlo magno, prende la
corona e ha mandato dal Papa di difendere la cristianità, di respingere cioè i longobardi. Compito
che non appartiene più al imperatore d’oriente, che guarda il pontefice di Roma come un semplice
vescovo. Il pontefice di Roma cerca in occidente aiuto e si rivolge a pipino, lo nomina re dei franchi
e poi, nella notte di natale dell’ 800, nomina Carlo imperatore del Sacro Romano impero. Nasce
cioè una formazione che nelle intenzioni del Papa è di gran lunga più importante dell’impero
Romano. Un impero che non avrà i difetti di quello romano semplicemente perchè nasce con il
volere di Dio. Viene riportata in auge l’idea della Roma eterna ed universale, della res pubblica
cristianorum. Carlo viene nominato imperatore, nasce uno strano connubio in cui l’imperatore è il
defensor ecclesiae ma questo esiste solo perché il Papa lo ha nominato.
I sovrani e poi gli imperatori della dinastia carolingia sono sovrani che legiferano, le loro leggi
vanno sotto il nome di capitulari. Questi sono a loro volta divisi in capitoli, in articoli. Sono norme
che hanno una classificazione fatta fin dal loro nascere, questa è fatta sia con riguardo ai destinatari
delle norme, sia con riguardo al principio di applicazione delle norme.
Con riguardo ai destinatari abbiamo i capitularia mundana, ecclesiastica, mista; mundana
contengono norme che disciplinano la materia laica, ecclesiastica la materia ecclesiastica. I
capitularia ecclesiastica riguardano l’organizzazione interna della chiesa.
Un’altra partizione è quella che riguarda il principio di applicazione delle norme, abbiamo
capitularia per se scribenda, e capitularia legibus addenda. I primi seguono il principio della
territorialità del diritto,sono cioè delle norme emanate per intere regioni o per tutto l’impero; gli
altri invece seguono il principio della personalità, sono norme che vanno ad integrare le norme dei
singoli popoli che continuano all’interno dell’impero. L’impero carolingio non è un’unità compatta,
ma è formata da diverse parti. Carlo Magno tiene conto della diversità delle popolazioni che
formano l’impero. I diversi popoli saranno inglobati nell’impero.
È una normazione piuttosto articolata come è articolata la società. L’organizzazione carolingia è
basata sul mantenimento e sulla specificità delle singole etnie. Un altro problema legato ai capitolari
è l’iter della loro formazione. I carolingi fanno vere e proprie leggi, nuove, i capitolari vengono
emanati durante i placiti, assemblee alle quali partecipano i più alti dignitari dell’impero: marchesi,
conti e vescovi. i marchesi e i conti sono uomini di fiducia dell’imperatore stanziati nelle zone di
confine e ne amministrano il territorio in nome dell’imperatore. Hanno il compito di fare applicare
le leggi e di sottoporre all’imperatore i problemi che incontrano nel loro territorio. I placiti sono
queste occasioni,le risposte dell’imperatore costituiscono i provvedimenti che verranno posti nei
capitulari. Nel momento in cui l’imperatore dice il provvedimento quello diviene legge. Certamente
la scrittura diventa fondamentale non per la sua validità, ma per la sua divulgazione.
Si è detto che l’impero carolingio non avesse una cancelleria per l’archiviazione o per la
registrazione, in realtà non è così, vi sono testimonianze più che eloquenti che dimostrano
l’esistenza di una cancelleria imperiale. Il problema è che la corte imperiale era una corte itinerante,
quindi i testi dell’archivio vengono persi, e non resta traccia dell’archivio. Mentre non vennero
perdute le copie che i destinatari dei capitolari facevano fare nel proprio interesse. I marchesi o i
conti facevano scrivere delle copie per far conoscere nel loro territorio le leggi. Questo metodo di
diffusione è un modo che crea qualche problema di autenticità, e infatti strettamente legata alla
produzione dei capitulari è il fenomeno delle falsificazioni, che riguardano in modo particolare i
capitulari ecclesiastici. L’età carolingia è un’età in cui l’uso della scrittura si diffonde in maniera
notevolissima. Carlo Magno pur essendo analfabeta è un uomo molto attento alla cultura, si
circonda delle personalità più colte, ad esempio Aquinio di York, monaco fondatore della scuola
palatina. La scuola inventa il metodo di scrittura detta minuscola carolina, che si diffonde in tutto
l’impero e che verrà utilizzata dai monaci per la trascrizione dei documenti. Nell’alto medioevo il
sapere è pressoché ecclesiastico, ciò significa che le classificazioni sono fatti dai monaci e
riguardano soprattutto materie ecclesiastiche. Nelle gerarchia delle fonti storiche un falso se
d’epoca non è meno importante di un documento autentico. Due raccolte in particolare, uno di
Ansegiso e uno di Benedetto Melita contengono in gran parte capitolari falsi di tipo ecclesiastico.
Lezione 3
Il medioevo è il frutto dell’incontro romano germanico, ripercorriamo adesso la strada percorsa dal
diritto romano. Partiamo da Diocleziano, questi è imperatore dal 284 al 305, da lui in poi cambia il
ruolo che riveste la figura dell’imperatore, cambia a causa dell’influenza della regalità orientale.
Arrivano nuove suggestioni, l’imperatore è visto come un semi-dio, tale divinità è suffragata da una
serie di riti. La maior dignitas diviene sacralità. Chiaramente è l’inizio di un fenomeno che durerà
vari secoli. Giustiniano sarà allo stesso tempo imperatore e capo della chiesa. Quando l’imperatore
si sposta definitivamente in oriente questo fenomeno diviene più evidente.
Il diritto comincia sempre più ad essere legato al comando dell’imperatore, non a caso gli iura
perdono progressivamente la loro importanza. La perdono perché il potere imperiale tenta in ogni
modo di imbrigliare l’autonomia dei giuristi. Il consilium principis che è inizialmente un consiglio
di giuristi che aiuta l’imperatore, ma che poi diviene una vera e propria istituzione. I giuristi
lavorano per il princeps e crea le norme. È un processo assolutamente da quello degli iura, nelle
quali i giuristi autonomante riuscivano a creare norme. Ciò non vuol dire che gli iura non venivano
più usati, veniva ad esempio utilizzata la legge delle citazioni. C’è da dire che gli iura sono un tipo
di produzione giuridica limitata alla città di Roma, che difficilmente riesce ad essere compresa dal
resto dell’impero. Proprio a partire dal V secolo arriva il fenomeno della volgarizzazione del diritto,
questo fenomeno sia gli iura che la produzione di nuove leges. A partire dal III secolo abbiamo una
serie di raccolte di iura private, ad esempio le Pauli recceptae sententiae redatte tra la fine del III e
l’inizio del IV secolo. Si tratta di massime tratte dal pensiero di Paolo.
Un'altra raccolta è la Lex Dei, manualetto di comparazione tra la Bibbia e alcune leggi di Roma.
Altre raccolte dell’epoca sono i fragmenta vaticana, frammenti di un manuale destinato
all’istruzione e contengono brani di giuristi e leges; ed ancora i tituli et corpori ulpiani.
Il liber gai o epitome gai è un riassunto delle istituzioni di gaio, opera fondamentale grazie alla
quale l’occidente ha conosciuto le istituzioni di Gaio, finché Angelo Mai intorno alla metà del 1800
non trova il famoso palinsesto veronese contenente il testo originale delle istituzioni gaiane.
Gli iura sono un prodotto occidentale, nascono e sono pensati per Roma, le leges invece sono
certamente determinate dalle influenze orientali, proprio perché pongono al centro del sistema la
volontà del princeps semi-dio. L’operazione di Giustinano con la composizione del digesto porrà
fine agli iura e li farà divenire leges.
Gli iura subiscono questo fenomeno di cambiamento progressivo, e le leges assumono sempre
maggiore leges, non a caso dall’età dicloezianea cominciamo ad avere i primi codici, raccolte di
leges. Le grandi opere compilatorie si collocano sempre in momenti di grandi trasformazioni
politico-costituzionali. Nell’età dioclazianea vengono scritti il codice gregoriano e quello
ermgoniano. Codici sicuramente redatti in oriente, non nascono a Roma, si tratta di due codici
privati, non vengono promulgati di Diocleziano, anche se entrambi i codici sono stati pensati e
prodotti all’interno della cancelleria imperiale. La tendenza alla codificazione continua e arriva al
suo punto massimo con Teodosio, che nel 429 progetta la raccolta di due differenti codici, uno di
leges e uno di iura, quest’opera non viene portata a compimento, i tempi non sono ancora maturi,
poiché l’imperatore non può promulgare iura dato che questi hanno valore di per se. Nel 439 entra
in vigore un codex theodosianus, opera imponente in sedici libri che si pone come continuazione dei
codici gregoriano ed ermogeniano, cancella le leggi non cristiane e dichiara che dovrà essere
utilizzato nelle scuole e nei tribunali. La terza fonte del diritto romano sono i mores, le consuetudini
diventano a partire dal tardo impero la fonte del diritto principale. L’impero romano era ormai una
formazione unitaria di tali proporzioni che aveva bisogno di tutta una serie di regolazioni a livello
locale che sono fornite dalle consuetudini. Quando specialmente in occidente verrà meno
l’impalcatura formale dell’impero romano, quella impalcatura non verrà sostituita da una analoga
struttura di potere, vi saranno una serie di situazioni politiche molto piccole, molto frammentarie
che naturalmente utilizzeranno come fonte del diritto la consuetudine.
La consuetudine materializza il concetto di condivisione del diritto, più la norma è condivisa e più
sarà rispettata. Già a partire da Salvio Giuliano si pone il problema di bilanciare leggi e
consuetudini, Salvio Giuliano afferma che in caso di una legge desueta questa può essere abrogata
da una consuetudine. Costantino nel 319 dirà che per quanto forte possa essere la consuetudine non
potrà mai andare contro la legge. La forza del comando dell’imperatore vince qualunque uso
consuetudinario. Questa contrapposizione di idee fa intendere che il tempo stava cambiando, il
giurista esprime un parere, mentre l’imperatore emana una costituzione per dire che non può esserci
una consuetudine contra legem, ciò vuol dire che la situazione reale era diversa. Costantino tentava
di arginare un sistema che non teneva conto delle leggi dell’imperatore.
Il processo di stravolgimento delle fonti giuridiche romane arriva a compimento con Giustiniano,
imperatore a cui si devono la maggior parte dei materiali giuridici che ci sono arrivati.
Con le leggi Giustiniano non riesce nel suo intento di riunire l’impero però fa un opera molto più
duratura delle campagne militari. La compilazione giustinianea si compone di tre parti fondamentali
e di una quarta parte aggiunta in seguito. Le tre parti sono: Codice, Digesto e istituzioni. Il codice
viene emanato in due redazioni, il digesto è frutto di un lavoro frenetico compiuto sotto
supervisione di Triboniano , composto di iura e diviso in cinquanta libri, nel digesto compaiono i
pareri di una quarantina di giuristi diversamente dalla legge delle citazioni che ne nomina cinque.
Giustiniano afferma che gli ura sono il templum iustitiae, il luogo dove risiede la giustizia e la sua
sacertà. Certamente il digesto darà la svolta definitiva al sistema del diritto romano, gli iura
vengono promulgati dall’imperatore e quindi diventano formalmente leges, sono vigenti non perché
sono iura ma perché promulgati dall’imperatore. Le istituzioni sono destinate alla formazione dei
giuristi, riprendono la struttura delle istituzioni gaiane. Il codex contiene costituzioni imperiali.
Alle tre parti della compilazione dobbiamo aggiungere le novellae costitutiones emanate da
Giustiniano dopo la pubblicazione del codex reperite praelectionis.
Giustiniano riforma le scuole del diritto, i giuristi per diventare tali dovevano studiare per cinque
anni. Il primo anno era dedicato alla formazione di base basato sulle istituzioni, il secondo il terzo e
il quarto erano interamente dedicati allo studio del digesto. L’ultimo anno di scuola era dedicato
allo studio del codex. Le leggi dell’imperatore possono essere studiate solo da un giurista già
formato.
La compilazione giustinianea costitute una cristallizzazione del diritto romano, giustiniano vieta di
fare qualunque intervento sulla sua opera ad eccezione delle traduzioni e dispone che valga per
sempre. Tenta di fare un’operazione impossibile, di rendere il diritto valido in tutti i luoghi in tutti i
tempi. Le cose vanno in tutt’altra direzione. Nel 554 con una pragmatica sanctio (probetitione
virgili ???) la compilazione giustinianea viene introdotta nei territori d’occidente e va ad abrogare
la legislazione posta in essere dai sovrani ostrogoti. Nel 568 i longobardi arrivano in Italia e ciò
determina una scarsa divulgazione della compilazione nell’occidente e la prevalenza della
tradizione teodosiana che ritroviamo nell’Europa continentale.
La compilazione giustinianea viene utilizzato e adattato alle mutate situazioni politiche. Il diritto
romano non è più supportato da un potere che lo incrementa.
Il diritto giustizianeo segue strade diverse, innanzi tutto, durante l’alto medioevo l’istruzione del
diritto viene affidata alla scuole delle arti liberali. All’interno di queste arti si studia il diritto, che
non è più oggetto di studio specifico, ma che è studiata come una branca della retorica e della
logica. Queste scuole che hanno la loro sede nelle cattedrali e nei monasteri, la chiesa diviene
l’unica detentrice della cultura. In queste scuole si studia il diritto che viene applicato nei tribunali.
Il digesto fa la sua ultima apparizione in un citazione di Gregorio Magno e poi scompare. Non ci
sono riferimenti al digesto fino al rinascimento giuridico, ossia al XII secolo. Scompare perché è un
opera troppo complessa e non risponde alle esigenze di quella società.
Al contrario il testo maggiormente utilizzato sono le istituzioni, che vengono utilizzati sia come
legislazione vigente, sia per la formazione scolastica. Le istituzioni sono conosciute nella loro
forma originale e sono oggetto di un’attività interpretativa, tramite le glosse.
Il codex viene utilizzato, ma non nella sua forma originale, vengono utilizzati i primi nove libri
mentre gli ultimi tre libri vengono persi. Questo perché trattavano dell’organizzazione dell’impero.
Le singole costituzioni subiscono un processo di semplificazione, viene tolta sia la parte iniziale che
la parte finale. Il codex in altre parole si tratta di un epitome codicis.
Delle novelle giustinianee esistono due raccolte, l’epitome iuliani e l’authenticum, durante l’alto
medioevo viene conosciuta la prima che contiene alcune novelle tradotte nella forma latina e
anch’esse private della parte iniziale e di quella finale.
Questa distinzione è fondamentale per capire quale strada segue il diritto, dobbiamo capire come
quel diritto è arrivato fino al nostro ordinamento.
Le glosse servivano a spiegare con termini più semplici alcuni assunti ritenuti complicati.
Quest’attività è tipica dei secoli alto medioevali. Il punto di svolta, quando cioè il diritto torna nella
sua forma originaria avverrà nel rinascimento giuridico che collochiamo nel XII sec. In questo
periodo si compirà uno sforzo per andare a ritrovare manoscritti che certamente esistevano ed erano
conservati nelle biblioteche dei monasteri. La trasmissione della cultura era affidato al lavoro della
ricopiatura dei testi fatta presso i monasteri. Certamente nei grandi centri monastici stavano copie
della compilazione giustinianea. L’alto medioevo affida la formazione dei suoi intellettuali alle
scuole di arti liberali site presso i grandi monasteri. Un capitolare carolingio enumera le scuole
presso l’Italia settentrionale. La scuola di Pavia è la più importante, questa era la capitale
dell’impero prima e del regno poi, era sede del tribunale dell’impero. Il prodotto di questo connubio
è una scuola dove certamente si studia in maniera specifica diritto. Siamo tra X e XI sec, e il diritto
che si studia a Pavia è diritto longobardo-franco, e non romano, questo perché si sviluppa un centro
di studio giuridico per esigenza di formare giuristi capaci di applicare il diritto del re. Alla scuola di
Pavia vengono attribuite varie opere, che non ci dicono nulla circa l’insegnamento del diritto. Non
sappiamo se fosse una scuola specializzata, sappiamo solo che era studiato. Le opere attribuite alla
scuola di Pavia sono opere compilatorie ed opere esegetiche. Le prime raccolgono le fonti
normative, dobbiamo ricordare il liber papiensis e la lombarda. Queste opere contengono lo stesso
materiale disposto in ordine differente, la prima in ordine cronologico e la seconda in ordine
sistematico. Contengono la raccolta degli editti dei re longobardi ( edictum regum langobardorum) e
la raccolta di tutti i capitolari riguardanti il regno d’Italia ( capitolare italicum).
L’expositio ad librum papiensem è un opera esegetica di un autore ignoto, che fornisce i nomi dei
giuristi che lavorano in questa scuola e ci racconta alcune dispute tra gli studiosi divisi addirittura in
antiqui e moderni. Gli antiqui sostengono che mai si può utilizzare il diritto romano, mentre i
moderni sostengono che in caso di lacune il diritto romano può essere utilizzato.
Abbiamo parlato di iura e volgarizzazione del diritto, fenomeno che riguarda il diritto romano a
partire deal basso impero, precedente all’incontro romano barbarico. Consiste nella produzione di
opere o nel cambiamento delle opere dei giuristi classici, che vengono semplificate ed epitomate.
Ad esempio l’epitome gai o le pauli receptae sententiae. Il diritto romano contenuto negli iura passa
nella società romana, nasce una nuova civiltà giuridica che si fonda su quella romana ma utilizza
anche esperienze che vengono da altre situazioni.
Il fenomeno della volgarizzazione del diritto viene per la prima volta individuato da Brummer che
studiando i titoli al portatore e vede in quei titoli una situazione giuridica che i romani non
prevedevano. Brummer, che era uno storico del diritto tedesco vissuto nel 1800 e vede in questa
volgarizzazione un segno di decadenza, anche se il termine volgarizzazione deriva da folks gaist
ossia diritto del popolo. L’accezione negativa è priva di fondatezza storica. Il diritto volgare è frutto
del lavoro di adattamento degli iura alla prassi che comincia già a partire dal basso impero e
continua fino all’alto medioevo.
Per quanto riguarda le leges, divengono il vertice del sistema giuridico, corrispondono alla nuova
figura dell’imperatore-semi dio, è un imperatore che legifera, la sua legislazione a partire dall’età
giustinianea seguirà la strada dei codici. Frutto della cancelleria imperiale, prodotti in oriente, sono i
codici ermogeniano e gregoriano. Il codice theodosiano è invece ufficiale che si impone come
esclusivo nelle scuole e nei tribunali, fa parte di un progetto più ambizioso che riguardava anche
una compilazione di iura me che non sarà portata a conclusione.
Gli iura verranno regolati dalla legge delle citazioni, che da una parte ne impedisce la proliferazione
indiscriminata e dall’altra ne consente l’utilizzo forense.
La compilazione giustinianea è il punto di arrivo di questo fenomeno, Giustiniano emana una
compilazione che riguarda tutto il diritto romano positivo, ad eccezione dei mores. Il digesto cambia
la forma degli iura che divengono leges, nella forma giustinianea e non più in quella originale. Nel
digesto vi è dunque il pensiero dei giuristi modificato secondo il pensiero giustinianeo.
Durante i secoli dell’alto medioevo, che vanno fino al 1000, la compilazione giustinianea scava un
solco nella cultura dell’occidente europeo. In futuro si potrà rispolverare la compilazione nella sua
forma originaria che sarà alla base del rinascimento giuridico.
Lezione 4
Nelle precedenti lezioni abbiamo parlato della scuola dei glossatori, la quale diede avvio a quel
macro fenomeno che gli storici chiamano Rinascimento Giuridico che, per l’appunto, nasce con la
riscoperta dei testi del diritto giustinianeo. A questa scuola si deve pure la nascita del c.d. diritto
comune. È difficile dare una definizione esaustiva del diritto comune.
Per età del diritto comune s’intende quell’età che parte con la nascita della scuola di Bologna e
dunque con la nascita della scientia iuris , ovvero di quella disciplina che studia il diritto e che ha lo
scopo di formare i doctores, i quali hanno una formazione unitaria, una stessa cultura e che
andranno ad operare in situazioni in cui si applica non solo il diritto romano, ma anche diritti che
comuni non sono, ossia diritti propri.
Diritto comune è la traduzione dell’espressione latina ius comune che ritroviamo nelle fonti
medievali.
La dottrina che si è occupata del concetto di diritto comune risale a metà del ‘900 quando uno
storico del diritto, Francesco Calasso, elaborò una definizione di diritto comune.
Egli definisce il diritto comune come: “Quel grandioso fatto storico dell’età intermedia per il cui
diritto romano-giustinianeo, restituito nei suoi testi e posto a fondamento della scientia iuris per
opera della scuola di Bologna, fu considerato come diritto vigente generale in gran parte
dell’Europa fino alla pubblicazione delle codificazioni moderne”.
Fino alla metà del ‘900 l’atteggiamento degli storici nei confronti del diritto dell’età intermedia era
un atteggiamento di sufficienza nel senso che la maggior parte degli storici del diritto consideravano
il diritto medievale come un’età in cui si era utilizzato un diritto romano ammodernato.
Calasso non si ritieni soddisfatto di questa visione che non spiega niente poiché non si può supporre
un periodo di tempo così lungo in cui non succede niente.
Lo storico ritiene che vi sia una specificità che è proprio il diritto comune, il quale deriva dal fatto
di aver utilizzato il diritto romano applicandolo a situazioni nuove, creando così un sostrato che si
giustappone a diritti che sono diritti propri, ovvero a quel complesso fenomeno dei c.d. iura propria
che è invece l’espressione positiva del diritto medievale.
La dottrina di Calasso da l’avvio ad una serie di studi che possiamo considerare culminante con un
altra definizione di uno storico tedesco Peter Vaimar, secondo il quale è sbagliato dire che il diritto
comune abbia avuto vigore normativo e che questo vigore gli sia stato tolto dalle codificazioni. Al
contrario il diritto comune non ha mai avuto vigore e non è mai stato abrogato.
Apparentemente le posizioni dei due storici sembrano antitetiche ma in realtà così non è. Calasso ci
dice che il diritto comune è diritto vigente generale fino alle codificazioni, mentre Vaimar dice che
non è mai stato in vigore e quindi non è mai stato abrogato.
Le posizioni apparentemente antitetiche sono frutto di un elaborazione, dietro ci sta la
consapevolezza da parte della storiografia del fatto che il diritto comune è strumentale dei
ragionamenti e delle terminologie, che serve ai giuristi medievali per interpretare problemi che
possono essere interpretati solo alla luce dell’esperienza comune.
Nella terminologia latina non abbiamo una definizione esplicita di ius comune, ma soltanto una sua
definizione implicita: già solo il concetto di ius, senza alcuna specificazione vale come diritto
generale.
Sono due i frammenti che vanno presi in considerazione per intendere cosa intende il diritto romano
quando si parla di diritto comune.
Il primo è di Gaio secondo il quale “ tutti i popoli che sono retti da leggi e consuetudini, in parte
utilizzano il loro diritto proprio, e in parte il diritto comune di tutti gli uomini”.
Seconda Gaio il diritto si divide:
• Da una parte in Ius Proprium dei cittadini romani ( ossia ius civile);
• Dall’altra in Ius Gentium ( ossia il diritto di tutti gli uomini).
Il secondo frammento è di Salvio Giuliano il quale prospetta un altro concetto di ius comune; egli
prende come esempio il c.d. Ius Militare, cioè cioè diritto che poteva essere utilizzato dai soldati “in
servizio”. Una delle parti fondamentali di tale diritto è il c.d. “ testamentum militis” in base al quale
i soldati in battaglia potevano scrivere con il sangue, sullo scudo o in terra, il nome dell’erede
affinché il testamento fosse valido. Questo tipo di diritto era stato definito da Paolo come ius
singolare, ossia un diritto positivo posto per una specifica contingenza e che va proprio contro la
ratio del sistema, ciò per rispondere ad un esigenza particolare.
Giuliano si pone un quesito: se un tribunus militum trovatosi nell’accampamento fa testamento, ma
egli non è più in carica; tale testamento è valido o no?
Seconda Salvio Giuliano tale diritto non può essere più utilizzato perché il soggetto, pur trovandosi
nell’accampamento, non è più tribunus militum e quindi deve redigere il testamento secondo il
“communi iure civium romanorum”; cosicché il diritto dei cittadini romani che era per Gaio ius
proprium, per Giuliano diviene ius comune, contrapposto però non a ius proprium ma a ius
singulare.
In conclusione nel diritto romano ius commune si può contrapporre:
• O a ius proprium, sistema di diritto che riguarda un diritto più piccolo;
• O ius singulare, che è un diritto positivo dello stesso ordinamento del ius commune che
devia dalla ratio del sistema.
Di tutto questo il diritto medievale fa un gran utilizzo, molto più di quanto non fa il diritto romano
che non fondo questo problema non se lo pone.
Siamo in un’età, quella medievale, che senza stato o per lo meno in cui lo stato non ha il dominio
assoluto del potere di fare le leggi, non ha l’appannaggio assoluto dell’ambito normativo quindi ci
vuole un diritto che sia comune a tutti e che organizzi comunemente i rapporti tra i soggetti.
Questo diritto si può contrapporre a diritti che sono specifici di un singolo ordinamento, così come
si può contrapporre a diritti che riguardano singoli soggetti; basti pensare che tutta la dottrina nel
privilegio medievale è fondata sul ius singolare: infatti quando un sovrano concede un privilegio ad
una persona, ad un monastero, ad una città, ad un ente religioso si è in presenza di ius singulare,
perché è un diritto positivo che devia della ratio del sistema, un diritto che non è comune a tutti ma
è specifico per un soggetto.
Ius commune, quindi, si sostanzia in un diritto innanzitutto universale cioè che può essere applicato
in tutti gli ordinamenti, in un diritto sussidiario che si applica laddove non vi sono diritti specifici
che dispongono diversamente, e in un diritto universitario in quanto è un diritto in mano
esclusivamente ai doctores. Esso è un elemento di uniformazione per i giuristi in quanto tutti
studiano e conoscono il diritto comune.
Lo ius commune è anche un modello di legislazione scritta, sul cui modello poi verranno esemplati
sul modello della legislazione del ius commune, ossia dal diritto giustinianeo rivisto dai glossatori.
Ancora il diritto comune è lo stimolo alla tecnicizzazione dei diritti locali, che nell’alto medioevo
sono stati affidati alla consuetudine orale e che nel secondo medioevo si strutturarono in maniera
tecnica sulla base della nozione di ius commune. Infine è anche un mezzo di integrazione delle
lacune normative, infatti dove c’è una lacuna normativa in un sistema di ius proprium, qualsiasi
giurista che padroneggia lo ius commune potrà facilmente integrarla.
IL DIRITTO DELLA CHIESA
Altro elemento fondamentale dello ius commune è il diritto della chiesa.
Il diritto romano giustinianeo è quello che il medioevo eredita, quindi un diritto che non è prodotto
nel medioevo.
Diverso è invece il diritto della chiesa, che con il diritto giustinianeo ha in comune un elemento
essenziale, ovvero l’universalità.
Nel medioevo, infatti, impero e papato sono due enti universali che non hanno un potere universale,
ma un’autorità universale: essi sono cioè universalmente riconosciuti come enti supremi proprio
perché l’ecumene coincide con l’umanità stressa, cosicché tutto il diritto della chiesa ha portata
universale.
Per studiare la formazione e la strutturazione del diritto canonico, bisognerà tornare in dietro nel
tempo, ai primissimi secoli di vita del cristianesimo nonché alla contrapposizione tra cristianesimo e
istituzioni imperiali romane.
Senza dubbio le contrapposizioni vi furono, basti pensare alle persecuzioni, tuttavia all’iniziale
contrapposizione corrisponde anche una reciproca influenza: il cristianesimo nasce all’interno del
territori romano, e di conseguenza l’impero romano assorbe tutta una serie di fermenti culturali,
spirituali e organizzativi che vengono proprio dalla nuova religione.
Viceversa la chiesa utilizza l’organizzazione amministrativa dell’impero, basti pensare che la
divisione in diocesi corrisponde alla suddivisione in province dell’impero. L’influenza non si limita
solo all’ambito esterno, ma vi è anche una fortissima influenza dello stoicismo (da Cicerone a
Seneca) sul pensiero cristiano: basti pensare che la concezione del diritto “etico” ( secondo la quale
il diritto deve essere etico) è una concezione che la chiesa fa propria dallo stoicismo.
Questo percorso del diritto della chiesa è molto singolare in quanto la chiesa fin dall’inizio sceglie
di utilizzare la strada del diritto positivo per marcare la propria presenza nell’ambito della società (
al contrario di altre grandi religioni monoteiste, come l’ebraismo o l’islam che non scelgono la
strada del diritto in quanto questo è contenuto nei testi sacri).
Tale scelta della chiesa è frutto del rapporto strettissimo che sin da subito essa ha con l’impero
romano, e quindi con la tradizione culturale romana. Infatti nasce all’interno dell’impero e quando
questo cade si pone come suo erede: sarà la chiesa ad assumere, almeno idealmente l’idea di
“universalismo” dell’impero, però con una marcia in più dovuta al fatto che la chiesa ( a differenza
dell’impero che era una creazione dell’uomo) si pensa che sia eterna.
Così l’universalismo è destinato a non finire mai, per cui compito della chiesa è quello di guidare
gli uomini, quindi la società verso la salvezza eterna, anche attraverso la strada del diritto che è la
più conveniente anche per garantire che sulla terra gli uomini vivano rettamente.
Questa scelta giuridica della chiesa è visibile sin dai primi anni di vita, tanto che le prime norme che
riguardano la chiesa sono emanate da imperatori romani, a partire da Costantino fino a Teodosio e
Giustiniano. Tali norme innanzitutto riguardano la c.d. Episcopalis Audentia, ovvero il privilegio,
concesso da Costantino ai cristiani tra il 318 e il 321, di potere ricorrere al vescovo per dirimere le
controversie civili fra i fedeli.
Il vescovo è un personaggio che ha un ruolo fondamentale nella struttura della chiesa delle origini,
infatti l’istituto vescovile è un istituto al quale la chiesa demanda l’organizzazione e la presenza nel
territorio.
Dal IV secolo la chiesa si struttura territorialmente in diocesi, guidate da vescovi, corrispondenti a
circoscrizioni che hanno a capo una città; sopra i vescovi la chiesa pone i c.d. Metropoliti i quali
sono vescovi delle città capoluogo delle province imperiali quindi sostanzialmente la struttura
gerarchica della chiesa corrisponde alla struttura dell’impero. Al di sopra dei metropoliti vi sono i
Patriarchi, ossia i vescovi delle città maggiori ovvero i vescovi di Alessandria, di Antiochia, di
Costantinopoli, di Roma.
Il vescovo di Roma in questi primi secoli, non è superiore agli altri, è solo uno dei quattro
patriarchi. Come sappiamo la chiesa orientale non riconoscerà mai la superiorità del vescovo di
Roma e lo scisma tra la chiesa ortodossa e cattolica verte proprio su questo.
Altro privilegio importante concesso da Costantino ai cristiani è la c.d. Manumissio in ecclesia
ovvero una norma che stabilisce l’equiparazione dell’affrancazione di un servo sull’altare alla c.d.
manumissio inter amicos, con cui il diritto romano da possibilità di affrancare il servo non seguendo
le vie tradizionali ma tra amici.
Sempre nel 321 Costantino riconosceva alla chiesa la possibilità di essere erede o legataria di
testamenti.
Tuttavia il luogo comune di Costantino come imperatore cristianissimo è falso, infatti sappiamo che
in realtà oltre a riconoscere l’importanza del cristianesimo, riconosce anche il dio sole.
Il cristianesimo fa parte della struttura dell’impero, quindi la struttura si divide in una parte etica,
una giuridica e una amministrativa-istituzionale; l’unione di questi tre elementi fa si che il
cristianesimo trionfi su tutte le altre religioni.
Tuttavia il diritto della chiesa non è soltanto un diritto imposto dall’esterno, esso prende una strada
autonoma, la chiesa infatti si darà il proprio diritto tramite i concili, assemblee di vescovi che
possono essere provinciali ( vescovi della provincia) ed ecumenici ( tutti vescovi della terra).
Importanti furono il concilio di Nicea del 325 e il concilio di Costantinopoli del 381, in cui la
chiesa compie un operazione non solo teologica ma anche giuridica. Tali concili sono dedicati
essenzialmente a definire i dogmi della fede, alla definizione e alla risoluzione di problemi
importanti come il c.d. monofisismo, ossia la natura unica di Dio e Cristo.
Il problema sulla natura di Dio e Cristo è stato al lungo oggetto di scontro tra chi sosteneva che
padre e figlio non erano della stessa natura e che sosteneva che il contrario; in seguito al concilio di
Costantinopoli al padre e al figlio verrà aggiunto lo spirito santo e verrà dunque definito il dogma
della trinità.
Le decisioni prese all’interno dei concili hanno valore normativo-obbligatorio per tutti i cristiani,
verranno chiamati canoni, ossia norma conciliare. Dunque nella prima fase del diritto canonico
avremo una fase teologica-giuirdica, una fase in cui vi è una separazione netta tra teologia e diritto.
Questa fase del diritto della chiesa si focalizza intorno a due ambiti normativi: uno è quello delle
costituzioni imperiali romane, l’altro è quello dei canoni dei concili ecumenici.
IMPERO E CHIESA
Il problema della definizione e dogma e del rischio delle eresie costituisce una sorta di linea rossa
dei primi secoli di vita del cristianesimo. In seguito i vescovi di Roma che si susseguiranno,
combatteranno sempre contro i tentativi dell’imperatore di Bisanzio di ingerirsi negli affari della
chiesa, basti pensare che Costantino partecipò al concilio di Nicea.
Nell’editto di Tessalonica del 380 Teodosio non soltanto dichiara che il cristianesimo è la religione
di stato, ma dichiara altresì che ad essere religione di stato è il “cattolicesimo niceo-romano” così
che con tale editto l’arianesimo, la dottrina che vedeva le due nature diverse tra Cristo e Dio, viene
condannato come eresia; e soprattutto si pone sullo stesso piano Roma e Alessandria, questa parità
durerà solo un anno, infatti l’anno seguente verrà dichiarata la supremazia della chiesa di Roma su
tutte le altre.
Tuttavia, anche se vi fu tale riconoscimento, il problema dell’ingerenza dell’imperatore ci sarà
sempre proprio perché con la proclamazione del cristianesimo come religione di stato vi sarà il
tentativo dell’imperatore di fare una chiesa di stato, a tale tentativo il Papa di Roma si opporrà
sempre tanto che sarà il Papa stesso ad “inventarsi” un nuovo imperatore che sarà Carlo Magno.
La nascita dell’impero Carolingio segnerà definitivamente la presa di posizione del Papa di Roma
nei confronti dell’impero di Bisanzio.
Tale problema dei rapporti tra impero e papato è un problema che attraversava tutta la vita politica
della chiesa e che risale, addirittura, ai rapporti tra Ambrogio, vescovo di Milano, e Teodosio.
Ambrogio in una lettera a Teodosio dirà che “l’imperatore sta dentro la chiesa“ nel senso che
l’imperatore è un uomo e come tale è un fedele di Cristo e quindi farà parte dell’ecumene.
Apparentemente opposta a questa affermazione c’è quella di Ottato di Rilevi il quale dirà che “la
chiesa sta dentro l’impero”. Queste affermazioni non sono opposte, ma complementari in quanto “la
chiesa, come istituzione, fa parte dell’impero, tuttavia l’imperatore, in quanto uomo, fa parte della
chiesa”.
Queste affermazioni ci fanno capire quanto complessi fossero i rapporti tra questi due poteri: da un
lato vi era un potere che si fondava sulla presunzione che la chiesa fosse l’unione di tutti gli uomini
( cioè il corpo mistico di Cristo) e quindi un entità infallibile che ha il compito di guidare l’umanità
verso la salvezza eterna; dall’altro lato l’imperatore è colui che ha il compito di assicurare il bene
terreno dei sudditi e poiché ha tale compito, l’impero è la struttura voluta dal Cristo per
l‘organizzazione del mondo, la chiesa deve essere parte dell’impero, deve essere tutelata
dall’impero, deve appoggiarsi ad esso e rispettarlo.
Dunque sin dall’inizio si ha un rapporto complesso dove non c’è e non ci sarà mai una prevalenza
definitiva di una di esse sull’altra, ci saranno solo momenti in cui l’impero tenterà di prevalere sul
papato e viceversa.
Esemplificativo e fondamentale per la dottrina è la sintesi che di questo problema farà Papa
Gelasio I , pontefice dal 492 al 496, il quale è autore di un principio che segna profondamente la
storia della chiesa e dei suoi rapporti con l’impero.
Egli, in una lettera all’imperatore Anastasio, sostiene che il mondo è retto dalla “AUTORITAS
SACRATA PONTIFICIUM” (autorità del pontefice) e dalla “REGALIS POTESTAS” (autorità
reale) cioè da due autorità che insieme reggono il mondo. Gelasio utilizza due termini diversi,
autoctoritas per il papa e potestas per l’impero, tale utilizzo non è casuale in quanto:
• Auctoritas è un potere di legittimità, un potere di grazia, quindi il potere del papa è il potere
di conferire legittimità;
• Potestas è una forza giuridicamente vincolante che riguarda comportamenti esterni.
Esse sono due sfere differenti che si occupano di ambiti diversi, l’insieme di potestas e auctoritas
regge l’ordinamento giuridico; talmente differenti che è difficile stabilire quale delle due prevalga.
Parlando della lettera di Gelasio abbiamo introdotto il “ruolo del pontefice di Roma”.
Lo stile epistolare è il dato caratterizzante della normazione dei pontefici, infatti le norme dei papi
si chiameranno “Epistole decretali” (o semplicemente decretali): esse sono delle lettere che i
pontefici scrivono in risposta a quesiti che gli vengono posti e nelle quali è contenuto un principio
normativo Generale (che cioè può essere utilizzato in situazioni analoghe) avendo il comando del
papa valenza universale.
Le prime decretali pontificie compaiono nelle seconda metà del 4° sec e sono come strutture simili
ai reiscritti, ai mandati imperiali.
Dunque l’altro elemento, oltre alle costituzioni imperiali e ai canoni, cono le decretali :così che già
alla fine del 5° sec il quadro normativo che riguarda la chiesa è ampio e soprattutto disordinato,
tanto che cominciano le prime raccolte normative dei testi che riguardano il diritto della chiesa;
raccolte che sono private (cioè fatte a scopo personale, per i singoli enti ecclesiastici) e che quindi
non hanno il carattere di ufficialità.
Fra queste ricordiamo la Raccolta Dionisiana (fine 5° sec – inizio 6°) composta da Dionigi il
piccolo, che consiste in una collezioni di decretali e canoni, canoni che vengono tradotti dal greco al
latino assicurando così alla raccolta dionisiaca una larga diffusione in occidente. La diffusione è
così grande che papa Adriano 1°, quando incorona Carlo Magno, gli dona una copia della dionisiaca
arricchita da nuovi canoni e decretali che Carlo Magno dovrà utilizzare come diritto della chiesa nel
nuovo impero. Questa collezione prenderà il nome di “Dionesiana-Adriana” e sarà quella utilizzata
nell’impero Carolingio.
Il diritto canonico è un diritto che nasce in oriente con i concili ma che poi si sposta in occidente
dove vi sono due fattori fondamentali: l’importanza del papa di Roma e il suo intervento diretto
nella scena politica occidentale, e la formazione dell’impero Carolingio i cui imperatori
intervengono nella vita interna della chiesa.
Un altro fenomeno che si aggiunge a ciò sono i c.d. “Vescovi-Conti” infatti la dinastia successiva ai
carolingi (cioè gli Ottoni) prenderà l’abitudine di nominare i vescovi, nomina che comporta un
vantaggio per l’imperatore, ovvero il fatto che è garantito il ritorno del feudo alla morte del
vescovo; se poi il conte è anche vescovo, non potendosi sposare non potrà avere eredi che
rivendicheranno il feudo, quindi il feudo tornerà con certezza nelle mani del signore che l’ha
concesso.
La chiesa dunque negli ultimi secoli dell’alto medioevo è sempre più ostaggio dell’impero tanto che
nell’anno 1000 si avrà la “riforma Gregoriana”, la quale è una riforma interna della chiesa che nasce
in Francia e che culmina con la figura di papa “Gregorio VII”.
Tale riforma impone che gli ecclesiastici (cioè gli uomini della chiesa e non la chiesa) non possano
possedere nulla, non possano gestire anche indirettamente niente: questo significa togliere uno degli
elementi della contrattazione, in nome di una riaffermata supremazia del papa sull’imperatore.
Gregorio VII è autore del famosissimo Dictatus Papae , ovvero un elenco di preposizioni brevi,
programmatiche dove si afferma con chiarezza l’autorità suprema del papa sia nei confronti di
qualsiasi autorità laica sia nei confronti di tutti gli altri organismi che compongono la chiesa
(compreso il Concilio).
Il papa non può essere giudicato da nessuno ma al contrario ha il potere di giudicare tutti perché è il
diretto vicario di Cristo in terra quindi su di lui non c’è nessuna altra autorità.
Ciò ha una conseguenza immediata sul piano giuridico ovvero la possibilità dell’appello supremo al
papa: così che tutte le controversie di qualunque entità possono essere sospese ricorrendo
all’appello diretto del papa.
Fra gli strumenti elaborati dalla chiesa Gregoriana quello di migliore efficacia è la “scomunica”
ovvero l’esclusione dall’ecumene, dalla comunità dei fedeli di Cristo.
Se si è tramite la scomunica, fuori dalla comunità si diventa “Res nullius” proprio perché il
medioevo è una età in cui l’individuo è concepito come parte di un ordinamento, di un sistema: ad
esempio c’è la donna, c’è il minore, c’è il mercante … cioè tutti soggetti definiti da un insieme di
diritti che sono i diritti dell’ordinamento di cui essi fanno parte.
L’insieme dei vari ordinamenti si ricompone nell’ordinamento dei fedeòi di Cristo, se si è fuori da
tale ordinamento, fuori dall’ecumene significherà non avere più sudditi, non avere più nessuno che
dovrà obbedienza.
Ecco perché Enrico III starà per 3 gironi e 3 notti inginocchiato per chiedere perdono a Gregorio
VII che lo aveva scomunicato: dunque la scomunica era l’arma più terribile che i pontefici potevano
inventarsi per contrastare lo stra-potere dell’imperatore.
La riforma Luterana viene fatta non soltanto da Gregorio VII ma anche da un insieme di grandi
intellettuali del tempo (tra i quali Anselmo da Lucca) i quali (tramite le loro opere, le loro collezioni
di norme) forniscono al pontefice un supporto per una nuova idea politica.
Le collezioni di tali teologi-filosofi sono un misto tra Teologia e diritto nel senso che all’interno di
tali opere troviamo sia fonti normative che riguardano la chiesa, sia frammenti di opere che
normative non sono, quali ad esempio le opere dei padri della chiesa come S. Agostino, quindi
nell’11° sec in queste elaborazioni teologia e diritto stanno insieme.
Altro esempio di teologia e diritto insieme sono i c.d. “libri Penitentialis” ovvero uno strumento che
consentiva al confessore di essere contemporaneamente sia confessore che giudice dunque, i libri
penitenzialis erano dei prontuari di peccati e di reati insieme (quindi di pene e di penitenze
insieme).
Tuttavia la scolta è da attribuire a Graziano, un monaco contemporaneo di Irnerio: come Irnenio
aveva separato “il diritto alla retorica”, Graziano separò “il diritto salla teologia” tanto che
possiamo dire che con Graziano nasce il Diritto Canonino: ovvero nasce l’idea che il diritto della
chiesa sia un ambito differente dalla teologia.
Graziano riesce a fare ciò attraverso un opera la c.d. “Concordia discordatium canonum” (cioè
concordia dei canoni discordanti) nota come “Decretum” (1140 -1142) ovvero una straordinaria
raccolta di materiale delle varie opere precedenti (per esempio le opere di Anselmo da Lucca). In
tale opera l’intento di Graziano era quello di “concordare” le varie fonti che secondo lui erano
discordanti.
Prima di Graziano di tale discordanza si era accorto Abelardo che nell’opera “sic et non” propone
al lettore le contraddizioni che stanno all’interno dei testi sacri (basti pensare alle contraddizioni tra
il nuovo ed il vecchio testamento).
Tuttavia Abelardo pur proponendo le varie discordanze – contraddizioni, non da una soluzione
proprio perché i testi sacri sono la Parola di Dio, egli infatti non può dire quale delle contraddizioni
prevale essendo “tutta” parola di Dio ( il quale lascia liberi gli uomini di scegliere la scelta
migliore). Sarà dunque Abelardo a suggerire a Graziano il metodo di mettere davanti al lettore i
passi contrastanti, egli aggiungerà “i criteri” per risolvere le contraddizioni.
Graziano utilizzerà fonti del “Diritto Divino” e fonti del “Diritto Umano”: le prime sono fonti i cui
principi giuridici non possono essere contraddetti o messi in discussione. Naturalmente fonti di
diritto divino sono le scritture del vecchio e del nuovo testamento.
Le fonti del diritto umano sono: innanzitutto le fonti normative della chiesa stessa cioè canoni
conciliari, decretali pontificie; poi tutte le fonti laiche che si occupano di chiesa ovvero le
costituzioni imperiali, la compilazione Giustinianea, il codex Teodosiano tratto dalla Lex romana-
Wisigotorum; ma anche i capitolari ecclesiastici, i libri pentinetiales, le opere dei padri della chiesa.
Tutto questo materiale sta sul tavolo di Graziano il quale, essendo un privato, deve giustificare i
principi con i quali cerca di conciliare le discordanze tra tali opere.
I criteri, le rationes, che trova Graziano sono quattro:
1. il primo criterio è la ratio temporis (il criterio del tempo). La legge posteriore non abroga la
legge precedente. Tale criterio naturalmente si può utilizzare solo per le fonti del diritto umano. Ad
esempio un capitolare che dice “uccidi” non può abrogare il comandamento “non uccidere”.
2. altro criterio è la ratio loci (il criterio del luogo). La legge speciale deroga la legge generale.
Ad esempio un canone di un concilio provinciale che dispone specificamente per quel territorio
deroga ad un canone generale di un concilio ecumenico che dice diversamente. Quest’ultimo sarà in
vigore per tutti i territori, il primo soltanto per quel specifico territorio. Questi due criteri da soli non
possono risolvere il problema per questo interverranno altri due criteri più complessi.
3. uno è la ratio significationis (il criterio del significato). Per Graziano due norme
contrastanti valgono entrambe poiché disciplinano per due cose diverse.
4. l’altro è la ratio dispensationis in cui Graziano dice che una è l’eccezione e l’altra è la
regola generale (se per esempio su una determinata fattispecie quattro canoni dicono in modo
uguale ed uno dice diversamente, allora quest’ultimo sarà l’eccezione, per cui vale la regola
generale ma si deve tenere conto anche dell’eccezione).
Graziano essendo un privato non ha alcuna autorità, ha deciso di fare un’opera di questo tipo solo
perché è un maestro di arti liberali che vive in un contesto, quello della scuola di Bologna, in cui si
sta affermando un nuovo tipo di studi, che è quello degli studi di diritto.
Tuttavia solo gli studiosi di diritto della scuola di Irnerio hanno un materiale sul quale studiare
ovvero Libres Legales, ossia la compilazione Giustinianea risistemata da Irnerio, mentre per il
diritto della chiesa manca l’equivalente di questi libri.
Proprio per questo motivo il manuale di Graziano avrà un grande successo nelle scuole, tanto che
sin da subito iniziano a formarsi i c.d. Giuristi Canonisti.
L’avere introdotto questo ambito di studi all’interno della formazione dei giuristi ha anche una
ricaduta pratica. Graziano infatti, acquisisce una tale fama che addirittura Dante lo collocherà nel
paradiso nel cielo dei sapienti, e di dirà: “l’uno e l’altro foro aiutò si che piace in paradiso”.
Tali tribunali (fori) sembrerebbero a prima vista il tribunale laico e il tribunale ecclesiastico ma in
realtà non è così. Infatti sia il tribunale civile che il tribunale ecclesiastico sono entrambi tribunali
che si reggono sul diritto, e non sulla teologia.
La separazione dei tribunali che viene realizzata con il Decretum di Graziano, e quindi con la
creazione del diritto canonico, è la separazione fra il tribunale della coscienza e il tribunale delle
azioni.
Il primo avrà come giudice il confessore, il secondo un giudice sia esso laico o ecclesiastico.
Dunque d’ora in poi vi sarà una separazione netta fra peccato e reato, fra penitenza e pena; il
tribunale della coscienza giudicherà certamente sulle azioni e sulle omissioni ma anche sulle
intenzioni.
Intenzioni che non sono mai oggetto di competenza di un giudice delle azioni ma solo del giudice
della coscienza, il confessore.
Dal Decretum in poi sul soglio pontificio saliranno i c.d. papi giuristi, come ad esempio Alessandro
III, ciò significa che si avrà alla fine del 1100 un impressionante aumento di Decretai Pontificie, le
quali verranno copiate in coda al decretum e verranno chiamate extra-vagantes.
Successivamente, alla fine del XII sec e nei primi 30 anno del XIII, abbiamo 5 raccolte di decretali
dette Quinque compilationes antique: due delle quali hanno carattere ufficiale in quanto
promulgate ufficialmente da pontefici, in particolare la terza antiqua è di Innocenzo III e la quinta di
Onorio III.
Gran parte del materiale delle quinque compilationes confluirà nel c.d. Liber extra composto da
Gregorio IX nel 1234. Tale opera è importantissima per varie motivi: innanzitutto perché è una
compilazione ufficiale, promulgata con bolla e con la quale il pontefice dichiara che tale
compilazione è l’unica da utilizzare nelle scuole e nei tribunali, vieta inoltre a chiunque di fare altre
raccolte di decretali se non espressamente autorizzate dal pontefice; infine invia la compilazione
alla scuola di Bologna, a quella di Orleans e a tutte le altre scuole.
Dunque il Liber extra comprende buona parte delle Quinque compilationes e le Decretali originali
di Gregorio IX. Esso è diviso in cinque libri riguardanti cinque grandi ambiti su cui si muoverà il
diritto canonico d’ora in poi.
Essi sono Iudex, giudice quindi giurisdizione; Iudicium, giudizio quindi clero; Clerum, quindi
organizzazione del clero; Connubia, matrimoni; Crimen, diritto penale.
Nel 1298 papa Bonifacio VIII emana il Liber sexstus che è una compilazione ufficiale nella quale
Bonifacio dichiara che le uniche raccolte da tenere in considerazione sono il Liber extra e lo stesso
Liber sexstus. Tale papa sarà uno dei protagonisti del tempo, avrà uno scontro violentissimo con il
concilio, in particolare con i cardinali Colonna i quali mettono in discussione la sua elezione; sarà
anche protagonista dello scontro con Filippo il bello - Re di Francia.
Anche il Liber sexstus è diviso in cinque parti ed è importante perché prelude ad un periodo in cui
la chiesa, il papato dal 1309 al 1378 in conseguenza allo scontro tra Bonifacio e Filippo il bello
viene spostato ad Avignone.
Il periodo avignonese è fondamentale perché vengono alla luce le c.d. Clementine, ovvero un’altra
raccolta di decretali volute da Clemente V, importanti perché sono le ultime raccolte ufficiali di
decretali.
In seguito nel 1500 un umanista francese Jean Chappis farà una raccolta che chiamerà Corpus Iuris
canonici nella quale inserirà il Decretum, il Liber extra, il Liber sexstus, le clementine, ma anche
due raccolte private; una di Decretali extra vagantes ed una detta di Extra vagantes Comunes.
Esso verrà promulgato ufficialmente alla fine del 1500 e rimarrà in vigore fino alla promulgazione
del Codex del Diritto canonico.
SCHEMA GENERALE
In conclusione le fasi del diritto della Chiesa sono due:
1. la fase giuridico teologica nella quale la chiesa per affermarsi all’interno dell’impero
utilizza la via del diritto;
2. la fase giuridica che prende le mosse dalla riforma Gregoriana ma che inizia con il decreto
di Graziano fino poi alle decretali.
Così che diritto romano, diritto canonico unito alla Scientia Iuris sono il diritto comune.
Quindi possiamo affermare che diritto comune è l’insieme di diritto romano – Giustinianeo, di
diritto canonico dal Decretum in poi, e dalla interpretazione dei giuristi che adattano il materiale
normativo alla realtà del loro tempo.
Lezione 5
La scuola di Pavia, nell’alto medioevo non si può parlare di un insegnamento autonomo del diritto,
ma questo viene studiato all’interno di un organizzazione del sapere enciclopedico. La società non
concepisce il dotto specializzato ma concepisce il sapiente che sa tutto. A ciò deve aggiungersi che
le esigenze della società sono da ritenersi soddisfatte, dal punto di vista giuridico, dalle epitomi e
dalla prassi. Le figure centrali per la produzione del diritto sono i giudici e i notai, ossia quei
soggetti che avendo una preparazione giuridica la utilizzano per dare nomi a situazioni che il diritto
romano non aveva mai prodotto. I primi secoli del medioevo si caratterizzano per configurare una
società rei centrica, al centro degli interessi della società c’era la res, mentre la società romana era
antropocentrica. Significa che mentre il mondo romano immagina un rapporto che dall’uomo va
verso la cosa, cioè immagina che su una res possa esistere un solo dominium, o un solo dominus. Il
medioevo presenta situazioni molto diverse, una società che usa il possesso, un bene immobile
viene cioè gravata di vari diritti di più soggetti. Esemplificativo di tutto questo è il feudalesimo. Se
un bene che appartiene ad un signore viene concessa ad un vassallo, che potrà esercitare su quella
terra tutti i diritti ecco che allora sulla stessa res si avranno due domini, il concedente e il vassallo.
Questo rapporto vassallatico è il più emblematico ma ve ne sono molti altri.
Avremo contratti in cui il proprietario e l’agricoltore si metteranno d’accordo per dividere tutto a
metà, avremo l’enfiteusi etc..
Siamo in un epoca in cui non c’è un legislatore che appalta l’intero mondo del diritto, ma siamo in
un epoca in cui il diritto dei privati è gestito dai privati con l’intervento concreto dei notai.
Il notaio è un personaggio conosciuto all’interno dell’ambiente in cui si muove, ha condotta
irreprensibile, il notaio ha delle qualità intrinseche non imposte dall’alto, ha l’autorevolezza in se
tale da essere un punto di riferimento per la società in cui opera. Lo scopo del ricorso al notaio è
fermare l’incontro delle volontà, l’atto notarile è soltanto testimonianza dell’avvenuto incontro delle
volontà, affinché quel incontro sia il più inattaccabile possibile lo sottopone a tutta una serie di
formalità, prima di tutta la sottoscrizione (firma) . Si vuole difendere l’atto dagli attacchi esterni e
per il futuro, finché i contraenti saranno in vita potranno cambiare o ribadire i termini dell’accordo,
ma quando i contraenti non ci saranno più questo compito sarà compiuto dall’atto notarile.
Il problema principale era la gestione della terra, è l’epoca in cui la maggior parte delle comunità
vive di quello che produce, è l’epoca del particolarismo giuridico. Il signore amministra la giustizia,
riscuote i tributi. Non c’è sovrapproduzione non c’è un mercato attivo.
Come detto il diritto è il prodotto della società e quindi risponde alle sue necessità. Più la società si
complica, cresce economicamente maggiori saranno le richieste di un diritto più dettagliato.
Se nell’alto medioevo il diritto non è soggetto di uno studio autonomo è dovuto al fatto che le
nozioni date dai soggetti operatori del diritto, seppur formati nelle scuole di retorica, sono efficaci
per la società. Non c’è ancora la necessità di formare giuristi di professione. Il 1000 è
tradizionalmente il secolo che segna il confine tra alto (fine del V sec e il 1000) e basso medioevo
( 1000-1400). Il mille è un anno carico di significati che gli uomini del tempo vedevano come la
fine del mondo, si diffuse il millenarismo la convinzione che col passare al nuovo millennio il
mondo venisse distrutto. Ciò naturalmente non avviene e l’XI secolo è un secolo di grande
espansione, le cui cause sono molteplici e tutte collegate. Esse sono: l’espansione demografica che
porta un aumento della forza lavoro e un aumento della produzione agricola, che comporta
un’apertura del mercato, nelle città cominciano a scambiarsi le merci. Su questi mercati arrivano
delle merci che sono il frutto dell’attività dei mercanti. Alla fine del X secolo mercanti amalfitani,
veneziani e poi pisani cominciano a solcare nuove rotte, le rotte dell’oriente, qui comprano oggetti
preziosi e materie prime sconosciute in occidente. I mercanti portano le loro merci in occidente e le
vendono nei mercati e nelle fiere, riparte l’economia. La nuova società che pone al centro le città,
chiede un nuovo diritto poiché il diritto delle epitomi e dei notai non è più sufficiente.
Nel XII secolo prende vita quel fenomeno detto rinascimento giuridico, nel campo del diritto il
rinascimento giuridico è tre secoli prima del rinascimento artistico. Il rinascimento giuridico parte
da Bologna, qui nasce la prima scuola di diritto, la prima università. Questa è il centro deputato alla
formazione dei giuristi. La Sorbona c’era gia però questa era una scuola che nasce come
continuazione di una scuola episcopale, mentre la scuola di Bologna è una scuola laica che nasce ad
opera di un privato. Le origini della scuola sono a metà tra il mito e la realtà, le cose che sappiamo
con certezza è che il fondatore è un maestro di arti liberali di nome Irnerio. Le cronache dicono che
questo personaggio cominciò a leggere i testi della legge e leggendo cominciò ad insegnare. La
prima fase dell’università è una fase lasciata all’iniziativa privata. Un maestro che spiega a dei
soggetti che vogliono imparare e alla fine di un percorso di preparazione li nomina doctores. La
scuola nasce come un’organizzazione privata, gli studenti che sono detti soci, stipulano una
convenzione col maestro, dominus, che prevede il pagamento di una colletta al dominus e si crea tra
dominus e soci una c.d. comitiva. Siamo in quella ambientazione in cui lo studio superiore avviene
nella casa del dominus, i soci vivono col dominus e da lui imparano, quando il dominus ritiene di
aver concluso il percorso formativo, indice un colloquio pubblico in cattedrale e nomina i suoi soci
doctores. Da questo momento in poi i nuovi doctores potranno insegnare il diritti.
Nel 1155 l’imperatore Federico I Barbarossa emana una costituzione a favore degli studenti che di
recano a Bologna a studiare il diritto, a questi viene concesso una sorta di salvacondotto che
consente loro di spostarsi dalle terre di origine fino a Bologna senza pagare alcun pedaggio, e ripara
le offese che verranno commessi nei confronti degli studenti come se fossero stati commessi nei
confronti dello stesso imperatore. La costituzione prevedeva che fosse il loro maestro a giudicarli
nelle controversie che i riguardava, ed infine esentava gli studenti dal diritto di rappresaglia. Il
diritto di rappresaglia è la possibilità che un creditore insoddisfatto ha di equivalersi verso uno
qualunque dei soggetti appartenenti alla stessa natio del debitore insolvente. Chiaramente è una
costituzione che è volta a tutelare e potenziare la scuola di Bologna. La motivazione che spinge
Federico ad emanare la norma è il tipo di diritto studiato nella scuola.
A Bologna si studiava il diritto romano giustinianeo, come detto le epitomi non erano più sufficienti
a regolare la nuova società così si va alla ricerca dei testi antichi. Irnerio ha il merito di aver
ricomposto i testi originali della compilazione giustinianea. Fondamentale la riscoperta del digesto
che torna alla luce dopo secoli. È una riscoperta che non avviene tutta in una volta ma segna almeno
tre fasi, come vedremo tra poco.
Dopo la riscoperta del digesto Irnerio mette mano alla sistemazione del code, che era stato privato
degli ultimi tre libri, riporta alla luce gli ultimi tre libri e riporta alla luce l’autenticum, ossia una
raccolta di novelle giustinianee che sostituisce l’epitome giuliani. Tutto questo materiale
confluiscono nei c.d. libri legales, che sono oggetto di studio della scuola di Bologna.
I libri legales diventano oggetto di studio nelle scuole di diritto; sono cinque e contengono la
compilazione giustinianea nella forma vulgata, una ricostruzione dei manoscritti che Irnerio ritiene
essere quelli giustinianei.
La littera pisana florentina è un manoscritto probabilmente più antico di quelli utilizzati da Irnerio, e
quindi più vicino all’originale,il c.d. archetipo, di cui però non abbiamo notizia.
La suddivisione che fa Irnerio resterà nei secoli a costituire la base del diritto comune, cinque tomi :
il primo volume è detto digestum vetus e contiene i libri che vanno dal 1 al 24, Irnerio scopre per
primi questi libri e li mette insieme, successivamente scopre altri libri. La nuova scoperta riguarda
gli ultimi libri del digesto che vanno dal 38 al 50, che compongono i digestum novum . In una terza
fase scopre il digestum rinfortiatum che in qualche modo vuol dire rafforzato che contiene i libri
che vanno dal 24 al 37. Il quarto volume dei libri legales prende il nome di codex e contiene i primi
nove libri del codice non epitomati, nella loro forma ricostruita. Il quinto e ultimo volume prende
varie denominazioni, è detto volumen, parvum o anche authenticum. In realtà è il più grosso dei
libri legales, contiene i cosiddetti tre libri, ossia gli ultimi tre libri del codex dal 10 al 12 che erano ,
stati eliminati nell’alto medioevo. Irnerio mantiene la divisione del codex , in questo periodo per
codex si intende l’insieme dei primi nove libri. Insieme ai tres libri vi sono le istituzioni, e ancora
l’authenticum, ossia una raccolta di novelle di Giustiniano che sostituirà l’epitome giuliani.
Il termine lezione che oggi viene utilizzato deriva dalla metodologia di studio della scuola di
Bologna, dobbiamo immaginare un’epoca in cui la circolazione dei volumi è molto scarsa. È
impensabile che tutti gli studenti abbiano un testo, il testo è uno solo che viene letto dal dominus, la
letio è la lettura, viene letto un passo della compilazione. Questi testi non sono semplici, richiedono
una spiegazione, lo studio si basa dunque sulla glossa. Questa è un’annotazione che il dominus pone
al fianco del frammento e che è volta a chiarire il significato oscuro del termine. La glossa è una
annotazione marginale o interlineare che almeno nella sua prima fase sostituisce un termine oscuro
con uno più chiaro. Quella della glossa diventa la metodologia di questa scuola che verrà detta
scuola dei glossatori. Questa scuola a partire da Irnerio lavora sulla spiegazione della compilazione
giustinianea, ogni maestro pone sul testo una propria spiegazione del testo. Ognuno dei maestri
usava siglare le proprie glosse con le proprie iniziali. Nei primi decenni del 1200 la situazione
divenne complicata, le glosse erano diventate argomentative dove i maestri annotavano i passi
simili che disciplinavano fattispecie analoghe. La sovrapproduzione di glosse si ferma intorno al
1250, quando l’ultimo glossatore di nome Accursio compila la c.d. magna glossa. Accursio
seleziona oltre 96000 glosse. I glossatori hanno una conoscenza della compilazione giustinianea
unica ed irripetibile, nessuno dopo di loro conosce la compilazione come loro. Conoscono tutti i
passi che possono essere tra loro collegati. Accursio seleziona le glosse e cerca di dare un apparato
omogeneo e lo pone a corredo perpetuo della compilazione giustinianea. Il corpus iuris sarà sempre
accompagnato dalla magna glossa. Anzi ci si baserà maggiormente sui testi della scuola che su
quelli originali. La scuola dei glossatori finisce così la sua spinta creativa.
La scuola di Bologna ha due facce, da una parte i formano studiosi e dall’altro si forma scienza,
studio. Irnerio da una parte risistema il materiale giustinianeo e dall’altra forma dei dottori: Martino,
Bulgaro, Ugo e Iacopo, detti i quattro dottori. Appartengono alla seconda generazione della scuola,
ognuno di loro forma altri dottori.
Vediamo come l’università medievale si struttura in istituzione, abbiamo detto che all’inizio è un
organizzazione privata, gli studenti cercano il maestro e si mettono d’accordo per i programmi e il
salario, siamo in un periodo in cui la formazione universitaria ha un valore formativo, gli studenti
chiedono non il titolo ma una formazione e il maestro sarà tanto più quotato quanto più sarà bravo a
dare questa formazione. Dalla fase privata si passa verso i primi anni del 1200 ad un’organizzazione
istituzionalizzata, si passa all’universitas studentium, è l’università degli studenti, un insieme di
studenti che si cominciano a organizzare in nationes, ogni natio è capeggiata da un rector che è uno
studente. A Bologna si fondano due università una detta degli ultra montani e uno dei citra montani.
La prima raccoglie gli studenti stranieri, mentre la seconda raccoglie gli studenti di ogni parte
d’Italia. La formazione si articolerà in tre anni di studio sui testi giustinianei, con lezioni divise tra
digestum vetus e novum, svolte di mattina, e codex istitutiones e tres libri che vengono svolte il
pomeriggio. Gli ultimi due anni si cominciano gli esami, il percorso degli esami è un percorso
complesso, a tappe, il primo esame consiste in una lettura e ripetizione pubblica che lo studente fa
davanti ai suoi colleghi, questa dissertazione pubblica si articola in due momenti, la prima in cui lo
studente sceglie un argomento e lo espone, nel secondo momento i colleghi gli pongono delle
domande, se supera questo esame ottiene un baccellierato e diviene bacalarius. Una volta ottenuto
questo primo “diploma”, lo studente sceglie un docente e sostiene un’altra prova d’esame detta
tentamen, che è un esame privato in cui lo studente deve dimostrare il suo livello di preparazione su
tutta la compilazione giustinianea, una volta passato questo esame c’è la c.d. privata definito un
mare magnum tremundum ac rigoroso esamen. La privata consiste nella assegnazione al candidato
di due argomenti da parte della commissione, composta dai docenti della scuola e dal vescovo, al
candidato vengono assegnati due argomenti a sera e lui il giorno dopo dovrà discuterli. Questo è il
tipo di esame attualmente utilizzato per l’assegnazione delle cattedre universitarie.
La cerimonia si conclude con la consegna di alcuni simboli che connotano il nuovo doctor, questi
sono l’anello, la toga e il berretto e poi l’abbraccio della commissione che significa che il nuovo
doctor è cooptato dalla comunità dei docenti. I giuristi sono praticamente dei personaggi dotati di
una cultura talmente spendibile nel mercato da diventare un ceto potentissimo. Alla fine del 1200
nasce il loro potere che crescerà esponenzialmente per tutto il medioevo e l’età moderna che verrà
bloccato solo dall’impianto del sistema codicistico.
L’attività della scuola dei glossatori non si esplica soltanto attraverso il genere letterario della
glossa, ma utilizza anche altri generi letterari, tra questi va ricordato il genere delle questiones. Il
termine quaestio viene da quaero che vuol dire domanare, le quaestiones erano dei problemi
giuridici che il maestro poneva ai suoi allievi, questi si dividevano in due gruppi, uno sosteneva una
soluzione, l’altra sosteneva la soluzione contraria. Le quaestiones venivano disputate una o due
volte l’anno, ed era un momento solenne del corso di studi, la disputa poteva anche essere pubblica
e solitamente venivano trascritte. Il dominus sceglieva un problema giuridico che poteva essere
tratto, nelle quaestiones ordinarie, dalla compilazione giustinianea, alla fine della disputa il dominus
dava la soluzione. Esisteva anche le quaestiones de facto, la cui fattispecie era tratta da un caso
della vita contemporanea, la soluzione veniva comunque trovata all’interno della compilazione
giustinianea. È evidente che alcune fattispecie possono essere valide in ogni tempo, mentre altre
sono tipiche del tempo in cui si producono. Il procedimento analogico è alla base della creazione
del diritto che viene fatta in questo periodo, i giuristi cioè attraverso l’interpretazione analogica
della compilazione giustinianea creano ius novum. Non sono dei legislatori, non hanno quindi tra le
loro prerogative quella di creare leggi, ma sono quelli cui la società chiede di risolvere problemi
giuridici nuovi. La possibilità di trovare soluzioni è data da un concetto ampio dell’interpretazione,
che possiamo definire creativa, che va ben oltre la spiegazione.
Il problema che hanno davanti questi studiosi deriva dal fatto che la produzione legislativa di chi
governa non è intesa come totale appannaggio del diritto, esiste un’ ampia zona giuridica che non è
di competenza del legislatore. Questa zona è il diritto privato, che è il diritto dei privati. Il digesto
che traccia le coordinate del diritto privato è un diritto che nasce a Roma dalla giurisprudenza e non
dall’imperatore. anche i giuristi medioevali si trovano di fronte ad un sistema che devono gestire in
proprio. Da una parte devono utilizzare un diritto valido, e dall’altra questo diritto deve essere pure
efficace. Il diritto giustinianeo era valido perché emanato dall’auctoritas costituentium, emanato
dall’imperatore e mai stato abrogato. Il diritto giustinianeo pur essendo valido è vecchio di sei
secoli prima e non può rispondere a domande del XII secolo, perché rispondeva già poco alle
domande del VI secolo se no non si spiegano le novelle giustinianee. Quindi i giuristi medioevali
devono interpretare la compilazione giustinianea per far dire a Giustiniano cose che non avrebbe
sicuramente neanche pensato. Esempio tipico è la teoria tutta medioevale del dominio diviso, le
fonti romane ci dicono che su una res possiamo pensare ad un solo dominus, il bene è di chi esercita
il dominium. I giuristi medioevali si trovano a dover risolvere controversie di tipo feudale, dove un
bene è di tutti e di ciascuno. I glossatori risolvono il problema, ponendo on una glossa accanto alla
parola dominium la parola utile. Il glossatore afferma che se esiste in casi particolare, es. enfiteusi,
una possibilità di una reivindicatio utilis da parte di colui che tiene il fondo, allora esiste anche un
dominium utilis. Si divide il dominio, ci saranno il dominus eminens, che manterrà un dominium
eminens, e un dominus utilis che avrà un dominium utilem. Naturalmente questa costruzione
risponde ad esigenze tutte medioevali e usa strumentalmente il diritto romano. Usano il diritto
romano come apparato strumentale e non come diritto sostanziale.
Lezione 6
Il diritto comune si comprende giustapposto a qualcosa che comune non è, diversamente non
avrebbe senso definirlo comune. Il diritto comune si compone di tre elementi essenziali: il diritto
romano giustinianeo, il diritto canonico, e l’interpretazione dei giuristi. È un diritto che fa parte del
bagaglio di tutti i dottori.
Ci occupiamo adesso del diritto proprio, detti iura propria, che sono i diritti di un ordinamento
particolare. Un ordinamento particolare è un ordinamento che non è universale; sono universali
l’impero e il papato che sono legati ad un’autorità universale. Il concetto di ente universale non
corrisponde al potere universale, ma all’autorità universale.
Gli ordinamenti particolari trovano sul territorio la loro ragione di esistere, il medioevo è l’età del
pluralismo degli ordinamenti. Gli ordinamenti particolari si distinguono in ordinamenti a base
territoriale e su base personale. Su base personale sono le corporazioni, le confraternite religiose e
le associazioni professionali, prima fra tutte la corporazione dei mercanti, il diritto mercantile è un
diritto che si caratterizza per essere tipico di coloro che fanno parte della corporazione dei mercanti.
Lo ius mercatorum nasce a partire dall’ XI-XII secolo, che viene creato dagli stesi mercanti e viene
utilizzato in tutto il mondo, il diritto dei mercanti è fondamentale nel medioevo poiché struttura
tutta una serie di modalità giuridiche specifiche della categoria, il mercante ha bisogni di un diritto
che tuteli le esigenze professionali, prima tra tutte la celerità, lo ius mercatorum prevede
l’istituzione di tribunali mercantili retti non da giuristi ma da mercanti, che abbiano la potestà di
emanare delle sentenze basandosi sulla propria testimonianza orale, non utilizzando documenti
scritti. La specificità del diritto dei mercanti vince sulla generalità del diritto, quindi una
controversia tra un mercante e un non mercante sarà giudicata in un tribunale mercantile.
Il problema delle usure, è un esempio tipico della produzione di diritto nuovo partendo dal diritto
comune, la chiesa condanna l’usura come un peccato mortale, condanna il lucro sul denaro
arrivando a dire che pretendere un interesse sul denaro dato a mutuo è peccato mortale perché il
lucro è fatto su un bene che è di Dio, ossia il tempo.
I mercanti medioevali sono imprenditori diversi dai commercianti di oggi, hanno un’attività molto
complessa che ad ogni gradino della lavorazione del prodotto finanza le fasi di avanzamento, è
chiaro che i mercante rischia ad ogni passo, quindi ha bisogno di un finanziatore dotato di capitali e
che li voglia investire nell’impresa. Utilizzando il mutuo, che però secondo la chiesa doveva essere
gratuito, altrimenti si tratterebbe di reato di usura, i mercanti avrebbero così seri problemi a trovare
un finanziatore. Questo problema andava risolto con un ragionamento giuridico, i giuristi dicono
che non si tratta di mutuo, ma di società che è detta commenda. Nella commenda avremo due soci,
un socio stans e uno tractator, il socio stans metterà il capitale, il tractator metterà la propria abilità
professionale, alla fine i soci divideranno gli utili. La commenda è uno dei contratti utilizzati in
tutto il medioevo ed è alla base della straordinaria espansione mercantile del medioevo.
I contratti di commenda possono essere fatti solo se uno dei due contraenti è un mercante,
diversamente non hanno alcun tipo di validità.
Esempio di diritti particolari degli enti su base territoriale è il diritto dei comuni. Le coordinate
comuni del diritto dei comuni sono gruppi di uomini liberi che si associano liberamente e decidono
di gestire in proprio lo spazio cittadino. Intorno all’anno 1000 c’è un aumento di prodotto, che crea
ricchezza. Intorno ai luoghi dei mercati si creano tutta una serie di servizi. La città diviene il luogo
dove vendere le merci prodotto o importate.
Il primo tipo di comune istituzionalizzato è il comune consolare, retto dai consules, magistrati eletti
dall’assemblea dei cittadini che durano in carica un anno, e sono affiancati nella loro attività di
governo dall’assemblea allargata di tutti i cives, e da un assemblea ristretta formata dai più anziani
o dai più importanti cittadini. Questi sono gli organi che governano il comune consolare che
produce norme di ius proprium. I consoli quando vengono eletti giurano di rispettare un determinato
programma di governo, che prendono il nome di brevia iuramentorum. Gli brevia sono una fonte
della legislazione comunale. Altra fonte sono le deliberazioni dell’assemblea, detti statuti. Una terza
fonte sono le consuetudini, diverse da città in città. Queste tre fonti compongono la legislazione
comunale. I comuni a metà del XII secolo entrano in rotta di collisione con l’imperatore, alcuni
comuni si riuniscono in un’associazione che si chiama lega lombarda, che sconfigge Federico
Barbarossa nella battaglia di legnano (?) . A quel punto l’imperatore è costretto a concedere il
privilegio della pace di Costanza, formalmente è un privilegio ma in realtà è l’accettazione di un
trattato di resa e di una sconfitta. I comuni non chiedono la scomparsa dell’imperatore, ma gli
chiedono di avere un’autonomia all’intero della sfera di autonomia del comune. I comuni possono
eleggere i propri ufficiali, che dovranno essere in seguito nominati dall’imperatore, e ancora
l’imperatore concede ai comuni di poter utilizzare i propri more. La conseguenza diretta è che i
comuni cominciano a mettere per iscritto non solo le consuetudini ma anche i brevia. Subito dopo la
pace di Costanza cominciamo ad avere tutta una serie di statuti comunali, contenenti i brevia, le
consuetudini e gli statuti veri e propri. Ben presto nascono delle magistrature, detti degli statutari,
che hanno il compito di controllare la congruità interna degli statuti e la rispondenza dei principi
degli statuti ai principi generali che reggono l’ordinamento dal punto di vista dello ius comune.
Gli statuti comunali cominciano a diventare fonti di diritto. Altra conseguenza immediata della pace
di Costanza è il cambiamento dell’assetto interno dei comuni, la magistratura consolare composta
da un numero pari spesso comporta l’incapacità di decidere, si passa quindi già alla fine del 1100 al
governo podestarile. Il podestà è un organo di un governo monocratico, deve essere sempre uno
straniero, ha al suo soldo personale una comitiva di uomini armati che gli consente di stabilire la
legge e l’ordine pubblico, alla sua elezione giura, l’assemblea ha sempre un ruolo centrale, ma la
presenza di un potere esterno è una garanzia di maggiore governabilità. Il potestà non può essere
rieletto, non può avere terre all’interno del comune e non può prendere moglie tra le donne del
comune. Nasce così una classe di politici di professione che girano i comuni amministrando la cosa
pubblica, molti di questi sono giuristi.
Il regno di Sicilia, nasce nel 1130, il cui primo sovrano è Ruggero II della casa di Altavilla,
normanno di origine, figli di Ruggero il Granconte che aveva riconquistato la Sicilia fino ad allora
nelle mani degli Arabi. A metà dell’XI sec gruppi di cavalieri normanni vengono chiamati nel sud
d’Italia dai sovrani longobardi per cacciare gli arabi. In seguito a vari successi i longobardi
concedettero pezzi di terre. Tra questi si fa strada Roberto il Guiscardo, che ottiene il titolo di conte
di Puglia, entra in conflitto diretto dal Papa, lo sconfigge e da questi ha il compito di riconquistare
la Sicilia. A sua volta affida il compito al fratello Ruggero il quale riesce nell’impresa. E viene
nominato conte di Sicilia. La Sicilia è quindi un unico dominio feudale nelle mani di un solo
signore. Ruggero divide l’isola in feudi, molti dei quali ecclesiastici, ripristina le vecchi diocesi e ne
crea di nuove. A capo di queste diocesi Ruggero pone sempre uomini di sua personale fiducia, la
gestione dell’isola è una gestione unitaria, molto importante perché quando alla morte gli succederà
il figlio, proprio dalla Sicilia partirà alla conquista dell’Italia meridionale. Nella notte di Natale del
1130 si farà nominare Re di Sicilia dall’antipapa Anacleto. La monarchia normanna di Sicilia è una
monarchia che si struttura sul modello di analoghe compagini monarchiche europee, prima tra tutte
la monarchia normanna di Inghilterra fondata nel 1066 da Guglielmo il conquistatore. La struttura
prevede vari modelli istituzionali, prevede una corte itinerante, con ufficiali sul territorio che hanno
il compito di esigere i tributi e di amministrare la giustizia. Nel 1140 Ruggero II riunisce ad Ariano
un’assemblea di nobili del regno e qui detta il primo corpus di norme che fanno parte della struttura
normativa del regno, le c.d. assise. Le assise sono il primo monumento legislativo del regno di
Sicilia. È una legislazione di diretta iniziativa regia e l’assemblea ha l’unico compito di ascoltare la
volontà del re. Anche i successivi re normanni emanano assise.
Alla dinastia normanna succede la dinastia sveva, Costanza d’Altavilla, ultima erede dei sovrani
normanni, sposa Enrico VI, figlio di Federico barbarossa e imperatore del sacro romano impero.
Costanza che era monaca viene fatta sposare a Enrico, dal loro matrimonio nasce Federico II,
partorito pubblicamente in una tenda alla presenza di militari del regno e della casa imperiale,
affinché questi potessero testimoniare che il parto era avvenuto nonostante la tarda età di Costanza.
Federico II rimarrà orfano di padre all’età di tre anni, quindi diverrà re a quella età affiancato dalla
madre e dal pontefice. Federico governa in Sicilia per oltre trenta anni dal 1220 fino al 1250,quando
muore; viene scomunicato due volte e per porre un limite alla prima scomunica pattuisce col
pontefice una crociata, ma invece di combattere con il sultano stringe un accordo e ritorna a
Palermo con un seguito di animali esotici, odalische, eunuchi, fa un vero e proprio harem e per
questo viene scomunicato una seconda volta. È un personaggio singolare perché divide la sua vita in
due ambiti, da una parte la monarchia siciliana ricevuta dalla madre e l’impero che conquista in
maniera non pacifica in germania, poiché l’assunzione di due poteri così forti in capo di un'unica
persona non era ben vista, soprattutto dal papa. Non unirà mai le due figure, avrà due cancellerie.
Nel 1231 a Melfi Federico emana il liber augustalis, si tratta di un corposo complesso di norme che
Federico definisce costituzioni e non più assise, nonostante il termine indicasse le norme imperiali.
Federico è imperatore ma quelle norme valgono solo per il regno di Sicilia quindi non potrebbero
definirsi tali. Il liber augustalis è un’opera singolare, innanzitutto non possono essere applicate leggi
diverse da quelle contenute in quel tomo, quindi tutto quello che c’era prima viene abrogato. Fatta
eccezione per alcune assise normanne che Federico recepisce.
La legislazione federiciana è una legislazione che tiene conto dei vari ordinamenti che stanno
all’interno del regno, occorre ribadire che il regnum siciliae è un ordinamento particolare, con
confini definiti (Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia). Il regnum è sostenuto da un ordinamento che
contiene al suo interno varie e molteplici realtà. In una delle costituzioni del liber augustalis che è
nota come puritatim, Federico stabilisce la gerarchia delle fonti. I giudici dovranno applicare le
costituzioni del liber augustalis, in caso di lacuna normativa i giudici potranno applicare le
consuetudini, che in Italia meridionale sono una sorta di statuti che riguardano le varie città.
Ciascuna città ha il proprio bagaglio consuetudinari. In defectu delle consuetudini i giudici potranno
applicare gli iura communia, quindi ai diritti comuni. Questi diritti sono il diritto longobardo e il
diritto romano. Nel liber augustalis per diritto comune si intende il diritto longobardo e il diritto
romano. Il diritto longobardo viene considerato diritto comune a causa della presenza consolidata
nel territorio soprattutto peninsulare del regno. Il liber augustalis è un’opera che si arricchisce di
norme anche dopo il 1231. Sono norme che modificano e migliorano le norme precendenti.
La ripresa dell’attività normativa non è un caso isolato, infatti nel 1234 viene emanato il liber extra
da Gregorio IX. È un periodo in cui tutte le monarchie europee producono compilazioni di norme,
questo perché ci sono più giuristi nella piazza e molti di questi vengono impiegati dai sovrani.
La legislazione del regno di Sicilia continuerà con i sovrani successivi.
Possiamo considerare il regnum siciliae un modello di un ente particolare a carattere territoriale che
produce ius proprium.
Torniamo ad occuparci della scientia iuris, la scuola dei glossatori si chiude nel 1250 con la magna
glossa di Accursio, che seleziona le glosse e fa da cornice definitiva al corpus iuris. La scuola dei
glossatori ha esaurito la sua spinta. Bisogna cambiare modo di interpretare. Il rinnovamento negli
studi del diritto viene dalla Francia, dove viene istituita la scuola di Orlean.
In Francia esisteva già la Sorbona dove però si studiava esclusivamente filosofia. La vicinanza con
Parigi e la scuola di sorbona influenza moltissimo il nuovo metodo di studio de diritto.
Siamo nel periodo che si definisce della filosofia scolastica, il riflesso degli studi aristotelici e della
logica del sillogismo condiziona fortemente lo studio del diritto della scuola di Orlean. Qui viene
usato un metodo nuovo che non riflette più sulle singole parole, sui verba iuris, ma riflette sulla
logica del sistema giuridico. Quindi i giuristi cominciano a staccarsi dalla parola e cominciano a
guardare al sistema nel suo complesso. Le orme rispondono a dei principi e quindi sono valide per
questo.
Da maetri della scuola di orlean il nuovo metodo passa in Italia grazie a Cino da Pistoia. Questi è
autore di un nuovo metodo che espone nella Lectura super codice. Nella sua opera Cino espone il
nuovo metodo di studio dei testi giuridici. In primo luogo si dovrà fare la divisio legis, cioè la
scomposizione della norma nelle varie parti logiche che la compongono. La seconda tappa dello
studio riguarderà la c.d. positio casum, cioè la ricostruzione delle fattispecie che sono regolate da
quella norma. La scuola dei commentatori fa appunto un commento a tutte le leggi.
Il giurista deve trovare le parti logiche che compongono la norma, una volta trovate, egli potrà
ricostruire tutte le fattispecie che sono rette da quei principi logici, alla fine porrà le quaestiones e le
solutio. Mentre i glossatori li abbiamo conosciuti come interpreti veneranti del testo che stavano
studiando, adesso con la scuola dei commentatori l’atteggiamento comincia a cambiare.
La ricerca dei principi giuridici è certamente un qualcosa che riguarda la scuola dei commentatori,
che prende le mosse da Cino da Pistoia, ha un precedente fondamentale, questo precedente stà in
una parola che è equitas. Per comprendere il ruolo dell’equitas bisogna fare un passo in dietro e
tornate ad Irnerio. Alcune sue glosse ci danno il pensiero di Irnerio circa l’equitas, nel diritto
romano l’equitas è quell’elemento che consente di mitigare sanzioni eccessive dovute alla stretta
applicazione della legge, è intrinseca al sistema che si esplica con il diritto pretorio. Nel mondo
giustinianeo il concetto di equitas cambia e diventa l’ideale che sta fuori del sistema e al quale
questo deve tendere. Irnerio dice che esistono due tipi di equitas, una rudis e una constituta.
L’equitas diviene constituta quando interviene un atto normativo a disciplinare una determinata
fattispecie. L’unico soggetto a poter cambiare l’equitas da rudis a constituta è il legislatore. Irnerio
vede come unico legislatore l’imperatore Giustiniano. Le norme del legislatore sono esempi di
equitas constituta ma presuppone che questi traspongano idee di equitas rudis. Il ruolo del giurista è
dunque quello di trovare il principio della legge. L’interprete deve, in altre parole, interpretare le
norme e renderle utilizzabili. Quanto più il giurista sarà arguto tanto più il principio da lui trovato
sarà valido.
I commentatori lavoreranno su generi letterari che i glossatori non conoscevano, come ad esempio il
commento, non più spiegazione esegetica ma commento del digesto, utilizzeranno anche il tractatus
su argomenti specifici, in fine utilizzeranno anche gli iura propria, ossia tutte le fonti del diritto che
concorrono alla formazione dell’ordinamento.
A partire dalla scuola dei commentatori più che i testi originali delle norme verranno utilizzati i
commenti fatti dai giuristi. Cino ha un allievo importantissimo che è Bartolo da Sassoferrato,
considerato il più importante giurista di sempre. Bartolo è un personaggio che vive pochissimo,
muore a 36 anni, ma nella sua pur breve esistenza scrive tantissime opere, insegna all’università. A
lui dobbiamo l’esistenza del diritto internazionale. Fonda la moderna teoria del marchio di fabbrica.
Alla sua morte vengono istituite delle cattedre per studiare l’opinio bratoli, che diventerà legge in
molti stati. Nascerà il bartolismo, che ci ha tramandato la famosa massima nemo iurista niqui
bartolista. Bartolo è autore di una teoria importantissima sulla legittimazione della potestas
statuenti degli enti particolari. Nelle fonti di tradizione romanistica questi enti non trovavano
legittimazione. Bartolo trova una giustificazione alle leggi dei comuni e degli altri enti particolari, la
più antica è la teoria della permissivo, che afferma che gli enti sono legittimati a porre leggi perché
l’imperatore lo ha concesso. Questa teoria è subito superata, se la legge è concessa dall’imperatore
allora egli potrà revocarla in qualsiasi momento. Bartolo supera questa teoria ed formula la teoria
della iurisditio, che sta ad indicare l’insieme dei poteri di governo di un ordinamento, quindi non
soltanto la giurisdizione. Bartolo dice: esiste una iurisditio maxima che appartiene all’imperatore,
questa si estende su tutta la terra, esiste poi una iurisditio minima, che è quella che un proprietario
esercita sul suo fondo. Tra quella maxima e quella minima ci sono tutta una serie di iurisditiones,
che non sono subordinate gerarchicamente alla iurisditio maxima, ma sono uguali, quello che
cambia è il confine in cui si esercitano, stanno con la iurisditio maxima in un rapporto di genus e
species. C’è un rapporto di specificazione. L’allievo principale di Bartolo è Baldo degli Ubaldi,
questi perfeziona la teoria di Bartolo, è autore del c.d. sillogismo aureo. Che non viene
immediatamente compreso dai suoi contemporanei. Baldo dice populi sunt quae iuve gensum(?),
cioè ogni ordinamento si regge con ius gentium, col diritto che esso stesso produce. Quindi un
ordinamento è legittimato a darsi delle norme per il fatto stesso che esiste. Baldo dice che se
l’ordinamento non si da delle regole non può definirsi tale. Concetto che viene ripreso da Santi
Romano che definisce ordinamento qualunque aggregato in grado di darsi delle regole condivise.
Lezione 7
Cerchiamo di tratteggiare adesso le linee essenziali di quattro secoli, dalla fine della scuola dei
commentatoti fino alla codificazione napoleonica. Ogni periodo ha le sue specificità, è possibile
però individuare alcune linee essenziali che ci porta dall’antico regime alla rivoluzione francese e
dunque alla codificazione napoleonica. Quello che il medioevo fonda, ossia una civiltà giuridica
molto complessa e che richiede certamente un’attenzione più specifica, diversamente si incorre
nell’equivoco di considerare tutto come tradizione romanistica. Abbiamo visto come a partire
dall’età dei glossatoti, manovrano le regole giuridiche, si affiancano o si sostituiscono a quella che è
la funzione tipica del legislatore-governante. Attraverso l’interpretazione i giuristi creano un
sistema di diritto. I tratti che dobbiamo ricordare per l’età moderna (che comincia
convenzionalmente con l’invenzione della stampa e la scoperta dell’america, e dura fino al
congresso di Vienna del 1891). Innanzi tutto continuiamo a parlare della scienza giuridica.
Nel 1400 succede che sotto l’influsso dell’umanesimo, l’umanesimo porta nello studio del diritto la
filologia, studio dei testi antichi. Alcuni umanisti importanti, come Poliziano e Lorenzo Valla,
studiano il diritto da una prospettiva filologica. Ad esempio studiano i manoscritti con cui è stata
tramandata della compilazione giustinianea, la littera pisano-florentina e la vulgata o boloniensis
verranno studiati da Poliziano. La metodologia uilizata del glossatori è rozza e non tiene conto della
storicità del testo, i glossatori usano la compilazione giustinianea e la piegano ai loro interessi, gli
umanisti dicono che i giuristi devono restituire alla loro epoca storica i testi che studiano. La
compilazione giustinianea va dunque restituita all’epoca cui appartiene.
La scuola dei culti utilizza il mos gallicum iura docendi, questa scuola è fondata da un giurista
italiano, Andrea Alciato, si trasferisce a Bruges e fonda appunto la scuola che applica uno studio
filologica al diritto. In Francia il diritto utilizzato è il diritto del Re, quindi i giuristi francesi sono
più liberi di studiare le fonti che si sono sempre studiate con un occhio nuovo, con una nuova
apertura. La scuola dei culti annovera altri illustri personaggi tra cui Curiacio e Hotman. Quest’
ultimo è autore di un’opera intitolata Anti-tribonianus, Triboniano è colui che aveva armonizzato la
redazione finale del digesto. Hotman muove una critica ferocissima a Triboniano e dunque a
Giustiniano, dicendo che chi vuole conoscere realmente il pensiero dei giuristi classici romano non
dovrebbe leggere il digesto, poiché il digesto è in realtà un’opera di sconvolgimento profondo del
pensiero dei giuristi classici, Triboniano estranea dalle opere dei giuristi classici quelle frasi che si
armonizzano all’idea giustinianea. Quello che fa è un lavoro di falsificazione delle norme.
Giustiniano snatura la logica e la natura stessa degli iura, che non avevano bisogno della sua
promulgazione. Dopo 11 secolo arriva la critica di Hotman, egli invoca studi più approfonditi alla
ricerca di fonti pre-giustinianee. Quest’atteggiamento ha nei confronti della tradizione medioevale
degli studi del diritto un effetto distruttivo, evidentemente una cosa è studiare le fonti e una cosa è
fare i giuristi. Infatti in Italia parallelamente si sviluppa il mos italicus iura docendi, uno degli
esponenti più importanti è Alberigo Gentili, che lavora per lungo tempo in Inghilterra, dice che
certamente quello che dicono i giuristi francesi non è sbagliato, tuttavia egli separa nettamente
l’effetto pratico e quello scientifico. Senza l’esperienza che ha sviluppato la scienza giuridica a
partire dai glossatori oggi non esisterebbero operatori di diritto. In Italia la scienza giuridica sposta
la sua sede dalle università agli studi degli avvocati. Qui entra in gioco l’importanza della stampa,
fra i primissimi testi ad avere una divulgazione a stampa notevole, vi sono una raccolta di consilia,
raccolte di pareri di eminenti giuristi, che verranno utilizzati anche dagli avvocati meno eminenti.
L’avvocato è un uomo facoltoso, viene pagato con i soldi, cosa rada nell’età medievale e moderna,
questo denaro viene spesso investito nell’acquisto dei libri, ancora molto cari ma sicuramente meno
cari dei manoscritti. Attraverso questa raccolta di consilia abbiamo una seconda stagione di
diffusione di una cultura giuridica omogenea. Il latino è la lingua del diritto e lo rimarrà per tutta
l’età moderna. Non c’è una barriera linguistica e quindi queste raccolte possono essere utilizzate in
tutta Europa. Potremmo dire che il 1400 ha come caratteristica principale questo sdoppiamento
della scienza giuridica, che da una parte continua nel solco della tradizione concentrandosi
maggiormente sui consilia e concentrandosi sulla professione privata, e dall’altra parte con la scuola
culta che invece utilizza gli strumenti della filologia per studiare più la storia del diritto che il diritto
stesso.
Il 1500 è il secolo in cui compaiono le prime monarchie assolute, che postula che vi sia un sovrano
detentore di ogni potere e di ogni comando sui suoi sudditi. L’assolutismo, che è un fenomeno che
parte in pieno 1500 e che dura fino alla rivoluzione francese, ingaggia una battaglia strenua con il
sistema giuridico vigente. Se il sovrano è detennero di ogni potere è detentore anche del potere di
fare le leggi, non può più delegare ai giuristi il compito di creare attraverso l’interpretazione il
sistema vigente, ma deve intervenire in ogni aspetto della vita giuridica. Naturalmente questo è un
presupposto puramente teorico. Il termine assolutismo ha un’accezione negativa, affibbiata dalla
rivoluzione francese, deriva da solutus, ossia sciolto, il sovrano è legibus solutus, è sciolto
dell’osservanza delle leggi positive. La solutio riguarda un ambito preciso, non riguarda infatti le
leggi naturali e quelle divine. Evidentemente la nascita delle monarchie assolute e la nascita di un
potere sovrano accentratore sono il segno che quel pluralismo giuridico di cui abbiamo parlato per i
secoli precedenti non funziona più, è finito l’universalismo. La sua fine è dovuta a due fattori
fondamentali , intanto l’impero è ormai un’entità soltanto nominale ed è uno stato territoriale come
gli altri, quindi l’imperatore è un re come gli altri, e poi la scoperta dell’america ha scardinato
l’eurocentrismo. L’esistenza di un nuovo mondo significa la scoperta di realtà sconosciute, e poi
crea problemi per quanto riguarda il dominio sul nuovo mondo. Il nuovo mondo non è dell’impero,
ma è diviso tra Spagna, Portogallo, Inghilterra e poi Francia, quest’universalismo imperiali perde il
suo fondamento anche teorico. Anche la chiesa, altro pilastro dell’universalismo, perde ugualmente
la sua portata universale quando in Europa si afferma la riforma luterano, che spezza
definitivamente l’unità della chiesa di occidente. È evidente che l’universalismo pontificio crolla.
Se finisce l’universalismo, finisce anche quel sistema della complementarietà tra diritto comune e
diritti particolari, viene sostituito da un sistema su base nazionale. Ogni nazione ha un diritto suo
proprio che può includere il diritto comune, ma può anche non includerlo. Il diritto comune farà
parte del sistema nazionale soltanto si principi placuit. Inizia un periodo che verrà, con un termine
ancora una volta negativo, definito di particolarismo giuridico. Cioè non più un universo
pluriordinamentale basato sul principio della reductio ad unum, dell’universale che contiene il
particolare ma non lo ingloba, cioè ogni ordinamento è particolare ha un suo confine e un suo capo.
Il 1500 è un secolo in cui cominciano le grandi guerre in Europa, guerre nazionali, combattute con
eserciti nazionali che sono composti da truppe pagate dal re, truppe mercenarie. Truppe che
costituiscono l’ossatura degli eserciti di stato. Naturalmente per mantenere un esercito sono
necessari molti soldi, questi soldi si prendono dalle tasse, il regime da tassazione non è compatibile
con l’idea di nazione. I sovrani assoluti cominciano allora uno scontro contro la nobiltà, tenteranno
in ogni modo di introdurre sistemi di fiscalità diretta su base patrimoniale che interesseranno anche
i domini feudali. Quindi da una parte lo stato tenta di organizzarsi su basi differenti, c’è bisogno di
un controllo del territorio che sia diretto, dall’altro un sistema di particolarismi che continua ad
opporre una resistenza strenua. I giuristi stanno da entrambe le parti, sono tra quelli che traggono
maggioro benefici da questa situazione, e saranno tra i più accaniti sostenitore del regime del
particolarismo. Tra 1500 e 1600 assistiamo ad un nuovo spostamento del cuore della giuridicità
della produzione del diritto, dagli studi degli avvocati alle aule dei tribunali, questo percorso è
l’ultima tappa prima della ghigliottina, poi la svolta sarà definitiva con l’avvento del nuovo sistema.
I grandi tribunali sono i tribunali centrali dei vari stati europei, ogni monarchia a partire dal 1500 in
poi si dota di un tribunale centrale, anche se in regno d Sicilia lo aveva già dal 1200. I grandi
tribunali sono i tribunali supremi, hanno competenze di ultimo appello e hanno competenza
esclusiva su tutta una serie di materie tra cui i reati di lesa maestà, alcuni problemi riguardanti la
gestione dei feudi maggiori. Adesso assistiamo alla professionalizzazione delle corti giudicanti, nei
secoli precedenti i tribunali erano composti da giudici alcuni giuristi e altri no giuristi ed erano
presieduti da soggetti che non erano esperti di diritto. Adesso queste corti sono composti
esclusivamente da giuristi, scelti personalmente dal sovrano tra quelli più importanti dell’impero. I
tribunali centrali sono i tribunali del re, svolgono concretamente quella funzione di giudice che era
stata da sempre una delle prerogativa della figura del sovrano, sono il braccio giudicante del
sovrano. Più antico di questi grandi tribunali è la Sacra Rota, questa viene istituita nel XIV secolo
ed è il tribunale centrale dello stato della chiesa, ha una valenza importante nell’ambito delle cause
matrimoniali, giudica su tutte le materie che sono di competenza del diritto canonico. Altri tribunali
centrali vi sono in tutti gli stati. Il diritto si produce nei grandi tribunali, abbiamo detto che però
sono i tribunali dei sovrani, potrebbe sembrare in contraddizione, infatti c’è una contrapposizione
tra sovrani e giuristi. La diffusione della giurisprudenza dei consilia che aveva preso le mosse dalle
rationes, aveva strutturato il metodo della communis opinio cioè se un determinato orientamento era
corroborato dal parere concorde di più giuristi diventava una sorta di precetto normativo. Nei fatti
quella communis opinio diventava cogente, il precedente non era vincolante in base ad un precetto
normativo ma lo diventava nei fatti. Cominciano a circolare a stampa raccolta di communes
opiniones, ad uso della pratica forense, gli avvocati usavano questi prontuari sia per le loro arringhe
sia come orientamento per il processo. Nel momento in cui i grandi giuristi cominciano ad occupare
stabilmente il posto nelle corti giudicanti dei grandi tribunali centrali ecco che la communis opinio
comincia ad essere costituita dalle sentenze dei grandi tribunali, ancora una volta non si tratta di un
precetto normativo ma si tratta di un precetto della prassi. Pensiamo al sistema di common law
americano in cui il precedente fa diritto. I tribunali di antico regime non motivano mai le sentenze,
naturalmente questo comporta da un punto di vista dei giudici un notevole accrescimento dei loro
poteri. Senza motivazione della sentenza sarà molto più difficile ricorrere in appello contro quella
sentenza, l’assenza di motivazioni rende piuttosto difficile però conoscere gli orientamenti
ideologici degli stessi tribunali. Infatti comincia a prendere piede un genere letterale nuovo che è
quello delle decisiones, illustri giuristi che hanno fatto parte delle corti giudicanti, compongono
privatamente delle raccolte in cui danno conto di quale sia stata la discussione all’interno della corte
giudicante. Le prime raccolte di decisiones sono quelle della Sacra Rota, ma possediamo raccolte di
decisiones di tutti i grandi tribunali. È chiaro che è un uso che trova nella reiterazione la sua forza,
tanto più saranno sentenze che seguono un determinato orientamento tanto più quell’ordinamento
diventerà legge, non vi sarà intervento del sovrano che riuscirà a scardinare la forza della communis
opinio. Si crea una vera contrapposizione tra i grandi tribunali e l’attività di accentramento
legislativo che vogliono fare i sovrani. I tribunali continueranno fino alla rivoluzione francese ad
interpretare la legge. Dobbiamo considerare che c’è un problema che riguarda la certezza e la
conoscibilità del diritto, abbiamo da una parte i grandi tribunali e la loro giurisprudenza, dall’altra
una produzione normativa di proporzioni enormi che procede in maniera alluvionale
sedimentandosi su se stessa, non ricorrendo mai all’abrogazione di norme precedenti, non
ricorrendo a canali unici di pubblicizzazione, per cui se ricordiamo Manzoni che fa dire al suo
Azzeccagarbugli “a saper bene maneggiare le grida nessuno è reo e nessuno è innocente”, perché
avendo una legislazione che si è accumulata per sei secoli ed è tutta vigente sarà la bravura
dell’avvocato saper trovare la legge utile. I grandi tribunali svolgono un’azione di
omogeneizzazione, volta a cancellare le incoerenze del sistema, è un’azione interna al tribunale,
fuori c’è la legislazione di sovrani che continua a produrre regolamenti. Chiaramente il problema
della certezza e della conoscibilità del diritto diventa il problema fondamentale della vita del diritto,
un problema al quale reagiscono con forza da una parte i movimenti filosofici del tempo, dal
giusnaturalismo all’illuminismo giuridico, che postulano una razionalizzazione del sistema, un
diritto che come dirà Leibniz sia composto seguendo le regole dei teoremi matematici, composto di
norme e soltanto di norme che hanno una struttura logica sempre individuabile. La chiarezza del
sistema e la conoscibilità delle fonti vengono chieste dagli intellettuali, ma vengono chieste anche
dalle strutture pubbliche. Le consolidazioni sono una risposta a questa esigenza, questo termine
viene utilizzato spesso in contrapposizione al termine codificazione, le consolidazioni sono delle
raccolte di norme che in qualche modo sembrano anticipare per alcuni versi quelle che saranno le
caratteristiche dei codici moderni. Tuttavia non sono ancora dei codici, innanzitutto sono delle
raccolte di norme che vengono redatte con lo scopo di ordinare il mondo del diritto, quindi sono
tutte raccolte di norme preesistenti che vengono organizzati, o da privati o per iniziativa dei
sovrani. Il codice contiene invece diritto nuovo. I criteri in base ai quali questi materiali sono
raccolti sono criteri utilitaristici, non creazione di un sistema organico ma semplificazione. Un’altra
caratteristica fondamentale è che non hanno carattere abrogativo nei confronti del materiale che non
confluisce nelle consolidazioni. Formalmente tutte le leggi regie che non sono abrogate restano in
vigore. Se la causa viene discussa davanti al tribunale centrale, che ha accesso a tutti gli atti della
cancelleria regia è ipotizzabile che avvocati e giudici possano utilizzare anche atti non compresi
nelle raccolte, ciò invece non è possibile nei tribunali periferici che possiedono solo le
consolidazioni. La prima raccolta ufficiale del regno di Sicilia è del 1497, e contiene capitoli dal
1200 a metà del 1400. si trovano consolidazioni in tutti gli stati europei, ma tra le più importanti
vanno ricordate quelle di Luigi XIV, il re sole, prototipo del sovrano assoluto. Il quale non potendo
ancora utilizzare la ghigliottina, per affermare il potere assoluto fa costruire una reggia dove mette i
più grandi nobili del regno e crea un formidabile apparato funzionariale che affianca e poi
sostituisce la gestione delle funzioni principali dello stato, tra cui la gestione della giustizia, che fino
ad allora era ad esclusivo appannaggio dell’aristocrazia. La vendita delle cariche, che avveniva fino
ad allora, era un ostacolo all’accentramento delle funzioni nelle mani del re. A Luigi XIV dobbiamo
le ordanances, che sono quattro compilazioni che riguardano: procedura civile, procedura penale,
diritto commerciale e diritto della navigazione. Luigi XIV fa delle leggi quadro che riguardano la
composizione dei tribunali e le modalità da seguire per lo svolgimento dei processi, interviene
inoltre sul diritto dei mercanti che usualmente non era di competenza dello stato. Luigi attua quella
politica detta mercantilistica, con cui il sovrano si dichiara protettore delle attività commerciali e
per le quali percepisce un guadagno. Per le materie oggetto delle ordanances si prevede
l’abrogazione di tutte le norme che non sono menzionate. Questa caratteristica ha fatto pensare che
in realtà queste fossero già dei codici, tuttavia mancano di alcune caratteristiche fondamentali,
prima tra tutte quella della non eterointegrabilità, poiché per tutte le materie non indicate nelle
ordanances il sistema resta invariato.
Nel 1700 quest’esempio verrà seguito da molti altri sovrani, tra cui Vittorio Amedeo D’Aosta,
questo è un sovrano che si etichetta come sovrano illuminato, nel 1700 l’influenza della filosofia
illuminista produce uno strano fenomeno apparentemente contraddittorio. I grandi sovrano europei
sposano le grandi idee illuministe che di lì a breve li porterà a perdere il loro trono. L’ordine
postulata dagli illuministi viene accolto dai sovrani, che vogliono rafforzare la lotta contro i
privilegi. I progetti di riforma abbozzati dai sovrani illuminati falliscono quasi tutti, perché si
scagliano contro un radicamento del privilegio che è molto forte. Se il sistema giuridico è razionale
e le leggi sono conoscibili da tutti è chiaro che il ceto dei giuristi si fa meno forte. Fra i postulati
delle monarchie illuminate c’è oltre la razionalizzazione del diritto c’è la creazione del catasto,
ritenuto la base necessaria per una distribuzione fiscale più equa. Tutto questo fallisce, ma il sistema
è ormai il sistema è vicino al collasso, questo collasso è la rivoluzione francese. È il momento
concreto di stravolgimento del sistema, è la prima rivoluzione nella storia dell’umanità. Il termine
rivoluzione, che era legato all’astronomia, vieni usato per la prima volta in questa occasione. Ma
quella francese non era una rivolta ma era una rivoluzione, le cose da quel momento in poi non
sarebbero più state le stesse. I riflessi sul mondo del diritto sono anche questi rivoluzionari, si da un
taglio netto col passato, si introducono tutta una serie di istituti nuovi, di principi nuovi: la
cancellazione di tutti i privilegi feudali e la confisca dei beni ecclesiastici pongono fine per sempre
all’esistenza di due aree che si erano sottratte alla statalizzazione del diritto. La rivoluzione avvia un
processo di codificazione, non esiste una società riformata senza un diritto riformato. Si deve
prevedere un nuovo assetto dei rapporti tra gli uomini, e deve prevedere questo perché adesso i
soggetti del diritto sono nuovi. Il medioevo non conosce l’idea di persona ma conosce l’idea di
persona all’interno di un ordinamento, la rivoluzione riconosce l’unicità del soggetto di diritto: tutti
sono uguali di fronte alla legge. Il diritto che ha regolato i rapporti tra i privati non può più
funzionare. Un’operazione del genere può essere fatta soltanto da una rivoluzione del genere. I
governi rivoluzionari (1789-1799) elaborano tutta una serie di progetti di codice che affiancano a
tutta una serie di costituzioni, ma ancora una volta il potere politico è troppo debole per riuscire
nell’intento. L’operazione verrà compiuta da Napoleone, il primo dittatore nel senso moderno, che
riesce a imporre un codice: il code napoleon del 1804, che verrà poi esteso a tutti gli stati che sono
sotto l’influenza della Francia napoleonica. Il codice napoleone è il primo codice e si occupa di
diritto privato, è diviso in tre libri: presone , proprietà e modi di acquisto della proprietà. Sentiamo
sempre dire che il code civil segue la tripartizione gaiana, e che Napoleone non fa altro che
prendere il diritto romano e tradurlo in francese, naturalmente ciò non corrisponde alla realtà. Il
code napoleon non è la traduzione francese dell’opera di gaio. Il primo libro riguarda la famiglia,
che viene considerata il nucleo della società. Il code napoleon introduce degli elementi
fondamentali anche per il nostro codice civile, introduce la disciplina del matrimonio civile e
introduce anche la tenuta dei registri dello stato civile, che fino a quel momento erano
esclusivamente appannaggio della chiesa. Il code introduce il divorzio, anche per mutuo dissenso. Il
secondo libro è dedicato alla proprietà e al possesso. Il code napoleon è definito borghese, tutela la
proprietà privata, postulando alcuni principi che poi passano a costituire il diritto privato moderno.
Il code napoleon è preceduto da un titolo preliminare nel quale sono contenuto delle disposizioni
importanti, innanzi tutto si dichiara che qualunque altra norma è abrogata, in secondo luogo si
dichiara che all’interno del codice è tutto previsto, e il giudice dovrà attenersi esclusivamente al
codice, ma non potrà invocare il silenzio della legge, che dovrà quindi risolvere tutte le fattispecie
anche non previste nel codice, ricorrendo al codice stesso. Napoleone dopo il code civil ne farà altri,
il codice di procedura civile, penale, del commercio e di procedura penale. Dopo l’opera
codificatrice di Napoleone l’Europa non riuscirà a tornare indietro, tutti gli stati saranno costretti a
concedere codici plasmati sul code napoleon. Si dice che napoleone abbia preso da Gaio la
definizione di proprietà, contenuta nell’art 544 del codice. Ma in realtà la definizione gaiana
riguarda esclusivamente lo ius utendi et abutendi re sua, senza alcuna limitazione.
Bartolo dice dominium est ius de re corporali perfectae disponendo nidi lex proibeat, quindi per
Bartolo la proprietà è il diritto di disporre completamente di un bene corporale se non è vietato dalla
legge. Quindi è il pensiero di Bartolo a influenzare la definizione di proprietà del code civil.
A cura di Luigi Restivo e Michele Amico ENNA 2007 ®