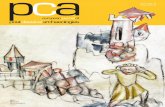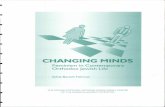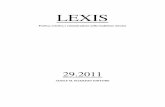STORIA DEL PENSIERO GIURIDICO MODERNO Berman -Diritto e rivoluzione II
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of STORIA DEL PENSIERO GIURIDICO MODERNO Berman -Diritto e rivoluzione II
1
STORIA DEL PENSIERO GIURIDICO MODERNO Berman - Diritto e rivoluzione II Introduzione Quando si parla di rivoluzione si intende un cambiamento fondamentale, rapido, violento e duraturo nell'ordine politico e sociale di una società. Questo significato é spesso datato a partire dallo scoppio della Rivoluzione francese del 1789, ma la stessa parola fu poi usata in altre cinque occasioni, che sono chiamate così chiamate le sei Grandi Rivoluzioni. In ciascuna di esse ci fu un sommovimento violento, e ciascuna ci impiegò più di una generazione per mettere radici, ciascuna introdusse un nuovo corpo normativo, ciascuna trasformò la tradizione giuridica occidentale. La storia che si prospetta nel libro di Berman, che tratta delle Riforme luterana e calvinista, deve guardarsi come parte di una storia ancora più ampia, in una prospettiva millenaria. Le sei Grandi Rivoluzioni: 1) la Rivoluzione papale La storia più ampia inizia con la separazione delle giurisdizioni secolare ed ecclesiastica, compiuta da un movimento rivoluzionario per liberare la Chiesa di Roma dalla soggezione ad imperatori, re e signori feudali, e per stabile una gerarchia indipendente del sacerdozio. Fu condotta inizialmente da Papa Gregorio VII, e per questo conosciuta come Rivoluzione Gregoriana (ma anche Lotta per le Investiture o Rivoluzione papale), e fu segnata da quasi 50 anni di guerre civili in Europa, dal 1075 al 1122. La Chiesa paneuropea di Roma divenne il primo stato moderno, e costituì un corpo normativo che fu ordinato nella grande trattazione di Graziano del 1140, "Concordanza di canoni discordanti", che fu la prima trattazione sistematica di un intero corpo normativo, e fu accolta come base autoritativa del del diritto canonico. Il diritto canonico aveva scopi molto più vasti rispetto si vari ordinamenti giuridici secolari, abbracciando non solo tutte le materie che riguardavano direttamente il clero, ma anche molte che riguardavano i laici (ad es: il diritto secolare dei contratti era molto meno perfezionato). C'erano molte materie di comune competenza, che davano origine ad una giurisdizione concorrente delle corti ecclesiastiche e scolari. La coesistenza e la competizione di differenti sistemi giuridici all'interno di una data comunità politica servì a rendere possibile la supremazia del diritto entro quella comunità, la quale fu sostenuta anche dall'ascesa, nel XII secolo, di una classe di persone impegnate in attività legali a pieno tempo. I testi del diritto romano compilati nel VI secolo da Giustiniano e riscoperti da all'apice della rivoluzione papale, furono analizzati e portati ad una sintesi con un metodo nuovo, più tardi chiamato scolastico, di conciliazione delle contraddizioni nei testi autoritativa e di derivazione dei concetti generali della congerie normativa e casistica esposta in quei testi. Vi era un'opinione generale secondo la quale il diritto avesse un interno meccanismo atto ad un cambiamento organico, che si sviluppasse per rielaborazione delle norme e delle decisioni precedenti per andare incontro ai bisogni presenti e futuri. La storicità del diritto era legata al concetto della sua autonomia e della sua supremazia sui governanti politici.
2
2) la prima Rivoluzione protestante: la Germania luterana Al termine del XV secolo la gerarchia papale era caduta nella più profonda corruzione, ma i richiami ad una politica ecclesiastica (ma anche secolare) più giusta e umana furono quasi ignorati. Nessuno dei cambiamenti che furono fatti per impedire l'inevitabile collasso toccò il problema cruciale dell'epoca, ovvero che le idee gregoriane erano state sorpassate da nuove evoluzioni. Nel 1517 Martin Lutero ruppe il processo evolutivo proclamando l'abolizione della giurisdizione ecclesiastica: sta all'Obrigkeit, l'autorità politica secolare, assumersi le responsabilità normative, e non alla chiesa. Viene instaurata la teoria dei "due regni". Per Lutero il diritto é necessario nel regno terreno per tre "usi della legge": 1. I principi morali che rendono i peccatori consapevoli delle loro colpe; 2. La minaccia delle sanzioni come deterrente per le condotte antisociali; 3. Per le procedure che educano e guidano le persone. I capi luterani dei principati tedeschi emanarono quindi degli Ordnungen, delle ordinanze che regolavano le materie precedentemente di competenza della gerarchia cattolica romana. I giuristi luterani usarono il metodo topico di Melantone per classificare il diritto, un metodo che fu poi adottato in tutta Europa. 3) la seconda Rivoluzione protestante: l'Inghilterra calvinista In Europa si ebbe una crisi politica dovuta all'ascesa di regimi monarchici oppressivi. Enrico VIII, come altri di questi sovrani, nell'inaugurare la Riforma inglese del XVI secolo rivendicò il potere assoluto sulle leggi. Nel secolo XVII però il concetto della supremazia regia venne ad essere progressivamente attaccato sia dal calvinismo internazionale che dai membri della piccola proprietà terriera. La Rivoluzione inglese del 1640-89 stabilì la supremazia del Parlamento sulla Corona. La Chiesa d'Inghilterra fu ridotta da chiesa di stato a chiesa privilegiata ma coesistente, grazie all'Atto di Tolleranza del 1689, alle sette calviniste che avevano iniziato la Rivoluzione. Vi fu una fondamentale e duratura trasformazione dell'ordinamento giuridico inglese: 1. I giudici non furono più soggetti all'autorità del monarca; 1. Le prerogative courts furono abolite; 1. La giuria non poté più essere dominata dal giudice; 1. Le vecchie forms of actions furono ammodernate; 1. La dottrina del precedente ricevette il suo significato moderno; Queste innovazioni avevano parte delle loro radici nelle concezioni del calvinismo. I puritani avevano avevano una forte credenza nella provvidenza divina, e consideravano l'Inghilterra la nazione eletta di Dio, destinata ad incarnare la Sua missione per l'umanità. Credevano che Dio volesse la riforma del mondo e sottolineavano il ruolo che aveva il diritto come strumento in tale riforma. 4) la Rivoluzione francese: il razionalismo deistico Il deismo é un sistema di valori occidentale che crede nell'esistenza di Dio ma non nella divinità di Cristo. I philosophes francesi del XVIII secolo quali Voltaire, Rousseau ed altri famosi lumières erano deisti che insegnavano che gli esseri umani sono nati liberi e uguali. L'Illuminismo all'inizio ebbe una dimensione religiosa, ma successivamente il deismo si rispecchiò, grazie soprattutto al suo essenziale razionalismo, in cambiamenti fondamentali nel diritto pubblico e privato. L'accento dei partigiani della Rivoluzione
3
francese fu posto sulla democrazia, sulla libertà e i diritti civili. Il potere supremo fu attribuito ad un corpo legislativo democraticamente eletto, incaricato di realizzare politiche che riflettevano l'opinione comune delle classi medie proprietarie che l'avevano eletto. Venne introdotto un sistema di stretta separazione dei poteri. I Francesi vennero a sottolineare il chiarimento della dottrina giuridica per mezzo della promulgazione di una legislazione organica. 5) la Rivoluzione americana: mezza "inglese" e mezza "francese" La Rivoluzione americana appare come una guerra d'indipendenza, ma da un'altra prospettiva può essere vista come un movimento per stabilire un nuovo genere di governo e di diritto, essenzialmente differente da quello inglese. La filosofia di Thomas Jefferson intorno ai diritti naturali ed eguali di tutti gli uomini collega la Rivoluzione americana con quella francese, e non con quella inglese. La nuova repubblica americana non fu semplicemente la sintesi di due diversi opposti, ma introdusse anche tre principi costituzionali che non erano né inglesi né francesi né una combinazione tra i due: 1. Il federalismo americano; 1. Il continentalismo; 1. L'istituzione della revisione giudiziale delle leggi. 6) la Rivoluzione russa: il socialismo ateistico di stato La Russia si occidentalizzò progressivamente nel XVIII, nel XIX e agli inizi del XX secolo, e il sistema di valori marxista-socialista dei capi della rivoluzione russa bolscevica del 1917 era esso stesso un sistema di valori occidentale. L'ateismo marxista sovietico fu un'eresia cristiana. Se si studia attentamente il l'ordinamento giuridico sovietico così come esso si é sviluppato nel corso di 75 anni, possiamo trovare molti parallelismi con quello occidentale. Le differenze essenziali rimasero principalmente due: 1. La maggiore proporzione con la quale il diritto fu usato per dirigere e controllare le
attività economiche e sociali 1. La proporzione con la quale il diritto fu usato per disciplinare le convinzioni e i
comportamenti del popolo sovietico, ovvero il ruolo parentale del diritto. Questi due aspetti segnano i principali contributi della Rivoluzione russa. Alla base del diritto sovietico era una concezione ateistica che postulava la fondamentale bontà della natura umana, e fu la perdita della fede in questa concezione utopica, più di ogni altro fattore, che provocò il crollo dell'Unione Sovietica. *** Lo studio della storia giuridica europea richiede una periodizzazione differente da quella che é stata applicata allo studio dei sistemi giuridici delle singole nazioni prese separatamente. La periodizzazione é stata sempre più ignorata da quando le ricerche storiche hanno cominciato a diventare sempre più ristrette. La storiografia scientifica ha portato ad una frammentazione sempre del passato in pezzi sempre più piccoli, e alla fine alla perdita di ogni senso di direzione. Questo tipo di studiosi é arrivato ad accogliere un'erronea periodizzazione, ovvero la divisione cinquecentesca del passato in tre periodi: antico, medioevale e moderno. Soprattutto quando si parla della tradizione giuridica occidentale é importante evitare l'uso anacronistico dei termini "Medioevo" e "medievale" per riferirsi al periodo pre-protestante della storia europea, dato che fu la loro separazione fra le giurisdizioni ecclesiastica e secolare a sfociare nella creazione del primo sistema giuridico moderno.
4
Una nuova storia millenaria dell'Occidente é emersa negli ultimi decenni, ispirata soprattutto dalla partecipazione di questa, assieme ad altre civiltà, ai primi stai dello sviluppo dell'economia mondiale. I sistemi di valori protestanti dei secoli XVI e XVII sono stati variamente recepiti nella letteratura scientifica della storia europea nei secoli XX e XXI: • Si é loro accreditato di aver facilitato l'ascesa del nazionalismo (aggressivo),
dell'individualismo (egoistico), del capitalismo (avido) e del secolarismo (razionalistico); • I contributi positivi allo sviluppo del pensiero giuridico sono stati ignorati. La tesi che il primo protestantesimo abbia esercitato un'influenza decisiva sulle origini del capitalismo in Occidente fu espressa da Max Weber, ma il suo ragionamento fu ampiamente malinteso dai fautori così come dagli avversari. Weber non disse che il protestantesimo è una causa del capitalismo. Egli disse che una forma di protestantesimo, ovvero il calvinismo così come fu praticato dai puritani inglesi del XVII secolo, fu congruente e simpatetico con lo spirito del capitalismo industriale borghese che più tardi sarebbe emerso in Europa. Dato che poteva sembrare un paradosso il fatto che i calvinisti inglesi fossero sia simpatetici con il capitalismo sia denunciatori della peccaminosa idolatria di Mammona, Weber dovette risolvere la questione tramite la dottrina della predestinazione, secondo la quale l'uomo vive nella terribile situazione di incertezza riguardo la propria salvezza, e quindi deve seguire al meglio la predestinazione datagli da Dio. In questo modo gli imprenditori seguono al meglio la loro vocazione cercando di creare quanto più profitto sia possibile, per ottenere un segno da Dio. Mentre il cattolicesimo romano e il luteranesimo concepirono la salvezza in termini di “ascetismo ultramondano” – “ausserweltliche Askese”, il solo calvinismo apprezzò l’“ascetismo intramondano” – “innerweltliche Askese”, che era il dedicarsi dell’individuo alla sua vocazione secolare. Secondo Berman però, non fu la dottrina calvinista della salvezza a generare lo spirito dell’attività imprenditoriale nei secoli XVII e XVIII, ma al contrario la dottrina calvinista sulla natura della comunità cristiana. La fede calvinista e luterana nell’unità e nella comunione della congregazione dei fedeli sostenne la formazione di comunità teocentriche su base strettamente pattizia. L’individuo è una “persona privata” nella sua relazione con Dio, ma una persona sociale in relazione ai tre stati:
• La famiglia • La chiesa • La suprema autorità di governo (Obrigkeit)
Sia la congegazione luterana che quella calvinista erano comunità autonome su base strettamente “pattizia” (si pensi ad esempio all’invenzione delle società per azioni, nelle quali gli investitori dovevano impegnarsi insieme in una causa comune). L’errore di Weber nella sua analisi è stato quello di concentrarsi sulle dottrine individualistiche della predestinazione invece che su quelle collettivistiche del patto e delle comunità pattizie. Parte prima: La Rivoluzione tedesca e a trasformazione del diritto tedesco nel sedicesimo secolo Capitolo primo: La Riforma della chiesa e dello stato, 1517-55
5
Vista nella sua formulazione più semplice, la Rivoluzione tedesca fu la lotta vittoriosa dei principi territoriali della Germania contro il papa e l’imperatore tedesco per il diritto di stabilire la fede luterana e di essere sovrani nei loro principati. La Rivoluzione non soltanto mise fuori legge la Chiesa cattolica romana nei principati protestanti, ma vi stabilì anche degli stati unitari secolari con ordinamenti giuridici integrati. Clero e nobiltà furono entrambi subordinati a un nuovo tipo di monarchia. La riforma politica e quella religiosa procedettero insieme, diventando due facce della stessa medaglia. L’intera popolazione fu coinvolta nella guerra civile. Ci fu una riforma sociale-economica, una riforma culturale e intellettuale e una riforma dell’intero ordine giuridico. La Rivoluzione non fu solo tedesca, ma fu anche una Rivoluzione europea. 1. La Germania: l’ impero (Reich) e i principati territoriali (Länder) La Germania nel 1500 era il più grande paese d’Europa sia per estensione che per popolazione. Consisteva di diverse centinaia di territori secolari ed ecclesiastici chiamati terre, entro un’assai larga struttura chiamata il Sacro Impero Romano. Quando fu fondato da Carlo Magno prima dell’anno 800, l’Impero non era affatto detto romano. All’inizio dell’XI secolo fu istituita la prassi di dare all’erede designato a succedere all’impero il titolo di “Re dei Romani”, per poi essere incoronato dal papa come “Imperatore dei Romani”. All’inizio questo titolo simboleggiava le pretese teocratiche dell’imperatore, per poi arrivare semplicemente ad indicare la sua autorità nella sfera secolare. L’impero non aveva una capitale né un’amministrazione permanente, e fino al 1495 non ebbe una corte di giustizia professionale. L’imperatore non poteva tassare, e la sua elezione dipendeva da un collegio elettorale di principi ecclesiastici e secolari. L’impero sviluppò nuove istituzioni politiche e giuridiche e attraversò fasi di relativamente maggiore forza e debolezza. Come supremo giudice dell’impero, l’imperatore nei suoi spostamenti udiva gli appelli contro i giudizi delle varie corti. Aveva inoltre il diritto di convocare le assemblee deliberative chiamate giornate imperiali o diete (Tag, Reichstag in tedesco, dalla parola giorno). Gli imperatori attraverso le diete imperiali promulgavano nuove leggi, spesso sotto la denominazione di pace territoriale (pax terrae o Landfriede). Malgrado la debolezza del meccanismo di imposizione, queste leggi imperiali ebbero validità e spesso penetrarono nel diritto territoriale. Sia il potere che il diritto imperiale declinarono gradualmente e all’inizio del XV secolo il potere e il diritto dei principati tedeschi continuò a diventare sempre più forte. Questo non vuol dire che non ci fosse una Germania, dato che vi erano una lingua, una letteratura e un diritto comune tedesco. Questo comune diritto era in qualche modo rappresentato dallo Sachsenspiegel, Specchio dei Sassoni, un libro scritto intorno al 1220 dal giurista sassone Eike von Repgau. Si trattava di una raccolta sistematica di princìpi e regole giuridiche dalla lunghezza di circa 240 pagine. La materia era principalmente il diritto consuetudinario locale e feudale della Sassonia e il diritto regio dell’imperatore tedesco. Lo Sachsenspiegel giunse molto presto ad acquisire una validità semi-ufficiale per tutti i territori germanofoni. Fu glossato da giuristi dotti e ne nacquero delle imitazioni. Nonostante ogni città avesse le proprie leggi, si può parlare di un modello di diritto urbano pan-germanico, il quale era in larga parte consuetudinario. Ovviamente le consuetudini di una città erano diverse dalle consuetudini di un’altra, ma vi fu sempre una comune cultura politica e giuridica.
6
Oltre ad essere governata dal diritto imperiale, da un diritto territoriale e da un diritto urbano, la Germania era governata anche dal diritto canonico della Chiesa cattolica romana. La giurisdizione rivendicata dalla Chiesa cattolica romana si estendeva a tutte le materie relative ai beni del clero e della chiesa così come a molte materie che riguardavano direttamente il laicato, e i laici avevano spesso l’uso di sottomettere volontariamente e loro controversie alle corti ecclesiastiche. Il diritto romano invece svolgeva un ruolo sussidiario rispetto al diritto positivo e consuetudinario, ed era usato solo a fini accademici e per integrare il diritto vigente. Benché fosse unita sotto molti aspetti, la Germania era politicamente divisa da un grandissimo numero di unità territoriali di varia grandezza. Nell’anno 1521 il Sacro Romano Impero della Nazione Germanica consisteva di circa 400 giurisdizioni politiche. Nel XIV e XV secolo vi fu un grande sviluppo del diritto dei territori tedeschi, che attinse sempre di più alla terminologia e ai concetti di diritto romano dotto. Con l’elezione di Massimiliano I, nel 1493, ci fu un’espansione del potere e della giurisdizione imperiali, che minacciò di ridurre ulteriormente l’autonomia dei vari principi, soggetti gerarchicamente all’imperatore stesso. Una dieta del 1495 stabilì una Landfriede che dichiarava per la prima volta che il diritto romano doveva essere il diritto positivo secolare dell’impero, e istituì una corte imperiale per applicare quel diritto ed udire gli appelli delle cause giudicate in prima istanza. 2. Segnali di cambiamento L’impero di Massimiliano era così grande e vario, che gli fu impossibile tenere il controllo dei principati tedeschi per più di una settimana. La maggior parte del tempo in cui regnò fu spesa in guerre esterne, che non erano popolari presso i principati territoriali tedeschi continuamente pressati da richieste di denaro per sostenere le campagne militari di Massimiliano. Alla sua morte, nel 1519, fu eletto imperatore il nipote Carlo V, che si adoperò per ristabilire il concetto dell’unità dell’Europa cristiana sotto la guida del papa e dell’imperatore. Aggravato anche dal fatto che parlasse tedesco con un accento straniero, fu pressato da tensioni politiche ed economiche fra l’autorità imperiale e quella dei principati entro l’area tedesca dell’impero. Un’altra fonte di tensioni ben più potente all’interno dell’impero fu la crescente competizione fra la gerarchia cattolica romana e i principi secolari. Questo perché ogni vescovo, seppure direttamente sottoposto al papa in certe materie e all’imperatore in certe altre, allo stesso tempo esercitava una giurisdizione concorrente rispetto ai vari principi secolari sui cui territori si estendeva la sua diocesi. Per di più la chiesa possedeva 1/3 delle terre della Germania ed era esente da imposizione fiscale secolare. Le tensioni furono molto aggravate dalle campagne del papato per drenare risorse attraverso la vendita delle cosiddette indulgenze. Il papa rivendicava il potere d’intercedere presso Dio a nome dei peccatori al fine di rimettere le pene, che altrimenti sarebbero state loro inflitte dopo la morte in purgatorio, e, dal 1476, non solo su di loro ma anche sui loro cari defunti. Ovunque in Europa si chiedevano ad alta voce la riduzione dei poteri ecclesiastici e la riforma della chiesa e dello stato. In verità, per almeno tre generazioni l’intero Occidente aveva vissuto in uno stato pre-rivoluzionario. In Germania le richieste di riforma provenivano non solo dai profeti e dagli umanisti ma anche dai governanti secolari. Già nel 1438 un pamphlet largamente diffuso, intitolato La Riforma di Sigismondo, propose vari cambiamenti sia in campo secolare che in campo
7
ecclesiastico, ma se ne ricavò ben poco. Numerose città adottarono estese modifiche nel campo del diritto, chiamate riforme, che però non andavano incontro alle lamentele della maggior parte dei ceti popolari. Ovunque la chiesa era sempre sulla difensiva, ma ovunque resisteva ad una radicale riforma. 3. Lutero e il papa. La Riforma della chiesa La scintilla che accese la Rivoluzione tedesca partì nel 1517 da un professore di teologia all’università di Wittenberg, il monaco agostiniano Martin Lutero. Fino alla sua morte nel 1546, Lutero rimase il capo spirituale e la guida intellettuale sia della riforma della chiesa che di quella dello stato in Germania. 3.1. Il luteranesimo Le persistenti invocazioni di riforme erano per lo più richieste di riforme morali, giuridiche e amministrative interne alla chiesa e al campo secolare. Lutero al contrario invocò l’abolizione della gerarchia cattolica romana. Affrontò la questione dell’autorità ecclesiastica direttamente e nei termini più radicali, invocando la fine di ogni giurisdizione ecclesiastica e di ogni suo potere legislativo, giudiziario ed amministrativo. Questo era il significato delle Novantacinque Tesi che nel 1517 egli mandò al vescovo di Magonza e affisse anche alla porta della chiesa del castello del principe-elettore di Sassonia a Wittenberg: esse non solo attaccavano le indulgenze e gli altri abusi dell’autorità papale, ma negavano anche a necessità di un terzo nell’amministrazione della penitenza. Lutero sostituì la teoria gregoriana delle due spade con una nuova teoria dei due regni. La chiesa appartiene al regno celeste della grazia e della fede, ed è governata dall’Evangelo; il regno terreno è il regno del peccato e della morte, ed è governato dalla legge. La salvezza esiste solo per la grazia, che è donata a coloro che hanno fede, e non per qualcosa che l’uomo possa fare per rendere la propria anima accettabile a Dio. La fede stessa, nella teologia luterana, è una virtù “passiva”, liberamente donata da Dio a coloro che egli ha scelto, ai suoi “eletti”. Per Lutero il battesimo non può automaticamente cancellare l’innata depravazione dell’uomo. Il perdono può essere ottenuto solo attraverso un diretto confronto fra il peccatore penitente e Dio, per grazia divina, al di fuori di norme e procedure. L’umanità è totalmente incapace di risollevarsi da sola dalla sua caduta. Anche se sembrerebbe offrire una visione totalmente negativa del regno terreno, Lutero era convinto che anche in questo mondo vi fosse la presenza di Dio. I riformatori luterani rimpiazzarono la dottrina cattolico-romana della chiamata, che veniva associata in primo luogo alla professione monastica e sacerdotale, con la dottrina che ogni occupazione nella quale un cristiano s’impegna deve essere trattata come una chiamata (Beruf, vocatio) di Dio. In particolare, si diceva che i pubblici ufficiali avessero una speciale chiamata al servizio della comunità. Questa chiamata richiedeva loro di adottare un’etica sociale cristiana che differiva dall’etica personale cristiana – in pratica, erano autorizzati a vendicare l’ingiustizia, anche con l’uso della violenza. Questa dottrina fu applicata soprattutto alla teoria del principe cristiano, in una concezione essenzialmente diversa da quella di Machiavelli, suo contemporaneo: il suo principe agiva in basi di considerazioni di potenza, mentre quello di Lutero agiva anche per rendere giustizia. Questa concezione del principe era diversa anche da quella di Jean Bodin, che fu offerta successivamente: secondo Bodin, il principe era un monarca assoluto, unico rappresentante di Dio in terra, ed in grado di violare le sue stesse leggi e superiore a
8
qualsiasi autorità terrena. Il principe di Lutero era invece soggetto a vincoli istituzionali e non era più vicino a Dio degli altri esseri umani. Lutero con riguardo al principe applicava il quarto comandamento, “onora il padre e la madre”, ponendolo così al livello di Landesvater, ovvero padre della sua terra, e dandogli l’obbligo di amministrare come un buon padre di famiglia. Il cristiano non doveva pensare di poter ottenere crediti in paradiso con il fare il bene; egli doveva fare uso della volontà e della ragione per fare il maggior bene che Dio abbia reso possibile. La teologia luterana non offriva soluzioni per i più acuti problemi politici, ma nonostante questo fu il motore trainante della Rivoluzione che si ebbe in Germania prima nella chiesa e poi nello stato. 3.2. La personalità di Lutero Nato in Sassonia nel 1483 da una famiglia di minatori, conseguì il magistero nelle arti liberali. Si iscrisse quindi ad un corso di diritto civile, ma in seguito ad un incidente con un fulmine attraversò una crisi religiosa che lo portò ad entrare nel monastero dei frati agostiniani di Erfurt. Nel 1511 abbandonò il monastero per studiare teologia all’università di Wittenberg, dove poi iniziò ad insegnare. Nel 1517 sconvolse tutta la cristianità occidentale con la denuncia pubblica delle indulgenze. Le Novantacinque Tesi circolarono rapidamente a stampa in tutta la Germania e nei paesi vicini. Nel 1520 il papa emise una bolla dando a Lutero 60 giorni per ritirare le sue tesi, e lui per tutta risposta fece un rogo colossale con i libri di diritto canonico sui quali si sosteneva il potere papale. Nel 1521 il papa emise un’altra bolla, con la quale scomunicava Lutero come eretico ed invitando l’imperatore a procedere contro di lui. Di conseguenza Carlo V convocò Lutero al Reichstag di Worms del 1521, e al rifiuto di disconoscere i suoi scritti, emise il documento noto come Editto di Worms, che bandì Lutero come “demonio in abito da monaco”. Molti principi territoriali non vollero mandare ad effetto l’editto imperiale, come il suo protettore Federico il Saggio, cosicché egli poté dedicarsi alla traduzione dal greco al tedesco del Nuovo e Vecchio Testamento. Scrisse molte altre opere, e nel 1525 ruppe i suoi voti monastici sposando la suora Caterina von Bora. Lutero fece della sua vita e della sua opera l’integrale rappresentazione delle dottrine che predicava. Fu visto dagli uomini del suo tempo come un profeta tanto atteso, mostrato con la colomba dello Spirito Santo in testa o con l’aureola. Era una persona passionale ed un abile oratore, anche se alla fine usò termini di disprezzo verso coloro che rifiutavano di convertirsi al cristianesimo. 4. L’espansione del movimento della Riforma Lutero non occupò mai nessuna posizione politica, né nella chiesa né nello stato. Dapprima sperò che la stessa gerarchia cattolica avrebbe accettato il nuovo insegnamento. Quando questo non ebbe successo, si rivolse all’imperatore. Non ebbe ancora successo, e solo nel 1524 si convertì uno dei principi, il giovane Filippo d’Assia. Importanti capi religiosi si allearono con Lutero, alcuni dei quali presero poi strade leggermente o totalmente diverse, e nei primi anni 20 del Cinquecento numerose città in Svizzera e nella Germania meridionale adottarono ufficialmente una forma o l’altra della fede evangelica. La Rivoluzione tedesca divenne nelle sue prime fasi un movimento di massa, sostenuto in tempi diversi da un gran numero di persone appartenenti virtualmente a tutte le classi della nazione tedesca. Come molte altre, anche questa rivoluzione diede origine a delle “ali” estremiste, dalle quali Lutero si discostò.
9
5. Lutero e i principi. La riforma dello stato. Fu l’alleanza dei luterani con i principi, e di quei principi fra loro, ad assicurare la vittoria del luteranesimo nei territori abitati dalla maggioranza del popolo tedesco. Nel 1525 fu organizzata un’alleanza dei principi cattolici con il proposito di annientare il movimento evangelico; essa includeva il duca dell’Alta Sassonia, l’arcivescovo di Magonza e l’elettore di Brandeburgo. Altri principi si unirono insieme in alleanza per difendere la causa luterana. Nel 1529, in un Reichstag tenuto a Spira, la maggioranza cattolica approvò una risoluzione imperiale per porre fine a tutte le innovazioni religiose e per restaurare i vescovi nelle loro giurisdizioni. In risposta, i principi dei cinque territori luterani e delle quattordici città luterane misero fuori una protesta. Il nome di protestanti fu appunto dato a coloro che stesero la Protesta di Spira e alla fine ai molti milioni di persone che li seguirono sulla loro via. Carlo V tornò in Germania nel 1530 per presiedere la Dieta di Augusta, dove un gruppo di teologi cattolici presentò un documento che mostrava 404 errori contenuti negli scritti luterani, mentre i protestanti presentarono la Confessione Augustana, un documento ad espressione delle dottrine luterane fondamentali. I principi protestanti abbandonarono la dieta prima della sua conclusione, e in loro assenza i cattolici adottarono una risoluzione che proibiva le innovazioni ereticali, istituiva la censura e richiedeva indietro le proprietà secolarizzate. Nel 1531 i firmatari della Confessione Augustana formarono quindi la Lega di Smalcalda per la difesa della fede protestante. Dato che l’imperatore era occupato su altri fronti, la lotta con la Lega si ebbe negli anni 1546-47 e si risolse con la sconfitta di quest’ultima. Nel 1552 i principi protestanti si allearono con Enrico II di Francia e sconfissero nell’imperatore, cosicché nel 1555 ci fu un’altra dieta imperiale ad Augusta, che stabilì la Pace di Augusta e fece cessare le guerre civili in Germania. La Pace di Augusta stabilì fondamentali principi per la soluzione dei gravi conflitti religiosi che per 45 anni avevano infuriato nella parte tedesca del Sacro Romano Impero. Il capo di ogni principato dell’impero ebbe il potere di decidere se la sola religione del suo territorio dovesse essere quella della Confessione Augustana o la religione antica, secondo il principio del “cuius regio eius religio” – la religione sia quella del principe territoriale, con alcune eccezioni. La Pace di Augusta concesse ciò che i principi luterani più desideravano, il ius reformandi, anche se rimanevano ingenti condizioni di favore per l’”antica religione”. Nel 1556 Carlo V riconobbe il fallimento di restaurare un impero cattolico romano e abdicò al trono imperiale facendosi monaco. 6. Il ruolo delle città La riforma tedesca fu un evento urbano. Rispetto agli sviluppi interni alle città della Germania, gli elementi popolari non possono essere facilmente distinti dagli elementi autoritari, dal momento che i sentimenti e gli interessi della popolazione urbana trovavano espressione in iniziative prese dalle magistrature urbane. Il conflitto urbano era spesso fortemente influenzato dalla volontà politica delle magistrature principesche del territorio nel quale una singola città era collocata. Le città contenevano una relativamente piccola percentuale della popolazione totale della Germania nel 1500, e dal punto di vista intellettuale esse erano sensibili al luteranesimo, che presupponeva una cultura letteraria urbana. 7. La Guerra dei Contadini. "La rivoluzione dell'uomo comune" Negli anni 1524-25 vaste rivolte scoppiarono nel sud della Germania, coinvolgendo alla fine un numero molto elevato di contadini armati. Queste rivolte trovarono la resistenza
10
armata di alcuni principi, che si erano prima uniti in una coalizione chiamata Lega Sveva. Agli inizi del 1526 la ribellione era schiacciata. Benché fosse chiamata "Guerra dei Contadini", la rivolta fu di fatto una movimento di massa i cui partigiani provenivano dalle classi più povere delle città così come dalla campagna, e fu combattuta dall'uomo comune contro l'oppressione dei poteri spirituali e temporali. Agli inizi del 1525 i capi della rivolta contadina diffusero un manifesto, detto dei Dodici Articoli, rivolto al lettore cristiano e pieno di citazioni scritturali per ognuna delle sue richieste. Uno dei più importanti capi della rivolta, l'anabattista Thomas Müntzer, anticipando Karl Marx di tre secoli, dichiarò che ognuno dovrebbe ricevere esattamente secondo i suoi bisogni. La visone egalitaria della fratellanza cristiana trovò un supporto istituzionale nella diffusa formazione delle cosiddette Associazioni Cristiane, le quale unirono tra loro e adottarono un modello costituzionale repubblicano. In quel modello, il comune rurale e urbano formava la base di una struttura politica territoriale in cui tutti gli uffici politici dovevano infine basarsi su elezioni comunali. Nei territori più grandi fu istuita un'assemblea territoriale (Landschaft) per rappresentare i vari comuni. Il fondamento del nuovo ordine politico doveva essere la legge di Dio. Lutero denunciò sia i contadini per aver fatto ricorso alla violenza sia i principi per il loro diniego ad accogliere le giuste richieste economiche e sociali. Nella dieta di Spira del 1526 furono accolte delle raccomandazioni basati sui Dodici Articoli. Benché non vi fosse un loro accoglimento nella legge imperiale costituirono un riconoscimento della legittimità di molte delle rimostranze dei contadini. 8. Ripercussioni europee della Rivoluzione tedesca La Rivoluzione tedesca fu una rivoluzione europea. Il luteranesimo prese piede nei paesi scandinavi più rapidamente e in una forma più estrema che nella stessa Germania. Nei primi anni ’20 del Cinquecento la Danimarca e la Svezia adottarono un rigido luteranesimo adottato dallo stato, con gravi sanzioni penali in caso di aperta professione della fede diversa dalla luterana. In Polonia un numero significativo di esponenti della nobiltà aderì al luteranesimo negli anni ’20 e ’30, ma mentre qui scomparve poi quasi del tutto, nei paesi baltici di Lettonia, Estonia e Prussia Orientale diventò subito una presenza stabile. Mentre il luteranesimo si diffondeva dai territori tedeschi principalmente verso l’Europa centro-orientale, il calvinismo si diffuse soprattutto in Francia, Olanda, Scozia ed Inghilterra. Giovanni Calvino fu prima un partigiano delle dottrine luterane e nel 1535 scappò dalla Francia in Svizzera per evitare la persecuzione del re. Stabilitosi a Ginevra, aderì sia ad alcune istituzioni luterane che ad altre ecclesiastiche, pubblicando le sue famose Istituzioni della religione cristiana nel 1536. La differenza più importante fra il luteranesimo e il calvinismo fu l’idea calvinista che nelle materie ecclesiastiche l’autorità suprema risiedesse negli anziani della locale congregazione della fede, in contrasto con l’idea luterana che nelle materie ecclesiastiche affidava al principe territoriale l’autorità suprema. Il calvinismo giunse anch’esso ad avere diverse versioni in diversi paesi, e portò altresì a varie guerre di religione. In Francia a partire dal 1572 gli Ugonotti furono oggetto di ampi massacri, che cessarono nel 1598 con l’Editto di Nantes, che concesse agli Ugonotti la libertà di coscienza, anche se con forti restrizioni. L’Inghilterra fu dilaniata da conflitti fra varie forme di protestantesimo e anglicanesimo non-romano. Il calvinismo fece delle incursioni nella seconda parte del XVI secolo, e nel XVII svolse un ruolo determinante nell’avvento della supremazia parlamentare. Anche in paesi che rimasero cattolici romani militanti, come l’Italia e la Spagna, il protestantesimo ebbe ripercussioni
11
profonde. Queste furono in prima istanza negative, infatti si fece uso di una spietata Inquisizione per mandare a morte, espellere o reprimere in altro modo il piccolo numero di protestanti che in quei paesi ebbero l’ardire di sollevare la voce contro Roma. Una risposta positiva alla sfida del protestantesimo fu invece la Controriforma cattolica romana. Al suo carattere teologico diede forma soprattutto il Concilio di Trento, che si riunì la prima volta negli anni 1545-47, nuovamente nel 1551-52 e infine nel 1562-63. Le prime sessioni del concilio riaffermarono le tradizionali dottrine teologiche cattoliche romane che erano state contestate dal protestantesimo, ma dall’altra parte fece anche qualcosa per correggere alcuni dei principali abusi che i protestanti contestavano. Questi sviluppi e quelli ad essi correlati in altri paesi cattolici romani furono anche parte di un movimento indipendente interno al cattolicesimo, un’autonoma Riforma cattolica. Le ripercussioni religiose furono strettamente connesse in tutta Europa con le ripercussioni politiche. Ebbe luogo allora ciò che è stato chiamato confessionalizzazione dell’Europa. Ciascuna delle confessioni venne ad identificarsi con i territori in cui essa era proclamata dai governanti. Questa virtuale unificazione di chiesa e stato entro ciascuna delle varie comunità politiche europee, che portò alla prima Grande Guerra europea, la Guerra dei Trent’anni del 1616-48. La Pace di Augusta nel 1555 aveva posto fine con successo alla guerra civile tedesca dei principati contro l’impero cattolico romano, ma l’imperatore Ferdinando II, un Asburgo d’Austria, mobilitò i principi cattolici romani per promuovere una guerra contro i territori e le città protestanti in Germania, al fine di recuperare i beni e diritti ecclesiastici. Per oltre tre decenni la Germania fu dilaniata da violenti massacri, fino alla Pace di Vestfalia, un trattato multilaterale che applicò a tutte le maggiori potenze europee certi termini basilari dell’assetto religioso tedesco. La religione del principe doveva ancora essere stabilità come religione territoriale, però alle confessioni non ufficiali fu concesso il diritto alla fede. Così venne stabilito un principio di tolleranza religiosa fra luterani, calvinisti e cattolici romani. Dal punto di vista del diritto costituzionale dei paesi che presero parte alla Pace di Vestfalia, il principio della supremazia regia sia sulla chiesa sia sullo stato fu riaffermato. Allo stesso tempo il nuovo principio costituzionale di una limitata tolleranza religiosa divenne il fondamento di una nuova concezione del diritto internazionale, basata sulla sovranità statale. Il principiò di sovranità attribuito ai principi tedeschi con la Pace di Augusta fu esteso a tutte le nazioni europee nelle loro relazioni reciproche in base al diritto internazionale. 9. La riforma del diritto Alla nascita della Riforma luterana, molti dei suoi capi lanciarono un duro attacco non solo al vecchio diritto ma a tutto quanto il diritto. Lutero sosteneva infatti che “la verità e il diritto sono sempre nemici”. Allorché la Riforma consolidò la forza divenne chiaro che l’attacco contro il vecchio diritto avrebbe condotto all’anarchia, e venne quindi elaborandosi una nuova filosofia giuridica, basata su un nuovo metodo e una nuova scienza, sfociata dall’alleanza tra la teologia luterana e l’autorità civile dei principi tedeschi. L’intima connessione fra la teologia luterana e l’autorità principesca trovò la sua espressione giuridica in nuovi princìpi di diritto costituzionale che riguardavano tanto la sfera religiosa quanto quella secolare. Il principe protestante si sostituì alla giurisdizione della gerarchia papale negli affari ecclesiastici, ma anche alla sua giurisdizione sui laici nelle relazioni familiari e coniugali, i reati mortali, l’istruzione, l’assistenza ai poveri ed altri ambiti. Tutto un insieme di ordinanze su tali materie scaturì dai corpi legislativi principeschi e urbani nella scia della Riforma.
12
Il predominio del principe e della sua autorità suprema segnò anche uno stadio nella transizione da quello che in tedesco è chiamato Ständestaat, governo dei ceti, al Fürstenstaat, governo dei principi. Nel sottolineare la vocazione del principe come padre del suo paese, Lutero non solo ne fece la fonte suprema del diritto ma impose anche dei limiti al diritto-dovere della disobbedienza civile da parte dei soggetti, qualora il signore ordinasse loro di agire in modo empio o malvagio. Oltre alla questione della disobbedienza civile, Lutero si occupò delle limitazioni alla competenza, alla giurisdizione e al potere del principe secolare. Egli non governava da solo ma assieme ai suoi funzionari, che formano assieme a lui la Obrigkeit. I funzionari, per quanto possano essere stati oppressivi per la popolazione in genere, servirono da limite all’esercizio arbitrario dei poteri del principe. In realtà il potere di un principe era limitato in genere dall’esistenza della confederazione di fatto dei singoli principati tedeschi. Dopo il 1555 ogni signore territoriale fu eguale ad ogni altro per autorità di fronte ai suoi soggetti. Per di più la Rivoluzione cristallizzò un nuovo concetto di territorio in senso geografico piuttosto che dinastico. Un’ulteriore limitazione era imposta dal concetto di repubblica come comunità politica che governa col diritto uno stato di diritto – Rechtstaat. Si presupponeva che i governanti avrebbero condotto le loro politiche per mezzo della legge, e che essi stessi sarebbero stati moralmente vincolati ad osservare le leggi di cui erano gli autori. Nel diritto e nella procedura penali, codici territoriali di carattere sistematico e unitario furono emanati. Nell’insieme del diritto l’unificazione fu raggiunta non mediante una formale codificazione, ma per mezzo di una trattatistica scientifica di carattere sistematico intorno ad un unico sistema normativo applicabile ad un dato territorio. Il pensiero giuridico luterano sottolineò l’importanza di una certa precisione nelle norme giuridiche come forma essenziale che il diritto assume. Inoltre affermava l’importanza dell’avere leggi scritte, per non affidarsi all’eccessiva discrezionalità die giudici. Inoltre, Lutero sosteneva che il primo compito di una corte è quello di applicare il diritto, e non quello di trovarlo. Maggiore importanza fu data ai professori universitari attraverso l’Aktenversendung, l’invio degli atti ai docenti, istituto che in Germania durò fino al 1878. 10. Questioni omesse
• L’emancipazione degli Ebrei – gli Ebrei che non si convertivano al cristianesimo erano obbligati a vivere nei ghetti, a portare un segno di riconoscimento e a limitarsi solo ad alcune occupazioni.
• L’abolizione del diritto di stregoneria – qui furono minime le differenze di approccio tra cattolici romani e protestanti, dato che entrambi, nel XVI e XVII secolo, dato che entrambi emanarono norme molto simili contro la stregoneria.
Capitolo secondo: La filosofia giuridica luterana La filosofia giuridica luterana è rimasta ampliamente nell’ombra dell’umanesimo giuridico, ed è stata offuscata anche dalla prospettiva ristretta in cui in generale è stato trattato il pensiero luterano. Una delle ragioni più forti di questa trascuratezza è stata la convinzione che la Riforma fosse limitata alle questioni religiose. Nei fatti però è vero il contrario: le concezioni luterane furono la fonte non solo di una nuova teologia ma anche di una nuova scienza politica e di una nuova cultura giuridica. La struttura basilare della filosofia giuridica occidentale si è formata durante e dopo il sommovimento rivoluzionario del tardo XI e del primo XII secolo. Allora i grandi studiosi del
13
diritto avevano iniziato a formulare un insieme coerente di princìpi riguardanti la natura e gli scopi del diritto, le fonti, i generi, etc. Non solo la struttura fondamentale, ma anche alcuni postulati basilari furono per la prima volta postulati in questo periodo. Il diritto naturale era pensato come immediatamente accessibile alla ragione umana. Il diritto divino era rivelato alla ragione umana nei testi sacri e nella tradizione della chiesa. Il diritto umano, pur essendo una risposta al volere divino, era visto come il prodotto di una volontà umana difettiva che poteva essere e necessitava di essere corretta dalla ragione umana. 1. La filosofia giuridica di Lutero Lutero conservò sempre un attivo interesse per le questioni di filosofia giuridica e politica. Nel corso della sua rivolta contro Roma dal 1517 al 1522, Lutero attinse alle sue nuove istituzioni teologiche così come alla sua ampia conoscenza del diritto canonico. Egli si occupò anche di approntare numerosi commentari e dotti sermoni sul Vecchio Testamento e all’esegesi dei Dieci Comandamenti. Dalla sua teologia Lutero trasse l’implicazione che è dovere dei cristiani accettare i Dieci Comandamenti come un diritto divino da applicarsi non solo direttamente nella vita personale, ma indirettamente anche nella vita politica. Il potere civile non era infatti libero di governare arbitrariamente. La percezione del diritto da parte di Lutero era diversa da quella dei suoi predecessori cattolici nei suoi fondamenti filosofici e teologici. La dottrina cattolica romana prevalente aveva fatto della coscienza l’ancella della ragione. Essa aveva distinto fra la facoltà di apprensione, che era chiamata synderesis, e la facoltà applicativa, che era chiamata conscientia. Una persona razionale usa la sinderesi per apprendere e chiarire i principi e i precetti del diritto naturale; usa la sua coscienza per applicare quei principi e quei precetti alle concrete circostanze pratiche (esempio: grazie alla synderesis la persona apprende il principio di amare il prossimo; attraverso la conscientia connette questo principio alla pratica di assistere i poveri). Lutero, al contrario, subordinò la ragione alla coscienza: essa deriva direttamente dalla fede e non applica solo i princìpi del diritto divino e naturale alle situazioni concrete, ma è anche la fonte e l’incarnazione della nostra comprensione di quei princìpi. Per Lutero però l’unione di Dio al popolo dipende dalla sola fide così come rivelato nella sola scriptura, ovvero la Bibbia. L’obbedienza al diritto non riscattava l’uomo dalla sua peccaminosità, né lo rendeva più accettabile a Dio. 2. Gli usi della legge Se la salvezza non dipende dalle opere della legge, allora perché Dio ordina la legge? Quali sono, dal punto di vista di Dio, i suoi usi? Lutero ne descrisse due e ne approvò un terzo:
1. Uso civile o politico: dissuadere il popolo dalla cattiva condotta con la minaccia delle sanzioni penali. Si applica sia ai Dieci Comandamenti che alle leggi civili che ne derivano. Per mantener l’ordine è importante che vi siano precise norme giuridiche, non solo come deterrente per i malviventi ma anche per distogliere i giudici dal decidere arbitrariamente.
2. Uso teologico: Lutero qui dipende dall’interpretazione di San Paolo circa il significato dei Dieci Comandamenti per i cristiani: renderli consapevoli della loro innata colpevolezza e condurli al pentimento.
3. Uso pedagogico: educare i fedeli a ciò che vuole Dio e così guidarli alla virtù. 3. La filosofia giuridica di Filippo Melantone
14
Mentre Lutero insegnò la giustizia di Dio, Melantone insegnò la giustizia della società. Ai suoi tempi egli fu qualificato come l’educatore della Germania – praeceptor Germaniae. Melantone fu un fanciullo prodigio, tanto che all’età di 21 era già professore di greco all’università di Wittenberg, nel 1518. Lutero difese le idee del suo giovane collega e divenne uno dei suoi più fidati amici e sostenitori. Melantone si unì alla causa della Riforma protestante tedesca. Nel 1519 si laureò anche in teologia e divenne un brillante professore della materia. Nel 1521 pubblicò i suoi famosi Loci communes rerum theologicarum, Luoghi comuni alle discipline teologiche, il primo trattato sistematico di teologia protestante. Melantone svolse un ruolo di primo piano nei dibattiti tra luterani ed oppositori. Redasse la dichiarazione principale della teologia luterana, la Confessione augustiana. Lutero e Melantone non furono mai in disaccordo su alcun punto importante, e benché Melantone attingesse alla tradizione filosofica occidentale, lo faceva in modo tale da “aggiustarla” alle dottrine luterane. Sviluppò su basi luterane una concezione sistematica del diritto, che può essere riassunta in tre capi: 1) La relazione tra diritto naturale e diritto divino Melantone credeva, come i contemporanei cattolici romani, nell’esistenza di una legge di natura (lex naturae) o diritto naturale (jus naturae), e postulò come loro che la ragione era data all’uomo da Dio per discernere e applicare questo diritto naturale. Espose però una dottrina nuova del diritto naturale dal punto di vista ontologico, vale a dire circa la sua origine nella natura essenziale dell’uomo. Dio ha posto in tutte le persone certi elementi di conoscenza, notitiae, che sono un lume superiore e naturale, senza il quale ci sarebbe impossibile trovare il cammino nel regno terreno. Queste notitiae non includono solo dei concetti logici (l’intero è maggiore di ciascuna delle sue parti), ma anche certi concetti morali (le offese che ledono la società devono essere punite). Questi innati concetti morali sono impossibili da provare o confutare, perché sono al di là della ragione umana. Quest’ultima, essendo corrotta dal peccato originale, è incapace anche di applicarli senza distorcerli. Per Melantone e Lutero la ragione umana è inevitabilmente corrotta. Si creava però un paradosso, che Melantone risolse subordinando il diritto naturale alla legge biblica. Quest’ultima illumina il diritto naturale ed è compendiata dai Dieci Comandamenti, le cui tavole furono divise nei primi 3 comandamenti e nei restanti 7. I primi 3 corrispondono al bisogno umano dell’unione con Dio, mentre gli altri corrispondono al bisogno della comunità delle persone. Per Melantone i Dieci Comandamenti erano un modello per il diritto positivo, e non solo una legge morale per la vita spirituale interna, come sostenuto dai cattolici romani. La ragione umana può discernere il diritto divino e naturale solo se è guidata dalla fede. 2) Gli usi del diritto naturale in una società civile Melantone, così come Lutero, credeva che nell’ambito del regno celeste il diritto non avesse alcun ruolo utile. Allo stesso modo sorgeva quindi la questione sulla funzione del diritto, alla quale egli rispose formulando gli usi:
1. Uso civile – costringere il popolo, col timore della punizione, a fuggire il male e a fare i bene;
2. Uso teologico – rendere le persone consapevoli della propria incapacità di fuggire il male e fare il bene;
15
3. Uso pedagogico – educare i fedeli: difatti il credente cristiano, benché salvo, non era ancora perfetto.
3) La relazione fra diritto naturale e diritto positivo Mentre Dio dispone linee guida per la società civile attraverso il diritto naturale, la società civile ha il compito di trasformare i princìpi generali del diritto naturale in norme particolari di diritto positivo. Questo è ciò che il diritto naturale “educa” lo stato a fare. Allo stesso modo lo stato deve esercitare, per mezzo delle sue leggi, una funzione educativa nei confronti dei suoi soggetti. I governanti politici erano chiamati ad essere ministri di Dio e dovevano promulgare “norme positive razionali”. Per essere razionali, le leggi positive come primo criterio devono fondarsi sui prìncipi generali del diritto naturale; come secondo criterio invece, devono essere conformi alle necessità politiche, economiche e sociali di un dato tempo e luogo. Nell’elaborare il primo criterio, Melantone prese le mosse dall‘idea che è compito dei governanti politici essere custodi e guardiani della prima e seconda tavola del Decalogo. Melantone sviluppò una teoria generale sia del diritto penale che del diritto civile. Secondo lui la sanzione penale serve come forma di retribuzione divina, di deterrenza sociale, di deterrenza generale e di educazione. Mentre per spiegare la fonte del diritto civile egli postulò il dovere del governante di facilitare e regolare la formazione e il funzionamento dei vari tipi di rapporti sociali volontari, soprattutto quelli contrattuali, familiari e relativi alla chiesa visibile. Si occupò dei contratti in forma categorica e per prìncipi generali. Solo occasionalmente applicò i principi generali ai casi specifici, come nel caso del contratto di mutuo di cui condannava i tassi d’interesse. Era il diritto naturale a dare al governante l’autorità di creare leggi positive, ma solo leggi positive conformi al diritto naturale, ed egli stesso era vincolate dalle leggi positive da lui promulgate. Inoltre, Melantone sosteneva che tutti avevano il dovere di obbedire e nessun diritto di resistere all’autorità politica e al diritto positivo, anche in caso di autorità arbitrarie e abusive. Cambiò questa teoria a partire dal 1555, ovvero da quando i principi avevano iniziato ad avere maggior potere: sostenne che il diritto positivo contrario a quello naturale dovesse essere disobbedito, e spettava ai soggetti resistere ai governanti. Inoltre Melantone era convinto dell’importanza della pubblicazione del diritto scritto come garanzia contro il potere arbitrario. Vedeva anche nel diritto romano un impedimento all’arbitrarietà del potere, e lo considerava ratio scripta, ovvero ragione scritta, una realizzazione del diritto naturale, ed era approvato da Dio nonostante l’origine pagana. Secondo lui era anch’esso una fonte dell’ordine politico a tutela del potere contro gli attacchi della folla e un impedimento agli abusi di potere come salvaguardia contro la tirannide. 4. La filosofia giuridica di Johann Oldendorp Oldendorp fu una delle individualità giuridiche più forti della sua epoca. Nacque ad Amburgo negli anni ’80 del XV secolo, studiò diritto a Rostock e Bologna e divenne professore di diritto romano a Greifswald. Negli anni ’20 del XVI secolo decise di consacrare la sua vita alla Riforma luterana, e fu così costretto a trasferirsi varie volte prima di stabilirsi a Colonia, come professore e membro dell’amministrazione. Andò infine a Marburgo, dove insegnò fino alla morte, avvenuta nel 1567. Accettò la chiamata a Marburgo a condizione di essere libero dall’obbligo consueto di tenere lezione sui testi del Corpus Juris Civilis nell’ordine e nel modo imposti dai post-glossatori, il famoso mos
16
italicus. Il Landherr Filippo il Magnanimo lo autorizzò ad introdurre una riforma radicale dell’educazione giuridica a Marburgo. La sua filosofia giuridica può essere divisa in 3 parti: 1) Diritto divino, diritto naturale e diritto positivo La filosofia giuridica di Oldendorp prende le mosse da una definizione semplice del Recht, diritto, come totalità delle norme giuridiche. Queste ultime sono definite come regole generali create per da certe autorità che comandano, proibiscono, puniscono o permettono una certa condotta. Il Recht, diritto, si identifica con le specifiche Gesetze, leggi, nello stile del moderno positivismo. Le leggi create dalle autorità civili sono subordinate alle leggi instillate da Dio nel cuore umano. Questa lex in hominibus, o lex naturalis, è direttamente vincolante per le autorità civili. Nella teoria di Oldendorp ci sono quindi tre stati del diritto, che formano una gerarchia: il diritto divino, il diritto naturale e il diritto umano. La lex divina è ristretta alle leggi descritte nella Bibbia, in primo luogo i Dieci Comandamenti. La legge naturale invece deriva da quelle parti della Bibbia che stabiliscono prìncipi generali di amore e onestà; si tratta di una legge data da Dio, e ciascuna persona ha la capacità di discernerla attraverso la ratio civilis. Anche la legge, secondo Oldendorp è derivata in ultima istanza dalla Sacra Scrittura (V Comandamento: “onora il padre e la madre” -> rispetto del principe e delle sue leggi; VI Comandamento: “non uccidere” -> norme di diritto penale; VIII Comandamento: “non rubare” -> norme di proprietà privata; IX Comandamento: “non dire falsa testimonianza” -> norme di procedura; X Comandamento: “non desiderare la donna d’altri” -> norme di diritto di famiglia). Oldendorp mise un accento particolare sull’VIII Comandamento, “non rubare”, nel quale vide la fonte anche del diritto dei contratti. All’analisi di questi applicò le quattro cause aristoteliche:
1. Causa efficiente: mutuo beneficio; 2. Causa materiale: portare entro un comune ordine la varietà degli affari umani; 3. Causa formale: compravendita, locazione, donazione etc; 4. Causa finale: esercizio della responsabilità della mutua condivisione attraverso la
perseverazione dell’equità commutativa fra le parti del contratto. Nei casi eccezionali in cui le leggi della Germania erano difettive rispetto alla legge naturale o quella divina, era obbligo della coscienza cristiana disobbedire. 2) L’equità Come dovevano essere applicate ai singoli casi le norme giuridiche generali ed astratte? I prìncipi generali non decidono i casi concreti. L’equità, secondo Oldendorp, è ciò che richiede un attento esame delle circostanze concrete del caso particolare, e che permette al giudice di applicare correttamente la regola generale a quelle circostanze. Al contrario di Aristotele, che lo prevedeva solo in determinati casi, per Oldendorp ogni applicazione del diritto ha bisogno di essere governata dalla Billigkeit, l’equità, che aveva tre funzioni:
1. Sospendere le norme giuridiche che confliggono con la coscienza; 2. Migliorare le norme giuridiche; 3. Interpretare le norme giuridiche in ogni caso cui tali norme si devono applicare.
L’equità è instillata da Dio nella coscienza delle persone individue. Al fine di discernere che cosa è equo, il singolo giurista deve studiare la Bibbia, pregare Dio e sondare la sua coscienza, che per Oldendorp era un elemento essenziale della filosofia giuridica.
17
3) La politica e lo stato Oldendorp sottolineò che l’ordine civile è disposto da Dio e obbliga i soggetti a un’obbedienza incondizionata. Ma allo stesso tempo era pronto, al contrario di Lutero e a precisazione di Melantone, a fornire una cospicua lista di casi d’eccezione. Oldendorp si occupò anche di fornire i compiti dell’autorità civile: emanare norme conformi alla volontà di Dio, sostenere la fede provvedendo ai predicatori, mantenere la pace con le altre comunità civili. Lo stato aveva personalità giuridica e quindi diritti e doveri. Oldendorp pose in risalto la funzione pedagogica del diritto, e lo chiamava paedagogus noster ad Christum, la nostra guida sulla via di Cristo. Capitolo terzo: La trasformazione della scienza giuridica tedesca Il sommovimento politico e religioso della Germania fu accompagnato e rafforzato da una trasformazione del metodo con il quale diritto veniva analizzato e sistematizzato. L’originario metodo scolastico fu trasformato dal nuovo metodo topico. L’attacco alla cosiddetta scolastica avvenne dapprima dai giuristi aderenti all’umanesimo, e si divise in tre fasi, l’ultima delle quali incarnò lo spirito della Rivoluzione tedesca: 1. La fase scettica dell’umanesimo giuridico Alla metà del XIV secolo, pionieri dell’umanesimo quali Petrarca e Boccaccio avevano attaccato i giuristi del tempo a causa della loro ignoranza delle antichità romane, a causa delle loro discussioni intorno a questioni banali e alla loro mancanza di vera scienza. Nel XV secolo questi addebiti furono fatti propri dal filologo umanista Lorenzo Valla, che fu un maestro di concretezza contro ogni astrazione. Per Valla l’interpretazione si basava sul significato letterale e non sulle costruzioni fittizie. Il significato a sua volta doveva essere tratto dal senso accettato da chi avesse un’educazione linguistica. Di conseguenza, per comprendere il diritto romano giustinianeo era necessario sapere quale fosse il senso delle parole contenute nei testi di Giustiniano. Valla inveì sia contro la lingua barbarica di glossatori e commentatori, sia contro le loro distorsioni del senso dei testi. La Magna Glossa di Accursio, compilata attorno al 1250, era una colossale concordanza delle glosse che erano state apposte al Digesto di Giustiniano dal tempo di Irnerio. Essa in misura considerevole arrivò a rimpiazzare lo stesso Digesto e per Valla fu paragonabile ad uno schermo oscuro, che impediva di vedere la purezza dei testi originali. Valla e i suoi seguaci trattarono i testi semplicemente come un’invenzione letteraria del sesto secolo, e quindi inevitabilmente contestarono l’autorità delle interpretazioni dei testi, Una volta che i testi furono ridotti a nulla più che letteratura, le glosse e i commentari loro apposti vennero visti come una distorsione del senso originario. In questa prima fase dello sviluppo, l’umanesimo giuridico non fu in grado di apportare alcuna soluzione costruttiva ai problemi giuridici del tempo. 2. La fase assiomatica dell’umanesimo giuridico I giuristi umanisti della seconda fase andarono oltre i loro predecessori in due aspetti: semplificarono il diritto escludendo ampi settori delle analisi tradizionali, e disposero ed interpretarono le singole norme giuridiche secondo prìncipi e concetti più stringenti. Il nuovo stile assiomatico andò oltre il chiarimento testuale. Il punto di partenza divennero i princìpi e i concetti giuridici, non più i testi o le loro glosse. Qui venne sviluppato un nuovo
18
metodo di insegnamento del diritto, chiamato mos iuris docendi gallicus, ovvero stile francese, che si opponeva al preesistente metodo bartolista, il mos iuris docendi italicus. Il grande triumvirato del diritto romano era composto da Zasius, Alciato e Budeo. Gli scritti di Budeo appartengono alla prima fase dell’umanesimo giuridico, mentre Zasius attaccò senza pietà sia Budeo che Valla. Egli riteneva che non si potesse pretendere che le opere giuridiche dei giureconsulti romani fossero facili, perché decifrarle richiede la scienza dei giuristi dotti. Zasius era interessato soprattutto all’elaborazione di concetti e prìncipi giuridici generali e a mostrare le loro implicazioni nella soluzione dei problemi specifici che i testi esemplificavano. Alciato riprese molto da Zasius e fondamentalmente condividevano le stesse idee. Entrambi scrissero numerosi trattati presentando il soggetto giuridico preso in esame in modo assiomatico. Essi contribuirono a salvare il pensiero giuridico europeo dalle critiche demolitrici della prima fase scettica dell’umanesimo giuridico. Introdussero importanti riforme nella scuola e scrissero i primi trattati organici su cospicue sezioni del diritto. 3. La fase sistematica della scienza giuridica: Usus modernus protestantorum Questa fase iniziò tra la fine degli anni ’20 e gli anni ’30 del Cinquecento. Eminenti giuristi iniziarono in questa fase a derivare da princìpi e concetti non solo singoli aspetti del diritto, ma il diritto nella sua globalità. La scienza giuridica scolastica (1) classificava e analizzava norme giuridiche (2) tratte principalmente da testi autoritativi e da interpretazioni autoritative di quei testi (3), ricavando da esse un insieme di concetti e di prìncipi rispondenti a criteri razionali di tipo convenzionale. Per contro, la nuova scuola protestante (1) classificò e analizzò i concetti e i prìncipi giuridici (2) tratti dalla ragione innata e dalla coscienza (3), illustrandoli come un insieme di norme giuridiche (4) trovate in un’ampia varietà di fonti. Nonostante Lutero volesse abolire la chiesa di Roma, egli non era nemico del diritto, benché sembrasse attaccare le fondamenta stesse della legalità. Cercò invece di gettare le fondamenta di un nuovo ordine giuridico che corrispondesse agli obblgihi imposti dalla Scrittura. 4. Il metodo topico di Melantone La prima delle opere di Melantone, Loci communes rerum theologicarum, pubblicata nel 1521, pose le fondamenta per una nuova teologia sistematica. Melantone insegnava che per costruire una qualsiasi scienza, i loci communes dovrebbero essere applicati alla materia oggetto d’investigazione, sotto forma di una serie di domande: 1) Qual è la definizione dell’oggetto investigato? 2) Qual è la sua divisione in genere e specie? 3) Quali sono le sue diverse cause? 4) Quali sono i suoi diversi effetti? 5) Quali sono gli oggetti limitrofi? 6) Quali sono gli oggetti affini? 7) Quali sono gli oggetti contrari? Gli scolastici avevano considerato i loci come una sezione della retorica, e quindi come una guida nella disputa, mentre gli umanisti li usarono per reperire la struttura dell’oggetto indagato. Per Melantone i loci erano assiomi universali, applicabili non soltando alla lingua e alla filosofia, ma anche alla teologia e al diritto. 5. Johann Apel I suoi due libri costituirono la base della moderna scienza giuridica tedesca. La Methodica, che fu pubblicata nel 1535, si basava sulle lezioni tenute da Apel all’università. L’opera comincia indirizzando l’attenzione sulle Istituzioni di Giustiniano, e le impiega per dar luogo ad un’esemplificazione nel campo delle norme giuridiche,
19
classificate ed analizzate nei termini dei loci di Melantone. Le risposte alle sette questioni danno luogo ad una sintesi nella quale si fissano i concetti ed i prìncipi. L’Isasoge è redatta invece nella forma di una conversazione tra un mediocre giurista, uno studente di diritto alle prime armi, e una terza persona, Sulpicio, che rappresenta l’autore stesso. Tutti e tre criticano malinconicamente l’insegnamento del diritto mediante le glosse al testo del Digesto. Sulpicio attribuisce alle Istituzioni un’origine sistematica delle norme giuridiche dall’idea stessa del diritto insita nella ragione. Apel tornò alle fonti secondo il metodo ermeneutico usato da Lutero, Melantone e altri teologi protestanti nell’interpretazione della Bibbia. Quest’ermeneutica cercava di dischiudere il senso della Scrittura al lettore contemporaneo. Apel fu il primo giurista ad applicare l’ermeneutica protestante al diritto e a presentarlo dunque come un insieme integrato di prìncipi e concetti, dal quale le varie norme giuridiche erano logicamente derivate. Uno dei maggiori contributi di Apel fu quello di sottoporre a critica e rielaborare la suddivisione del diritto fra “persone”, “cose” e “azioni”. Procedette a distinguere il diritto sulle cose, il “dominio”, dal diritto ad un’azione, l’”obbligazione”. Questa distinzione in dominio ed obbligazioni pose i termini fondamentali della moderna scienza giuridica occidentale. Apel fu tra i primi giuristi occidentali ad usare il termine “diritto civile” per riferirsi principalmente alla disciplina del rapporto tra privati. L’enfasi sulla definizione e l’elaborata classificazione dei prìncipi giuridici in genere e specie, portarono a nette distinzioni entro il corpo stesso del diritto civile. Es: separazione del contratto dall’acquisto del dominio – il contratto dà origine a una causa di obbligazione, che a sua volta è un diritto al, non un diritto nella proprietà. Il dominio, che è un diritto nella proprietà, può essere acquistato in una varietà di modi, inclusi non solo l’occupazione e l’eredità, ma anche il contratto. Con l’acquisto del dominio si ha una causa remota del dominio, mentre con il contratto di vendita si ha una causa prossima. Questa analisi fu accettata fino al XIX secolo e si fa ancora oggi distinzione tra il diritto di proprietà dell’acquirente nel caso di beni mobili che siano stati consegnati dal venditore, e il suo diritto contrattuale alla consegna di beni mobili che siano rimasti in possesso del venditore. 6. Konrad Lagus L’opera di Apel era meno organica e dettagliata della Methodica che pubblicò Lagus nel 1543. Anche lui partì dalle Istituzioni, che secondo lui fornivano la struttura dell’ordine giuridico, e diede poi una descrizione sistematica delle principali parti di cui consistono la scienza e l’arte del diritto. Divise il suo trattato in due parti: una filosofica che tratta della natura generale del diritto ed espone il metodo del libro, e una storica che è una dettagliata analisi dell’intera struttura del diritto. La sistemazione del diritto fu fatta seguendo l’analisi aristotelica dei quattro generi di “cause”:
1. cause efficienti: distinse il diritto naturale dal diritto civile; suddivise inoltre il diritto civile fra leggi fatte dall’impero, dalla chiesa, dalle municipalità, etc;
2. cause materiali: distinse le materie di cui sono composte le forme giuridiche particolari: diritto divino concernente le cose sacre, il sacerdozio, etc. il e diritto umano consistente nel diritto militare, feudale, etc;
20
3. cause formali: distinse le forme che prende il diritto, suddividendo l’equità a sua volta in equità scritta e non scritta;
4. cause finali: distinse gli scopi ai quali serve il diritto – materie pubbliche, private. Diventa quindi fondamentale la distinzione tra diritto pubblico e diritto privato.
L’applicazione delle categorie aristotelico-melantoniane ebbe importanti conseguenze sul piano filosofico: vi si possono scorgere sia elementi di diritto positivo che di diritto naturale. La parte storica del trattato di Lagus si divide in sei parti, che rispecchiano la sua sistematizzazione del diritto. In ciascuno dei sei capitoli della seconda parte la topica generale è risolta nelle sue due specie, ed ogni specie è trattata in uno o più titoli. Il piano di Lagus portò alla realizzazione della concezione di Apel, di un’organizzazione sistematica di tutto il corpo normativo contenuto nel diritto. Ciò implico due nuovi principi metodologici:
1. Lagus organizzò le materie giuridiche attorno ad una topica generale, comune a tutte le scienze (loci communes), incluse le quattro cause aristoteliche, mentre precedentemente venivano organizzate attorno ai loci ordinarii;
2. Lagus combinò le fonti di diritto romano con le fonti di diritto canonico, mentre precedentemente queste erano state analizzate separatamente.
In aggiunta al suo Compendio di diritto civile (questo il nome che fu poi dato alla sua Methodica), egli analizzò sistematicamente anche il diritto della Sassonia. Anche quest’altro compendio fu diviso con la stessa classificazione di quello precedente. 7. Lo sviluppo successivo della sistematica giuridica Il metodo iniziato da Apel e Lagus si sviluppò in varie direzioni, soprattutto in Germania. Fra i più illustri esponenti tedeschi del metodo giuridico dell’ultima parte del XVI secolo vi furono Nicolaus Vigelius e Johann Althusius. Vigelius fu allievo di Oldendorp, e nel 1561 pubblicò il suo Methodus. Nei primi 3 libri viene trattato il diritto pubblico, mentre nei restanti 21 di quello privato. Un ultimo libro completa l’opera trattando di miscellanea. Come Lagus, egli espose una tavola in cui la struttura della sua Methodus era illustrata visivamente. A differenza di quella di Lagus però, la sua omette il diritto divino e il diritto naturale, concentrandosi solo su quello positivo. Si tratta di uno schema visivo dei contenuti dell’intero trattato. Althosius pubblicò invece la sua opera maggiore, Iurisprudentia Romana, nel 1586. Egli divise tutto il diritto in pubblico e privato, e quest’ultimo in dominio ed obbligazione. 8. Implicazioni politiche e filosofiche della nuova scienza giuridica Il bisogno di un nuovo tipo di sistemazione del diritto nacque in prima istanza da una perdita di fiducia nella sacralità degli antichi testi giuridici romani e nell’autorità delle loro glosse e commentari. La scienza giuridica precedente alla Riforma presupponeva la distinzione delle giurisdizioni, secolare ed ecclesiastica, ciascuna con i suoi testi giuridici autorevoli. Le contraddizioni che sorgevano tra le due tipologie potevano essere tollerate a causa della cristianità federale in cui giurisdizioni concorrenti si fondavano su diversi testi normativi. Ciò invece non poteva essere tollerato in un ordinamento giuridico unitario di tipo principesco o regale. Vi fu inoltre un’esaltazione del ruolo politico dello studioso del diritto. Capitolo quarto: La Rivoluzione tedesca e la riforma del diritto penale
21
Il diritto penale tedesco subì una notevole trasformazione nel corso del XVI secolo. Una causa fu il bisogno di controllare la diffusa violenza che caratterizzò lo stato sociale della Germania nel tardo XV e nel primo XVI secolo. Il sistema penale preesistente era inadeguato a far fronte con efficacia alla vastità alla criminalità professionale o semi professionale. Per molti secoli aveva avuto corso in Germania, un sistema giudiziale con tribunali composti di 7-12 notabili laici, detti Schoeffen (assessori), che sedevano con un Richter (direttore). Fonte principale del diritto era la consuetudine, e gli Schoeffen dovevano conoscerla o essere in grado di accertarla. Il fatto che una gran parte del diritto consuetudinario arrivò ad essere espressa a mezzo di opere o raccolte scritte, come ad esempio il Sachsenspiegel, modificò alquanto il suo carattere. La procedura applicabile nei giudizi penali presso le corti degli Schoeffen prima del XVI secolo conservava alcuni tratti di una delle più antiche forme tribali di procedura penale, in cui le cause penali erano introdotte dall’accusa della vittima o un parente/amico, in cui l’accusato doveva essere prosciolto sulla base di giuramenti prestati dal lui o dai suoi accusatori e sostenuti da altri. Se condannato, l’accusato era obbligato a pagare una compensazione alla vittima o ai suoi parenti. Nel XII secolo, con l’avvento della Rivoluzione papale, il sistema tribale subì una trasformazione in Germania come nel resto d’Europa. Il crimine più grave (quello capitale) fu distinto nettamente dai meno gravi, e la pena per il crimine più grave, segnatamente la morte o la mutilazione, sostituì la composizione negoziata fra le parti o i loro parenti. Mentre il procedimento per giuramento sopravvisse, gli altri mezzi di prova furono pressoché eliminati. Inoltre, le autorità urbane principesche cominciarono a prendere l’iniziativa dell’azione penale contro le persone accusate delle trasgressioni più gravi. Elementi del modello accusatorio tedesco si combinarono con quello inquisitorio della canonistica. Un importante elemento del procedimento inquisitorio era il ricorso alla tortura per indurre l’accusato alla confessione. L’introduzione di questa pratica può essere fatta risalire al 1215, come conseguenza dell’abolizione delle ordalie (il giudizio divino, dal tedesco Ur-theil) nel IV Concilio Lateranense. Per sostituire le ordalie occorreva un mezzo di prova che ottenesse un grado di certezza comparabile con quello del giudizio divino. Una tale certezza doveva trovarsi in quella che fu detta prova piena, ovvero quella tramite:
1. Due inoppugnabili testimonianze relative agli elementi essenziali del crimine; 2. La volontaria confessione al processo in piena corte.
Questo per limitare quanto più possibile la discrezionalità dei giudici. Questa spiegazione però lascia aperte molte questioni:
1. Se la corte poteva raggiungere, anche in assenza di prova piena, la certezza sostanziale nei casi non capitali, perché tale prova era invece necessaria nei casi più gravi?
2. Anche se la confessione era la regina delle prove, quanto poteva essere affidabile una confessione elargita sotto tortura?
3. Perché la tortura non veniva utilizzata in caso di processi contro alcune categorie privilegiate, quali aristocratici, medici e dottori di diritto?
Con riguardo alla regola dei due testi, della confessione e della tortura c’erano delle nozioni sparse che potevano trovarsi nei testi di Giustiniano. Nonostante questo, il grande giurista italiano Bartolo da Sassoferrato, ad esempio, scrisse che la prova piena non necessita di due testi o della confessione, ma le basta una piena convinzione del giudice.
22
Al contrario i canonisti concessero al giudice meno poteri discrezionali, conservando rigorosamente la regola della prova piena. La spasmodica ricerca di una confessione può essere spiegata con la volontà di far pentire l’accusato agli occhi di Dio, seppur forzatamente, salvando così la sua anima. In questo caso, perché allora la presenza di due testi poteva sopperire alla confessione? Boh. 1. Schwarzenberg, la Bambergensis e la Carolina Schwarzenberg fu il più grande legislatore tedesco dell’età della Riforma. Nel 1507, quando aveva poco più di quaranta anni, egli produsse per Bamberg un codice di diritto sostanziale e processuale per i delitti capitali, che acquistò fama pressoché immediata in tutta la Germania. Chiamato Bambergensis, servì da modello per numerose legislazioni pressoché identiche. Nel 1521 la Dieta di Worms deliberò di adottare un codice imperiale per i delitti capitali e Carlo V incaricò Schwarzenberg di occuparsene. Nel 1532 fu quindi proclamata la Constitutio criminalis Carolina, modellata in gran parte parola per parola sul codice di Bamberga. La Bambergensis fu la prima codificazione sistematica di un singolo settore del diritto. La Carolina si applicava nel Tribunale camerale imperiale Reichskammergericht, la sola corte imperiale, la cui giurisdizione penale però era alquanto limitata in confronto a quella delle corti territoriali e delle altre corti non imperiali. La Carolina doveva servire da modello per la legislazione imperiale; conteneva nondimeno una clausola d’eccezione che la rendeva espressamente opzionale per i principati. Anche se era una fonte residuale, ben presto venne a svilupparsi un diritto penale comune tedesco. Lo scopo della codificazione del diritto penale era quello di riformare il diritto secolare tedesco. La Bambergensis e più tardi la Carolina avevano lo scopo di riformare il diritto processuale e sostanziale applicabile nei casi di delitto capitale, cioè a quei delitti che rendevano operativa la procedura inquisitoria che si era sviluppata nelle corti secolari tedesche nel XV secolo. Schwarzenberg non escogitò le fattispecie contenute nei codici; si trattava di trasgressioni già identificate, definite e punite in base al diritto consuetudinario. Del pari, non inventò le pene atroci applicabili alle persone riconosciute colpevoli di questi delitti. Il merito della Bambergensis e della Carolina fu quello di ridurre il carattere arbitrario e incerto del diritto penale preesistente. Nell’ambito della procedura penale introdussero un sistema razionale di valutazione delle prove; nell’ambito del diritto penale sostanziale stabilirono definizioni precise degli elementi dei vari delitti. I maggiori cambiamenti compresi sia nella Bambergensis che nella Carolina:
1. Le sopravvivenze arcaiche dei mezzi di tutela privati furono definitivamente eliminate o fortemente limitate;
2. La prova per giuramento fu definitivamente eliminata; 3. L’accusa penale privata fu fortemente limitata dal requisito che il privato querelante
desse garanzia per le spese legali e per l’offesa e il danno arrecati all’accusato nel caso in cui non si giungesse ad un processo e ad una dichiarazione di colpevolezza;
4. Il Richter designava un pubblico ministero ufficiale per agire come accusatore, Ankläger. Si stabilirono i limiti al potere della pubblica accusa;
5. Le procedure straordinarie contro persone semplicemente accusate di essere socialmente pericolose furono eliminate;
23
6. Fu stabilito un rigorosissimo regime delle prove. Per ogni elemento del delitto era richiesto un indizio persuasivo, redliche Anzeigung (indizio sufficiente). Solo in presenza di tali indizi l’accusato poteva essere sottoposto a tortura affinché confessasse;
7. Particolari tipi di prova richiesti per l’accusa furono specificati in dettaglio per le diverse fattispecie delittuose: • Assassinio commesso in assenza di testimoni: accusato visto con vesti
lorde di sangue o in atteggiamenti sospetti, oppure che avesse qualcosa di proprietà della vittima;
• Avvelenamento segreto: accusato ha comprato o maneggiato del veleno, ha rapporti di inimicizia con la vittima;
• Furto: cosa rubata presso il sospettato, non riesce a provare di averla ottenuta in buona fede;
• Oltre a ciò: furto così grande che il sospettato spende molto più di quanto non potrebbe con i suoi mezzi;
• Tradimento: comportamento furtivo, insidioso e insolito con coloro che si sospettava avesse tradito;
• La dichiarazione del teste: doveva essere ricevuta a norma di legge e con diligenza dal Richter e da due persone capaci di ricevere la deposizione di un teste, e trascritta dal notaio della corte, che doveva anche fare attenzione alla testimonianza;
• Proscioglimento dell’accusato in mancanza di prova di colpevolezza; • Consiglio dei rechtsverstendigen: Sia il Richter che gli Schoeffen erano
ripetutamente ammoniti che nei casi difficili essi avrebbero dovuto ricercare il consiglio dei sapienti nel diritto.
Per riformare la procedura penale tedesca era necessario attuare mutamenti notevoli anche nel diritto penale sostanziale. Precedentemente, quando vigeva solo il modello accusatorio, la comunità sapeva che cosa apparteneva al dominio penale e cosa no. Con l’introduzione del modello inquisitorio, il diritto consuetudinario apparve confuso ed arbitrario e fu soggetto ad abusi. Servivano quindi definizioni più precise degli illeciti e princìpi più chiaramente articolati. I codici di Schwarzenberg vennero incontro a questa necessità, attraverso i seguenti contributi:
1. I primi 105 dei 219 articoli della Carolina stabiliscono regole e definizioni applicabili ai delitti e alle pene in generale;
2. Gli elementi necessari di quasi ognuno tra le dozzine di delitti elencati nei codici sono attentamente definiti;
3. Pene specifiche sono disposte per tutte le diverse fattispecie penali. Le pene si differenziano per severità in relazione alla natura del delitto e al grado di colpevolezza del delinquente. Questo riflette un concetto primitivo di proporzionalità della pena rispetto al delitto;
4. È stabilito il principio generale, per cui la responsabilità penale deve essere limitata agli atti proibiti commessi o con dolo o per colpa. Non può esservi responsabilità penale senza colpevolezza (nel senso di mens rea). È fatta inoltre distinzione fra trasgressione intenzionale ed atti impulsivi provocati da una giustificabile alterazione;
5. È imposta responsabilità penale per il tentativo di commettere il delitto, senza riguardo per l’assenza di danno per la vittima, quando l’interruzione dell’atto criminoso sia avvenuta contro la volontà dell’autore;
24
6. Certi atti illeciti (ad esempio la stregoneria) non dovevano dar luogo a responsabilità penale a meno che non avessero causato danno;
7. Chi manca della capacità di intendere è esonerato dalla responsabilità penale, e la legittima difesa è esposta come scriminante dell’omicidio.
2. La relazione della riforma del diritto penale con la Rivoluzione tedesca Dato che la Bambergensis fu pubblicata prima della Riforma, potrebbe sembrare che non ci sia alcun collegamento fra le due cose. Schwarzenberg, tuttavia, divenne un ardente e influente luterano e scrisse dei trattati in difesa della nuova teologia evangelica; inoltre sostenne in più occasioni la causa luterana. La Bambergensis contiene importanti princìpi giuridici nei quali si riflettono tre aspetti della Rivoluzione tedesca: 2.1. L’aspetto religioso La Bambergensis e la Carolina riflettono la convinzione luterana che il diritto è uno strumento di Dio per il solo regno terreno, e che le opere del diritto non sono una via per la salvezza nel regno celeste. Venivano contestati sia la dottrina del purgatorio sia il carattere sacramentale della penitenza. La salvezza c’è per la sola fede. L’osservanza delle norme morali e civili non è una via per la salvezza, i suoi scopi divini sono invece:
1. Uso teologico: definire e punire i peccati; 2. Uso civile: distogliere il popolo dal commettere peccato per timore della pena; 3. Uso educativo: insegnare al popolo quale condotta Dio giudica giusta.
2.2. Aspetti scientifici La Bambergensis era un diritto legislativo scritto in una lingua chiara, concisa, comprensibile a tutti, ma, come la Bibbia stessa, bisognoso della conoscenza e della saggezza di uomini di dottrina perché potesse essere interpretato ed applicato ai casi concreti. Il metodo topico di Melantone si incarnava nella legislazione di Schwarzenberg. Nella divisione della codificazione in due parti, erano impliciti i loci communes: la prima parte esponeva i prìncipi generali applicabili a tutti i delitti capitali; la seconda esponeva le particolari specie delittuose in modo da confermarle a quei prìncipi (divisione tra la arte generale e la parte speciale del codice penale!). 2.3. Aspetti politici La Bambergensis diede al principe e alla magistratura suprema, la Obrigkeit, giurisdizione su tutti i delitti capitali entro i propri confini. la Carolina, il diritto imperiale, era applicabile solo nella limitatissima serie di casi di competenza dell'unica corte imperiale, il Reichskammergericht. Capitolo quinto: La trasformazione del diritto civile e del diritto dell'economia tedeschi Nel XVI secolo ebbero luogo cospicui cambiamenti nel diritto civile e dell'economia tedeschi, specialmente nel diritto dei contratti, della proprietà e delle transizioni relative al credito.
25
1. Il contratto 1.1 Il diritto scientifico (jus commune) Un diritto dei contratti unificato emerse in Europa per la prima volta nelle opere dei giuristi del XVI secolo. Prima ci fu un diritto dei contratti al plurale. Nel diritto romano giustinianeo il contratto doveva essere conforme a uno dei tipi predeterminati per poter essere mandato ad effetto. Sia in base al diritto romano che al diritto tedesco prima del XII secolo, un mero scambio di premesse non dava origine ad un'obbligazione contrattuale finché una delle parti non avesse almeno cominciato ad adempiere alla sua promessa. In netto contrasto col diritto consuetudinario e quello romano, vi fu il diritto canonico del XII secolo, che asseriva che la forza giuridicamente vincolante dei patti dipendeva dall'intenzione delle parti. Questo perché il mancato mantenimento di una promessa era considerato un peccato. 1.2. Il diritto legislativo e consuetudinario Nel XVI secolo furono redatte per la prima volta su larga scala le ordinanze territoriali (Landesordnungen). Una tale legislazione sistemava e modificava il diritto consuetudinario prevalente che disciplinava la maggior parte degli aspetti della vita economica del popolo tedesco. Tanto il diritto romano quanto il diritto canonico erano utilizzati dalle corti tedesche per colmare le lacune e per risolvere le ambiguità. Però in caso di contrasto fra il diritto legislativo o il diritto consuetudinario, da una parte, e lo jus commune dall'altra, doveva prevalere il primo. In assenza di un chiaro contrasto, il jus commune disponeva i prìncipi generali con cui il diritto legislativo e consuetudinario erano interpretati dai giuristi dotti. Ciò che distingueva il jus commune era il suo carattere scientifico, cioè sistematico. Il diritto legislativo e il diritto consuetudinario erano meno sistematizzati, meno espressi nei loro prìncipi generali; essi erano più diffusi e più legati alle condizioni pratiche, economiche e sociali. Le differenze fra il diritto generale dei contratti descritto nella trattatistica di jus commune da un lato, e dall'altro il diritto delle forme contrattuali particolari definite nelle leggi territoriali e urbane così come nel diritto consuetudinario, sono ampiamente messe in luce dalla conservazione e anzi dall'aumento dei requisiti formali del diritto legislativo e consuetudinario. Nel jus commune un nudum pactum poteva costituire un contratto vincolante. Però secondo le organiche leggi territoriali come la Landesordnung del Württemberg, del 1555, i contratti relativi ai trasferimenti di proprietà dovevano essere registrati nel registro della locale corte in presenza di entrambe le parti; fino a quel momento essi si dicevano inoperanti, e ognuna delle parti poteva recedere. La legge del Württemberg segue senza dubbio il jus commune nel descrivere alcune regole generali introno a diversi tipi di contratto, mentre le variazioni importanti sono da ricercare nei particolari. Il diritto applicabile alle transazioni finanziarie illustra in modo vivido la relazione fra i diritti dotti e il diritto consuetudinario e legislativo tedesco del XVI secolo. I romanisti avevano trovato nei testi giustinianei una varietà di norme applicabili a varie forme di trasferimento della proprietà. Vivendo però in un'economia del tutto diversa, i glossatori e i commentatori europei diedero un nuovo significato ai testi del diritto romano. Allo stesso tempo, i teologi cattolici romani introdussero nuove considerazioni morali, due delle quali erano che il credito non deve essere portato ad un eccessivo tasso d'interesse e che la
26
proprietà non deve essere trasferita ad un prezzo ingiusto. Queste due teorie vennero ampiamente accolte ed applicate dai filosofi e dai giuristi luterani. Nel Trattato sul commercio e sull'usura di Lutero, del 1524, egli condannò l'avidità, ma al tempo stesso difese la normale attività commerciale produttrice di guadagno, affermando che: "é equo e giusto che un mercante tragga dai suoi prodotti tanto profitto quanto valga a rimborsarlo dei suoi costi, a compensarlo delle sue fatiche, del suo lavoro e del suo rischio." I beni devono essere: "valutati al prezzo al quale essi sono comprati e venduti comunemente sul mercato o generalmente nel paese (...) Il profitto ottenuto in questo modo io lo considero onesto e giusto." Ingiusti invece erano i monopoli e l'accumulazione dei prodotti allo scopo di innalzare i prezzi. Lutero riteneva ragionevole la richiesta di un interesse sul mutuo, dato che il rischio del creditore costituisce una forma di lavoro. Ciò non differisce sostanzialmente dalla teoria dei principali teologi e filosofi morali cattolici romani. Ciò che sostanzialmente era differente, erano le condizioni economiche e le condizioni politiche e giuridiche nelle quali Lutero e gli altri teologi e legislatori del XVI secolo si trovavano rispetto ai tempi precedenti. • Economicamente, le transazioni finanziare erano in via di enorme incremento per gli
scopi e per la loro importanza. Un'ampia ascesa dei prezzi, unita a un forte incremento della popolazione, contribuì a far salire la domanda di credito. Inoltre il XVI secolo fu un periodo di sostanziale crescita economica, stimolata da una serie di nuovi fattori economici.
• Politicamente e giuridicamente, la lotta contro i due peccati dell'ingiusto prezzo e dell'usura ora divenne fondamentale responsabilità dei principi, che intervenivano soprattutto per mezzo della legislazione secolare e delle sanzioni giudiziarie e amministrative secolari. É questa un'età alla quale gli storici dell'economia hanno attribuito l'aggettivo di "mercantilistica", a significare, in parte, un esteso controllo da parte dello "stato" sopra l'attività economica. Mentre un tempo le transazioni aventi ad oggetto il credito garantito erano legate in primo luogo alla compravendita di beni, la finanza su larga scala rovesciò la relazione fra denaro e beni. Il diritto dotto, il jus commune, aveva poco o nulla da dire tanto sulla legislazione quanto sul mutevole diritto consuetudinario attraverso i quali queste politiche si realizzavano. Di particolare importanza fu lo sviluppo di nuove pratiche bancarie e mercantili connesse, da una parte, con il finanziamento delle attività militari ed economiche dei governanti territoriali, e dall'altra, con la forte espansione delle transazioni monetarie private in campo transnazionale. I principali strumenti giuridici utilizzati per effettuare il finanziamento privato delle attività governative e mercantili erano le lettere di cambio. Le transazioni commerciali tramite i "pagherò" erano disciplinate interamente dal diritto consuetudinario non scritto. I pagherò esigibili in un paese straniero furono chiamati bolle di cambio. La parola "cambio" si riferiva al cambio delle diverse valute. La parola "bolla" deriva dal latino bulla, lettera. Quando i mercanti divennero sedentari, il cambiamento in cambio estero cominciò ad avere luogo sempre più a distanza. Il problema fu risolto attraverso i
27
contratti di cambio fra i mercanti-banchieri e i loro clienti. La lettera di cambio divenne la valuta europea internazionale.
2. La proprietà 2.1. Il diritto scientifico (jus commune) C'era una sovrapposizione di concetti giuridici fra le differenti giurisdizioni. In tutte la parola latina dominium significava non solo diritti sulla terra o sui beni ma anche signoria, Herrschaft, sulle persone. In nessuna di esse inoltre, il diritto di proprietà era chiaramente distinti dal diritto delle obbligazioni nascenti da contratto o di altro genere. In base al diritto feudale non si aveva la "proprietà" della terra nel senso moderno del termine, ma la si "deteneva" in una qualsiasi forma di possesso. I diritti sulla terra erano vincolati agli obblighi del detentore verso i superiori. I principi avevano il dominium supremo. La Chiesa cattolica romana, che prima della Riforma deteneva da 1/4 a 1/3 del territorio, aveva spesso un dominium esclusivo di terre e beni usati soltanto per scopi ecclesiastici. I diritti di proprietà ecclesiastici erano diversi: i Francescani non potevano avere il dominium né sulla terra né sui beni, dato che in base alla regola del loro ordine non dovevano possedere nulla. Essi avevano un diritto alla terra e ai beni (jus ad rem), ma non un diritto su di essi (jus in re). Anche i vassalli, in confronto ai signori, avevano lo stesso tipo di diritto. Questa situazione fece nascere il concetto giuridico di dominium utile, o dominio beneficiale, contrapposto al dominium directum, che includeva il diritto di disporre della cosa. I canonisti avevano sviluppato norme a tutela di chi possedeva terra o beni. Inoltre il possesso era definito non come una situazione di fatto, ma come una situazione giuridica, un diritto a possedere. Si poteva avere un diritto a possedere la terra - in latino saisina, in tedesco Gewere - anche se si fosse lontano in pellegrinaggio o in crociata. I romanisti tedeschi del XVI secolo diedero un nuovo rilievo alla distinzione tra dominium directum e dominium utile. Con il declino delle relazioni feudali signore-vassallo e signore-contadino e con il sempre più largo sostituirsi ad esse delle relazioni locatore-locatario, il diritti relativi alla terra così come ai beni mobili vennero via via ad essere soggetti a ciò che i romanisti chiamavano emphyteusis (affitto), rapporto in base al quale l'enfiteuta si obbligava a consegnare annualmente una certa quantità di beni o di servizi o di denaro in cambio di una occupazione della terra a lungo termine, ovvero hypotheca (pegno), in base alla quale l'acquirente della terra la ipotecava come garanzia dell'obbligo di adempiere annualmente a tali condizioni di pagamento. I cambiamenti economici e sociali portarono a distinguere i diritti di proprietà dai diritti che sorgevano dalle obbligazioni contrattuali d'altro genere. Fu Apel a creare la distinzione basilare, che sopravvive fino ad oggi, fra il diritto di proprietà e il diritto delle obbligazioni. Egli limitò il diritto di proprietà ai diritti relativi alla terra e ai beni mobili. Le obbligazioni, danno origine ad azioni personali, mentre il dominio da dà origine ad azioni reali. La sua divisione divenne dominante in Germania ed in altri paesi. 2.2. Il diritto legislativo e consuetudinario Così come nel diritto dei contratti, anche nel caso del diritto di proprietà gli scrittori del jus commune contribuirono a redigere, e redigendo a sistematizzare, la nuova legislazione. Ma anche in questo caso, il diritto positivo che si creava sia per i cambiamenti nella consuetudine sia per le leggi territoriali ed urbane, differiva in aspetti importanti dal diritto descritto ed analizzato nella letteratura di scuola. I concetti di emphyteusis e hypotheca non erano in grado di contenere interamente l'ampia varietà delle situazioni giuridiche
28
emergenti, e per disciplinarle c'era bisogno della legislazione e dell'amministrazione principesca e urbana. Ciò che é largamente assente dai trattati cinquecenteschi sul jus commune é un'analisi della dettagliata disciplina delle modifiche apportate alle relazioni di diritto civile dal diritto consuetudinario e dalla legislazione territoriale. Questa lacuna fu parzialmente colmata da un nuovo genere di letteratura giuridica del XVI secolo, che elencava e compendiava le differenze tra il jus commune e il diritto di un territorio particolare. Gli autori di queste raccolte di "differenze" sottolineano che il diritto territoriale prevale sul jus commune dove i due siano in contrasto. Uno dei meccanismi giuridici più largamente usati nel XVI secolo per il trasferimento dei diritti di proprietà, non aveva alcuna corrispondenza nel diritto romano classico e post-classico; esso prese il nome di Rentenkauf (o census), che alla lettera significa "l'acquisto di un diritto a pagamenti periodici". Questo diritto creava al concessionario un diritto di proprietà sulla terra, e non una pura e semplice obbligazione al concedente. La concessione sfuggiva alle restrizioni feudali, per il fatto che non richiedeva il consenso di un superiore nella catena feudale. Nei secoli XV e XVI, l'acquisto del diritto alla riscossione annua venne praticato in misura assai larga in tutta Europa e consistette spesso in riscossioni di denaro piuttosto che di beni. Il Rentenkauf venne ad assomigliare ad un moderno mutuo immobiliare, cioè a un credito da restituirsi in rate annuali e garantito da un interesse nella proprietà in terra ed edifici. Fu principalmente attraverso la varietà di forme di vendita o di locazione della terra contro un acconto più il pagamento di rendite annuali, che i possedimenti rurali feudali si trasformarono in possedimenti terrieri privati. 3. La società d'affari La società d'affari non subì cambiamenti paragonabili al contratto e alla proprietà. La società rimase il metodo fondamentale di mettere insieme risorse finanziare e d'altro genere. Anche la banca conservò largamente la forma della società. La produzione continuò ad essere gestita da corporazioni. Nel commercio frontaliero, le fiere mercantili tradizionali si espansero dando vita alle borse, in cui i banchieri svolsero un ruolo dominante. Tutto ciò non va confuso con la nascita del capitalismo, dato che mancano la società per azioni e il libero mercato; piuttosto bisogna parlare di mercantilismo. Capitolo sesto: La trasformazione del diritto sociale tedesco L'interazione dialettica tra lo spirituale ed il secolare nella Germania luterana é vividamente illustrata nelle centinaia di nuove norme relative a ciò che potremmo chiamare responsabilità e diritti "spirituali", promulgate dai principi e dai consigli cittadini della Germania luterana del XVI secolo. Queste erano chiamate ordinanze, Ordnungen, e ognuna di esse costituiva un complesso unitario di regole che portavano "ordine" In una vasta sfera di attività e di relazioni che coprivano un intero settore del diritto. Le ordinanze che qui sono chiamate spirituali trasferirono nelle autorità secolari la giurisdizione sopra materie che erano state governate da ciò che era stato chiamato il diritto spirituale della Chiesa di Roma. Le nuove Ordnungen spirituali furono chiamate con una varietà di nomi. Esse erano solitamente redatte dai principali teologi protestanti, combinando dottrine teologiche e dottrine giuridiche relative a materie che erano considerate strettamente connesse con la fede cristiana. I diversi tipi di ordinanze spirituali erano rivoluzionari per quanto riguarda quattro aspetti:
29
1. Esse non erano promulgate dalla gerarchia ecclesiastica ma dai consigli municipali e dalle altre assemblee rappresentative che agivano sotto l'autorità del principe;
2. Le loro violazioni erano soggette alle sanzioni amministrative e penali delle autorità e delle corti secolari;
3. Queste ordinanze contenevano e rafforzavano la teologia protestante; 4. Esse riflettevano la nuova scienza giuridica. 1. La spiritualizzazione del diritto secolare Cinque erano i principali tipi di materia spirituale regolati da ordinanze promulgate dalle autorità secolari nei territori della Germania protestante durante il XVI secolo. 1.1. La liturgia Composte dai principali teologi luterani, le ordinanze ecclesiastiche (Kirchenordnungen) promulgate nel XVI secolo dalla maggior parte dei governanti secolari dei più importanti principati e centri urbani luterani, oltre a disciplinare le strutture istituzionali della chiesa, regolavano anche la liturgia. Un'importantissima innovazione fu la sostituzione del latino col volgare tedesco. Innovazioni connesse a questa furono il forte accento sulla partecipazione dell'assemblea all'amministrazione dei sacramenti così come alle preghiere comunitarie. L'accento luterano sulla partecipazione dell'assemblea all'amministrazione dell'eucarestia rifletteva un cambiamento ecclesiologico e teologico del carattere del sacramento che aveva importanti implicazioni sociali. I luterani, al contrario dei cattolici romani, insistevano che il sacramento era consumato quando sia il pane sia il vino erano consumati dai congregati, e non dal solo sacerdote, che partecipavano collettivamente al sacramento ogni settimana. Nel pensiero luterano il sacramento aveva un aspetto sociale, realizzando l'accoglienza del singolo nella comunità. Per quanto riguarda il sacramento del battesimo, il principale cambiamento luterano del rituale cattolico romano fu la sua traduzione in tedesco. Il battesimo luterano si differenziava da quello cattolico romano nell'accento che poneva sulla responsabilità della congregazione verso l'infante battezzato. Lutero voleva le preghiere in volgare tedesco perché occorreva la fede di tutto il corpo della congregazione per proteggere l'infante dalle insidie del demonio. Connessa con la traduzione della liturgia in volgare tedesco fu anche l'introduzione dell'innodia, una nuova preghiera comunitaria. Lutero sosteneva che la musica fosse un dono di Dio e quindi non apprezzava gli inni latini cantati dal solo cantore con il suo coro. Nel corso della sua vita Lutero scrisse molti inni tedeschi e mise la messa luterana cantata ogni domenica, invece che una volta all'anno. Un'altra innovazione fondamentale fu l'accresciuto significato del sermone del pastore: la sua predica della Parola divenne per la prima volta la parte centrale della liturgia. Ai sermoni luterani, contrariamente a quelli cattolici romani, si attribuiva un effetto salvifico. Il compito del predicatore era di spiegare la Bibbia nella lingua del popolo. Il principio della libertà di predicare era implicito nella dottrina luterana circa il ruolo ed il carattere del sermone. 1.2. Il matrimonio Il nuovo diritto matrimoniale luterano era contenuto talvolta nelle più generali Kirchenordnungen e talvolta nelle ordinanze matrimoniali speciali (Eheordnungen), in cui la teologia luterana del matrimonio era esposta insieme con uno svolgimento sistematico del diritto matrimoniale. Il matrimonio luterano non era un sacramento, dal momento che
30
non si stimava dovesse essere a tutti gli effetti un simbolo della grazia divina e dell'appartenenza al regno dei cieli ma esso era essenzialmente uno stato esteriore, fisico e secolare. Se gli sposi tradivano, il matrimonio poteva esser sciolto, al contrario del credo cattolico. D'altra parte però, mentre il concetto cattolico romano del matrimonio poneva lo stato coniugale al di sotto del celibato ecclesiastico, il concetto luterano lo innalzava al livello di una vocazione sacra. Si richiedevano una cerimonia pubblica ed il consenso dei genitori al fine di contrarre un matrimonio valido. Era richiesta anche la presenza alle nozze di due buoni e onorevoli testimoni, nozze che dovevano essere solennizzate con una cerimonia ecclesiale e annotate nei registri della chiesa con le firme degli sposi, dei testimoni e di altre persone. Il diritto canonico romano riconosceva la validità dei matrimoni segreti così come di quelli more uxorio, ovvero di convivenza. Le cause matrimoniali andarono sempre più a finire nei concistori, ovvero i tribunali ecclesiastici protestanti, in composizione sia laica che clericale. 1.3. La legislazione scolastica Le numerose ordinanze scolastiche (Schulordnungen) presero la forma di proclamazioni teologiche da una parte, di esposizioni sistematiche di un particolare ramo del diritto dall'altra. Per capire l'importanza che l'istruzione aveva per i protestanti, ci si può affidare alle parole di Melantone: "La formazione migliore conduce ad una morale migliore, ed una morale migliore conduce ad una migliore comunità." Le principali differenze con li cattolici romani erano riposte nel credo luterano che tutte le persone dovevano essere istruite, e che stava principalmente nell'autorità politica, e non quella ecclesiastica, di assicurare l'istruzione pubblica universale. Lutero e i suoi compagni costruirono elaborati e dettagliati curricula per le scuole pubbliche, che furono incorporati in molte ordinanze scolastiche. Dovettero essere istituite scuole tanto in latino quanto in volgare. Nei principati luterani le scuole non erano soggette al controllo ecclesiastico centralizzato. Gli insegnanti non erano reclutati dalle autorità ecclesiastiche ma da quelle locali. La Bibbia costituiva l'oggetto principale dello studio. Non tutti i fanciulli, probabilmente la gran parte, riuscivano in ogni caso a frequentare la scuola, e per provvedere a tale problema furono istituite forme di assistenza finanziaria. Spesso questo processo é stato descritto come "secolarizzazione dell'istruzione", anche se é più giusto parlare di spiritualizzazione del ruolo delle autorità secolari ed in speciali modo del principe territoriale, che sotto il protestantesimo divenne la suprema fonte legislativa della scuola pubblica. Come padre del paese il principe era responsabile dell'educazione spirituale dei suoi soggetti. 1.4. La disciplina morale Le ordinanze disciplinari (Zuchtordnungen) furono promulgate dai consigli cittadini e dai principi luterani per fare rispettare la moralità ad opera delle autorità secolari. In questo caso la teologia luterana concordava con la teologia cattolica romana, ma differivano per quel che riguardava le risposte che dovevano essere date dalle autorità ecclesiastiche e civili. Secondo la teologia luterana, la conierà visibile doveva disciplinare il peccatore, ma solo al fine di punire e di indurre ad evitare i peccati nel regno terreno e non in vista della suprema riconciliazione con Dio. La sanzione ecclesiastica più severa che potesse essere imposta per la violazione della disciplina morale era il "piccolo bando", cioè l'esclusione dalla Cena del Signore. Era introdotta una netta distinzione tra il peccato (morale) e il reato (legale).
31
1.5. Le leggi per i poveri La Rivoluzione tedesca trasferì dal clero e dagli ordini monastici alle autorità secolari l'obbligo di principale di regolare, finanziare ed amministrare le attività caritative. La teologia luterana dell'assistenza ai poveri era diversa in tre aspetti dalla precedente teologia cattolica romana: 1. Essa poneva maggiore enfasi sulla responsabilità dell'intera comunità e una minore
enfasi sulla responsabilità delle autorità ecclesiastiche; 2. Attribuiva alle autorità politiche locali la prevalente responsabilità morale nello stabilire,
regolare e gestire l'assistenza ai poveri; 3. Era meno tollerante verso i peccati di avidità e pigrizia. Furono i teologi luterani di formazione giuridica a prendere l'iniziativa della redazione di molte leggi per i poveri (Armenordnungen). L'ordinanza redatta da Carlostadio per la città di Wittenberg era funzionale all'istituzione di una cassa comune della municipalità, in sostituzione delle preesistenti singole istituzioni caritative. La cassa comune inizialmente doveva essere finanziata in gran parte con le risorse acquisite dalla soppressione dei monasteri e delle altre passate istituzioni cattoliche romane. In seguito vi fu l'adozione di quote obbligatorie proporzionali allo status dei cittadini. A capo della struttura amministrativa c'era un'assemblea dei cittadini del luogo, che doveva riunirsi annualmente e provvedere all'elezione di di dieci direttori. Nella teoria di Lutero c'era una forte critica alla mendicità: non erano tutti i poveri, ma i "poveri meritevoli", coloro per i quali le nuove leggi sulla povertà erano progettate. Nb: manca l’ultimo paragrafo Nb2: nella Parte seconda mancano i capitoli settimo e nono
32
Parte seconda: La rivoluzione inglese e la trasformazione del diritto inglese nel diciassettesimo secolo Capitolo ottavo: la trasformazione della filosofia giuridica inglese Prima della Riforma protestante i libri di diritto scritti dai canonisti inglesi e dai romanisti inglesi riflettevano una filosofia giuridica che si distingueva a stento da quella dei canonisti e dei romanisti degli altri paesi europei. Nel XV secolo Fortescue pose le origini del diritto inglese nella consuetudine immemorabile, risalente fino all'età pre-romana. Egli celebrava nella ragione divina la fonte suprema del diritto ed il suo fine ultimo nel perseguimento del bene comune. Anche il nome di St. German é richiamato come uno dei fondatori del pensiero giuridico inglese, nonostante in fondo rimase entro la tradizione della filosofia giuridica europea del XVI secolo, quando essa iniziava a separarsi dalla precedente teologia romana cattolica e dal metodo scolastico. Fu il teologo anglicano e filosofo politico Richard Hooker che, negli anni '90 del XVI secolo, nella sua opera Of the Laws of Ecclesiastical Polity, gettò i fondamenti teologici e filosofici per quel che poi nel XVII secolo divenne un pensiero giuridico specificatamente inglese. Egli ebbe un'acuta premonizione che il conflitti che dividevano l'Inghilterra avrebbero portato ad un'acuta lotta civile. Per Hooker il diritto era fondato sulla ragione, sulla moralità e sulla naturale socievolezza dell'uomo; fino a quel punto egli aderiva alla classica teoria scolastica del diritto naturale. Ma egli affermava anche che il diritto si fino sulla volontà, sulla politica e sulla natura umana corrotta, che richiede, per il bene stesso della socievolezza, la sottomissione al comando di una autorità politica. Il governo é il risultato dell'inclinazione naturale dell'uomo alla socievolezza. 1. La teoria giuridica della monarchia assoluta: Giacomo I e Bodin Re Giacomo espose una filosofia organica delle relazioni reciproche tra diritto divino, diritto naturale e diritto positivo. In The Trew Law of Free Monarchies, scritto nel 1598, egli si contrapponeva frontalmente alla teoria secondo cui é la legge che fa il principe e non il principe a fare la legge, e in consistenza della quale il principe era sottoposto alla legge. La sua risposta era che Dio, come creatore dell'universo, stabilisce i monarchi per realizzare la sua volontà sulla terra. Così i re derivano il loro potere direttamente da Dio attraverso il contratto sociale con il loro popolo. É il sovrano a determinare che cosa é ragione e cosa essa richiede, e nei casi eccezionali il sovrano, così come Dio, può agire arbitrariamente, contro ragione. Questa teoria non era originale di re Giacomo, che derivava molte delle sue idee dall'influente pensatore politico e giurista francese cinquecentesco Jean Bodin, che aveva affermato che come in natura Dio governa l'universo come un monarca assoluto, così nella società umana la sovranità deve essere esercitata in ogni comunità politica territoriale da un monarca assoluto. L'opera maggiore di Bodin, la République, pubblicata nel 1576, era diretta in parte contro le dottrine della sovranità divisa, dei limiti giuridici dell'autorità monarchica e del diritto di resistenza contro i monarchi che sfidavano tali limiti. In particolare, Bodin attaccava la teoria ugonotta secondo la quale gli anziani o i magistrati dovrebbero rovesciare il monarca che perseguita gli aderenti alla vera fede. Anche Francis Bacon sostenne che il governo é qualcosa di naturale, e che come la natura richiede e produce il governo, così il governo richiede e produce il diritto.
33
Non si supponeva che il monarca assoluto fosse un despota, al contrario egli doveva governare con leggi giuste in quanto rappresentante di Dio. Ciò che lo rendeva assoluto era la sua mancanza di responsabilità verso nessun altro a parte che Dio. Anche in caso di tirannia, i sudditi non potevano ribellarsi, dato che ciò era evidentemente una punizione divina. Di fatto, Giacomo non fece altro che sottolineare in continuazione la coerenza delle sue teorie con la recedente prassi dei Tudor. 2. Sir Edward Coke, capo dell'opposizione leale a Sua Maestà Né Coke né i suoi alleati su opposero ai concetti teorici basilari e ai prìncipi di governo e di diritto che erano espressi da Giacomo I. Egli amava il common law e combatteva per esso contro coloro che avrebbero voluto ridurre la sua portata e la sua giurisdizione, comreso lo stesso re, ma non negò mai la veridicità delle loro premesse filosofiche. Egli era in realtà, fino in fondo, anglicano e monarchico. Per lui il re era il capo della chiesa e dello stato. Tuttavia, come chief justice dal 1606 al 1616 e poi come membro del Parlamento, Coke combatté ostinatamente per limitare le prerogative del potere regio e per assoggettarle al common law e al potere parlamentare. Per Coke le leggi del re comprendevano non solo le leggi del monarca regnante, ma anche le leggi dei suoi predecessori. Fu questa convinzione ad essere il pomo della discordia tra lui e il re. Difatti, quando il Parlamento si oppose nel 1621 alla politica del re verso la Spagna e la Chiesa cattolica romana e Giacomo proibì di occuparsene ulteriormente, Cole invocò i privilegi ereditati dal Parlamento nei regni precedenti. Per questo motivo Coke venne segregato per sette mesi nella Torre di Londra. In pratica Coke accettò la teoria del suo monarca e tuttavia fondò una nuova scuola di pensiero giuridico inglese diametralmente opposta ad essa. Coke aveva una concezione del common law inglese come l'incarnazione del ragionamento di molte generazioni di uomini di dottrina. Egli non dubitava dell'esistenza della ragione umana e del diritto naturale, così come definito dalla filosofia occidentale in generale, ma le giustapponeva un diverso tipo di ragione, che potrebbe essere chiamata ragione storica. Non si trattava di una ragione impiantata da Dio nella natura umana come tale, ma di una ragione frutto del ragionamento dei giuristi inglesi lungo i secoli. Egli sostenne inoltre che sia il diritto naturale che il diritto positivo erano incorporati nel common law. Coke fondò il primo principio di una historical jurisprudence, che poi fu sviluppato ulteriormente dai suoi seguaci dei secoli successivi. Il primo principio consisteva nell'affermazione che il diritto nazionale deve essere inteso soprattutto come il prodotto della storia di quella nazione. Da questo punto di vista, le fonti primarie del diritto sono la consuetudine e il precedente. Le altre fonti del diritto devono essere considerate alla luce dello sviluppo storico e alle circostanze storiche. 3. La filosofia giuridica di John Selden Selden fece fare allo storicismo di Coke un passo da gigante al di là della concezione di un passato remotissimo e di un immutabile diritto fondamentale, verso la concezione di un passato evolutivo e di un diritto fondamentale in evoluzione. Selden affermò la continuità ma sottolineo anche i cambiamenti del common law. La qualità del diritto di un popolo, secondo Selden, non era da ricercarsi nell'antichità dello stesso, ma nella sua capacità di rispondere ai bisogni di un particolare popolo. Le
34
consuetudini dei diversi popoli, benché radicate in una natura umana comune, sono soggette ad un continuo ed organico processo di cambiamento Selden non solo affermò Dio come la fonte del diritto civile, ma sviluppò anche la consapevolezza di dover adempiere alle obbligazioni noaiche. Per lui la regola più importante del diritto naturale appare essere ma regola che i contratti devono essere osservati, pacta sunt servanda. Ciò che nel pensiero di Selden fu più notevole fu il suo con etto storico ne sociologico che le legittime diversità fra i sistemi giuridici nazionali avevano la loro fonte nelle diverse consuetudini dei diversi popoli. La consuetudine era per lui la manifestazione del consenso dei popoli, ed affermò che ogni diritto ha origine nel diritto consuetudinario. 4. La vita e le opere di Sir Matthew Hale Fu Hale che per primo espresse una teoria generale del diritto su basi storiche, che era implicita nella rappresentazione del common law inglese data da Coke e negli studi di Selden. Tuttavia, Hale integrò la sua teoria storica con i due maggiori competitori, la teoria del diritto naturale e il positivismo giuridico. Hale credeva che non solo la continuità giuridica ma anche la continuità religiosa fosse vitale per l'identità civile. 5. La filosofia giuridica di Hale Hale tracciò i contorni di una terza grande teoria giuridica, la teoria storica, che due secoli più tardi doveva contendere il primato alla teoria del diritto naturale e alla teoria positivista, ma che Hale produsse in congiunzione con queste piuttosto che in opposizione. La teoria storica di Hale tratta del diritto parzialmente come la manifestazione di uno spirito storicamente in sviluppo, dello sviluppo degli ideali e delle tradizioni, dell'evoluzione del costume di un popolo a cui il diritto appartiene. In virtù della sua origine in questo spirito, il diritto impone limitazioni sia alla sovranità del potere legislativo, sia all'autorità della ragione e della coscienza. La filosofia giuridica di Hale può essere divisa in quattro teorie: 6. La dimensione storica del diritto naturale e del diritto positivo Hale riteneva che il diritto naturale, come il diritto positivo, costituisse un distinto corpo normativo, e che esso avesse un carattere vincolante per gli stati. Egli scrisse che ci sono molti delitti che sono tali per diritto naturale e che perciò sono universalmente sanzionati dal diritto penale. Tuttavia Hale limitò lo scopo tanto del diritto divino quanto del diritto naturale. Alcuni delitti prescritti dalla Bibbia erano adatti solo agli Israeliti e dunque non sono obbligatori per gli altri stati. Inoltre, la forma e la misura della punizione non sono determinate dalla legge di Dio ma dal diritto positivo. Queste leggi devono essere studiate e comprese nei termini del loro sviluppo storico. Il diritto naturale include prìncipi che sono comuni a tutti gli stati, mentre il diritto positivo é soggetto alla discrezione del legislatore. Hale teorizzò che il furto era giustamente punito con la pena di morte in Inghilterra, perché le circostanze e il numero di delitti lo richiedevano, studiando la dimensione contemporanea in cui va applicato il diritto. 6.1. Lo sviluppo storico di un sistema giuridico Hale concepiva la storia del common law inglese come un processo di adattamento a bisogni mutevoli. In una lunga prospettiva, egli vedeva tale adattamento come un processo di progressivo miglioramento e di auto-perfezionamento.
35
Fu la natura del mutamenti giuridico in Inghilterra, tuttavia, a far sì che la struttura costituzionale fondamentale del diritto rimanesse costante. La natura dello sviluppo storico del sistema giuridico inglese, secondo Hale, sta nel fatto chela costituzione stessa é creata dai successivi cambiamenti parziali, sperimentati nei secoli. 6.2. Il common law come ragione artificiale Hale accettò e sviluppò ulteriormente la concezione di Coke secondo cui il common law é esso stesso ragione artificiale, cioè che la sua logica interna consiste in un'esperienza ragionata degli avvocati, dei giudici e dei legislatori fatta nel corso di molti secoli. Hale parte con una definizione di Ragione, distinguendo due tipi di logica: da una parte la logica interna e d'altra parte l'umana facoltà di ragionare. Secondo Hale il più importante tipo di ragione é la combinazione di questi due generi di ragione. Dato che il diritto é il soggetto più difficile, poiché anche le persone più intelligenti possono trovarsi in disaccordo sul giusto e l'ingiusto, per evitare l'instabilità e l'arbitrarietà, le persone più sagge in rutti i tempi hanno concordato di istituire leggi particolari e particolari regole. Ci deve però essere un'elaborazione delle leggi al fine di soddisfare a circostanze straordinariamente diverse. Hale non applicava la ragione artificiale al solo common law, ma al diritto in generale; e non solo alla sua dimensione storica, ma anche politica. 6.3. La natura della sovranità Hale elenca le definizioni delle diverse forme di potere. C'è in primo luogo un potere coercitivo, poi un potere direttivo ed infine un potere invalidante. Poi elenca i sei poteri della sovranità: il potere di dichiarare guerra, il potere di dare valore e legittimità alla moneta del regno, il potere di concedere il perdono a persone che hanno commesso pubblici delitti, il potere di determinare la giurisdizione delle corti, il potere di fare leggi. Capitolo decimo: la trasformazione del diritto penale inglese Il diritto penale inglese subì senza dubbio cambiamenti notevoli nel XVI secolo e agli inizi del XVII. Prima della fine del XVII secolo non ci fu tuttavia un sistema onnicomprensivo che potesse essere chiamato "il" sistema inglese di diritto penale. 1. La coesistenza e competizione di diversi sistemi di diritto penale Pochissime tracce del diritto penale anglosassone sopravvissero alle riforme che seguirono all'indomani della Rivoluzione papale. I Normanni al potere in Inghilterra sostituirono il vecchio sistema di composizione della faida e della compensazione privata con un nuovo processo ordalico giudizialmente controllato. Con l'abolizione delle ordalie per decisione del IV Concilio Lateranense nel 1215, i re inglesi introdussero il processo con giuria per certi tipi di crimini violenti. I giudici reali inglesi itineranti convocavano le grandi giurie perché presentassero le persone sospette di aver commesso i cosiddetti reati maggiori durante il precedente periodo, e quindi convocavano le giurie più ristrette perché dichiarassero se le persone incriminate fossero colpevoli o innocenti. Non esisteva esibizione delle prove e la giuria era auto-informata. Il diritto penale sostanziale amministrato dai giudici reali attraverso le giurie locali consisteva di un limitato numero di tipi di delitti capitali. Anche i minori illeciti penali
36
potevano essere sottoposti alle giurie dai giudici regi, ma più spesso erano perseguiti dalle autorità locali. Anche le corti feudali acuì intervenivano il signore e i vassalli ebbero una giurisdizione penale sopra determinati tipi di illeciti e tutte seguirono un proprio tipo di procedura. Il sistema della giustizia penale amministrata dalle corti ecclesiastiche era superiore in importanza rispetto ai vari sistemi di giustizia penale secolare. Queste avevano almeno una giurisdizione concorrente sopra ogni genere di delitto commesso dai chierici e una giurisdizione esclusiva per una grande varietà di delitti commessi da laici. I sistemi della giustizia penale istituiti in Inghilterra nel XII e XIII secolo subirono una significativa evoluzione nei secoli XIV e XV. Guadagnarono importanza le corti urbane e mercantili. La giurisdizione penale delle corti regie andò gradualmente estendendosi e lentamente il sistema delle prove per certi tipi di testimonianza cominciò ad essere introdotto nei procedimenti cominciò ad essere introdotto nei procedimenti davanti sl grand jury e al petty jury. Col declino del feudo, una nuova classe di piccola aristocrazia terriera cominciò ad acquisire poteri di governo in sede locale. Il primo mutamento fu l'affermazione della supremazia regale sulla chiesa e l'istituzione di nuove corti regie con giurisdizione su molti tipi di materie che precedentemente erano state nella competenza delle corti ecclesiastiche e di altre corti. Delle nuove corti, il Conisglio Privato e la Court of High Commission ebbero la giurisdizione penale più ampia. Queste corti applicavano un diritto sostanziale e processuale differenti dal common law. Il Consiglio Privato dei Tudor era non solo il principale braccio esecutivo del re, ma anche un corpo giudiziario. Il Consiglio teneva spesso udienza in un'aula che aveva il cielo stellato, chiamata la Star Chamber, quando il Consiglio era in seduta come Court of Star Chamber, prendevano parte alla seduta anche il presidente del King's Bench e dei Common Pleas. Quando il re decideva d'interferire personalmente, la Star Chamber non poteva imporre sentenze. Le corti di common law, al contrario della Star Chamber, poteva imporre pene limitate, nei casi di crimini violenti. Fu agli inizi del diciassettesimo secolo la Star Chamber meritò la sua reputazione di strumento dell'oppressione politica ed ideologica. Le corti di common law erano interessate allo specifico atto criminale, mentre la Star Chamber si preoccupava dell'intenzionalità criminale. Solo dopo la fine del XVII secolo, con il trionfo del common law, molti nuovi settori del diritto penale furono recepiti sotto di esso. 2. Il trionfo delle corti di common law sulle loro rivali L'abolizione delle prerogative courts nel 1640 e il trasferimento di buona l'arte della giurisdizione penale alle corti di common law, ebbe conseguenze enormi per la sostanza del diritto penale inglese. Ciò significava che la persona doveva essere incriminata da un grand jury sulla base delle prove presentategli, e condannata da una giuria più ristretta, sotto la supervisione di una corte di common law. Alla dine del XVII secolo il Parlamento aggiunse, alla breve lista di reati maggiori, uno stuolo di altri reati ora prerogativa del common law e prima delle prerogative courts. Come reati maggiori, questi ora divennero crimini punibili con la morte, mentre altri reati minori erano sanzionati con multe ed imprigionamento. Il processo per i reati minori rimase largamente entro la competenza dei giudici di pace, ma il controllo della loro attività passò dalla Star Chamber al King's Bench in seduta itinerante.
37
La pubblica accusa era esercitata da privati o da organizzazioni di nuova istituzione, e normalmente l'accusato conduceva da sé la sua difesa. 3. L'effetto del trionfo della piccola aristocrazia terriera e dei mercanti agiati La Rivoluzione inglese dal 1640 al 1689 stabilì la supremazia del Parlamento sulla Corona e della piccola aristocrazia terriera e dei mercanti agiati sopra la nobiltà reale. Non sorprende perciò che una grande quantità di nuovi dei nuovi delitti capitali fosse volta a proteggere i diritti delle classi mercantili e dei proprietari terrieri. La più nota delle nuove leggi che imponevano la pena di morte per i delitti economici fu il Black Act del 1723, che pretendeva di essere un reato contro il gioco d'azzardo ma includeva in realtà un gran numero di altri reati. Alla vigilia della Restaurazione il controllo sulle terre forestali e sulla caccia passò dalla Corona alla piccola aristocrazia terriera. Il Black Act mise al bando i cacciatori di frodo ed introdusse molti tipi di crimini connessi alla proprietà terriera. Le disposizioni dell'atto, che spesso ignoravano la differenza tra tentato delitto e delitto effettivamente commesso, si applicavano anche ai correi e ai complici. Anche la classe mercantile agiata emergente fu beneficiaria della nuova legislazione penale. La pirateria fu oggetto di legislazione nell'anno 1700. Al fine di rendere celeri alcuni processi, bastava che si riunissero sette ufficiali della marina inglese e potevano applicare persino la pena di morte. Anche l'attività bancaria ricevette un'accresciuta tutela mediante una serie di leggi relative alla falsificazione, al furto e all'appropriazione indebita. 4. L'effetto del trionfo della teologia morale calvinista Agli inizi del XVII secolo ci fu il paradosso della straordinaria proliferazione di delitti capitali da una parte, e un sostanziale declino in percentuale delle incriminazioni che si concludevano con impiccagione dall'altra. Questo perché le corti preferivano assolvere o accorpare a reati minori piuttosto che adottare la pena capitale. La spiegazione che Douglas Hay dà di questo fenomeno é che i giudici tendevano ad essere membri della classe dominante della piccola aristocrazia terriera, che poteva esercitare il terrore o la clemenza, a seconda dell'impressione che volevano trasmettere alle classi inferiori. Molto é stato smentito da Langbein, che non condivideva la visione di Hay, ma che dal canto suo non dava una spiegazione al fenomeno. Potrebbe essere che le corti, quando si trattava di infliggere una pena capitale, volessero essere certe oltre ogni ragionevole dubbio. Nessuna spiegazione risolve però il paradosso, ma una chiave sta nella teologia morale calvinista. Quella teologia incoraggiava il massimo della severità nelle sanzioni penali come questione di diritto, unitamente però ad un alto grado di umanità e di coscienziosità nell'applicazione di quelle norme ai casi concreti. Il calvinismo, nella sua dorma inglese, accolse la distinzione luterana tra regole (inique) ed applicazione (secondo coscienza) delle regole, portati però al massimo. Questi contrastanti prìncipi erano connessi con tre dottrine calviniste: 4.1. La santità di vita e la salvezza per la fede Nella tradizionale teologia morale cattolica romana, ci si aspetta che solo l'élite spirituale della chiesa conformi la propria vita ai consigli di perfezione, mentre gli altri possono essere salvati mediante la confessione e la penitenza.
38
Sia Calvino che Lutero rifiutarono questa distinzione, credendo che tutti i credenti sono chiamati a condurre la santità di vita, immacolata dal peccato. Secondo la teologia calvinista tutti i peccati erano punibili con la condanna eterna nell'inferno, e per il ver credente tutti i peccati potevano essere perdonati per la grazia divina. 4.2. Peccati di premeditazione e peccati di debolezza La distinzione tra peccati di premeditazione e peccati di debolezza può aver giocato un ruolo importante nel motivare le decisioni delle giurie inglesi del XVIII secolo nelle cause per i reati maggiori, sia per condannare che per assolvere. Venivano tenuti da conto la giovinezza del detenuto, la debolezza, il buon carattere, la condotta precedente, la miseria della famiglia, le circostanze, la rispettabilità, le prospettive di ravvedimento. 4.3. La responsabilità della comunità per la repressione del peccato Dio ha imposto sulla comunità una responsabilità di assistere i singoli credenti nei loro sforzi per conseguire la virtù. Il comunitarismo fu l'aspetto dominante del sistema di valori prevalente nell'Inghilterra della fine del XVII e degli inizi del XVIII secolo. La giuria era considerata il rappresentate del giudizio collettivo della comunità. Col condannare il colpevole, la giuria adempiva alla responsabilità della comunità di reprimere e correggere il peccato. Con l'assolverlo, essa serviva a temperare quella responsabilità col suo giudizio, a seconda della natura e delle circostanze del peccato asserito. 5. L'impatto della teologia morale calvinista sul diritto penale 5.1. L'omicidio All'indomani della Rivoluzione inglese, il diritto giurisprudenziale relativo all'omicidio subì un considerevole cambiamento. Una chiara manifestazione di quel cambiamento fu l'introduzione della regola dell'omicidio volontario durante il compimento di altro resto (felony-murder rule) e della regola dell'omicidio colposo durante il compimento di un reato minore (misdemeanor-manslaughter rule). Anche questi sviluppi possono essere spiegati in parte con l'influenza della teologia morale calvinista. In base alla felony-murder rule, chi nel corso della commissione di un crimine violento causa la morte di una persona é responsabile di omicidio volontario, quand'anche la morte fosse del tutto imprevedibile. In base alla regola del misdemeanor-manslaughter rule, chi nel corso della commissione di un crimine minore causa la morte di una persona é responsabile di omicidio colposo, anche se la morte era imprevedibile. Sia l'atto del rubare che l'atto di uccidere erano violazioni della legge divina esposta nei Dieci comandamenti, e dunque in principio meritevole di morte. Prima del XVII secolo, la differenza tra omicidio volontario e omicidio colposo nel diritto inglese era stata basata sulla distinzione tra uccisione premeditata e uccisione imprevista, mentre dal XVII secolo in poi la premeditazione venne ad essere presunta. Dato l'elevato numero di reati di common law e l'adozione di regole che portavano molti ad essere accusati di omicidio volontario, fu necessario trovare un modo per distingue tra diversi tipi di omicidio. Fu introdotto ad esempio l'omicidio in stato di ira, che era ritenuto omicidio non intenzionale.
39
5.2. L'associazione a delinquere (conspiracy) La moderna dottrina inglese dell'associazione a delinquere nacque per la prima volta nelle decisioni della King's Bench all'inizio del XVIII secolo. La dottrina, unica nel suo genere, rende punibile il mero accordo di due i più persone per commettere un atto illegale o, i. Alternativa, un atto così immorale da diventare illegale quando sia posto in essere congiuntamente da due o più persone. Dato che era necessario un atto intenzionale in aggiunta alla nuda associazione a delinquere, il problema fu risolto con una finzione, che persiste fino ai nostri giorni: il fatto stesso che le persone si riuniscano e ne parlino é un atto intenzionale. 5.3. Le sanzioni penali La teologia calvinista e neo-calvinista ebbe una profonda influenza nella creazione di due nuovi tipi di sanzioni per i reati maggiori, vale a dire la deportazione e la detenzione. La detenzione per i reati maggiori fu introdotta nel 1706. La legge parlamentare non rese la reclusione un alternativa alla pena di morte, né la rese sostitutiva di questa. Piuttosto essa rese la detenzione in carcere una pena applicabile a ordine condannate per la Roma volta per i cosiddetti crimini suscettibili del beneficio del clero (clergyable felonies), cioè quei crimini per i quali la pena era stata prima limitata ad avere il pollice marchiato. Il Transportation Act del 1718 disponeva che i deportati fossero vincolati ai loro appaltatori, che dovevano assumersi il costo del trasporto ma che avevano il diritto di venderli. Sia la reclusione che la deportazione si scontavano in condizioni di lavoro duro, e senz subbio favorivano gli interessi dei mercanti e dei proprietari terrieri. Capitolo undicesimo: La trasformazione del diritto civile e del diritto dell'economia inglesi 1. La proprietà Nel diritto immobiliare, gli eventi chiave della fine del XVII e dell'inizio del XVIII secolo furono quattro: 1.1. L'abolizione della concessione fondiaria feudale (land tenure) Con le risoluzioni del 1641 e del 1645 il Lungo Parlamento abolì le preesistenti forme di concessione fondiaria della Corona ai suoi vassalli, e dopo la restaurazione della monarchia queste azioni furono confermate dal Tenures Abolition Act del 1660. L'effetto immediato di questa legislazione fu di privare la Corona del diritto di imporre unilateralmente certe forme di obblighi feudali ai concessionari della terra, che prima consisteva soprattutto nell'obbligo di prestazioni o servizi di carattere militare (knight-service e wardship), per poi tramutarsi, già dal XII secolo in poi, in un pagamento in denaro. Il Tenures Abolition Act ebbe l'effetto di assoggettare l'intero potere di tassazione della Corona alla volontà del Parlamento, ed inoltre trasformò la concessione vincolata ad un servizio in una concessione libera dall'obbligo di prestare servizi o di pagare un canone al un superiore. 1.2. L'eliminazione delle restrizioni alle chiusure dei fondi (enclosures) Assieme alla liberazione vista poc'anzi vi fu l'eliminazione delle restrizioni all'acquisto delle terre di uso comune degli abitanti dei villaggi, destinate principalmente al pascolo delle
40
pecore o all'allevamento del bestiame. Tali acquisti furono chiamati chiusure (enclosures) perché furono realizzati chiudendo le terre comuni con recinti, siepi e fossati. Nel sistema manoriale le chiusure non erano state frequenti. In tale sistema i contadini detenevano particelle fondiarie, di solito sparse in varie parti del territorio feudale, e i diritti e gli obblighi connessi a tali particelle avevano fondamento nella consuetudine feudale. Il graduale dissolverei delle relazioni signore-contadino cambiò il carattere delle concessioni manoriali. Nel XV secolo i contadini ricchi tendevano a comprare tali particelle dai contadini poveri, col risultato che furono scacciati dalla terra un gran numero di contadini. Quando le chiusure aumentarono di numero, a lamentarsi furono i contadini più poveri, parte della Corona e della nobiltà. La legislazione pose delle severe restrizioni al movimento delle recinzioni, che era diventato un fattore importante dell'ascesa della piccola aristocrazia terriera. Lentamente nel XVI secolo le chiusure furono legalizzate e si sviluppò la pratica di trasformare i possessi consuetudinari in concessioni in locazione. Il titolare della libera concessione dominante cui il possesso consuetudinario era subordinato, stipulava un accordo con il possessore consuetudinario (copyholder), per cui quest'ultimo avrebbe pagato una somma iniziale d'accesso e successivamente un canine annuo a lungo termine. L'affittuario a lungo termine non era più contadino ma fattore, i cui diritti di proprietà erano acquistati per contratto con il signore della terra. 1.3. Lo strict settlement Lo strict settlement era un mezzo con il quale i titolari di patrimoni fondiari potevano legittimamente assicurare intatta la successione della loro proprietà nella stessa famiglia per diverse generazioni. Coloro che facevano atto di donazione della terra ad altri spesso desideravano che l'ulteriore disposizione fosse ristretta in varie maniere, mentre il legatario o il donatario e i suoi successori desideravano altrimenti. Il diritto inglese venne incontro a questi problemi con una serie di regole. Determinate formule verbali nel legato o nella donazione potevano essere utilizzate per controllare l'ulteriore disposizione del fondo immobile in favore di particolari persone. • Esempio: A riceve in legato o donazione un bene immobile per la durata della vita, con
disposto che dopo la sua morte vada in proprietà di B e dei suoi figli. In questo caso A ha un life estate senza la facoltà di disporre liberamente del bene immobile, mentre B, nel caso in cui fosse vivo al momento della morte di A, potrebbe disporne liberamente.
• Esempio 2: A dona o lega il bene immobile a B, con la condizione che dopo la morte di quest'ultimo il bene passi al figlio che abbia compiuto i 21 anni d'età. B, prima che qualsiasi figlio compia i 21 anni, può disporre liberamente del bene, persino frustrando la volontà del donante. L'eventuale rimanenza, il contingent reminder, ovvero l'aspettativa di diritti sul bene del figlio, poteva essere distrutta. La ragione tecnica di questa regole é che se qualora B morisse prima che il figlio avesse compiuto 21 anni, allora nessuno avrebbe avuto i diritti di proprietà sulla terra, e ci si sarebbe trovati in abeyance of seisin.
La regola per cui una puramente ipotetica aspettativa di diritti dava al titolare di un usufrutto il pieno potere di alienare il bene immobile, minacciava d'impedire ai titolari dei grandi patrimoni fondiari di preservare quei patrimoni intatti per più di due generazioni. Il problema fu risolto da Sir Orlando Bridgman nel 1670, con l'invenzione dello strict settlement. In particolare, egli creò un trust da costituirsi tra F figlio e N nipote, con l'impegno dei trustees di preservare le eventuali aspettative di diritti sul bene immobile.
41
1.4. Lo sviluppo delle norme sul credito ipotecario Alla fine del XVII secolo, con la scomparsa definitiva di molte concessioni feudali e manoriali nella campagna, prese a svilupparsi un fiorente mercato anche nell'ambito dei fondi agricoli, compresi i patrimoni fondiari. Si rese necessario rispondere alla domanda fortemente accresciuta di rendere commerciabile la terra, e il modo forse più importante fu la distinzione fra due tipi di titolo: 1. Titolo equitable: poteva essere fatto valere solo in una corte di equity,
specificatamente la Cancelleria; 2. Titolo legale: applicabile solo in una corte di common law, specificatamente i Common
Pleas o il King's Bench. La creazione del titolo equitable implicò una trasformazione delle norme del trust, per cui la concessione della terra ad A in trust per B significava che entrambi diventavano proprietari della terra, ma proprietari a diverso titolo e con diritti ed obblighi diversi. b era il proprietario equitable mentre A era il proprietario legale. B aveva il diritto di possedere, usare e disporre della terra entro i limiti del trust, mentre A non doveva violare i diritti di B e i suoi creditori non potevano essere fatti valere in pregiudizio sulla terra. Servivano norme sul credito ipotecario per l'emergente mercato fondiario, e di conseguenza una nuova concezione della relazione del creditore ipotecario con la terra. Così l'ipotesi divenne semplicemente una garanzia per l'ammortamento di un debito. 2. Il contratto Il primo common law inglese aveva solo rimedi limitati per le controversie contrattuali, risolvendole principalmente tramite le azioni di debt, detinue, account, deceit, covenant e trespass on the case. Nessuna di queste era un'azione contrattuale in senso proprio, cioè un'azione per l'esecuzione dell'accordo in quanto tale. Nei casi in cui il common law non era in grado di decidere agevolmente, allora il cancelliere doveva basarsi sul diritto canonico, il diritto mercantile e sulla propria ingegnosità. Nel XVI e nel XVII secolo il diritto inglese applicabile ai contratti subì un significativo sviluppo. Le prerogative courts dei Tudor esercitarono una giurisdizione assai estesa, applicando la lex mercatoria alle cause commerciali. Le corti di common law cominciarono a riformare l'azione di assumpsit, rendendola disponibile non solo nei casi di danno causato da una condotta colpevole nell'adempimento, ma anche in determinati casi di mero inadempimento. Dal 1602 inoltre le corti di common law avevano elaborato anche la dottrina della consideration, per la quale la validità di un impegno era valutate nei termini delle circostanze che le avevano causate. Con la vittoria del common law sui suoi concorrenti, il vasto incremento nel numero e nella varietà delle cause commerciali davanti alle corti di common law richiese un'espansione e una revisione dei loro rimedi e delle loro dottrine. Ci fu un decisivo slittamento in alcuni dei presupposti fondamentali del diritto dei contratti che si era sviluppato nei cinque secoli precedenti: 1. La teoria fondamentale della responsabilità passò dalla rottura della promessa alla
rottura della contrattazione. L'accento fu posto sul carattere vincolante dell'accordo come tale e sulla delusione delle aspettative create dalla promessa. Le due promesse erano trattate come mutuamente interdipendenti;
2. La promessa di A e B é vincolante se essa é data in considerazione di alcuni vantaggi di A;
3. La base della responsabilità passo dalla responsabilità per colpa a quella assoluta
42
Si può dire che fu dal XVII secolo che nacque una teoria negoziale del contratto, basata sull'accordo delle volontà autonome delle parti. 3. Le società Quando Max Weber criticò il legame tra l'etica protestante e lo spirito del capitalismo, non tenne conto della nascita, all'epoca, della società per azioni. La società per azioni era un dispositivo per mettere insieme un gruppo di persone cospicue per costruire un'impresa d'affari a scopi filantropici da una parte, e un gran numero di azionisti per fornire i capitali dall'altra. Anche se queste costituirono attività imprenditoriali intese a produrre profitti per gli azionisti, allo stesso tempo l'impresa dipendeva dalla stretta collaborazione di molti uomini che la pensavano alla stessa maniera e che erano motivati da una comune causa. Un esempio importante fu nel 1694 la creazione della società per azioni chiamata Banca d'Inghilterra, al fine di finanziare la guerra del governo contro la Francia. 4. Le riforme del diritto dell'economia Le principali riforme al diritto dell'economia furono quattro: 4.1. L'attacco contro i monopoli Un aspetto importante del potere reale nel periodo dei Tudor e nel primo periodo degli Stuart era rappresentato dalla concessione di monopoli economici dalla Corona ai suoi favoriti. Alcuni di questi monopoli privati furono contestati in giudiziose nel 1624 la Corte dei Comuni promulgò lo Statute on Monopolies, che disponeva che tali ordinanze e regolamenti fossero approvati dal Parlamento prima che essi avessero effetto. Dopo la Gloriosa Rivoluzione le concessioni reali dei monopoli furono messe fuori legge per proteggere il tradizionale sistema di produzione e distribuzione di beni e servizi da parte delle varie corporazioni artigiane. I membri di ciascuno dei vari mestieri erano legati insieme in associazioni strettamente intrecciate che fissavano gli standard di qualità e i prezzi. 4.2. Nuovi metodi della finanza privata e pubblica I primi monarchi Stuart dovettero ricorrere a misure straordinarie per esigere danaro dai lori soggetti allo scopo di combattere le loro guerre, fatto che costituì una delle cause immediate della Rivoluzione del Parlamento. Con la Gloriosa Rivoluzione e l'ascesa al trono di Guglielmo e Maria, il Parlamento cominciò a progettare un nuovo sistema della finanza. Una fonte della finanza pubblica fu trovata attraverso l'istituzione della Banca d'Inghilterra come società per azioni, dalle cui risorse potevano esser tratti i prestiti alla Corona per finanziare le guerre in Inghilterra e sul continente europeo. Alla fine degli anni '80 del XVII secolo nacque il moderno mercato azionario, per cui le società poterono acquisire finanziamenti per il tramite della vendita di azioni trasferibili. Liste regolari di prezzi delle azioni vennero pubblicate nei periodi commerciali di Londra, e furono stampati contratti standard di compravendita. La trasformazione del sistema finanziario fu accompagnata dalla istituzione di nuovi metodi di tassazione e dall'introduzione di un debito pubblico. La Corona non viveva più principalmente in base alle risorse ereditarie della famiglia reale. I ricchi pagavano le tasse sui beni di lusso, i poveri stavano anch'essi le tasse virtualmente su ogni cosa che compravano.
43
4.3. Brevetti e copyright Le lettere patenti, usate nel XVI secolo per concedere monopoli di manifattura e di distribuzione di beni, vennero usate occasionalmente per concedere i diritti esclusivi di invenzione a un inventore. Lo Statute of Monopolies del 1624 ammetteva la concessione di lettere patenti, valida per 14 anni, al vero e primo inventore di nuove manifatture che procacciassero il vantaggio economico del reame. Fu solo dalla seconda metà del XVII secolo però che un brevetto venne pian piano ad essere visto come un diritto di proprietà legalmente riconosciuto all'inventore e non una semplice concessione. Lo stesso principio fu esteso agli autori delle opere letterarie e artistiche. Nel 1530 Enrico VIII concesse per la prima volta un copyright ad un autore. Nel 1649 il Parlamento promulgò una legge diretta alla protezione non degli autori in quanto tali, ma degli stampatori muniti di licenza contro la pirateria degli altri stampatori. Nel 1710 il Parlamento promulgò una legge che dava all'autore di un'opera il diritto esclusivo di pubblicazione per ventun anni. 4.4. L'assicurazione Nel secolo XVII si introdusse l'applicazione della matematica allo sviluppo di una scienza della previsione e del calcolo del rapporto tra rischio di perdita e costo dei premi di assicurazione. La moderna industria dell'assicurazione marittima nacque alla fine del XVII secolo a Londra. Le prime compagnie di assicurazione marittima, chiamate società di assicurazione, furono istituite agli inizi del XVIII secolo con privilegi reali, ma accanto ad esse operavano sottoscrittori privati. Molti altri tipi di assicurazione divennero disponibili nel corso del secolo XVIII. Capitolo dodicesimo: La trasformazione del diritto sociale inglese Così come nella Germania del XVI secolo, così nell'Inghilterra protestante dal XVI secolo al tempo della prima Riforma inglese fu istituita una chiesa di stato, cui tutti i sudditi inglesi erano tenuti ad appartenere per legge. Sotto i Tudor e i primi Stuart, la Chiesa d'Inghilterra fu governata da leggi regie che regolavano le materie che precedentemente erano state di competenza della Chiesa di Roma. I cambiamenti che vi furono sotto il profilo giuridico-spirituale sono analoghi a quelli che subì il diritto nella Germania protestante. Come in Germania, benché non nella stessa misura, la liturgia della chiesa anglicana diede maggiore possibilità di partecipazione all'ufficio divino. Il messale latino fu sostituito dal Libro della preghiera comune, scritto in inglese aulico. Fu anche incoraggiato il canto comunitario, e una predicazione ispirata venne a svolgere un ruolo centrale nel servizio religioso. La nuova liturgia inglese, come quella luterana, ridusse il numero dei sacramenti da sette a due: il battesimo e la Santa comunione. Il matrimonio non era più sacramento m una condizione sociale. In Inghilterra, come nei principati luterani, i reati contro la morale vennero ad essere identificati principalmente dalla legge piuttosto che dal diritto canonico cattolico romano. Tuttavia, al contrario dei luterani, lasciarono la giurisdizione sopra molti di tali reati alle corti ecclesiastiche. Vi furono anche riforme scolastiche analoghe a quella luterana, ma qui si richiedeva che gli insegnanti venissero scelti dal vescovo diocesano. Le leggi per l'assistenza ai poveri condannavano la mendicità e favorivano i poveri meritevoli, così come in Germania. Il compito di raccogliere le elemosine e le tasse per i poveri spettava però alla parrocchia locale.
44
La più alta autorità secolare inglese si affidò, molto più di quanto avvenne in Germania, ai vescovi e alle parrocchie locali nell'amministrazione del diritto spirituale. La prima Riforma inglese fu così una versione meno radicale del protestantesimo rispetto alla Riforma luterana della Germania. A meta del XVII secolo tuttavia, la seconda Riforma inglese si rivolse contro la concezione di una chiesa di stato monarchica alla quale tutti i sudditi inglesi erano tenuti ad appartenere. Il puritanesimo inglese prima penetrò alcuni settori della chiesa anglicana, quindi la rovesciò, e da ultimo servì a subordinarla al Parlamento e allo stesso tempo ad introdurre una politica di tolleranza per le cosiddette chiese dissenzienti. Dopo il 1689 la Chiesa anglicana non fu più una chiesa di stato; rimase la chiesa ufficiale, privilegiata e sostenuta dallo Stato, ma i sudditi inglesi divennero liberi di professare il culto presso altre chiese protestanti "tollerate". 1. La liturgia La Corona rimase il capo della chiesa d'Inghilterra; formalmente l'Atto di supremazia di Elisabetta I é in vigore fino ad oggi, nella misura in cui gli arcivescovi e i vescovi della Chiesa d'Inghilterra sono nominati dalla Corona e soggetti alla disciplina reale. Di fatto però, dopo il 1688, per consuetudine costituzionale la Corona deve semplicemente approvare coloro che vengono stabiliti dal primo ministro. La politica di non interferenza del Parlamento nella liturgia delle chiese permise alla Chiesa ufficiale d'Inghilterra di adottare una varietà di liturgie, che vennero ad essere definite come Chiesa Bassa e Chiesa Alta. Allo stesso tempo le chiese dissenzienti furono ampiamente esentate dalla rete di norme che regolavano il servizio divino e il credo. 2. Il matrimonio Il diritto matrimoniale inglese non si piegò così facilmente al sistema di valori protestante che stava alla base delle due Riforme d'Inghilterra. I regimi dei Tudor e degli Stuart accettarono la visione protestante secondo la quale il matrimonio non é un sacramento; essi però lo definirono "sacramentale" e preservarono la proibizione cattolica romana del pieno divorzio con il diritto di contrarre nuove nozze. I matrimoni clandestini continuarono ad essere legittimi in Inghilterra nel XVI secolo e agli inizi del XVII. In pratica il diritto matrimoniale durante la prima Riforma inglese rimase fondamentalmente lo stesso che era stato sotto il diritto canonico della Chiesa cattolica romana. Si dovrà attendere il Marriage Act di Lord Hardwicke del 1753 per far sì che i matrimoni dovessero essere notificati in anticipo con l'affissione di avvisi nella chiesa parrocchiale o nel vicinato dove i nubendi risiedevano, bandendo così i matrimoni clandestini. Inoltre, la convivenza more uxorio non costituiva più di per sé matrimonio. La legge prescriveva che tutti i matrimoni fossero celebrati nella Chiesa d'Inghilterra secondo il rito anglicano, alla presenza di un pastore e due testimoni. Il divorzio continuava ad essere concesso solo in casi straordinari, al contrario della separazione personale dei coniugi. Le questioni giuridiche rimasero di competenza delle corri ecclesiastiche anglicane. Solo con il Marriage Act del 1836 si ebbe cerimonia libera, obbligo di registrazione presso i registri governativi, possibilità di divorzio pieno per adulterio ed trasferimento alle corti civili della giurisdizione matrimoniale.
45
3. I reati morali La legislazione parlamentare durante la prima Riforma inglese riprodusse ampiamente la disciplina del diritto canonico della Chiesa cattolica romana precedentemente applicabile in Inghilterra e lasciò in ampia misura che fossero le corti ecclesiastiche a perseguire i reati e a punirli. Il Parlamento promulgò occasionalmente delle leggi che rendevano penalmente perseguibile uno o più di questi reati, sottraendoli perciò alla giurisdizione ecclesiastica. Nel 1641 il parlamento puritano abolì la giurisdizione penale delle corti ecclesiastiche. La Corte della High Commission, che era stata la suprema corte ecclesiastica, fu soppressa, così come la Star Chamber. Ora la Corte del King's Bench comincio ad avere giurisdizione come custos morum, come tutore della morale. Inoltre, il parlamenti della Restaurazione promulgarono anche delle leggi che davano ai giudici di pace e alle corti di common law la giurisdizione per infliggere sanzioni penali per i vari reati morali. Fu negli anni '90 del 1600 e nei primi anni del 1700 che il Parlamento cominciò gradualmente ma sistematicamente a sostituire la giurisdizione penale dei giudici di pace e delle corti di common law alla giurisdizione ecclesiastica in materia di reati morali. Nel 1737 il Parlamento impose per la prima volta un'organica normativa per la disciplina del teatro, affinché le rappresentazioni teatrali iniziassero ad venire incontro agli alti standard morali che il Parlamento, la Corona e una pletora di scrittori avevano proclamato. Negli anni '90 del XVII secolo nacquero delle associazioni volontarie in forma di Società per la riforma dei costumi, che svolsero un ruolo dominante nella rivoluzione morale del 1688. Queste associazioni, che crebbero mano a mano, si occupavano delle "maniere" delle loro comunità locali. Sia la chiesa che lo stato sostennero il movimento. Dei pronunciamenti reali della regina Maria e di re Guglielmo incoraggiarono gli operatori della giustizia ad unirsi a queste associazioni. Il carattere giuridico, benché non ufficiale, delle associazioni si rifletté drammaticamente nella pubblicazione di un pamphlet, nel 1700, intitolato A Help to a National Reformation, che esponeva le regole per la condotta appropriata degli informatori assunti dalle associazioni stesse. Le associazioni svolsero anche un ruolo importante nell'influenzare i magistrati e i legislatori a sostenere la causa della riforma morale, additando coloro che non prendessero apertamente parte nella loro causa. Le prove che abbiamo oggi però, dimostrano solo che le associazioni furono attive, e non che fossero efficaci. Le vicissitudini dei riformatori furono accompagnate dagli sforzi per irrobustire le forze dell'ordine ufficiali, con sorveglianti ed altre forme di vigilanza della sicurezza pubblica. 4. L'istruzione elementare. Le charity schools La Rivoluzione inglese portò nel periodo immediatamente successivo a radicali cambiamenti nel sistema inglese dell'istruzione elementare. Questi cambiamenti furono rivolti all'istituzione dei figli delle classi lavoratrici, e furono posti in essere per lo più da da associazioni volontarie di persone tratte dalla piccola nobiltà terriera, dal ceto mercantile e dagli artigiani e negozianti. Tutti dovevano conoscere e, se possibile, leggere la Bibbia, che fu tradotta in inglese. In Inghilterra nacquero le cosiddette grammar schools, che formavano i futuri dirigenti delle comunità non solo nella fede protestante ma anche nelle discipline classiche e negli studi umanistici. Nel XVI e nel XVII secolo le autorità secolari svolsero per la prima volta un ruolo dirigente nell'organizzazione dell'istruzione. Tuttavia la Chiesa d'Inghilterra svolse anch'essa un
46
ruolo importante: perché si potesse essere un insegnante in Inghilterra era necessaria l'autorizzazione del vescovo diocesano. Nel periodo Tudor-Stuart la chiesa fu in grado di esercitare un controllo pratico dell'istruzione del paese. La nuova classe di élite inglese, però, veniva istruita in una specie di dissidenza religiosa, con una forte convinzione della libertà di coscienza. Inoltre, i giovani giuristi delle Inns of Court imparavano che il common law era superiore alla Corona e alla chiesa. Negli anni '40 e '50 illustri scrittori puritani come John Dury sottolinearono che gli scopi della formazione erano due: 1. La formazione alla devozione; 2. La formazione all'utilità. I metodi dell'istruzione puritana erano molto restrittivi verso le fanciulle, che dovevano evitare tutto ciò che é effimero e dedicarsi esclusivamente ad imparare come divenire premurose mogli devote. Solo in caso di acuta intelligenza potevano seguire studi più seri. I ragazzi dovevano imparare tutto ciò che é utile, tramite una rigida e severa disciplina. Quel che i puritani cominciarono alla metà del XVII secolo, fu completato agli inizi del XVIII secolo non solo dal calvinismo ma anche dagli anglicani. L'accento sull'istruzione a tutte le classi fu perseguito mediante il riunirsi di persone animate da spirito pubblico nelle comunità locali, per formare associazioni volontarie allo scopo di istruire, mantenere e finanziar l'istruzione per i poveri. Le più importanti di tali associazioni furono le Societies for the Propagation of Christian Knowledge, SPCK, la prima delle quali fu fondata nel 1698 da cinque residenti di Londra. Essi fondarono le cosiddette charity schools per i figli delle classi lavoratrici. Le SPCK furono importanti non solo in ragione della loro profonda influenza sul contenuto dell'insegnamento elementare inglese per tutto il secolo successivo, ma anche per la loro interna struttura societaria e per il metodo di autogoverno. I membri versavano una quota annuale e godevano del diritto di voto nelle riunioni della società. Queste società operavano così su due prìncipi: 1. Il principio economico per cui la somma versata dai vari sottoscrittori, da sola
relativamente modesta, nell'insieme può essere usata per qualcosa di più produttivo; 2. Il principio giuridico per cui tali sottoscrittori possono perseguire i loro scopi dirigendo
effettivamente la società. Molte altre charity schools furono invece fondate da ricchi privati. Le SPCK furono inizialmente legate alla Chiesa d'Inghilterra, ma di fatto furono fin dall'origine strettamente collegate alle Società per la riforma dei costumi, ed erano quindi aperte anche alle chiese tollerate. • Aspetti discutibili: l'accento esagerato posto sulla disciplina. Ogni trasgressione era
severamente punita, anche con la spietata fustigazione. C'era la tendenza ad insegnare poco agli studenti in quanto appartenenti ad una classe inferiore, e il conseguente accento posto sull'apprendimento di un mestiere.
• Aspetti positivi: mitigazione della disciplina con un forte senso della responsabilità sociale. Ci furono scuole in cui la disciplina fu praticata senza brutalità da bravi insegnanti.
5. L'assistenza ai poveri Dal XII fino al XV secolo, in Inghilterra l'assistenza ai poveri fu presa in carico quasi esclusivamente dalle istituzioni ecclesiastiche cattoliche romane e fu finanziata quasi interamente con le imposte ecclesiastiche e con le contribuzioni volontarie. Nel XV secolo, con la grande migrazione dei contadini verso le città, il fardello dei poveri divenne troppo
47
pesante, e sempre più persone si dedicavano alla mendicità e alle ruberie, scatenando la reazione della legislazione penale a loro sfavore. Come in Germania, anche in Inghilterra l'abolizione della Chiesa cattolica romana fu l'occasione per l'istituzione di un nuovo sistema di assistenza ai poveri nella forma di "casse comuni", finanziate attraverso tasse municipali e contributi caritatevoli, e dirette ai poveri meritevoli. Dopo un periodo iniziale in cui l'amministrazione dell'assistenza ai poveri fu lasciata alla Chiesa d'Inghilterra, fu solo dopo la Rivoluzione dal 1640 al 1689 che tale responsabilità fu trasferita quasi interamente alle autorità civili. Una serie di leggi attribuì la responsabilità dell'assistenza ai poveri ai curati delle chiese parrocchiali, che al tempo era un'unità dia ecclesiastica che politica. Come unità ecclesiastica aveva a capo un prete che era assistito da coadiutori laici eletti tra i capifamiglia della parrocchia in un'assemblea annuale. Il principale esponente della parrocchia era il giudice di pace, nominato dalla Corona, che era quasi sempre il più grande proprietario terriero locale. Inoltre un connestabile, un sorvegliante delle strade pubbliche e un sovrintendente si poveri erano scelti di anno in anno tra i capifamiglia della parrocchia. Solo il prete era un ecclesiastico ed era l'unico pagato per il suo servizio. La Corona inglese aveva anche concepito di tenere a freni l'accattonaggio e il vagabondaggio mediante l'istituzione di case di correzione. In questo sistema l'ammontare del tributo per i poveri era inevitabilmente differente tra una parrocchia e l'altra, e ciò fece sì che molte persone iniziassero ad affollare le parrocchie meglio fornite. In conseguenza di questo fu approvata una serie di leggi chiamate Laws of Settlement, il cui scopo era quello di restringere la concessione di benefici entro una parrocchia a coloro che vi risiedevano da un dato lasso di tempo. Questo confinò molti bisognosi presso il territorio di una parrocchia per l'intera durata della loro vita. Inoltre, il diverso ammontare di denaro nelle varie parrocchie aveva un effetto deleterio sull'economia inglese nel suo complesso. I proprietari terrieri erano inoltre eccessivamente vessati dai tributi imposti dalla Corona per il mantenimento dei poveri e delle case correzionali, tutt'al più che spesso erano completamente inefficaci. Negli anni '40 del XVII secolo si volle passare dall'assistenza sociale all'assistenza al lavoro. Hartlib ed altri chiedevano la formazione di associazioni di cittadini autorevoli per istituire e dirigere case di lavoro ispirate ad imprese utili e produttive. Nel 1647 fu istituita la prima di queste associazioni, chiamata London Corporation of the Poor. Nella fase della Restaurazione queste case del lavoro furono preservate e servirono da modello. I sussidi erano negati alle persone abili che rifiutavano il lavoro, e in questi luoghi erano educati i loro figli. Il Workhouse Act del 1723 permise la creazione di case di lavoro uniche per diverse parrocchie. La parrocchia stessa, tuttavia, cambiò radicalmente nel corso della Rivoluzione e dopo di essa. Da un lato, la gerarchia ecclesiastica cessò di svolgere un ruolo ufficiale nella vita politica ed economica della parrocchia. Dall'altro, le convinzioni religiose continuarono ad essere di grande importanza nel determinare le scelte politiche ed economiche. Tra la fine del XVII secolo e il XVIII secolo, un ampio numero di donatori poté sottoscrivere congiuntamente il finanziamento di ospizi di vario genere. Una tale filantropia associata si modellò sull'esempio della società per azioni. Nel 1997 Christopher Hill ha definito il sistema di valori puritani come un'ideologia borghese e individualistica e la legislazione assistenziale dei secoli XVI e XVII come un mezzo col quale la nascente classe capitalistica dei mercanti e degli industriali sfruttò il
48
lavoro del sottoproletariato. Con ciò egli conduce a una conclusione radicale le vedute di molti. In realtà non era così. I capitalisti dell'epoca vedevano le nuove case di lavoro come una finte di concorrenza sleale, che faceva uso di lavoro a basso prezzo, sostenuto dal denaro dei contribuenti, per inondare il mercato di beni di qualità inferiore a basso prezzo. Coloro che istituirono il sistema inglese di assistenza ai poveri lo considerarono come: 1. Una risposta al volere di Dio; 2. Un atto di umanità comune; 3. Uno strumento di opportuna politica sociale. Matthew Hale distingue due generi di carità: l'assistenza verso i poveri impotenti e l'impiego dei poveri abili al lavoro.