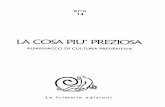Lo spazio come fonte di ispirazione nella musica del secondo Novecento
Spazio giuridico nell'agora e sull'acropoli: nota a IG I3 4, in A. Inglese (ed.), Epigrammata II....
Transcript of Spazio giuridico nell'agora e sull'acropoli: nota a IG I3 4, in A. Inglese (ed.), Epigrammata II....
EPIGRAMMATA 2 DEFINIRE, DESCRIVERE, PROTEGGERE LO SPAZIO
in ricordo di André Laronde
ATTI DEL CONVEGNO DI ROMA Roma, 26-27 ottobre 2012
a cura di
ALESSANDRA INGLESE
Edizioni TORED - 2013
Comitato scientifico: ALBIO CESARE CASSIO, FEDERICA CORDANO, CATHERINE DOBIAS-LALOU, ALESSANDRA INGLESE, EUGENIO LANZILOTTA, MARIA LETIZIA LAZZARINI, MARIO LOMBARDO, PAOLA SCHIRRIPA
Responsabile editoriale: EUGENIO LANZILLOTTA - ALESSANDRA INGLESE Responsabile grafica e stampa: AMERICO PASCUCCI Comitato di redazione: ALESSANDRA INGLESE - VALERIA FODERÀ ISBN 978-88-88617-64-0 © Copyright 2013 Edizioni TORED s.r.l. Vicolo Prassede, 29 00019 Tivoli (Roma) www.edizionitored.com e-mail: [email protected] – [email protected]
PRESENTAZIONE Il Convegno Epigrammata 2. Definire, descrivere, proteggere lo spa-
zio si è svolto a Roma il 26-27 ottobre 2012; oggi, a breve tempo, si pubblicano gli Atti che, come previsto dal progetto Epigrammata, si caratterizzano per una diversa tematica rispetto a quella del primo Convegno.
Questo nuovo volume, da una parte arricchisce notevolmente le prospettive di ricerca nello studio dell’Epigrafia greca, dall’altra con la sua veloce stampa conferma il progetto di ricerca che sta alla base degli incontri pensati da Alessandra Inglese, curatrice dei volumi, e dal Comitato scientifico.
Epigrammata infatti è un appuntamento biennale di Epigrafia greca, che riunisce studiosi dell’antico e si prefigge di valorizzare l’iscrizione greca in una prospettiva di tipo pluridisciplinare.
Questa seconda pubblicazione raccoglie studi di specialisti di di-scipline storico-epigrafiche ma anche archeologiche e filologiche, che si sono confrontati sul valore e la funzione dell’epigrafe in relazione allo spazio, inteso come spazio fisico e simbolico della relazione so-ciale, politico e cultuale nella città greca antica.
Le analisi che qui si propongono, sia attraverso un approccio teorico sia attraverso specifici casi di studio, sono tese ad evidenziare come le iscrizioni siano indicatori dei modi in cui l’uomo abbia abi-tato, definito e reso funzionale uno spazio e a far emergere il lessico o i formulari utilizzati in esse per descriverlo e organizzarlo, nonché le ragioni e le modalità in cui l’epigrafe abbia svolto una funzione di protezione, difesa e garanzia di aree o porzioni di esse.
EUGENIO LANZILLOTTA VIII
Il volume è in ricordo di André Laronde, illustre studioso fran-cese e profondo conoscitore della Libia antica. A questa terra da lui amata viene dedicata in modo particolare una sezione interna, mi ri-ferisco ai contributi di Catherine Dobias Lalou, di Mario Luni e di Alessandra Inglese.
André Laronde è stato per chi scrive un collega e amico di rife-rimento: mi è gradito ricordare che fu il primo Professore visitatore per la Storia antica dell’Università Tor Vergata nei primi anni della sua istituzione; fu invitato infatti nella primavera del 1988 dal Colle-ga compianto Lidio Gasperini e dal sottoscritto a tenere un semina-rio per presentare il suo volume Cyrène et la Libye hellénistique. «Li-bykai Historiai» de l’époque républicaine au principat d’Auguste (Paris 1987); successivamente è tornato a Tor Vergata anche in occasione del Seminario internazionale di studi Le Cicladi e il Mondo Egeo, svol-tosi a Roma il 19-21 novembre 1992. Da allora i rapporti sono con-tinuati nel tempo, segnati da profonda amicizia e stima e dall’interes-se comune degli studi sulla Libia.
Nel maggio del 2011 abbiamo a lui dedicato a Tor Vergata un seminario di Studi su Cirene, già programmato prima della sua im-provvisa scomparsa avvenuta nel febbraio del 2011, e che segnava una ripresa importante delle ricerche sulla Libia antica promosse dal nostro Dipartimento di Antichità e Tradizione classica.
Tre sono le fasi che hanno caratterizzato gli studi per Cirene e la Libia antica coltivati nell’ambito del Dipartimento: la prima è rap-presentata dalle ricerche di epigrafia greca condotte nel tempo da Lidio Gasperini che noi ora troviamo raccolti in Scritti di epigrafia gre-ca (Tored 2008) e nel volume collettaneo Cirene e la Ciranaica nell’antichità (Tored 2007); per la seconda fase su versante storiogra-fico, Gabriella Ottone ha pubblicato il primo volume della Collana “I Frammenti degli storici greci”, Libyka (Tored 2002), che costitui-sce un corpus delle testimonianze e dei frammenti delle opere in lin-gua greca sulla Libia e su Cirene. C’è infine una terza fase di studi e interessi sulla Libia che vede oggi Alessandra Inglese e Daniela Qua-drino come epigrafiste presso la Missione archeologica dell’Universi-
PRESENTAZIONE
IX
tà di Ubino a Cirene diretta da Mario Luni. La presenza di queste nostre due ricercatrici è un segno di continuità di studi, promossi dalla cattedra di Storia greca per l’area delle Cicladi, in particolar modo per Thera, e che hanno trovato uno sbocco naturale a Cirene.
Per la lunga amicizia con André Laronde, per la comunanza di interessi scientifici che abbiamo avuto modo di coltivare è sorto spontaneo dedicare a lui questo volume che ne continua e prolun-ga la memoria. Questa scelta è stata condivisa pienamente dal Co-mitato Scientifico, da Mario Luni e da Catherine Dobias Lalou, che ringrazio vivamente per avere composto il profilo dello Studio-so; insieme a Lei ringrazio anche J.J. Maffre per averci fornito la bi-bliografia completa.
Prima di chiudere questa mia presentazione, desidero esprimere un ringraziamento ai membri del Comitato Scientifico che hanno seguito con grande attenzione la preparazione e lo svolgimento del Convegno. E naturalmente un grazie particolare va ad Alessandra Inglese che sta curando con passione e competenza la realizzazione del progetto Epigrammata, di cui è responsabile e che già costituisce un riconosciuto ed importante appuntamento per gli studiosi di epi-grafia greca. Mentre licenziamo il volume è in organizzazione il III Convegno che si svolgerà nel prossimo mese di novembre presso la nostra Università e che avrà per oggetto una nuova interessante te-matica: Saper scrivere nel Mediterraneo antico. Esiti di scrittura fra VI e IV sec. a.C.
EUGENIO LANZILLOTTA
DONATELLA ERDAS
SPAZIO GIURIDICO NELL’AGORA E SULL’ACROPOLI: NOTA A IG I3 4
Pochi documenti hanno suscitato e continuano a suscitare un interesse tanto vivo negli studiosi quanto i “decreti dell’Hekatom-pedon”, pubblicati per la prima volta da Lolling nel 18901. Incisi su due metope originariamente provenienti da un arcaico tempio in po-ros dedicato ad Atena sull’acropoli di Atene2, i due decreti – in parti-colare il secondo – rivestono un ruolo centrale nella restituzione del-la topografia dell’acropoli tra l’età dei tiranni e l’incendio ad opera dei persiani del 480 a.C. Benché l’Hekatompedon menzionato nel secondo decreto alle ll. 10-11 e 18 della metopa B sia stato interpre-tato ora come edificio templare (ma di quale tempio si tratti è ancora oggetto di discussione), ora come un’area sacra dell’estensione di cento piedi3, e nonostante i due decreti incisi nelle metope presenti-
1 ÆEkatovmpedon. Sumbolai; eij~ th;n iJstorivan tw'n ejpi; th'~ ajkropovlew~ naw'n th'~ ÆAqhna'~, in «ÆAqhna'» II (1890), pp. 627-662; cfr. anche ID., in «AD» (1890), pp. 92-98.
2 Sul riuso di elementi architettonici di proprietà della divinità all’interno dell’acropoli cfr. ora le considerazioni di M.M. MILES, The Lapis Primus and the Older Parthenon, in «Hesperia» LXXX (2011), pp. 657-675, in part. p. 673.
3 Non è possibile dare conto qui dei numerosissimi e noti studi sull’argo-mento; mi limito a segnalare pertanto alcuni lavori più recenti a partire dal
DONATELLA ERDAS 276
no ampie lacune, almeno per il secondo documento si è certi che re-golasse lo svolgimento di alcune attività all’interno di un’area sacra posta sull’acropoli, punendo con multe di varia entità le trasgressioni alle norme imposte all’interno dell’area. La riscossione delle multe era affidata ai tamiai e al loro pritane4 sull’acropoli.
Grazie ai dati sulla sistemazione e la protezione di un’area sacra che se ne ricavano, il secondo decreto è stato da sempre oggetto di approfonditi studi storico-religiosi, che hanno indagato in particolar modo gli aspetti riguardanti l’amministrazione santuariale5, ma an-
contributo cruciale di M. KORRES, Die Athena-Tempel auf der Akropolis, in W. HOEPFNER (Hrsg.), Kult und Kultbauten auf den Akropolis. Internationales Symposion vom 7. bis 9. Juli 1995 in Berlin, Berlin 1997, pp. 218-243 (l’Hekatompedon dell’iscrizione farebbe riferimento a un tempio in poros databile alla fine del VI - inizi del V secolo mai terminato e immediatamente precedente il Prepartenone; una sintesi con scheda cronologica dei vari edifici è alle pp. 242-243); cfr. anche R. TÖLLE-KASTENBEIN, Das Hekatompedon auf der Athener Akropolis, in «JDAI» CVIII (1993), pp. 43-75; M. LIPKA, Anmerkungen zur Hekatompedon-Inschrift: eine Revision, in «ZPE» CXXII (1998), pp. 79-80; da ultimo A. SCHOLL, ANAQHMATA TWN ARCAIWN. Die Akropolisvotive aus dem 8. bis frühen 6. Jahrhundert v.Chr. und die Staatswerdung Athens, in «JDAI» CXXI (2006), pp. 30-36 (l’Hekatompedon corri-sponderebbe a un’area adibita a thesauros sull’acropoli). Per una sintesi delle diverse teorie a proposito dei santuari dedicati ad Atena sull’acropoli anche in relazione a IG I3 4 cfr. inoltre J.M. HURWIT, The Athenian Acropolis. History, Mythol-ogy, and Archeaology from the Neolithic Era to the Present, Cambridge 1998, pp. 111-112 e p. 341 ntt. 48-50 e, più di recente, B. HOLTZMANN, L’Acropole d’Athènes. Mo-numents, cultes et histoire du sanctuaire d’Athéna Polias, Paris 2003, pp. 85-88, con riferimenti bibliografici e storia degli studi.
4 Ciascuno dei tesorieri, a turno, aveva funzione di rappresentanza, non di presidenza, come il nome prytanis indurrebbe a ritenere. Cfr. quanto scrive in proposito R. DEVELIN, Prytany systems and eponyms for financial boards in Athens, in «Klio» LXVIII (1986), pp. 67-83; concordano H. Van Effenterre e F. Ruzè in Nomima I, p. 346.
5 Una lettura efficace delle attività praticate all’interno del santuario di cui si fa menzione nel secondo decreto è offerta da G. NÉMETH, MedÆ o[nqon ejgbalen. Regulations concerning everyday life in a Greek temenos, in R. HÄGG (ed.), Ancient Greek Cult and Practice from the Epigraphical Evidence. Proceedings of the Second International Seminar on Ancient Greek Cult, org. by the Swedish Institute at Athens, 22-24 November
SPAZIO GIURIDICO NELL’AGORA E SULL’ACROPOLI: NOTA A IG I3 4 277
che di contributi che si sono soffermati su aspetti giuridici rilevanti, come ad esempio il concetto di responsabilità soggettiva della colpa, di cui il nostro documento costituisce una precoce testimonianza, come ha mostrato a suo tempo G. Maddoli6.
A causa dell’estrema lacunosità, il primo decreto, che occupa le ll. 1-15 della metopa A, risulta invece assai meno indagato; di esso cercheremo di valutare alcuni aspetti sensibili, nel lessico e nei con-tenuti, per il diritto attico; partendo dalle scarse informazioni fornite dal testo proveremo quindi ad ipotizzare uno scenario giuridico coe-rente, anche in rapporto al secondo decreto.
In appendice è riprodotto il testo della metopa A, secondo
l’edizione di M.H. Jameson nelle IG I3, che presenta la migliore di-sposizione dei frammenti, cui si aggiungono due frammenti pubbli-cati di recente da A. Matthaiou7; qui la traduzione delle ll. 1-15, rela-tive al primo decreto:
(...) E se qualcuno (...) o presidio non (...) cinquanta dracme (...) la riscossione avvenga alla presenza dei tre arconti nell’agora senza il pagamento delle spese processuali; e delle
1991, Stockholm 1994, pp. 59-64 (ora in ID., Hekatompedon. Studies in Greek Epig-raphy, Debrecen1997 (“Hungarian Polis Studies”,1), pp. 21-30).
6 G. MADDOLI, Responsabilità e sanzione nei «decreta de Hecatompedo», in «MH» XXIV (1967), pp. 1-11. Sul tema della inconsapevolezza della colpa nella mentalità giuridica greca cfr. ora anche E.M. HARRIS, Antigone the Lawyer, or the Ambiguity of Nomos, in E.M. HARRIS - L. RUBINSTEIN (eds.), The Law and the Courts in Ancient Greece, London 2004, p. 44 (pp. 19-56, ora in E.M. HARRIS, Democracy and the Rule of Law in Classical Athens. Essays on Law, Society, and Politics, Cambridge 2006, pp. 41-80).
7 A.P. MATTHAIOU, Duvo neva qrauvsmata th'~ IG I3 4, in «Horos» XIV-XVI (2000-2003), pp. 19-22, grazie alla scoperta di due nuovi frammenti, ha ricostituito il testo delle ll. 11-14 e delle ll. 27-28, che sono state riconosciute come le ultime della metopa A, grazie alla presenza di segni decorativi. Ciò ha consentito di verificare che la disposizione dei frr. ad essi contigui f, g, e h, proposta da Hill e seguita dubitativamente da Jameson, era corretta (ibid., p. 21).
DONATELLA ERDAS 278
multe una metà sia pubblica e una metà (...) i tesorieri che si trovano nell’acropoli, avendo (...) e si giudichino gli schiavi come i liberi. Questo ha deciso il popolo sotto l’arcontato di Filocrate.
Il testo prescrive il pagamento di multe contro chi compia delle
violazioni o trasgressioni, la cui natura non è nota a causa dell’ampia lacuna tra l’ eja;n¼ dev t³i³~³ della l. 3 e il pe¼ntevkonta ⋮ d»ra¼cma;~ della l. 5. Sono poi descritte le modalità di riscossione. Segue infine la formula di sanzione e la data arcontale, con il nome dell’eponimo parzialmente in lacuna.
Ci soffermeremo solo rapidamente sulla cronologia del docu-mento, che può essere restituita grazie alla presenza della datazione arcontale non solo alle ll. 14-15 della metopa A, ma anche alle ll. 26-27 della metopa B, in entrambi i casi in chiusura dei due decreti e, purtroppo, in un contesto fortemente lacunoso. Si tratta della più antica datazione eponimica conservata su pietra in Attica, la prima in cui la menzione dell’arconte ha lo scopo di fornire un preciso e-lemento di cronologia8. Dopo lo studio recente di R. Stroud appare infatti ormai pienamente convincente una datazione al 485/4 a.C., grazie all’integrazione del nome di Philokrates9 proposta da Kirch-hoff, accolta da Wilhelm e che ha conosciuto da subito un largo consenso, pur con qualche significativa eccezione10.
8 Cfr. in proposito G. CAMASSA, La lontananza dei Greci, Roma 2004, p. 50:
l’altro documento quasi coevo in cui è presente una menzione dell’arcontato è l’ara di Pisistrato il Giovane (IG I3 948), in cui però la menzione dell’arcontato non ha l’intento di stabilire una cronologia ma di rendere pubblica la posizione preminente del dedicatario dell’ara. Cfr. anche ID., Tempo delle origini e misurazione del tempo, in «QS» LV (2002), pp. 55-65.
9 Attestato come arconte per il 485/4 a.C. nel Marmor Parium (FGrHist 239 A 50). Cfr. R. DEVELIN, Athenian Officials 684-321 B.C., Cambridge 1989, p. 57.
10 R.S. STROUD, A. Wilhelm and the Date of the Hekatompedon Decrees, in A.P. MATTHAIOU (epimel.), Attikai epigraphai: praktika symposiou eis mnemen Adolf Wilhelm (1864-1950), Athenai 2004, pp. 85-97, che offre una rassegna critica di tutte le altre proposte di cronologia (per una sintesi cfr. ora anche P. BUTZ, The Art
SPAZIO GIURIDICO NELL’AGORA E SULL’ACROPOLI: NOTA A IG I3 4 279
La restituzione del nome dell’arconte sembra infatti l’unica strada praticabile per una ricostruzione cronologica, dal momento che l’analisi del poscritto alla l. 14 come elemento datante (t³»au'ta de; e[docsen toi devmo¼i³) e alle ll. 26-27 del secondo decreto non è decisi-va, come è stato più volte osservato a partire da M. Guarducci11: un’analoga formula di sanzione è presente nel decreto per Salamina (IG I3 1, 510-500 a.C. ca.), ma la mancanza di ulteriori confronti non consente di classificare l’anomalia di una formula che include solo il demos e non anche la boule come indizio di arcaicità; ugual-mente deve dirsi del fatto che si tratti di un poscritto e non di un prescritto12. Altrettanto insidiosi si sono mostrati i tentativi di forni-re una ricostruzione cronologica fondata sulla forma delle lettere e sul confronto con iscrizioni attribuite al periodo che va dall’età dei Pisistratidi al 480 a.C. ca. I documenti più vicini dal punto di vista paleografico, infatti, non sono databili con precisione13 e anzi, talvol-
of the Hekatompedon Inscription and the Birth of the Stoikhedon Style, Leiden 2010, p. ix). Un dissenso deciso alla datazione proposta da Kirchhoff è stato espresso soprattutto da S. LURIA, Zur Geschichte der Präskripte in den Attischen Voreuklidischen Volkbeschlüssen, in «Hermes» LXII (1827), pp. 257-275 (i decreti sono precedenti alla riforma di Clistene e sono stati probabilmente ripubblicati intorno al 490 a.C.) e, in anni più recenti, da G. NÉMETH, Übersetzung und Datierung der Hekatom-pedon-Inschrift, in «JDAI» CVIII (1993), pp. 76-81, che propone una datazione al 499/8 o 498/7 a.C., combinando i dati paleografici e arcontali (non conosciamo il nome dell’arconte per questi due anni); ID., Hekatompedon-Probleme, in «ZPE» CI (1994), p. 217 (entrambi i contributi sono ora pubblicati in ID., Hekatompedon. Studies in Greek Epigraphy, Debrecen 1997 (“Hungarian Polis Studies”, 1), pp. 7-20); e da M. LIPKA, Anmerkungen zur Hekatompedon-Inschrift: eine Revision, in «ZPE» CXXII (1998), p. 79.
11 Note di epigrafia attica arcaica, in «ASAA» n.s. 3/5 (1941/1943), pp. 124-128. Guarducci, pur lasciando aperto il problema cronologico, sembrava tuttavia maggiormente propensa ad accogliere una datazione all’età dei Pisistratidi.
12 Cfr. in proposito B.D. MERITT, Notes on Attic Decrees, in «Hesperia» XXVIII (1941), p. 306 nota 11; P.J. RHODES, The Athenian Boule, Oxford 1971, pp. 64-65; A.S. HENRY, Prescripts of Athenian decrees, Leiden 1977, p. 2; A.G. WOODHEAD, Athenian Agora XVI, Inscriptions: the Decrees, Princeton 1997, p. 105.
13 All’ara di Pisistrato menzionata sopra, nt. 8 (522/1 a.C.), agli epigrammi
DONATELLA ERDAS 280
ta, le cronologie proposte poggiano in maniera circolare proprio sull’iscrizione dell’Hekatompedon.
Con l’arconte Philokrates ci troviamo dunque all’indomani del-
la riforma dell’arcontato ateniese che, come è noto, stabiliva il pas-saggio del sistema di accesso alla carica dall’elezione al sorteggio (ARIST., Ath. Pol. XXII 5). Questo rimane, accanto al primo impiego dell’ostracismo, pressoché l’unico accenno a questioni di politica in-terna ateniese per quegli anni, e non è necessario, credo, assegnare all’evento particolari influenze sul nostro documento14; per quanto concerne invece l’impegno ateniese con la Persia, è stato più volte ipotizzato che già a partire dai primi anni ’80 Temistocle avesse avvi-ato diverse misure di protezione contro una prevedibile offensiva persiana15. È tutt’altro che scontato, però, che a interventi del genere sia legato l’accenno a un presidio alla l. 4 del decreto, in un contesto
per i caduti di Maratona (IG I3 503-504, ca. 490/489 a.C.) e a pochi altri testi elencati da STROUD, A. Wilhelm and the Date, cit., pp. 90-92, si aggiunge anche IG I3 1477, come notava già L. JEFFERY, Local Scripts of Archaic Greece, rev. ed. by A.W. Johnston, Oxford 1990, pp. 299-300, uno dei documenti più vicini per scrittura all’iscrizione dell’Hekatompedon; si tratta di una lista di nomi (di caduti?) proveniente dalla lemnia Hephaestia, ora perduta, su cui cfr. da ultimo le osservazioni di D. MARCHIANDI, Riflessioni in merito allo statuto giuridico di Lemno del V secolo a.C. La ragnatela bibliografica e l’evidenza archeologica: un dialogo possibile?, in «ASAA» LXXXVI, s. III, 8 (2008), p. 16 nota 35 e di E. CULASSO GASTALDI, Cleruchie? Non cleruchie? Alcune riflessioni sugli insediamenti extraterritoriali di Atene, in R. SCUDERI - C. ZIZZA (a cura di), In ricordo di Dino Ambaglio. Atti del convegno (Università di Pavia, 9-10 dicembre 2009), Pavia 2011, pp. 125-128, che però propende per una datazione della lista all’età cimoniana.
14 In generale, sulla necessità di ridimensionare il valore che la storiografia moderna ha voluto attribuire alla riforma sul sistema di reclutamento degli arconti sotto l’arcontato di Telesinos nel 487/6 a.C. (ARIST., Ath. Pol. XXII 5) cfr. l’importante contributo di E. BADIAN, Archons and strategoi, in «Antichthon» V (1971), pp. 1-34.
15 Per un inquadramento generale della politica temistoclea in questi anni cfr. in part. M. OSTWALD, The reform of the Athenian state by Cleisthenes, in CAH2, IV, p. 342.
SPAZIO GIURIDICO NELL’AGORA E SULL’ACROPOLI: NOTA A IG I3 4 281
disperato dal punto di vista della ricostruzione del testo. Dopo l’edizione di Jameson nelle IG I3, che aveva tenuto conto delle resti-tuzioni di Hiller nelle IG I2 e degli appunti di Hill, su questa linea sono state fatte più di recente due proposte di lettura che vanno nel-la medesima direzione da parte di G. Németh16 e di P. Butz17. La menzione di una phroura, però, rimane oscura. I riferimenti che pos-sono essere chiamati in causa sono probabilmente i presidi men-zionati nell’Athenaion Politeia (ARIST., Ath. Pol. XXIV 3), presenti nei neoria e sull’acropoli. Il testo aristotelico si riferisce però agli anni che precedettero la nascita della lega delio-attica; è di conseguenza possibile che almeno le phrourai dei neoria siano state istituite succes-sivamente da Aristide18, mentre quelle dell’acropoli potrebbero esse-re state riallestite dopo il 480 a.C.19.
Per il momento ci sfugge dunque il tipo di violazione per la qua-le veniva prescritta la riscossione delle multe. Si conoscono invece l’entità della multa, 50 dracme, una cifra non molto alta (nel secon-do decreto dell’Hekatompedon sono previste anche multe di 100
16 Hekatompedon-Probleme, cit., p. 216 (con revisione autoptica dei frammenti).
La lettura della l. 4: ».......15......(ta; dhmovsia)ô e[¼r³ga³ ⋮ e] frora;n ⋮ m»e; ..¼ in luogo di »............25...........¼a³n³ ⋮ e] frora;n ⋮ m»e; ..¼ (IG I3 4), rimanda a un contesto sacrale; per la menzione di demosia erga Németh propone anche dei confronti.
17 P.A. BUTZ, The Art of the Hekatompedon Inscription and the Birth of the Stoi-khedon Style, Leiden 2010, pp. 161-162 (da leggere con la recensione di M.B. RICHARDSON, Rev. of BUTZ, The Art of the Hekatompedon Inscription and the Birth of the Stoikhedon Style, in «AJA» CXVI (2012), http://www.ajaonline.org), presenta una nuova edizione basata sulla revisione autoptica dei frammenti pubblicati in IG I3 4A, e dei nuovi frammenti editi da MATTHAIOU, Duvo neva qrauvsmata, cit., pp. 19-22.
18 Cfr. P.J. RHODES, A Commentary on the Aristotelian Athenaion Politeia, Ox-ford 1981, p. 304.
19 Ath. Pol. XXIV 3: ejn th'/ povlei frouroi; nV. Cfr. ancora RHODES, A Com-mentary, cit., p. 304. Nell’ultimo quarto del V secolo a.C. presidi ateniesi erano presenti in città all’interno delle mura, al Pireo e nelle città alleate (ibid., p. 304 ad Ath. Pol. XXX 2).
DONATELLA ERDAS 282
dracme: IG I3 4 B, ll. 16-17), e le autorità incaricate di riscuoterla: i tre arconti. L’integrazione del loro nome alla l. 6 appare infatti coe-rente con quanto resta nella pietra (ll. 6-8: pra'csin d»e; e\¼n³ai ⋮ p»ro;¼Ú~¼ t³o;~ tre»~ a[rconta~ to;~¼ ejn ajgora'i ⋮ a[n»eu p¼r³uta³»ne¼Úiv³on, ktl.)20. Un confronto molto vicino al decreto per il contesto giudi-ziario è costituito da un nomos che vieta l’estirpazione degli ulivi ad Atene, menzionato nell’orazione pseudodemostenica Contro Macar-tato ([DEM.] XLIII 71): ta;~ de; divka~ ei\nai peri; touvtwn pro;~ tou;~ a[rconta~, w|n e{kastoi dikastaiv eijsi. prutanei'a de; tiqevtw oJ diwvkwn tou' auJtou' mevrou~. o{tou dÆ a]n katagnwsqh'/, ejggrafovntwn oiJ a[rconte~, pro;~ ou}~ a]n h\/ hJ divkh, toi'~ pravktorsin, o} tw'/ dhmosivw/ givgnetai: ‹o} de; th'/ qew'/ givgnetaiÌ, toi'~ tamivai~ tw'n th'~ qeou'. Su altri aspetti rilevanti torneremo tra poco; ciò che interessa qui è la menzione degli arconti (non di uno specifico arconte, come abi-tualmente accade), che istruiscono la causa ciascuno secondo le pro-prie competenze, e che si occupano di trasmettere le multe ai prakto-res e ai tamiai della dea.
Nel decreto dell’Hekatompedon i tre arconti svolgono una fun-zione esecutiva, dal momento che hanno la funzione di esigere il pa-gamento di multe21, ed esercitano il loro incarico nell’ambito di una
20 Per il nesso, peraltro piuttosto comune, pro;~ tou;~ a[rconta~, cfr. e.g.
ARIST., Ath. Pol. LVI 6 (grafai; de; kai; divkai lagcavnontai pro;~ aujtovn, a}~ ajnakrivna~ eij~ to; dikasthvrion eijsavgei). Vd. anche ISAE. III 46 (kai; oujk »a]n¼ eijshvggeila~ pro;~ to;n a[rconta kakou'sqai th;n ejpivklhron) e 47 (ou[te ga;r ejpitivmion tai'~ pro;~ to;n a[rconta eijsaggelivai~ e[pestin, oujde; eja;n mhdemivan tw'n yhvfwn oiJ eijsaggeivlante~ metalavbwsin, ou[te prutanei'a ou[te paravstasi~ oujdemiva tivqetai tw'n eijsaggeliw'n) e passim. In generale il costrutto è diffusissimo dell’oratoria attica (soprattutto in Isocrate e Demostene). Cfr. anche PLATO, Leg. 764a 1: oJ de; mh; Æqevlwn, eja;n eijsaggelqh'/ pro;~ tou;~ a[rconta~, zhmiouvsqw penthvkonta dracmai'~ pro;~ tw'/ kako;~ ei\nai dokei'n, e Leg. 907e 2 (Platone si riferisce al rifiuto di votare gli agoranomi, che può essere denunciato ai magistrati ed essere da loro multato con 50 dracme).
21 Sul ruolo tutt’altro che secondario delle magistrature ateniesi nel far rispettare e nell’applicare la legge cfr. ora E.M. HARRIS, Who enforced the Law in Classical Athens?, in Symposion 2005: Vorträge zur griechischen und hellenistischen
SPAZIO GIURIDICO NELL’AGORA E SULL’ACROPOLI: NOTA A IG I3 4 283
causa pubblica. Che si tratti di un’attività esecutiva è chiaramente espresso dall’uso di pra'csin alla l. 622. Non conoscendo la violazione per la quale gli arconti vengono chiamati a riscuotere il denaro, e soprattutto non sapendo quali fossero i soggetti passibili di multa, non siamo nelle condizioni di comprendere per quale ragione si ri-corresse contemporaneamente alle tre principali magistrature23; non è chiaro poi se l’attività processuale vera e propria venisse seguita di-rettamente da loro o dai tesmoteti. La presenza di un processo è in-fatti evocata dalla specifica sulle spese processuali: nel decreto viene stabilito che le multe vengano riscosse alla presenza degli arconti nell’agora, senza effettuare il pagamento dei prytaneia. Questi costi-tuiscono un tipo di spesa processuale attestata a partire dal V secolo a.C., che prende il nome dal Pritaneo, edificio arcaico sede degli ar-conti ad Atene24. Le non molte occorrenze del termine in questa ac-cezione, di cui il decreto dell’Hekatompedon costituisce la più antica testimonianza, mostrano che essi venivano versati da entrambe le
Rechtsgeschichte (Salerno, 14.-18. September 2005) = Comunicazioni sul diritto greco ed ellenistico (Salerno, 14-18 Settembre 2005), Wien 2007, pp. 159-176, in risposta alle tesi di V.J. HUNTER, Policing Athens. Social Control in the Attic Lawsuits, 420-320 B.C., Princeton N.J. 1994 e di M. BEHRENT, Anthropology and the Classics: War, Vio-lence, and the Stateless Polis, in «CQ» L (2000), pp. 257-289.
22 Benché il senso della clausola non cambi nella sostanza, vale forse la pena di prendere nuovamente in considerazione la proposta di Hiller, poi respinta da Hill, di leggere nella pietra e[sá⋮âpracsin (‘riscossione’), come lascia intendere lo stesso Jameson in apparato a IG I3 4 (l. 6: »....¼a~ ⋮ ú»......13.....¼e~ ⋮ pra'csin d»e; e\¼n³ai ⋮ p»ro;¼-). L’unico ostacolo ad una lettura e[spracsin è costituito dal tricolon collocato all’interno della parola; potrebbe però trattarsi di un errore del lapicida: uno analogo si trova alla l. 17 della metopa A (k¼a³qekovsá⋮âa»~ (cfr. Jameson in apparato a IG I3 4). Il termine indica inequivocabilmente una riscossione di denaro e non l’intraprendere di una causa processuale. Per un’interpretazione nel senso di “azione legale” vd. Nomima I, n. 96, p. 342.
23 La presenza del polemarco potrebbe essere giustificata dal fatto che anche gli schiavi, come i liberi, erano tenuti al pagamento delle multe, anziché essere frustati, come di norma viene prescritto in documenti analoghi (cfr. infra).
24 Cfr. J.H. LIPSIUS, Das Attische Recht und Rechtsverfahren, I, Leipzig 1905, pp. 24-25; sui prytaneia vd. anche p. 246.
DONATELLA ERDAS 284
parti prima dei processi, e che la parte soccombente era tenuta a rimborsare le spese all’altra parte, mentre il denaro ricavato veniva utilizzato per lo stipendio dei dikastai25. Polluce (VIII 38) specifica inoltre che il limite minimo per il versamento dei prytaneia era costi-tuito da cause del valore di 100 dracme26.
Se una regolamentazione del genere era già in uso agli inizi del V secolo, questa è senz’altro una delle ragioni per cui nel decreto dell’Hekatompedon viene specificato che le spese processuali non devono essere pagate (come abbiamo visto la multa che viene com-minata nel decreto è di 50 dracme). Un’altra motivazione che rende superfluo il pagamento dei prytaneia è il fatto che la causa cui fa rife-rimento IG I3 4 fa parte delle cause pubbliche, per le quali di norma non è previsto il versamento delle spese processuali (l’unica eccezio-ne è per il momento costituita dal già citato nomos della Contro Ma-cartato, 71)27. Alcuni esempi epigrafici ateniesi attestano, a partire dalla metà del V secolo a.C., che le spese processuali non dovevano essere sempre pagate, in particolare nelle clausole dei decreti onorari che punivano eventuali ingiustizie compiute nei confronti dell’onorando; trattandosi in questi casi di individui non ateniesi la causa era di competenza del polemarco28.
25 Sul versamento dei prytaneia in favore della paga dei giudici cfr. [XEN.],
Ath. Pol. I 16, e POLL. VIII 38. Sui prytaneia in generale cfr. A.R.W. HARRISON, Il diritto ad Atene, II. La procedura, ed. it. a cura di P. COBETTO GHIGGIA, Alessandria 2001 (ed. or. Oxford 1971), pp. 92-94, 179-80; D.M. MACDOWELL, The Law in Classical Athens, London 1978, p. 239; cfr. ID., Wasps, Aristophanes, Oxford 1971, pp. 220-221.
26 Cfr. ancora HARRISON, Il diritto ad Atene, cit., p. 91 nota 105. 27 Normalmente le spese processuali erano versate nelle cause tra privati, cfr.
ad es. la causa intentata a Strepsiade per non aver pagato i suoi debiti in AR., Nub. 1180 e 1191, 1197. Vd. anche AR., Vesp. 659.
28 Cfr. e.g. IG I3 24, l. 8 (decreto onorario, 450 a.C. ca.); IG I3 55, fr. b, l. 3 (decreto onorario, 431 a.C. ca.); 91, fr. c-e, l. 11 (decreto onorario per Proxenides di Knidos; la data canonica del 416/5 a.C. va alzata al 422/1 a.C. per via della presenza del grammateus Archikles: cfr. A.G. WOODHEAD, The Athenian Agora XVI, cit., n. 20, p. 30 con indicazioni bibliografiche). Vd. anche HSCH., a 4995, s.v.
SPAZIO GIURIDICO NELL’AGORA E SULL’ACROPOLI: NOTA A IG I3 4 285
L’insieme dei dati ricavati fin qui – il pagamento di una multa di entità non eccessiva, la riscossione alla presenza di magistrati in un luogo pubblico (nel nostro caso l’agora) – cui si aggiungono le modalità di divisione del ricavato delle multe e la clausola riguardan-te liberi e schiavi29, ritorna in alcuni decreti riguardanti in generale il danneggiamento di aree di culto e luoghi pubblici ad Atene e nel re-sto della Grecia. Vale la pena di soffermarvisi per avere un’idea del tipo di procedura che veniva applicata, anche se i dati che se ne rica-vano non possono risolvere definitivamente l’incertezza sul tipo di violazione che costituiva il soggetto del primo decreto dell’Hekatom-pedon, tenendo anche conto della distanza cronologica che separa questi documenti dal 485/a a.C.
I confronti più vicini riguardano il taglio di alberi e piante in aree di culto (temene, boschi sacri, ecc.), dato in comune ancora una volta con la legge menzionata nell’orazione pseudodemostenica Con-tro Macartato, 71, mentre altri documenti dalla struttura analoga re-golano la pulizia di aree pubbliche o sacre.
L’esempio più antico, proveniente dall’Attica, è IG II2 1362 (LSCG 37, IV secolo a.C.), decreto di un demo che contiene un re-golamento relativo alla protezione degli alberi nel santuario di Apol-lo Erithaseus: lo hiereus e il demarco sono incaricati di riscuotere la multa, di cinquanta dracme, che viene pagata dai cittadini liberi che commettono l’infrazione; inoltre il loro nome viene consegnato al basileus e alla boule “secondo il decreto della boule e del demos degli Ateniesi”; gli schiavi invece devono subire cinquanta frustate e de-vono essere consegnati, insieme al nominativo del loro padrone, al basileus e alla boule, anche qui seguendo quanto disposto per decre-to30.
a[neu prutaneivwn: divkai tinev~, ai} divca tou' teqh'nai prutanei'a ejkrivnonto.
29 Va segnalato che dou'lo~ è frutto di integrazione (ll. 13-14: k³ai; ton³ »douvlon katadikavzen ka¼q³avper Ú »ton ej¼l³eu»qev¼ron); a questo proposito R. KOERNER, Gese-tzestexte, n. 4, pp. 8-9 invitava alla cautela; la restituzione del testo che è stata proposta appare tuttavia plausibile.
30 IG II2 1362, ll. 7-18: a]n dev ti~ lhfqei' »k¼Úovptwn h] fevrwn ti tw'n
DONATELLA ERDAS 286
Nel noto regolamento sui misteri di Andania (IG V 1, 1390, del 92/91 a.C.), alle linee 78-80 si dispone, riguardo al taglio di alberi nell’area del santuario, che l’entità delle punizioni, pecuniarie per i liberi e fisiche per gli schiavi, siano affidate ai sacerdoti, e che la me-tà dei proventi delle multe vada a chi conduce il trasgressore davanti ai sacerdoti.
In IG IX 2, 1109 (LSCG 84, 100 a.C.), decreto che regola la pro-tezione di un boschetto intorno al santuario di Apollo Koropeus, in Tessaglia31, oltre al pagamento di una multa per i liberi e alla fustiga-zione più il pagamento di una piccola ammenda per gli schiavi, viene stabilito che i tamiai riscuotano le multe per la città e che la metà di esse vada sul momento (paracrh'ma) a chi ha denunciato la violazio-ne, come prescritto nel regolamento dei misteri di Andania.
In generale, altre leggi o decreti riguardanti il rispetto di aree sa-cre prescrivono lo stesso genere di multe per liberi e schiavi e la di-stribuzione dei proventi tra lo stato (e/o il santuario) e colui che ef-fettua la denuncia (cfr. ad es. SEG XXIII 498, decreto che contiene alcune prescrizioni relative alla tenuta in pulizia del santuario di Dioniso e Latona a Delo, della fine del III secolo a.C.).
I documenti che abbiamo considerato ci consentono per il mo-mento di prospettare, solo a titolo di ipotesi, che anche il decreto
aj»p¼eirhmevnwn ejk tou' »iJ¼Úerou', a]n me;n dou'lo~ ei\ oJ lh»f¼qeiv~, mastigwv»s¼Úetai penthvkonta plhga;~ kai; paradwvsei »a¼Úujto;n kai; tou' despovtou tou[noma oJ iJereu;~ »t¼Úw'i basilei' kai; tei' boulei' kata; to; yhvfis»m¼Úa th'~ boulh'~ kai; tou' dhvmou tou' ÆAqhnaivwn: vacat Ú a]n de; ejleuvqero~ ei\, qw³avsei aujto;n oJ iJereu;»~¼ Ú meta; tou' dhmavrcou penthvkonta dracmai'~ vacat Ú kai; paradwvsei tou[noma aujtou' tw'i basil»ei'¼ Ú kai; tei' boulei' kata; to; yhvfisma th'~ bou»l¼Úh'~ kai; tou' dhvmou tou' ÆAqhnaivwn vacat.
31 A proposito del trattamento degli schiavi in questo documento e nel decreto relativo al santuario di Apollo Erithaseus cfr. ora I. ARNAOUTOGLOU, The Fear of Slaves in ancient Greek Legal Texts, in A. SERGHIDOU (ed.), Fear of Slaves - Fear of Enslavement in the ancient Mediterranean. Peur de l’esclave - Peur de l’esclavage en Me-diterranee ancienne (Discours, représentations, pratiques). Actes di XXIXe Colloque du Groupe International de Recherche sur l’Esclavage dans l’Antiquité (GIREA) (Re-thymnon, 4-7 November 2004), Franche-Comté 2007, p. 141.
SPAZIO GIURIDICO NELL’AGORA E SULL’ACROPOLI: NOTA A IG I3 4 287
della metopa A avesse come soggetto la violazione di alcune aree del-la polis, tenuto conto anche del genere di regolamentazioni presenti nel decreto della metopa B, a loro volta relative alla protezione e alla pulizia di un’area sacra cittadina (in questo caso l’acropoli). I due de-creti infatti sono concepiti come un insieme coerente, come appare dalla clausola di pubblicazione alle ll. 26-27 del secondo decreto (tau'tÆ e[docsen ⋮ toi dev»moi ej¼p³i; F»ilokravto~ a[rcont¼Úo~ ⋮ ta; ejn toi'n livqoi»n touvt¼oin)32. Il confronto con le modalità di riscossione delle multe negli altri testi riguardanti la violazione di luoghi sacri e lo spazio giuridicamente rilevante riservato ai delatori potrebbe inol-tre aiutare la comprensione delle ll. 8-9 del nostro decreto, ipotiz-zando che la metà dei proventi della multa comminata sia assegnata a chi denuncia la violazione.
Un ultimo aspetto che merita di essere considerato riguarda il
diverso luogo di riscossione delle multe nei due decreti dell’Heka-tompedon. Nel primo decreto, come abbiamo visto, la riscossione della multa avviene davanti agli arconti nell’agora (l. 733), la cui men-zione va senz’altro riferita allo spazio fisico34 – lo mostra la struttura
32 Sulle clausole di pubblicazione nelle iscrizioni (leggi e decreti) di età arcaica
e altoclassica cfr. K.J. HÖLKESKAMP, (In-)schrift und Monument. Zum Begriff des Geset- zes im archaischen und klassischen Griechenland, in «ZPE» CXXXII (2005), p. 88 con nt. 94.
33 Nell’edizione di Hiller in IG I2 3/4, dove i frammenti erano disposti diversamente rispetto al testo delle IG I3, l’ajgorav compariva, integrata, anche alla l. 18: »ton t¼a³mion »par¼en»ai¼ e{na⋮ ejn te»i ajgorai tei ejn p¼ovlei: ta;- (cfr. l. 16 di IG I3 4 A).
34 L’agora del Ceramico. Per la discussione ancora aperta sui tempi e i modi del passaggio dalla cd. archaia agora, posta a SW dell’acropoli, all’agora del Ceramico a partire da Judeich (W. JUDEICH, Topographie von Athen, München 1931) si rimanda qui alle sintesi recenti (differenti per prospettiva) di R. OS-
BORNE, Did democracy transform Athenian space?, in R. WESTGATE - N.R.E. FISHER - J. WHITLEY (eds.), Building Communities: house, settlement and society in the Aegean and beyond, Proceedings of a conference held at Cardiff University, 17-21 April 2001, Oxford 2007, pp. 196-197 e di F. LONGO, La definizione di un nuovo spazio
DONATELLA ERDAS 288
stessa della frase – e non va letta come un riferimento all’assemblea, come è stato proposto35. Nel secondo decreto dell’Hekatompedon, invece, le multe comminate sono riscosse dai tamiai e dal loro prita-ne direttamente sull’acropoli (metopa B, ll. 11-13: eja;n¼ d³ev³ ti~ ⋮ touvtoÚn ti dra'»i eijdo;~ ej¼c³s»e¼nai ⋮ qoa'n³ »mev¼c³ri trion ⋮ ojbeloÚn ⋮ toi'si tam³»ivasi⋮⋮⋮ta;~¼ h³iereva»~¼ t³a;~ ejm povlei; ll. 21-23: ho;~ dÆ a]n leiv¼pei ⋮ dunÚ»ato;~ o]n ajpotivne¼n ⋮ duvo dracm»a; e{kaston· ejspr¼avtteÚ»n de; to;(m) p¼ruv»tanin).
Lo svolgimento di pratiche giudiziarie tanto nell’agora quanto sull’acropoli non desta alcuna sorpresa, rappresentando tanto l’agora quanto gli spazi sacri i luoghi della legalità par excellence, già a partire dalle leggi di Draconte36; ne è una esemplificazione particolarmente indicativa la procedura di stanziamento degli arconti come ci viene raccontata nell’aristotelica Athenaion Politeia (LV 5): dopo il giura-mento nell’agora sulla pietra i magistrati devono salire sull’acropoli e
pubblico: l’agora del Ceramico dalla ‘nascita’ alla spedizione in Sicilia, in E. GRECO - M. LOMBARDO (a cura di), Atene e l’Occidente: i grandi temi. Le premesse, i protagonisti, le forme della comunicazione e dell’interazione, i modi dell’intervento ateniese in Occidente. Atti del Convegno Internazionale (Atene, 25-27 maggio 2006), Atene, 2007, pp. 128-134, con storia degli studi e aggiornamento bibliografico (pp. 117-118 e note 1 e 2). Più in generale cfr. anche E. GRECO, Definizione dello spazio urbano: architettura e spazio pubblico, in S. SETTIS (a cura di), I Greci. Storia Cultura Arte Società, 2: Una storia greca, II. Definizione, Torino 1997, pp. 620-635 (in part. pp. 621-622). Sulla creazione dell’agora nel Ceramico soltanto con l’età temistoclea, dopo la fine delle guerre persiane, cfr. invece J. PAPADOPOULOS, Ceramicus Redi-vius. The Early Iron Age Potters’ Field in the Area of the Classical Athenian Agora, «Hesperia» Suppl. 31, Athens 2003.
35 Cfr. B. JORDAN, Servants of the Gods: a Study in the Religion, History and Litera-ture of fifth-century Athens, Göttingen 1979, pp. 38-39. Hiller invece vi leggeva il riferimento a un’agora posta sull’acropoli (vd. IG I2 3/4 in apparato), probabilmente nel tentativo di trovare una coerenza interna tra il primo decreto al secondo.
36 Il riferimento è a IG I3 104, ll. 20-29; cfr. anche ARIST., Ath. Pol. LVII 4. Il tema, del resto, è ben noto. Rimando qui per l’agora ai contributi recenti di C. AMPOLO, L’agora come spazio politico e di comunicazione, in C. AMPOLO (a cura di), Agora greca e agorai di Sicilia, Pisa 2012, pp. 9-18, e D. ERDAS, Aspetti giuridici dell’agora greca, ibid., pp. 57-70.
SPAZIO GIURIDICO NELL’AGORA E SULL’ACROPOLI: NOTA A IG I3 4 289
produrre lo stesso giuramento, dopo di che entrano in carica37. Ma la distinzione nell’uso di questi due spazi sensibili nei decreti del-l’Hekatompedon non deve certo essere stata casuale.
Proviamo dunque a proporre una lettura conclusiva: i due decreti dell’Hekatompedon, pubblicati e concepiti come un unico documen-to giuridico, regolavano – forse entrambi, certamente il secondo – la cura e la pulizia di spazi cittadini importanti per la vita della polis. Il secondo decreto prevedeva che ad amministrare il corretto impiego di alcune aree dell’acropoli fossero i tesorieri sull’acropoli stessa, tramite la riscossione di multe; dal primo decreto si ricava invece che alcune violazioni compiute in luoghi diversi dall’acropoli (forse altre aree sa-cre? Non necessariamente spazi “civili”) venivano multate e gestite di-rettamente dagli arconti nell’agora. Una distinzione che non si spiega in modo soddisfacente chiamando in causa la spesso ingannevole di-cotomia sacro/pubblico38, ma che appare piuttosto legata alla necessi-tà di differenziare competenze e individuare spazi giuridici preposti. Le ampie e insanabili lacune della metopa A non consentono di spin-gersi oltre; l’invito è a riflettere sulla portata di questa distinzione nell’amministrazione della giustizia a pochi anni di distanza dalle ori-gini del processo democratico.
APPENDICE: LA METOPA A Per comodità di lettura si riproduce qui il testo di IG I3 4A, con
l’aggiunta alle ll. 11-14 e 26-28 dei frammenti pubblicati da MAT-
THAIOU, Duvo neva qrauvsmata, cit. Per l’apparato si rimanda all’edi-zione di Jameson nelle IG e alle note di Matthaiou nell’articolo so-pra menzionato.
37 Per questo e altri riti civici legati al lithos nell’agora cfr. ancora AMPOLO,
L’agora come spazio politico, cit., p. 13, e ERDAS, Aspetti giuridici, cit., p. 60 e nt. 29. 38 Sull’applicazione alla documentazione epigrafica del tema ormai classico
della religione embedded nella realtà greca cfr. ora P.J. RHODES, State and Religion in Athenian Inscriptions, in «G&R» LVI (2009), pp. 1-13.
DONATELLA ERDAS 290
»..................38..................¼ »..................38..................¼ ».............27............ eja;n¼ dev t³i³~³ »...¼ »............25...........¼a³n³ ⋮ e] frora;n⋮ m»e; ..¼ ».........18....... pe¼ntevkonta ⋮ d»ra¼cma;~ ⋮ t»..¼ »....¼a~ ⋮ h»......13.....¼e~ ⋮ pra'csin d»e; e\¼n³ai ⋮ p»ro;¼- »~¼ t³o;~ tre»~ a[rconta~ to;~¼ ejn ajgora'i ⋮ a[n»eu p¼r³uta³»ne¼- iv³on ⋮ kai; t»on qoion to; me;n h¼evmi»su ej¼~ d³»emovs¼ion ⋮ to; d- e; hevmis»u ............26............¼o³~ ⋮ edo³- ».¼e ⋮ hi».........20.........¼ei ⋮ ».....12.....¼ »...¼t».¼ ƒ i ».¼c»...¼gr³»....11.....¼ ⋮ to;~ tam³»iva~ t¼o;~ ej- »m povle¼i ⋮ hevconta~³»......14......¼oko³»...¼n ⋮ ton »....¼tion ⋮ k³ai; ton³ »douvlon katadikavzen ka¼q³avper »ton ej¼l³eu»qev¼ron ⋮ t³»au'ta de; e[docsen toi devmo¼i³ ⋮ ejpi; F- »ilokr¼av³»t¼o~ ⋮ a[rc»ont¼o~ vacat »ton t¼a³mion »m¼evn»en¼ h ³evna ⋮ ejn te»i to neo; perib¼olei ⋮ ta;- »~ k¼a³qekovs¿⋮¯a»~ eJmevr¼a~ ⋮ hovtam»per .....12.....¼e³»..¼ ».¼ ⋮ eja;n dunato;³»~ ej i· ej¼a;n de; mev³ »......14...... to; pruv¼- tanin ⋮ kai; di»dovna¼i ⋮tois»........18........ ca¼- lkiva ⋮ kai; ojbel³»o;~ p¼l³e;n p».........21..........¼ n ⋮semaine»...7...¼on»..........22..........¼ ».¼en de; ⋮ »................34................¼ »......15.......¼ »..........23...........¼ ».....12..... e¼ij³do;»~ ..........22..........¼ »..¼mi³»o..6... d¼e; tau't³»a .........21..........¼ »..¼ duoi³n³ »dra¼cmai'n ⋮ te»..........22..........¼ ».. ¼toi demosivoi ⋮ toi»..........23...........¼ »....¼l³ a]m me; doi ⋮ sk»...........25............¼ vacat OO BIBLIOGRAFIA
C. AMPOLO, L’agora come spazio politico e di comunicazione, in C. AM-POLO (a cura di), Agora greca e agorai di Sicilia, Pisa 2012, pp. 9-18.
I. ARNAOUTOGLOU, The Fear of Slaves in ancient Greek Legal Texts, in A. SERGHIDOU (ed.), Fear of Slaves - Fear of Enslavement in the ancient Medi-terranean. Peur de l’esclave - Peur de l’esclavage en Méditerranée ancienne (Dis-
SPAZIO GIURIDICO NELL’AGORA E SULL’ACROPOLI: NOTA A IG I3 4 291
cours, représentations, pratiques). Actes du XXIXe colloque du groupe interna-tional de Recherche sur l’Esclavage dans l’Antiquité (GIREA) (Rethym-non, 4-7 novembre 2004), Franche-Comté 2007, pp. 133-144.
E. BADIAN, Archons and strategoi, in «Antichthon» V (1971), pp. 1-34. M. BEHRENT, Anthropology and the Classics: War, Violence, and the State-
less Polis, in «CQ» L (2000), pp. 257-289. P. BUTZ, The Art of the Hekatompedon Inscription and the Birth of the
Stoikhedon Style, Leiden 2010. G. CAMASSA, La lontananza dei Greci, Roma 2004. G. CAMASSA, Tempo delle origini e misurazione del tempo, in «QS» LV
(2002), pp. 55-65. E. CULASSO GASTALDI, Cleruchie? Non cleruchie? Alcune riflessioni sugli
insediamenti extraterritoriali di Atene, in R. SCUDERI - C. ZIZZA (a cura di), In ricordo di Dino Ambaglio. Atti del convegno (Università di Pavia, 9-10 di-cembre 2009), Pavia 2011, pp. 113-144.
R. DEVELIN, Prytany systems and eponyms for financial boards in Athens, in «Klio» LXVIII (1986), pp. 67-83.
R. DEVELIN, Athenian Officials 684-321 B.C., Cambridge 1989. H. VAN EFFENTERRE - F. RUZE, Nomima. Recueil d’inscriptions politiques
et juridiques de l’archaïsme grec, I, Paris 1994. D. ERDAS, Aspetti giuridici dell’agora greca, in C. AMPOLO (a cura di),
Agora greca e agorai di Sicilia, Pisa 2012, pp. 57-70. E. GRECO, Definizione dello spazio urbano: architettura e spazio pubblico,
in S. SETTIS (a cura di), I Greci. Storia Cultura Arte Società, 2. Una storia gre-ca, II. Definizione, Torino 1997, pp. 619-652.
M. GUARDUCCI, Note di epigrafia attica arcaica, in «ASAA» n.s. 3/5 (1941/1943), pp. 115-134.
E.M. HARRIS, Antigone the Lawyer, or the Ambiguity of Nomos, in E.M. HARRIS - L. RUBINSTEIN (eds.), The Law and the Courts in Ancient Greece, London 2004, pp. 19-56 (ora in E.M. HARRIS, Democracy and the Rule of Law in Classical Athens. Essays on Law, Society, and Politics, Cambridge 2006, pp. 41-80).
E.M. HARRIS, Who enforced the Law in Classical Athens?, in Symposion 2005: Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Salerno, 14.-18. September 2005) = Comunicazioni sul diritto greco ed ellenistico (Saler-no, 14-18 Settembre 2005), Wien 2007, pp. 159-176.
DONATELLA ERDAS 292
A.R.W. HARRISON, Il diritto ad Atene, II. La procedura, ed. it. a cura di P. COBETTO GHIGGIA, Alessandria 2001 (ed. or. Oxford 1971).
A.S. HENRY, Prescripts of Athenian decrees, Leiden 1977. K.-J. HÖLKESKAMP, (In-)Schrift und Monument. Zum Begriff des Gesetzes
im archaischen und klassischen Griechenland, in «ZPE» CXXXII (2000), pp. 73-96.
B. HOLTZMANN, L’Acropole d’Athènes. Monuments, cultes et histoire du sanctuaire d’Athéna Polias, Paris 2003.
V.J. HUNTER, Policing Athens. Social Control in the Attic Lawsuits, 420-320 B.C., Princeton N.J. 1994.
J.M. HURWIT, The Athenian Acropolis. History, Mythology, and Archeaol-ogy from the Neolithic Era to the Present, Cambridge 1998.
L. JEFFERY, Local Scripts of Archaic Greece, rev. ed. by A.W. Johnston, Oxford 1990.
B. JORDAN, Servants of the Gods: a Study in the Religion, History and Lit-erature of fifth-century Athens, Göttingen 1979.
W. JUDEICH, Topographie von Athen, München 1931. R. KOERNER, Inschriftliche Gesetzestexte der frühen griechischen Polis, Köln -
Weimar - Wien 1993. M. KORRES, Die Athena-Tempel auf der Akropolis, in W. HOEPFNER
(Hrsg.), Kult und Kultbauten auf den Akropolis. Internationales Symposion vom 7. bis 9. Juli 1995 in Berlin, Berlin 1997, pp. 218-243.
M. LIPKA, Anmerkungen zur Hekatompedon-Inschrift: eine Revision, in «ZPE» CXXII (1998), pp. 79-80.
J.H. LIPSIUS, Das Attische Recht und Rechtsverfahren, I, Leipzig 1905. H.G. LOLLING, ÆEkatovmpedon. Sumbolai; eij~ th;n iJstorivan tw'n ejpi;
th'~ ajkropovlew~ naw'n th'~ ÆAqhna'~, in «ÆAqhna'» II (1890), pp. 627-662. H.G. LOLLING, in «AD» (1890), pp. 92-98. F. LONGO, La definizione di un nuovo spazio pubblico: l’agora del Ceramico
dalla ‘nascita’ alla spedizione in Sicilia, in E. GRECO - M. LOMBARDO (a cura di), Atene e l’Occidente: i grandi temi. Le premesse, i protagonisti, le forme della comunicazione e dell’interazione, i modi dell’intervento ateniese in Occidente. Atti del Convegno Internazionale (Atene, 25-27 maggio 2006), Atene 2007, pp. 117-154.
S. LURIA, Zur Geschichte der Präskripte in den Attischen Voreuklidischen Volkbeschlüssen, in «Hermes» LXII (1827), pp. 257-275.
D.M. MACDOWELL, Wasps, Aristophanes, Oxford 1971.
SPAZIO GIURIDICO NELL’AGORA E SULL’ACROPOLI: NOTA A IG I3 4 293
D.M. MACDOWELL, The Law in Classical Athens, London 1978. G. MADDOLI, Responsabilità e sanzione nei «decreta de Hecatompedo», in
«MH» XXIV (1967), pp. 1-11. D. MARCHIANDI, Riflessioni in merito allo statuto giuridico di Lemno del V
secolo a.C. La ragnatela bibliografica e l’evidenza archeologica: un dialogo possibi-le?, in «ASAA» LXXXVI, s. III, 8 (2008), pp. 11-39.
A.P. MATTHAIOU, Duvo neva qrauvsmata th'~ IG I3 4, in «Horos», XIV-XVI (2000-2003), pp. 19-22.
B.D. MERITT, Notes on Attic Decrees, in «Hesperia» XXVIII (1941), pp. 301-337.
M.M. MILES, The Lapis Primus and the Older Parthenon, in «Hesperia» LXXX (2011), pp. 657-675.
G. NÉMETH, Übersetzung und Datierung der Hekatompedon-Inschrift, in «JDAI» CVIII (1993), pp. 76-81 [ora in ID., Hekatompedon. Studies in Greek Epigraphy, Debrecen 1997 (“Hungarian Polis Studies”, 1), pp. 7-14].
G. NÉMETH, MedÆ o[nqon ejgbalen. Regulations concerning everyday life in a Greek temenos, in R. HÄGG (ed.), Ancient Greek Cult and Practice from the Epigraphical Evidence. Proceedings of the Second International Seminar on An-cient Greek Cult, org. by the Swedish Institute at Athens, 22-24 November 1991, Stockholm 1994, pp. 59-64 [ora in ID., Hekatompedon. Studies in Greek Epigraphy, Debrecen 1997 (“Hungarian Polis Studies”, 1), pp. 21-30].
G. NÉMETH, Hekatompedon-Probleme, in «ZPE» CI (1994), pp. 215-219 [ora in ID., Hekatompedon. Studies in Greek Epigraphy, Debrecen 1997 (“Hun-garian Polis Studies”, 1), pp. 15-20].
R. OSBORNE, Did democracy transform Athenian space?, in R. WESTGATE - N.R.E. FISHER - J. WHITLEY (eds.), Building Communities: house, settlement and society in the Aegean and beyond. Proceedings of a conference held at Cardiff University (17-21 April 2001), Oxford 2007, pp. 195-199.
M. OSTWALD, The reform of the Athenian state by Cleisthenes, in CAH2, IV, pp. 303-346.
J. PAPADOPOULOS, Ceramicus Redivius. The Early Iron Age Potters’ Field in the Area of the Classical Athenian Agora, «Hesperia» Suppl. 31, Athens 2003.
P.J. RHODES, The Athenian Boule, Oxford 1971. P.J. RHODES, A Commentary on the Aristotelian Athenaion Politeia, Ox-
ford 1981. P.J. RHODES, State and Religion in Athenian Inscriptions, in «G&R» LVI
(2009), pp. 1-13.
DONATELLA ERDAS 294
M.B. RICHARDSON, Rev. of Butz, The Art of the Hekatompedon Inscrip-tion and the Birth of the Stoikhedon Style, in «AJA» CXVI (2012), http://www. ajaonline.org
A. SCHOLL, ANAQHMATA TWN ARCAIWN. Die Akropolisvotive aus dem 8. bis frühen 6. Jahrhundert v.Chr. und die Staatswerdung Athens, in «JDAI» CXXI (2006), pp. 1-173.
R.S. STROUD, A. Wilhelm and the Date of the Hekatompedon Decrees, in A.P. MATTHAIOU (epimel.), Attikai epigraphai: praktika symposiou eis mnemen Adolf Wilhelm (1864-1950), Athenai 2004, pp. 85-97.
R. TÖLLE-KASTENBEIN, Das Hekatompedon auf der Athener Akropolis, in «JDAI» CVIII (1993), pp. 43-75.
A.G. WOODHEAD, Athenian Agora XVI, Inscriptions: the Decrees, Prince-ton 1997.









































![Lo sguardo malinconico sullo spazio-evento: elegia del paesaggio dipinto [su Biamonti e Morlotti]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/633172dd576b626f850cf17a/lo-sguardo-malinconico-sullo-spazio-evento-elegia-del-paesaggio-dipinto-su-biamonti.jpg)