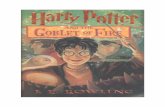Aspetti della municipalità di Canusium : l'albo dei decurioni
Aspetti sociolinguistici nel cinema inglese: il caso di Harry Potter
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Aspetti sociolinguistici nel cinema inglese: il caso di Harry Potter
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA
CORSO DI LAUREA INLINGUE E CULTURE STRANIERE OCCIDENTALI E
ORIENTALI
TESI DI LAUREA IN
LINGUA E TRADUZIONE INGLESE
ASPETTI SOCIOLINGUISTICI NEL CINEMA INGLESE: ILCASO DI HARRY POTTER
Relatore: Laureanda:
Chiar.mo Prof. Stewart Dominic ItaliaSonia
ANNO ACCADEMICO 2011/2012Indice
Capitolo 1: INTRODUZIONE
1.1. Presentazione
p.4
1.2. La trama di un fenomeno mondiale
p.4
1.3. I temi dell'opera
p.5
1.4. Le figure cardine
p.6
Capitolo 2: GLI UOMINI SONO LINGUA
2.1. Premessa
p.8
2.2. Solidarietà sociale e distanza sociale
p.8
2.3. Accenti e dialetti
p.9
2.4. The dropping of the g
p.11
2.5. The dropping of the h
2
p.12
2.6. Status e ruoli all'interno della società
p.13
2.7. Codici ristretti e codici elaborati
p.13
2.8. La lingua nei gemelli
p.14
Capitolo 3: AD OGNI PERSONAGGIO, IL SUO ACCENTO
3.1. Premessa
p.16
3.2. Gli accenti “standard”
p.17
3.3. Gli accenti “non standard”: Ron
p.21
3.3.1. Il “glottal stop”
p.21
3.3.2. Lealtà e simpatia
p.22
3.3.3. Precarietà economica
p.23
3.3.4. Uno studente “giovane”
p.24
3.4. Gli accenti “non standard”: i gemelli Weasley
p.24
3.4.1. Positività d’animo e marginalità letteraria
p.26
3.4.2. Espressioni “private” e giochi di suono
3
p.27
3.4.3. Proposizioni a metà
p.27
3.5. Gli accenti “non standard”: Scabior
p.28
3.5.1. Il Cockney
p.28
3.5.2. Interessi divergenti e ruoli di sfondo
p.29
Capitolo 4: CONCLUSIONI
4.1. Premessa
p.31
4.2. Sintetizzando...
p.31
4.3. Alcune riflessioni
p.33
BIBLIOGRAFIA
p.34
FILMOGRAFIA
p.35
SITOGRAFIA
p.35
4
1. INTRODUZIONE
1.1. Presentazione
Il mio lavoro di tesi è principalmente rivolto a uno
studio di alcuni accenti circoscritti al Regno Unito e
applicati nell'ambiente del cinema. Più nel dettaglio, il mio
interesse primario era indagare le cause per le quali a
specifici ruoli corrispondono specifiche parlate, perché (e
questo è un concetto che deve risultare il più possibile
5
chiaro) vi è una stretta relazione tra la parte che viene
affidata a un attore e la personale maniera in cui
quest'ultimo pronuncia le varie frasi e parole.
Tra le molte pellicole verso cui le mie analisi potevano
orientarsi, ho scelto di esaminare alcune delle inflessioni
che si ritrovano nei film di Harry Potter, per due differenti
motivi: innanzitutto, perché quest'opera è di mio assoluto
gradimento, e secondariamente, per il grande impatto mediatico
che ha riscontrato sul pubblico.
Il documento è diviso in quattro capitoli, di cui nel primo
(il presente per l'appunto) sono esposti, nell'ordine, la
trama dei libri portati al successo da J.K. Rowling, i temi
principali che i sette volumi affrontano e i personaggi più
importanti in essi rappresentati.
Il secondo capitolo è invece prettamente teorico, e proprio
per questo la sua rilevanza è fondamentale, in quanto ho
potuto elaborare le mie ipotesi sul perché determinati ruoli
fossero caratterizzati da determinati accenti grazie alle
ricerche di alcune tra le più autorevoli voci della
linguistica, a cui ho dedicato ampio spazio.
Nel terzo capitolo vengono quindi presentati quattro diversi
tipi di inflessioni prese da tre degli otto film prodotti
dalla Warner Bros. Pictures: dopo averle descritte nei loro
tratti più identificativi, mi sono concentrata sulla
sociologia dei personaggi così come trasparivano dai libri,
notando sempre dei collegamenti tra il loro modo di esprimersi
e i loro risvolti psicologici.
L'ultimo capitolo è quello conclusivo, in cui prima sono
6
sintetizzati gli aspetti focali di tutto il discorso, mentre
in una fase finale, vengono offerti degli ulteriori spunti di
riflessione.
1.2. La trama di un fenomeno mondiale
L'opera di Harry Potter nasce dalla penna della scrittrice
britannica J.K. Rowling nel giugno del 1997. La saga, di
genere fantasy, è stata pubblicata in sette romanzi, che hanno
avuto uno straordinario successo a livello mondiale.
La storia narra le vicende di un ragazzino orfano di nome
Harry, che all'età di undici anni scopre le sue vere origini
di mago. Avrà così la possibilità di studiare a Hogwarts, una
prestigiosa scuola di magia britannica, dove conoscerà i suoi
migliori amici Ron e Hermione, che lo accompagneranno in tutte
le sue avventure e che diventeranno per lui un punto di
riferimento. Trama principale dell'opera è la sua lotta contro
Voldemort, un pericoloso mago oscuro autore dell'omicidio dei
suoi genitori e da sempre determinato a ucciderlo a causa di
una misteriosa profezia fatta poco prima della nascita di
Harry. Intorno a ciò ruoteranno tutti gli avvenimenti più
importanti della saga. Figure di rilievo per Harry, oltre ai
suoi amici, saranno anche il padrino Sirius, grande amico dei
suoi genitori e per anni creduto responsabile della loro
morte, e il preside della scuola in cui studia, Albus Silente
(nell'originale Albus Dumbledore), uomo di sconfinata saggezza
e grandi abilità magiche, l'unico mago al mondo capace di
incutere timore in Voldemort. Silente in particolare sarà una
guida fondamentale nella formazione spirituale di Harry, e gli
7
fornirà la chiave per sconfiggere Voldemort una volta per
tutte.
1.3. I temi dell'opera
Nei primi volumi della saga, il tema principale che viene
trattato è l'innocenza e l'unicità del periodo dell'infanzia,
due caratteristiche che, secondo la stessa autrice,
rappresentano la grande forza dei bambini: “Mi ricordo
benissimo dei miei undici anni: a quell'età si è del tutto
impotenti. Ma i bambini hanno un mondo segreto che per gli
adulti sarà sempre impenetrabile” (Harry Potter e la pietra
filosofale, seconda di copertina, traduzione di Marina
Astrologo). Via via che la storia prosegue però le questioni
sviluppate diventano più delicate. In parallelo con la
crescita del protagonista, a partire dal quinto volume della
saga vengono affrontati temi quali l'influenza delle scelte
personali sulla nostra vita, la paura della morte e
l'importanza dell'amore in tutte le sue forme. Vediamo di
analizzarli brevemente punto per punto.
L'influenza delle scelte personali sulla nostra vita: la
Rowling esprime la convinzione che ciò che di brutto o di
bello ci capita non dipende da un destino prestabilito o da un
progetto già scritto, ma è piuttosto una conseguenza delle
scelte che operiamo nell'arco della nostra vita. Questo è
chiaramente esemplificato dalle parole di Silente nel sesto
volume della saga, quando nel suo studio spiega a Harry il
vero significato della profezia su quest'ultimo e Voldemort:
“Harry, never forget that what the prophecy says is only
8
significant because Voldemort made it so. [...] If Voldemort
had never heard of the prophecy, would it have been fulfilled?
Would it have meant anything? Of course not!” (J.K. Rowling,
509-510).
La paura della morte: l'antagonista principale della storia,
Voldemort, ritiene che la morte sia la più grande debolezza
dell'essere umano. Tenterà quindi di vincerla in tutti i modi
creando degli Horcrux, oggetti oscuri capaci di garantire
l'immortalità a una persona. È in questi oggetti che risiede
il segreto della sua apparente invincibilità. Apparente è la
parola chiave: la morte non può infatti essere realmente
dominata. Voldemort concepisce la morte come una debolezza
solo perché è incapace di capire che esistono cose ben
peggiori, ed è questo che determinerà la sua sconfitta
nell'ultimo capitolo della saga.
L'importanza dell'amore in tutte le sue forme: è il vero filo
conduttore dell'opera, e attraversa tutte le pagine dei sette
romanzi. È per amore che all'inizio della storia la madre di
Harry muore per proteggerlo da Voldemort, ed è per amore che
Harry è pronto a fare lo stesso per i suoi amici nell'ultimo
volume della saga. La capacità di amare rappresenta l'arma
vincente del protagonista, e sarà questa capacità che gli
permetterà di avere la meglio sul suo nemico.
1.4. Le figure cardine
Sebbene in più parti della storia sembra trasparire una
certa somiglianza tra Harry e Voldemort, (entrambi per
esempio sono in grado di comunicare con i serpenti), da quanto
9
appena esposto sopra si ricava invece che a livello più
profondo essi rappresentano l'uno l'esatto opposto dell'altro.
Voldemort infatti crede nel caso e nel destino, ha
terribilmente paura della morte ed è totalmente incapace di
concepire l'amore; Harry invece capisce che sono le scelte
personali ad avere influenza sulla nostra vita, comprende che
la morte non è il male peggiore ed è in grado di voler bene e
soffrire per le persone che ama.
Al centro di questi due personaggi si pone la figura di
Silente. In base a quanto raccontato nell'ultimo libro, il
preside da giovane era più simile a Voldemort nel modo di
pensare, poiché anche lui voleva dominare la morte. Nel corso
degli anni è riuscito però a capire appieno il valore
dell'amore e il ruolo che le scelte individuali ricoprono
nella nostra vita. In vecchiaia, quindi, diventa più simile al
protagonista Harry.
È chiaro che questi tre personaggi, per le ragioni fin qui
elencate, seppure in modo diverso rappresentano le figure
portanti dell'intera opera. Per questo motivo, nelle
trasposizioni cinematografiche di Harry Potter gli attori che
li interpretano parlano con un accento inglese “standard”, e
ciò li contrappone ad altri personaggi, che come vedremo, sono
interpretati da attori che parlano invece con altre varietà di
accento. Le implicazioni sociologiche che stanno dietro a
queste scelte sono argomento che verrà approfondito nei
capitoli successivi di questo documento.
10
2. GLI UOMINI SONO LINGUA
2.1. Premessa
Scopo di questo capitolo è illustrare alcune teorie
linguistiche che serviranno da supporto per la mia tesi
secondo la quale nel cinema le diverse varianti di accento con
cui parlano gli attori giocano un ruolo fondamentale nel
definire l'identità dei personaggi che essi interpretano. Lo
studioso a cui ho principalmente fatto riferimento è
l'irlandese David Crystal, scrittore, editore per la Cambridge
e attualmente professore di linguistica presso la University
of Wales, a Bangor. Tra i molti argomenti di cui Crystal si è
occupato fino a questo momento, ho incluso in particolare le
sue ricerche sulla morfologia di accenti e dialetti, sul
rapporto tra lingua e società e sulle forme di acquisizione
linguistica da parte dei gemelli nel periodo dell’infanzia. Ho
approfondito poi ognuno di questi contenuti con i contributi
di altri autori e studiosi, nello specifico:
Peter Trudgill e J.K. Chambers, professori di linguistica
rispettivamente alla University of East Anglia e alla
University of Toronto;
Jenny Cheshire, professoressa di linguistica alla University
of London;
Otto Jespersen e Martin Stevens, il primo professore
all'Università di Copenaghen, morto nel 1943, il secondo
12
professore al Michigan State College;
John Galsworthy, scrittore inglese morto nel 1933;
Basil Bernstein, sociologo e linguista britannico morto nel
2000;
William Labov, professore di linguistica alla University of
Pennsylvania;
David McNeill, professore di linguistica e psicologia alla
University of Chicago, nell'Illinois;
Charles Ferguson, professore di linguistica alla Stanford
University, morto nel 1998;
Elinor Ochs, professoressa di antropologia all'Università
della California, a Los Angeles.
2.2. Solidarietà sociale e distanza sociale
Secondo quanto afferma Crystal, i diversi usi che gli
uomini fanno della propria lingua sono espressione
dell'identità personale. Le differenze presenti nel nostro
modo di parlare possono facilmente rivelare a chi ci ascolta
alcuni tratti tipici di noi stessi, come per esempio le nostre
origini geografiche, la realtà sociale che ci circonda e il
livello di cultura che abbiamo: “[...] A major function of
language is the expression of personal identity – the
signalling of who we are and where we 'belong'” (Crystal 13).
Gli elementi che meglio ci permettono di attuare questa
caratterizzazione di noi stessi sono le inflessioni di accento
e le varianti dialettali, in base alle quali viene a
delinearsi una tra le funzioni più importanti della lingua:
gli uomini possono essere e sentirsi parte di un determinato
13
gruppo di persone (“solidarietà sociale”), oppure possono
percepire il medesimo gruppo come troppo lontano dalla propria
individualità (“distanza sociale”). (Crystal, 42)
2.3. Accenti e dialetti
È importante tenere questi due termini distinti, in quanto
sono ben lungi dall'essere sinonimi. Un accento è solo una
particolare pronuncia che un parlante applica alla propria
lingua; un dialetto invece include in sé anche differenze di
tipo grammaticale e lessicale. Per meglio spiegare la
differenza, si riportano le esemplificazioni di Crystal:
If we heard one person say He done it and another say He did it, wewould refer to them as using different dialects, because agrammatical difference is involved. Similarly, the choicebetween wee bairn and small child is dialectical, because this is acontrast in vocabulary. But the difference between bathwith a 'short a' [a] and bath with a 'long a' [ɑ:] is amatter of accent, as this is solely a matter of pronunciation.(Crystal 24)
Nonostante la considerevole divergenza, tuttavia, sia accenti
che dialetti vengono sottoposti a giudizi di valore, che
variano di grado di caso in caso. Per esempio, i parlanti che
utilizzano inflessioni “standard” per la propria lingua, nella
maggior parte dei casi vengono ritenuti più istruiti e vengono
considerati personalità più dominanti: “[...] The medium of
instruction and criterion of successful performance is
standard English” (Crystal, 35). Chi fa uso invece di accenti
associabili a classi sociali più basse e di dialetti più
periferici, è molto probabile che venga visto come portatore
14
di integrità morale ed è capace di esercitare un certo fascino
attrattivo sugli altri parlanti. La nostra percezione di una
persona, quindi (cioè l'immagine di innocenza, intelligenza o
ignoranza che per esempio ne ricaviamo), ci viene data dai
diversi fattori fonetici della lingua.
I dialetti sono argomento ampiamente discusso in “Dialects of
English: Studies in grammatical variation” a cura di Peter
Trudgill e J.K. Chambers. In questa raccolta di saggi vengono
analizzate le maggiori differenze di natura morfologica e
sintattica tra i vari dialetti dell'inglese. Nel capitolo
introduttivo, i due linguisti affermano che la maggior parte
dei parlanti di madrelingua inglese sparsi per il mondo
divergono tra loro più per le varianti di accento che per
quelle dialettali. Inoltre, la maggior parte dei dialetti sono
grammaticalmente e lessicalmente molto vicini allo Standard
English. È pur vero però che esiste una minoranza di persone
di lingua inglese che utilizza dialetti che Trudgill e
Chambers definiscono “traditional”, forme non standard e prive
di regole grammaticali fisse e definite: “These dialects
differ very considerably from Standard English, from other
mainstream varieties and from each other. They also differ in
unsystematic and unpredictable ways, and in their grammar as
well in phonology and lexis” (Trudgill and Chambers, 3). I
“traditional dialects” si possono localizzare geograficamente
soprattutto nelle aree rurali e periferiche, ma una parte di
essi la possiamo ritrovare anche in zone più urbane.
A supporto della teoria di Trudgill e Chambers circa la
differenza grammaticale tra forme standard e forme non
15
standard possiamo fare riferimento a uno studio compiuto da
Jenny Cheshire sul sistema verbale dei dialetti inglesi, il
cui saggio è anch'esso contenuto nella raccolta curata dai due
linguisti. Secondo la Cheshire, nelle forme dialettali non
standard della città di Reading, per esempio, il verbo “ain't”
viene adoperato in sostituzione di più forme standard, ed in
particolare:
come contrazione del presente negativo del verbo “to be”,
utilizzato come copula (We've got a park near us, but there
ain't nothing over there);
come contrazione del presente negativo del verbo “to be”,
utilizzato come ausiliare (How come that ain't working?);
come contrazione del presente negativo del verbo ausiliare
“to have” (I ain't got one single flea in my hair, they're
all married). (Cheshire, in Trudgill and Chambers, 54)
Le forme standard, invece, nel linguaggio colloquiale
comprendono:
il verbo assimilato al soggetto che lo precede (You're not
making room for me);
la particella negativa ridotta e assimilata al verbo che la
precede (You aren't a virgin). (Cheshire, in Trudgill and
Chambers, 62)
Dalla comparazione appena svolta, quindi, possiamo dedurre che
mentre con i dialetti standard ci troviamo semplicemente di
16
fronte a delle abbreviazioni, facilmente riconducibili alle
forme originali (You are not making room for me; You are not a
virgin), nei dialetti non standard la devianza dalle norme
grammaticali corrispondenti è nettamente maggiore (We've got a
park near us, but there is nothing over there; How come that is
not working?; I have not got one single flea in my hair, they're
all married). Proprio perché può abbracciare più funzioni
all'interno di una frase, risulta più difficile risalire alle
origini storiche del verbo “ain't”, che secondo Jespersen
(1940) e Stevens (1954) vanno rintracciate nel Middle English.
I due linguisti ipotizzano che “ain't” deriverebbe da
cambiamenti di suono in “haven't/hasn't” e “am not”. Per
quanto riguarda il primo caso, quando “haven't/hasn't”
occorreva in posizione atona, l'h aspirata iniziale veniva a
mancare e la vocale lunga con cui allora venivano pronunciate
le forme negative dei verbi irregolari poteva andare incontro
ad un processo di dittongazione, nello specifico [eɪ]; nel
caso di “am not”, invece, la prima consonante nasale si
sarebbe assimilata alla seconda, mentre la vocale iniziale si
sarebbe allungata, diventando successivamente il dittongo
[eɪ]. (Trudgill e Chambers, 56)
Quanto detto fin qui sulla divergenza tra forme standard e non
standard sarà di fondamentale importanza per il capitolo
successivo, perché rappresenterà un utile strumento di
supporto per la mia tesi secondo cui il modo di parlare dei
personaggi nel cinema non è un fenomeno puramente casuale, ma
risponde a dei criteri e a delle scelte ben precise.
17
2.4. The dropping of the g
Come abbiamo già accennato, uno dei principali fattori che
più influiscono sul nostro modo di parlare è il contesto
sociale del quale facciamo parte. La società è organizzata in
classi, costituite da un agglomerato di persone che
condividono simili caratteristiche economiche, oltre che
linguistiche. Le relazioni che intercorrono tra la lingua e la
classe sociale sono state oggetto di osservazione non solo da
parte dei linguisti, ma anche da parte di alcuni letterati dei
secoli XVIII e XIX. Ne è un esempio lo scrittore britannico
John Galsworthy, che nel romanzo “Maid in waiting”, scritto
nel 1931, attraverso una conversazione tra i personaggi di
Clare e Dinny Cherrel sottolinea alcune particolarità
linguistiche insite nel parlato di Lady Mont:
'Where on earth did Aunt Em learn to drop her g's?''Father told me once that she was at a school where an
undropped “g” was worse than a dropped “h”. They were bringin' in a country fashion then,
huntin' people, you know'. (John Galsworthy, chapter 31)
Dal dialogo traspare lo stupore di Clare per il modo di
parlare della zia, che fa uso di un linguaggio “basso” non
propriamente adatto alla posizione economica che ricopre.
Galsworthy sostanzialmente mette in luce uno dei segnali più
comuni che indicano la differente appartenenza di classe in
Gran Bretagna, e cioè la diversa pronuncia della “g” finale in
parole come “bringing” e “hunting”. Esistono fondamentalmente
due varianti: [n], più tipica delle classi proletarie, e [ƞ],
versione standard e in voga presso le classi più alte. Crystal
18
però asserisce che nel secolo scorso “dropping the g”, ossia
usare la prima delle due varianti di pronuncia illustrate
sopra, non era sintomo di ignoranza e mancanza di cultura, ma
piuttosto una caratteristica del parlato che le classi più
ricche ed istruite desideravano emulare, e questo è il motivo
per cui il personaggio di Lady Mont “drops her g's”. Solo nel
tardo XIX secolo si incominciò a considerare come più
“corretta” la pronuncia in [ƞ], poiché nella scrittura era
presente una “g” che si sentiva in qualche modo l'esigenza di
riprodurre. (Crystal 39)
2.5. The dropping of the h
Dall'estratto del romanzo di Galsworthy sopra riportato
viene messo in luce un altro connotato che è indicatore della
diversità di classe: “the dropping of the h”1, cioè la mancata
aspirazione dell'”h” iniziale in parole come “heaven” e
“head”, per esempio. Secondo Chambers e Trudgill, la pronuncia
aspirata dell'”h” darebbe più prestigio alla lingua inglese.
Ancora una volta, “the dropping of the h” si presenterebbe con
maggiore incidenza presso le classi sociali più basse di
qualsiasi regione geografica, come emerge da due diversi studi
che i due linguisti hanno svolto nel 1980 presso le città di
Norwich e Bradford, localizzate rispettivamente nell'est e nel
nord dell'Inghilterra (studi inclusi nell'opera
1 A differenza di quanto accade con “the dropping of the g”, in questo casonon vi è alcun accenno ad una possibile volontà da parte delle classi piùabbienti del secolo passato di imitare i proletari e pronunciare come loro un'”h” non aspirata, e questo dimostrerebbe che non ci sono mai stati dubbi su quali delle due varianti fosse generalmente considerata come la più “corretta”.
19
“Dialectology”). Per entrambe le città, è stata analizzata la
ricorrenza del fenomeno in cinque gruppi di parlanti divisi
per classe sociale, in base alla loro professione
e alla loro cultura. Si riporta sotto la tabella con i
risultati dell'indagine:
Class Bradford Norwich
Middle middle(MMC) 12% 6%Lower middle (LMC) 28% 14%Upper working (UWC) 67% 40%Middle working (MWC) 89% 60%Lower working (LWC) 93% 60%
Come traspare da questi dati, in tutte e due le aree la
percentuale di frequenza della mancata aspirazione dell'”h”
aumenta mano a mano che si scende nella scala sociale. Si può
inoltre notare che a Bradford “the dropping of the h” si
verifica con un'occorrenza assai maggiore in ogni fascia, e
questo probabilmente sta ad indicare che lì, rispetto a
Norwich, il fenomeno ha origini più antiche nel tempo.
(Chambers e Trudgill, 59)
2.6. Status e ruoli all'interno della società
Le differenze linguistiche riscontrabili tra i parlanti
non dipendono solo dalle diverse possibilità finanziarie di
ognuno di noi, ma anche dallo “status” e dal “ruolo” che le
persone esercitano all'interno della struttura sociale.
Secondo la definizione che ne dà Crystal, lo status è la
20
posizione che un individuo riveste all'interno della propria
comunità (prete, funzionario burocratico, ecc.). I ruoli sono
invece le modalità di comportamento che deve attuare chi ha un
determinato status. Ogni persona svolge più ruoli, che variano
a seconda dello status che per esempio ha all'interno della
propria famiglia (patriarca, primogenito, ecc.) o all'interno
del proprio luogo lavorativo (capo operaio, tirocinante,
ecc.). (Crystal, 41) In base all'importanza dello status e del
ruolo che si ricopre nella società, ne derivano determinate
convenzioni linguistiche, che possono comprendere un diverso
modo di approcciarsi e indirizzarsi alle persone, una diversa
proprietà di linguaggio e l'uso di un vocabolario più o meno
specifico.
Applicando le teorie di Crystal a livello pratico, possiamo
quindi dedurre che un rettore di un'università che sia al
contempo un capofamiglia tenderà generalmente a parlare con un
tipo di linguaggio “standard”. Diversamente, un operaio
semplice che all'interno del nucleo familiare rappresenti il
membro più giovane probabilmente utilizzerà un tipo di
linguaggio considerato più “basso”.
2.7. Codici ristretti e codici elaborati
È interessante apportare i contributi teorici del
sociologo britannico Basil Bernstein, che nel 1971 distinse
tra due diversi tipi di codici linguistici: un codice più
“elaborato” (elaborated code) e un codice più “ristretto”
(restricted code). Essi trarrebbero la loro origine
all'interno dei diversi tipi di struttura familiare, e si
21
trasmetterebbero negli individui attraverso l'educazione che
viene loro impartita. Codici elaborati sorgono in un contesto
in cui per esempio non si condividono gli stessi pensieri e
gli stessi valori, e proprio per questo vengono richieste una
maggiore specificità e chiarezza. Codici ristretti, invece,
sorgono all'interno di un medesimo gruppo di persone che non
ha bisogno di dettagli espliciti per comprendere determinati
significati, poiché i componenti hanno in comune tra loro lo
stesso bagaglio di conoscenze ed esperienze. Bisogna fare
attenzione però a non confondere il codice ristretto e il
codice elaborato rispettivamente con linguaggi e registri
“bassi” e “alti”.
Secondo molte teorie che Bernstein definisce errate, i bambini
della media borghesia avrebbero accesso facilmente ad entrambi
i codici, mentre i bambini appartenenti alla classe del
proletariato sarebbero limitati inizialmente all'utilizzo del
codice ristretto, e dovrebbero impegnarsi molto di più per
imparare a padroneggiare anche il secondo tipo di codice,
richiesto negli istituti scolastici. Le difficoltà a cui
andrebbero incontro dipenderebbero fondamentalmente
dall'incapacità dei bambini di estrazione sociale più bassa di
compiere astrazioni nei loro discorsi. Per dimostrare
l'infondatezza di queste teorie, Bernstein fa riferimento a
una registrazione compiuta dal linguista americano William
Labov, in cui un ragazzo di 15 anni di colore spiega perché
pensa che Dio sia bianco: “Why? I'll tell you why! Cause the
average whitey out here got everything, you dig? And the
nigger ain't got shit, y'know? Y'understan'? So – um – for in
22
order for that to happen, you know it ain't no black God that's
doin' that bullshit”. (Labov, 217)
La capacità di astrazione in queste poche battute appare
evidente, seppure il codice risulti ristretto e il linguaggio
usato non propriamente “standard”.
2.8. La lingua nei gemelli
Vorrei concludere questo capitolo discutendo delle
particolari circostanze in cui ha origine la lingua nei
fratelli gemelli. I bambini di norma ricevono la maggior parte
degli impulsi linguistici dai propri genitori o da altri
adulti in generale. Stando però agli studi di Crystal, questo
stesso principio non si verifica nel caso dei gemelli, poiché
essi dipenderebbero esclusivamente l'uno dall'altro per
apprendere le principali strutture morfo-sintattiche e
lessicali. In una simile situazione, crescendo e passando la
maggior parte del tempo insieme, non è affatto infrequente che
molti gemelli sviluppino forme di comunicazione assolutamente
“private”. Essi si esprimerebbero sostanzialmente attraverso
un tipo di linguaggio estraneo agli adulti che li circondano,
fatto di giochi fonetici e suoni apparentemente privi di
significato: “To the outsider, this kind of dialogue might
resemble a 'secret language', but it is no more than a form of
phonetic play”. (Crystal, 247)
Un'altra caratteristica molto interessante dei gemelli,
linguisticamente parlando, riguarda il loro modo peculiare di
interagire con le altre persone. Osserviamo un attimo le
conversazioni che seguono:
23
MOTHER: What can you see in the picture?TWIN A: A cat.TWIN B: And a dog.
MOTHER: What do you want me to read?TWIN A: Puss.TWIN B: In boots.2
Da entrambi questi dialoghi si rileva che i gemelli
abitualmente, piuttosto che parlare in contemporanea, si
dividono in parti eque una stessa frase. La loro capacità di
sincronizzazione è sorprendente: se il primo sa esattamente
quando e dove interrompersi, il secondo riesce a completare in
maniera soddisfacente e nelle giuste tempistiche quanto appena
detto dal fratello. Ciò dimostra quindi che essi si conoscono
a vicenda più che esaustivamente: “They know each other's
rhythms, and each is able to predict a great deal of what the
other is likely to say”. (Crystal, 247)
2 Cfr. Crystal pag. 247.
24
3. AD OGNI PERSONAGGIO, IL SUO ACCENTO
3.1. Premessa
Questa terza parte costituisce il cuore del mio lavoro e
la sua importanza è di conseguenza fondamentale, poiché viene
dimostrato dettagliatamente quanto i connotati fonetici di un
attore vadano ad incidere sulla rappresentazione del ruolo che
egli deve interpretare. Come già enunciato nell'introduzione
di questa tesi, il mio studio socio-linguistico si è basato
principalmente sugli accenti che si riscontrano nei film di
Harry Potter. Dato però che i membri che compongono il cast
effettivo sono in numero troppo elevato, non ho potuto
esaminare la parlata di ognuno di loro, anche per limiti di
spazio, per cui, dopo un'attenta selezione3, la mia scelta si è
rivolta verso l'analisi delle inflessioni fonetiche di otto
personaggi in particolare, elencati qui di seguito:
3 I primi cinque personaggi sono stati selezionati per la loro importanza all’interno della storia. Difatti, a mio parere, è attorno ad essi che vengono costruite le trame principali, e sono essi che nella maggior parte dei casi sciolgono gli intrecci della saga. Gli ultimi tre personaggi invece sono stati selezionati per le loro peculiarità fonetiche, reputate da me decisamente curiose e meritevoli di riflessioni.
25
Harry Potter, protagonista indiscusso dei libri;
Tom Riddle, alias Lord Voldemort, antagonista di Harry e da
sempre determinato ad ucciderlo;
Albus Silente, preside della scuola di magia dove Harry e i
suoi compagni studiano;
Hermione Granger, migliore amica di Harry e figlia di
genitori non maghi;
Ron Weasley, anche lui migliore amico di Harry, di umili
origini;
Fred Weasley e George Weasley, gemelli omozigoti
appassionati di scherzi e burle, fratelli maggiori di Ron;
Scabior, un Ghermidore (Snatcher nell'originale inglese) che
sarà presente solo nell'ultimo episodio della saga.
Il metodo che ho adottato per costruire le mie ipotesi è
sempre lo stesso. Dopo avere ascoltato alcune loro
conversazioni, prese da più film della serie, le ho riportate
in questo documento prima in inglese, e poi le ho trascritte
nei simboli fonetici corrispondenti, secondo la diversa
pronuncia che ognuno di questi otto personaggi applicava alle
varie parole. Questo procedimento iniziale mi ha permesso di
stabilire se il loro accento fosse da considerarsi vicino o
lontano rispetto alle regole della fonetica inglese. Ciò che
ne è emerso è che le prime quattro parlate sono abbastanza
fedeli agli standard prefissati, mentre le ultime quattro, in
un climax crescente, se ne distanziano sempre più. Conclusa
questa fase meramente linguistica, in un passaggio successivo
26
ho tracciato il profilo di ognuna di queste figure così come
appariva dai romanzi, da un punto di vista sociale e mettendo
soprattutto in rilievo aspetti caratteriali, competenze
intellettive e possibilità finanziarie. Infine, ho supportato
le mie argomentazioni con i contributi di Crystal e degli
altri studiosi a cui ho fatto riferimento anteriormente.
3.2. Gli accenti “standard”
Basandoci sulle teorie che abbiamo discusso nel capitolo
precedente, non stupisce affatto che i personaggi di Harry,
Hermione, Voldemort e Silente (Dumbledore in originale),
parlino con un accento che rispecchia appieno i canoni della
fonetica inglese. Gli attori che li interpretano sono
rispettivamente Daniel Radcliffe, originario di Londra, Emma
Watson, cresciuta nell'Oxfordshire, Ralph Fiennes, nato ad
Ipswich, nel Suffolk, e Michael Gambon, proveniente da
Dublino. Tutti e quattro gli attori fanno uso di un accento
che può essere considerato di tipo assolutamente “standard”,
in quanto le devianze dalla norma in esso presenti sono
pressoché nulle. Per dimostrare la veridicità di questa
affermazione, ho riportato sotto alcune loro battute tratte da
due diverse scene del quinto film della saga, “Harry Potter e
l'ordine della fenice”, che ho poi trascritto in simboli
fonetici. Nella prima delle due scene, Hermione cerca di
spiegare ai suoi amici i sentimenti di confusione che prova la
ragazza di cui Harry è innamorato:
Don't you understand how she must be feeling? Well,
27
obviously she's feeling sad about Cedric, and therefore confusedabout liking Harry and guilty about kissing him. Conflicted
because Umbridge is threatening to sack her mother from her jobat the Ministry and frightened of failing her O.W.L.s because she'sso busy worrying about everything else. (Harry Potter and theorder of the phoenix, scene 16)
Ecco la trascrizione fonetica della scena:
[dəʊnt ju: ʌndə'stænd haʊ ʃi: mʌst bi: 'fi:lɪŋ wel 'ɒbviəsliʃi:z 'fi:lɪŋ sæd ə'baʊt 'sedrɪk ænd 'ðeəfɔ: kən'fju:zd ə'baʊt'laikɪŋ 'hæri ænd 'gɪlti ə'baʊt 'kɪsɪŋ hɪm kən'flɪktɪd bə'kɒz'ʌmbrɪʤ ɪz 'θretənɪŋ tə sæk hə 'mʌðə frɒm hə ʤɒb æt ðə 'mɪnɪstriænd 'fraitənd ɒv 'feilɪŋ həraʊlz bə'kɒz ʃi:z səʊ 'bɪzi 'wɒrɪŋə'baʊt 'evriθɪŋ els]4
Nella seconda scena, Voldemort sopraggiunge al ministero della
magia per uccidere Harry, ma si affronta invece a duello con
Silente, accorso per salvare il ragazzo. Alla fine, Harry
viene posseduto da Voldemort:
Dumbledore: It was foolish of you to come here tonight, Tom.The Aurors are on their way.
Voldemort: By which time I shall be gone. And you...shall bedead.
Harry: [While being possessed by Voldemort] You, you've lost old man.Dumbledore: Harry.Voldemort: So weak, so vulnerable! Look at me!Dumbledore: Harry, it isn't how you are alike. It's how you are
not! [Pause] Harry.Harry: ...You're the weak one. And you'll never know love, or
friendship. And I feel sorry for you.Voldemort: You're a fool, Harry Potter. And you will lose
everything. (Harry Potter and the order of the phoenix, scene 29)
Ecco la trascrizione fonetica della scena:
4 Per tutte le trascrizioni fonetiche, cfr. l’applicazione online PhoTransEdit.
28
Dumbledore: [ɪt wɒz 'fu:lɪʃ ɒv ju: tə: kʌm hi:ə tə:'nait tɒmði: 'ɔ:rəz ɑ:rɒn ð eiə wei]
Voldemort: [bai wɪtʃ taim ai ʃæl bi: gɒn ænd ju: ʃæl bi: ded]Harry: [ju: ju:v lɒst əʊld mæn]Dumbledore: ['hæri]Voldemort: [səʊ wi:k səʊ 'vʌlnəbl lʊk æt mi:]Dumbledore: ['hæri ɪt ɪznt haʊ ju: ɑ:rə'laik ɪts haʊ ju: ɑ: nɒt
'hæri]Harry: [jʊ ðə wi:k wʌn ænd ju:l 'nevə nəʊ lʌv ɔ: 'frendʃɪp ænd
ai fi:l 'sɒri fɔ: ju:]Voldemort: [jʊrə fu:l 'hæri 'pɒtə ænd ju: wɪl lu:z
'evriθɪŋ]
Come già ripetuto più volte nei vari passaggi di questa tesi,
gli attori che interpretano un determinato ruolo nel cinema
vengono scelti anche in base al loro modo di parlare, poiché
il loro particolare accento caratterizza il personaggio che
essi incarnano. Cerchiamo di capire quali sono le ragioni per
cui tutti e quattro i personaggi di Harry, Hermione, Voldemort
e Silente utilizzano un accento che potremmo definire quasi
impeccabile dal punto di vista fonetico. Per farlo, è
necessario ricordare una frase di Crystal esposta al paragrafo
2.3.: “The medium of instruction and criterion of successful
performance is standard English”. Come già detto infatti,
secondo Crystal chi adopera un accento inglese standard viene
visto come portatore di una grande personalità, oltre che in
possesso di notevole cultura. Quest'ultima condizione si
applica perfettamente a tutte e quattro le figure in
questione: tutti e quattro sono dei leader e tutti e quattro
sono alquanto intelligenti e dotati dal punto di vista
29
dell'abilità magica. Vediamo di esaminarli singolarmente.
1) Voldemort: è indubbiamente il capo sotto tutti i punti di
vista del suo gruppo di seguaci, da lui chiamati
Mangiamorte (Deatheaters nell'originale). Egli dà ordini
e si fa obbedire, incutendo timore e punendo chi
contravviene alle sue regole o semplicemente chi fallisce
nel portare a compimento i suoi piani, come appare
evidente già dal primo libro della saga, dove nel
penultimo capitolo il professor Raptor (Quirrell
nell'originale), sostenitore dell'oscuro mago, spiega
come il suo “padrone” sia stato spesso duro con lui
quando commetteva degli errori: “[...] I have let him
down many times. He has had to be very hard on me. [...]
He does not forgive mistakes easily. When I failed to
steal the stone from Gringotts, he was most displeased.
He punished me...” (J.K. Rowling, 234)
Il timore che Voldemort incute ai suoi Mangiamorte deriva
in buona parte anche dalla sua immensa abilità come mago,
abilità che si è manifestata fin dai tempi in cui iniziò
a studiare alla scuola di Hogwarts e di cui egli è
pienamente cosciente. La consapevolezza delle proprie
grandi capacità lo hanno portato spesso ad
autoproclamarsi il più grande mago del mondo;
2) Silente: personalità dominante sotto più aspetti. Egli è
il capo sia della scuola di Hogwarts, essendone il
preside fin da prima della nascita del protagonista, sia
di una società segreta fondata da lui stesso che si
30
contrappone all'operato di Voldemort e dei suoi seguaci,
società chiamata Ordine della fenice (Order of the
phoenix nell'originale). A differenza di Voldemort, però,
le sue qualità di leader nella maggior parte dei suoi
studenti e dei suoi colleghi non infondono paura, bensì
un profondissimo rispetto, che deriva anche nel suo caso
dalle sue impressionanti potenzialità magiche e dalla sua
intelligenza. Dalla lettura dei vari romanzi possiamo
trovare più testimonianze di ciò, che vanno dalle sue
innumerevoli invenzioni e scoperte scientifiche fino ai
suoi duelli con altri pericolosi maghi oscuri, da lui
sempre battuti. In particolare, nel sesto capitolo del
primo libro, si legge: “Considered by many the greatest
wizard of modern times, Dumbledore is particularly famous
for his defeat of the dark wizard Grindelwald in 1945,
for the discovery of the twelve uses of dragon's blood,
and his work on alchemy with his partner, Nicholas
Flamel.” (J.K. Rowling, 81) Come già accennato nel primo
capitolo di questa tesi, proprio per il suo valore
Silente è l'unico mago che Voldemort teme;
3) Harry: rappresenta certamente l'asse portante del suo
piccolo gruppo, composto da lui stesso e dai suoi due
migliori amici, Ron e Hermione. È infatti lui la mente
della maggior parte dei piani che i tre organizzano per
affrontare le sfide che si presentano sul loro cammino.
Nel settimo libro, da un litigio tra Harry e Ron, appare
chiaro come quest'ultimo e Hermione sembrano quasi
dipendere dal protagonista per portare a termine le loro
31
missioni: “We thought you knew what you were doing! [...]
We thought you had a real plan! (J.K. Rowling, 266)
Viene inoltre affermato più volte nel corso dei romanzi
come Harry sia un mago molto valido e molto brillante per
la sua età, (alla conclusione del ciclo, ha infatti
appena 17 anni). Egli è in grado di produrre magie molto
avanzate per un ragazzo così giovane, e dimostra di
sapere tenere testa più che egregiamente a maghi molto
più anziani ed esperti di lui. Non a caso, è infatti
riuscito a sfuggire al suo nemico mortale per un
considerevole numero di volte, un'impresa, come detto da
Silente nel quinto volume della saga, mai riuscita a
nessun altro prima di lui. Ma oltre alle mere abilità
magiche, il vero punto di forza di Harry è il suo
coraggio, che gli permette di agire sempre con la massima
lucidità anche di fronte alle situazioni più drammatiche;
4) Hermione: anche lei può essere considerata assolutamente
una leader, seppure in maniera diversa rispetto agli
altri tre. Se è vero infatti che non si trova “a capo” di
nessun gruppo, è anche vero però che all'interno dei
romanzi ella rappresenta senza dubbio il personaggio
femminile più importante di tutta la storia, ed è grazie
a lei e alle sue intuizioni che al lettore vengono
chiariti alcuni dei punti più oscuri della trama.
Hermione, inoltre, essendo una ragazza altamente posata e
riflessiva, agisce da influsso moderatore tra i suoi due
amici Harry e Ron (entrambi dal carattere molto più
impulsivo ed impetuoso), e qualora essi volessero
32
compiere azioni troppo avventate, riesce il più delle
volte con i suoi consigli a richiamarli all'ordine. È
anche dotata di grande astuzia e dedizione allo studio,
caratteristiche che nell'ambito scolastico le permettono
di apprendere velocemente; è per questo unanimemente
vista dai suoi compagni e dai suoi insegnanti come una
strega molto capace e molto competente. “You're the
cleverest witch of your age I've ever met, Hermione”:
queste sono le parole che alla pagina 290 del terzo libro
della saga, “Harry Potter and the prisoner of Azkaban”,
le rivolge un suo professore.
In conclusione quindi, quanto sostenuto da me alla pagina 18
di questa tesi viene confermato dai brevi profili appena
tracciati: tutte e quattro queste figure sono personalità
dominanti e tutte e quattro sono in possesso di
un'intelligenza non indifferente e di capacità fuori dal
comune. Pertanto, è probabile che questi loro tratti
distintivi si riflettano anche nel loro modo di parlare, ed è
per questo che nelle trasposizioni cinematografiche essi
vengono interpretati con un accento inglese assolutamente
“standard”.
3.3. Gli accenti “non standard”: Ron
L'accento del migliore amico di Harry Potter, Ron Weasley
(il cui ruolo è affidato nelle trasposizioni cinematografiche
all'attore Rupert Grint, originario di Watton-at-Stone,
nell'Hertfordshire), è a mio parere uno dei più interessanti
33
da analizzare. Pur essendo una figura importante della storia
infatti, Ron, a differenza degli altri personaggi di cui
abbiamo discusso nel paragrafo precedente, ha un'inflessione
del suo parlato piuttosto lontana dallo “standard English”.
Questo lo si evince immediatamente da alcune sue battute
tratte da una scena del settimo film della saga, battute che
ho poi di nuovo trascritto in simboli fonetici. Nella scena in
questione, Ron e Harry hanno un diverbio abbastanza acceso:
All right, I'll spit it out. But don't expect me to be gratefuljust because now there's another damn thing we've gotta find.[...] We're about as close to getting rid of it as we are to
finding the rest of them, aren't we? (Harry Potter and thedeathly hallows part 1, scene 16)
Ecco la trascrizione fonetica della scena:
[ɔ:l'rait ail spɪt ɪʔ aʊʔ bʌt dəʊ:n ɪcs'pect mi: tə bi:'greitfʊl ʤʌst bə'kɔ:z naʊ ðeəz ə'nʌðə dæm θɪŋ wi:v 'gɒʔə faindwi:rə'baʊʔ æz kləʊs tə 'geʔɪŋ rɪd ɒv ɪt æz wi: ɑ: tə 'faɪndɪŋ ðərest ɒv ðəm ɑ:nʔ wi:]
3.3.1. Il “glottal stop”
Come si nota, nella trascrizione di cui sopra è presente
per ben sei volte un simbolo fonetico che non occorreva in
nessuna delle espressioni precedenti, poiché non fa parte
dell'inglese “standard”: il simbolo [ʔ], definito in
linguistica “glottal stop”. Si tratta in sostanza di una
consonante occlusiva glottidale, la cui articolazione avviene
appunto nella glottide (o laringe), attraverso una brusca
apertura delle pliche vocali; non è mai accompagnata da
34
vibrazione laringea.5
Nella lingua inglese il “glottal stop” si verifica soprattutto
con la mancata pronuncia della “t”6 (per dirla nei termini di
Crystal, “the dropping of the t”), sia che essa si trovi in
posizione intervocalica o in posizione finale.
Perché il personaggio di Ron fa uso di questo tipo di accento
così lontano dai canoni della fonetica inglese? Le ragioni
principali che si possono addurre (e che verranno esaminate
nel dettaglio nei paragrafi che seguono) sono da ricercarsi
sostanzialmente nei suoi tratti caratteriali e nella sua
situazione familiare.
3.3.2. Lealtà e simpatia
La prima motivazione che possiamo trovare per spiegare la
particolarità dell'accento di Ron va rintracciata alla pagina
9 di questa stessa tesi, in cui si legge: “Chi fa uso invece
di accenti associabili a classi sociali più basse e di
dialetti più periferici, è molto probabile che venga visto
come portatore di integrità morale ed è capace di esercitare
un certo fascino attrattivo sugli altri parlanti”.
Integrità morale e fascino attrattivo: due condizioni che
calzano a pennello al nostro Ron. Nell'arco di tutti e sette i
romanzi egli appare come un personaggio immancabilmente buono
e pulito. Il suo miglior pregio è la lealtà verso gli amici,
che lo porta ad appoggiarli incondizionatamente e a schierarsi
dalla loro parte quando ne hanno più bisogno. Significativa al
5 Cfr. Leoni e Maturi, pag. 61.6 Cfr. Sivertsen, pag. 111.
35
riguardo è la trama del secondo volume della saga, in cui
Harry per un breve periodo viene accusato da tutta la scuola
(a torto) di essere il responsabile delle aggressioni ai danni
di alcuni suoi compagni. In quella circostanza, Ron, migliore
amico del ragazzo, è uno dei pochi che credono alla sua
innocenza.
Ron non ha di fondo un carattere coraggioso come quello del
protagonista, ma appunto il suo forte senso della lealtà lo
costringe a sfidare le sue peggiori paure per aiutare le
persone a cui tiene, come accade sempre nel secondo libro
della saga. Nel quindicesimo capitolo, infatti, egli deve
affrontare il suo terrore per i ragni per cercare di scoprire
la verità riguardo ai crimini commessi all'interno della
scuola, crimini che hanno portato ingiustamente all'arresto di
Hagrid, il guardiacaccia della scuola a cui Harry, Ron e
Hermione sono molto affezionati.
Il fascino che questo personaggio esercita, oltre che dalla
sua lealtà, scaturisce indubbiamente anche dalla sua simpatia
e dal suo umorismo. Ron fin dalle prime pagine dei romanzi
viene descritto come un adolescente immensamente divertente e
capace di trasmettere allegria a coloro che lo circondano.
Queste sue qualità vengono evidenziate nel quarto volume della
saga, in cui Harry, dopo un litigio con Ron, mette
quest'ultimo a confronto con Hermione: “Harry liked Hermione
very much, but she just wasn't the same as Ron. There was much
less laughter and a lot more hanging around in the library
when Hermione was your best friend”. (J.K. Rowling, 315)
Riassumendo quindi, l'integrità e il fascino di Ron sono due
36
fattori che, stando alle teorie linguistiche di Crystal,
contribuiscono a rendere il suo accento così poco fedele alle
norme della fonetica inglese.
3.3.3. Precarietà economica
Il secondo motivo per cui Ron nelle pellicole
cinematografiche viene interpretato con un accento inglese
“non standard” va ricercato nella situazione finanziaria dalla
quale questo personaggio, nella finzione letteraria, proviene.
Nel capitolo 2 di questo documento viene ripetuto più volte
come la differente appartenenza di classe economica vada ad
influenzare il nostro modo di parlare: più in basso si scende
nella scala sociale, maggiore è la distanza dai canoni
fonetici prestabiliti (si rimanda, al riguardo, alla tabella a
pagina 12 sul fenomeno “the dropping of the h”).
Dalla descrizione fornitaci dalla Rowling appare evidente che
le possibilità finanziarie in cui versa Ron non sono delle
migliori. La sua famiglia è composta da nove persone: lui, i
suoi genitori, i suoi cinque fratelli maggiori e sua sorella
minore. Il padre Arthur ha un lavoro da impiegato al
ministero, ma le mansioni di cui quotidianamente si occupa non
sono delle più redditizie. Molly, moglie di Arthur, è una
casalinga. Quando il personaggio di Ron ci viene introdotto
(cioè nel primo volume, in procinto di frequentare il suo
primo anno a Hogwarts), solo due dei suoi fratelli, Bill e
Charlie, hanno già preso il diploma di magia e si sono resi
economicamente indipendenti, mentre tutti gli altri devono
ancora completare gli studi. A causa delle condizioni poco
37
agiate in cui si trova quindi, Ron è costretto ad utilizzare
abiti, libri e strumenti magici di seconda mano. Ciò gli
provoca spesso un certo imbarazzo, soprattutto nei confronti
del suo migliore amico Harry, che seppure orfano, è invece in
possesso di una vera e propria fortuna, ereditata dai suoi
defunti genitori. Nel quarto libro della serie manifesta così
la sua insofferenza verso le sue precarie origini: “Must be
nice to have so much money you don't notice if a pocketful of
Galleons goes missing. [...] I hate being poor. It's rubbish.
I don't blame Fred and George for trying to make some extra
money. Wish I could”. (J.K. Rowling, 540)
È legittimo supporre, in definitiva, che la bassa estrazione
sociale di Ron abbia avuto delle ripercussioni sulle sue
caratteristiche linguistiche, e il suo accento nei film di
Harry Potter viene quindi riprodotto come altrettanto basso
anche per questa ragione.
3.6. Uno studente “giovane”
Vi è una terza spiegazione che potremmo addurre per
giustificare le peculiarità fonetiche di Ron. Ripensiamo un
attimo a quanto asserito da Crystal circa status e ruoli
all'interno della comunità: dallo status specifico che si
riveste nella propria famiglia o nel proprio luogo lavorativo,
ne deriva un ruolo specifico che determina modalità
comportamentali specifiche, e per esteso, modalità
linguistiche specifiche. Maggiori sono le responsabilità che
ricopre un individuo quindi, maggiore risulta essere la sua
proprietà di linguaggio (anche a livello fonetico).
38
Nel caso di Ron, dal paragrafo precedente appare chiaro quale
sia il suo status all'interno della struttura sociale: non ha
un'occupazione professionale, in quanto è ancora un semplice
studente, e nella sua famiglia rappresenta il figlio maschio
più giovane. Egli, in sostanza, è esente da grosse
responsabilità e può pertanto permettersi di attuare un
comportamento meno rigoroso, che va ad influenzare anche il
suo modo di parlare.
3.4. Gli accenti “non standard”: i gemelli Weasley
È possibile riscontrare un accento “non standard” anche
nei personaggi di Fred e George (interpretati dagli attori
James e Oliver Phelps, nati a Birmingham nel 1986), due
gemelli omozigoti che nella finzione letteraria sono due dei
fratelli di Ron. Nonostante il legame di sangue che intercorre
tra di loro e l'appartenenza al medesimo gruppo familiare
tuttavia, il parlato di Fred e George, sotto il profilo
fonetico, ha pochi connotati in comune con quello di Ron e per
la maggior parte ne differisce in maniera considerevole.
Vediamo con la conversazione di cui sotto, tratta dal terzo
episodio della serie, di capire perché.
Fred: Nicked it from Filch's office of course, first year. George: Now listen, there are seven secret passageways out of
the castle; we'd recommend...Fred and George: ...this one. George: The one-eyed witch passageway, it'll lead you straight
to Honeydukes cellar. Fred: But you'd best hurry, Filch is heading this way. George: Oh, and Harry don't forget: when you done, just give it
a tap and say...
39
Fred and George: ...“Mischief managed”, otherwise anyone canread it. (Harry Potter and the prisoner of Azkaban, scene 167)
Ecco la trascrizione fonetica della scena:
[nɪkt ɪɁ frɒm fɪlʧǝz 'ɒfɪs ɒv kɔ:s fɜ:st jiǝ naʊ 'lɪsǝn ðerɑ:sevən 'sɪkrɪt 'pӕsǝʤweiz aʊt ɒv ðǝ kɑ:səl wi:d rǝkǝ'mend ðɪswʊn ðǝ wʊn aid wɪʧ 'pӕsǝʤwei ɪtl lid ju: streit tə hʌni dju:ks 'selə bəɁ ju:d best hʊri fɪlʧ ɪz 'hedɪŋ ðɪs wei ǝʊ ænd 'hӕridǝʊn fǝ'get wen ju: dʊn ʤʊst gɪv ɪt ə tӕp ænd sei 'mɪsʧi:f'mӕnɪʤd 'ʌðǝwaiz 'eniwʊn kӕn ri:d ɪt]
Da queste poche righe emerge che ad eccezione di “honey” e
“otherwise” (pronunciate “correttamente”), le altre parole che
nell'inglese “standard” contengono il fono [ʌ] vengono invece
riprodotte dai gemelli con il fono [ʊ]. Nello specifico:
[wʊn] e ['eniwʊn] al posto di [wʌn] e [eniwʌn][hʊri] al posto di [hʌri][dʊn] al posto di [dʌn][ʤʊst] al posto di [ʤʌst]8
L'accento di Fred e George appare quindi in netto contrasto
con quello di Ron, poiché come si rileva dalla scena che
abbiamo esaminato alla pagina 21 di questa tesi, il migliore
amico di Harry non sostituisce mai a [ʌ] il suono [ʊ].
Inoltre, Ron faceva un maggiore utilizzo del fono [Ɂ] (nella
scena che ho portato come esempio si ripeteva per sei volte),
mentre nel caso dei gemelli è presente solo in due occasioni.
Alla luce di quanto detto fino ad ora, gli interrogativi che
dobbiamo porci sono a questo punto numerosi: perché Fred e
7 Nella scena in questione, Fred e George stanno consegnando a Harry una mappa incantata che gli permetterà di recarsi di nascosto al villaggio vicino alla scuola.
8 Cfr. Oxford English Dictionary.
40
George non si esprimono con un accento “standard”? Perché non
fanno un uso regolare del suono [ʊ], ma lo alternano invece a
[ʌ]? Perché, pur essendone fratelli, l'inflessione del loro
parlato si distingue da quella di Ron? Le risposte a queste
domande sono fornite nei paragrafi seguenti.
3.4.1. Positività d’animo e marginalità letteraria
Le motivazioni per le quali i gemelli Weasley nelle serie
cinematografiche di Harry Potter sono contraddistinti da un
accento non canonico risiedono, ancora una volta, nella loro
moralità, nel loro fascino attrattivo (che deriva anche in
questo caso dalla loro simpatia) e nella situazione economica
da cui provengono. Di quest'ultima ho già ampiamente trattato
a pagina 23, e pertanto non aggiungerò ulteriori dettagli.9 Per
quanto riguarda invece le altre due caratteristiche,
esattamente come il loro fratello Ron, Fred e George sono da
considerarsi due personaggi estremamente positivi e piacevoli.
Essi infatti non sono mai attratti dalle forze del male e
posseggono un forte senso della lealtà. Sono inoltre sempre
fedeli ai giusti, che supportano in ogni circostanza. Un
esempio di ciò lo possiamo ritrovare nel quinto episodio della
serie, in cui Hermione, a causa della mancanza di competenza
di una professoressa della scuola, chiede a Harry di insegnare
a lei e ad altri compagni alcune magie difensive che
permettano loro di proteggersi nel caso venissero aggrediti.
Nel sedicesimo capitolo, un ragazzo di nome Zacharias Smith
9 Dato che Fred e George sono i fratelli di Ron, ne consegue che tutti e tre condividono il medesimo stato di precarietà finanziaria.
41
mette in discussione le reali capacità del protagonista
(“[...] We've all turned up to learn form him and now he's
telling us he can't really do any of it”), e questo è ciò che
i due gemelli gli rispondono: “That's not what he said. Would
you like us to clean out your ears for you?”. (J.K. Rowling,
307).
Oltre a queste loro qualità morali, i gemelli Weasley sono
senza ombra di dubbio i personaggi più comici dell'intera
saga. Dentro la scuola di Hogwarts sono conosciuti per essere
dei veri burloni, e il loro talento per combinare guai supera
di gran lunga la loro predisposizione agli studi. Questo loro
talento si tramuterà nel futuro nel loro mestiere effettivo:
apriranno infatti un negozio di scherzi a Diagon Alley, un
villaggio magico situato a Londra.
C'è infine un'ultima ragione per giustificare l'accento “non
standard” di Fred e George, ed è da ricercarsi nella funzione
che i due fratelli svolgono all'interno dei romanzi di Harry
Potter. A differenza dei personaggi che abbiamo analizzato
precedentemente, i due gemelli non hanno un'importanza
fondamentale ai fini della trama, poiché il ruolo che essi
esercitano è piuttosto secondario; rispetto ad altre figure
primarie quindi, le responsabilità che ricoprono per gli
sviluppi della storia, a livello simbolico, sono molto più
ridotte.
3.9. Espressioni “private” e giochi di suono
La risposta agli ultimi due interrogativi che ci eravamo
posti alla fine del paragrafo 3.4. la possiamo rintracciare
42
nelle parole di Crystal riportate alla pagina 14 di questa
tesi, in cui si legge in particolare che i fratelli gemelli
“dipenderebbero esclusivamente l'uno dall'altro per apprendere
le principali strutture morfo-sintattiche e lessicali. In una
simile situazione, crescendo e passando la maggior parte del
tempo insieme, non è affatto infrequente che molti gemelli
sviluppino forme di comunicazione assolutamente 'private'”.
Nel caso specifico di Fred e George Weasley, il loro modo
“privato” di comunicare si tradurrebbe in un'inflessione del
parlato divergente da quella dei familiari più stretti, e
sarebbe dunque questo il motivo principale per cui il loro
accento inglese non è assolutamente accomunabile a quello di
Ron.
Crystal proseguiva poi il suo discorso sul linguaggio dei
gemelli affermando che, nel periodo dell'infanzia, essi si
esprimono attraverso una serie di “giochi fonetici”. Ebbene,
non è lecito supporre che il continuo alternarsi del fono [ʊ]
con il fono [ʌ], di cui prima abbiamo fatto menzione, sia il
risultato di un gioco fonetico che Fred e George mettevano in
atto quando erano bambini?
3.4.3. Proposizioni a metà
Prima di terminare la mia analisi delle caratteristiche
linguistiche di Fred e George, vorrei puntare un momento
l'attenzione su quanto scritto nell'ultima parte del paragrafo
2.8.: [...] I gemelli abitualmente, piuttosto che parlare in
contemporanea, si dividono in parti eque una stessa frase. La
loro capacità di sincronizzazione è sorprendente: se il primo
43
sa esattamente quando e dove interrompersi, il secondo riesce
a completare in maniera soddisfacente e nelle giuste
tempistiche quanto appena detto dal fratello”.
Questa condizione si riscontra anche nelle interazioni dei
gemelli Weasley. In una scena del terzo film della saga, Ron
fa vedere ai suoi amici Harry e Hermione un ritaglio di
giornale raffigurante lui e la sua famiglia in vacanza in
Egitto. Fred e George lo prendono in giro dicendo che non l'ha
mostrato a nessun altro prima di loro,
Fred: Not unless you count Tom...George: The day maid...Fred: The night maid...George: That bloke who fixed the toilet...Fred: And that wizard from Belgium! (Harry Potter and the
prisoner of Azkaban, scene 6)
Come si può notare, sia Fred che George spezzettano le varie
frasi, lasciandole in sospeso in determinati punti. L'uno
ricomincia da dove l'altro si era arrestato, con sicurezza e
senza alcun tipo di esitazione, ed entrambi si dimostrano in
grado di concludere più che correttamente i propri pensieri.
3.5. Gli accenti “non standard”: Scabior
L'ultimo accento che esamineremo prima di porre fine a
questo capitolo è quello di Scabior, interpretato al cinema
dall'attore londinese Nick Moran.
Scabior è un personaggio comparso solo nell'ultimo libro della
saga, e funge, in un certo senso, da aiutante dei cattivi.
Egli ha il compito di scovare, dietro compenso, tutti i
44
Mudblood, cioè maghi e streghe discendenti da una famiglia non
magica (che sono spesso oggetto di razzismo da parte degli
altri maghi), e portarli al ministero, dominato ormai da
Voldemort e i suoi seguaci, per farli processare e condannare.
La pronuncia che nel settimo film Scabior applica alla propria
lingua è veramente curiosa e particolare, come palesa la scena
che segue, in cui lui e un altro gruppo di maghi riescono a
catturare Harry, Ron e Hermione:
(To Hermione) Hello beautiful. [...] Your boyfriend will getmuch worse than that if he doesn't learn to behave himself. (Toa transfigured Harry) What happened to you, ugly? [...] What's yourname? (Harry Potter and the deathly hallows, scene 26)
Ecco la trascrizione fonetica della scena:
[eləʊ 'bju:ʔɪfʊl jɔ: 'bɔ:ifrend wɪl geʔ mʌʧ wɜ:s ðæn ðæt ɪf i:dʌzn lɜ:n tə bə'haiv 'ɪmself wɒʔ 'æpənd tə ju: ʌgli wɒts jɔ:naim]
3.5.1. Il Cockney
Dalle brevi battute appena prese in considerazione si
intuisce che l'accento di Scabior è, tra tutti quelli che
abbiamo in precedenza analizzato, forse il più lontano dalle
norme fissate dalla fonetica inglese. Difatti, oltre al
fenomeno del glottal stop, che costituiva uno dei tratti
peculiari di Ron e che è qui presente in maniera più
consistente, ci sono altri due elementi che contribuiscono a
rendere l'inflessione di Scabior del tutto “non standard”: la
mancata aspirazione dell'h (ossia il cosiddetto “dropping of
45
the h”), e la diversa pronuncia del dittongo [ei], resa in
questo caso come [ai]. Queste due componenti insieme sono tra
gli ingredienti principali10 del Cockney, una parlata tipica
della classe proletaria di Londra, che si verifica soprattutto
nella zona dell'East End.
Nel paragrafo che segue verranno approfondite le ragioni che
sussistono dietro alle scelte degli autori cinematografici di
rappresentare Scabior con un accento Cockney.
3.5.2. Interessi divergenti e ruoli di sfondo
Proprio all'inizio del capitolo 2 è enunciata la teoria
principale di Crystal: le diverse caratteristiche fonetiche di
ognuno di noi, oltre che a individualizzarci, ci permettono di
sentirci partecipi di un determinato gruppo di persone, o al
contrario di sentirci distanti dallo stesso. È precisamente
questo il punto di partenza per spiegare l'inflessione Cockney
di Scabior. Egli infatti si esprime in modo così dissimile
dagli altri personaggi già incontrati (Harry, Ron, Hermione,
Silente, Voldemort e i gemelli Weasley) perché non si sente
solidale con nessuno di loro.
Per tutto il corso del settimo libro viene detto
esplicitamente che il mondo della magia è in guerra e tenta di
resistere alla campagna di terrore messa in atto da Voldemort
e i suoi seguaci. Uno degli obiettivi primari del signore
oscuro è purificare la sua razza dai Mudblood e convertirsi in
una specie di sovrano, dominando, con il consenso o con la
forza, tutto il popolo magico. Tra le molte figure che, per10 Cfr. Wells, pagg. 307-308 e pag. 322.
46
amor del bene, hanno scelto di contrastarlo, troviamo appunto
Harry, Ron, Hermione, Silente e i gemelli Weasley.
Scabior non ha interesse a parteggiare né per il gruppo di
Voldemort (di cui infatti non è diretto alleato), né per il
gruppo che tenta di resistergli. Per lui non ha importanza se
al bene avrà il sopravvento il male o viceversa, non ha
importanza se il signore oscuro sarà sconfitto o se invece
riuscirà a soddisfare la sua sete di potere. Quello che a
Scabior sta a cuore è semplicemente trarre profitto come può
dalle varie situazioni che gli si presentano davanti. Il
Ministero corrotto gli ha offerto una lauta ricompensa per dar
la caccia ai Mudblood, e lui adempie a questo dovere per puro
scopo di lucro e nulla più.
In quest'ottica dunque, è legittimo supporre che Scabior
adotti la parlata del Cockney come un mezzo per enfatizzare
maggiormente la sua posizione di distacco rispetto agli altri
personaggi sopra menzionati, con cui avverte di non avere
nulla in comune. E con loro non ha nulla in comune anche sotto
il profilo del ruolo che riveste all'interno della saga.
Abbiamo già accennato infatti che egli viene per la prima
volta introdotto solo nel volume conclusivo della serie, dove
permane nello spazio di un capitolo per poi sparire dalla
storia senza più rientrarne. Questo, a mio parere, è già
sufficiente a relegarlo come personaggio di sfondo, in quanto
nei romanzi Scabior ha una rilevanza del tutto minima, ancora
minore rispetto a quella di Fred e George, che per lo meno
compaiono in tutti e sette i libri. Il peso quasi
inconsistente che Scabior riveste nella saga costituisce
47
quindi, potenzialmente, il secondo motivo per cui egli viene
interpretato con un accento Cockney.
4. CONCLUSIONI
4.1. Premessa
In questo quarto e ultimo capitolo, articolato in due
parti distinte, verranno tirate un po' le somme di tutto il
discorso fin qui sostenuto.
Nella prima parte sono riassunti i punti chiave del mio
studio, relativi soprattutto al tipo di accento parlato dai
personaggi e alle supposte motivazioni per le quali essi
comunicano in un determinato modo, con un veloce riferimento
anche alle teorie linguistiche utilizzate a sostegno delle mie
ipotesi.
Nella seconda parte, che si configura come la conclusione vera
e propria di questo documento, vengono espresse delle
ulteriori deduzioni sullo stretto legame che vi è tra
inflessioni fonetiche e ruoli cinematografici. Sono inoltre
messe a nudo anche alcune pecche e debolezze che possono
48
essere presenti in questo lavoro di ricerca, proprio per
fornire le basi per una riflessione più accurata su un tema
vasto come quello scelto, che avrebbe sicuramente meritato di
essere discusso con più ricchezza di particolari.
4.2. Sintetizzando...
È apparso già evidente come i diversi accenti che abbiamo
illustrato nel capitolo precedente riflettano in toto la
psicologia dei personaggi dei film di Harry Potter, che
vengono in qualche modo particolareggiati dalle loro stesse
inflessioni del parlato. Vediamo di riassumere brevemente in
che misura ciò si verifica per ognuno degli otto ruoli sui
quali ho maggiormente rivolto l'attenzione.
1) Harry, Silente, Voldemort e Hermione: ognuno dei quattro
possiede, in maniera differente, qualità di leader ed
elevate capacità intellettive, due connotati che
risaltano costantemente e regolarmente durante il corso
dei romanzi. Un accento prevalentemente standard, stando
alle teorie discusse nel capitolo 2, appare quindi essere
il migliore per evidenziare in modo potenziato questa
loro forte personalità;
2) Ron: i suoi pregi più grandi sono l'integrità morale, che
si traduce in fiducia e lealtà verso i propri cari, e la
simpatia, che è spesso un'arma vincente per
sdrammatizzare le situazioni più difficoltose e per
smorzare la tensione a cui per buona parte del tempo sono
sottoposti i protagonisti. Dando adito alle voci più
49
autorevoli della linguistica, queste due caratteristiche
di Ron, unite alle sue umili origini, alla sua condizione
di figlio maschio più giovane e alla sua professione di
studente, sono ancor più messe in luce da un accento non-
standard avente come tratto principale la consonante
occlusiva glottidale [ʔ];
3) Fred e George: come il loro fratello minore Ron,
anch'essi sono dominati da grande moralità, poiché
mostrano di sapere perfettamente distinguere cosa è bene
da cosa è male, e cosa è giusto da cosa è sbagliato. Sono
inoltre l'incarnazione vivente della simpatia, che
sfoggiano in moltissime occasioni con scherzi e dispetti
di ogni sorta. La loro funzione secondaria per gli
sviluppi della storia è un ulteriore motivo che
giustifica la scelta di rappresentarli con un accento
non-standard, accento divergente da quello di Ron
soprattutto per l'adozione, nella maggior parte dei casi,
del fono [ʊ] in sostituzione del fono [ʌ]. Le domande che
ci eravamo posti (perché Fred e George non parlano come
il loro fratello Ron e perché non utilizzano il suono [ʊ]
in maniera uniforme), hanno trovato risposta nella loro
condizione di gemelli, i quali, secondo gli studi di
Crystal, da piccoli apprendono le fondamenta della lingua
l'uno dall'altro (al contrario degli altri bambini, che
invece dipendono dai genitori) e questo può contribuire
quindi a rendere la loro inflessione diversa da quella
degli altri componenti del gruppo familiare. Nel periodo
dell'infanzia inoltre, i gemelli mettono in atto anche
50
dei giochi fonetici. Nel caso di Fred e George, è
risultato appunto plausibile che l'alternarsi dei suoni
[ʊ] e [ʌ] sia una traccia di un loro personale linguaggio
con cui erano soliti interagire da bambini. Ultimo
elemento riscontrabile in Fred e George (e di nuovo nei
gemelli in generale), è la loro tendenza a dividersi in
parti uguali uno stesso enunciato in modo naturale e
istintivo grazie alla profonda conoscenza che hanno l'uno
dell'altro;
4) Scabior: non condivide gli interessi di nessuno dei
personaggi principali della saga, con cui non ha nulla in
comune anche dal punto di vista dell'importanza che
riveste all'interno dei romanzi, dove ha un ruolo del
tutto irrilevante. Sempre tenendo in considerazione le
teorie linguistiche alle quali si è fatto riferimento,
l'accento Cockney, molto lontano dall'inglese standard,
si configura come il più appropriato per enfatizzare la
distanza di Scabior rispetto agli altri protagonisti
della serie.
4.3. Alcune riflessioni
Lo scopo del mio lavoro era quello di sottolineare come in
ambito cinematografico nulla è lasciato al caso, neppure la
parlata degli attori, la quale è anzi un fattore fondamentale
nella costruzione del personaggio da interpretare. I
contributi teorici esposti nel capitolo 2 e applicati poi a
livello pratico nel capitolo 3, avvalorano a mio parere in
pieno la mia tesi, nonostante questo documento possa
51
ovviamente presentare delle limitazioni, prima fra tutte la
vasta entità dell'opera da me scelta per argomentare le mie
ipotesi. Infatti, i reali personaggi che popolano la storia
del maghetto inglese più famoso del mondo sono in quantità
elevatissima, mentre quelli da me qui presi in esame si
riducono ad un numero che in comparazione appare quasi
ridicolo. Alla luce di quest'ultima considerazione quindi, se
si andassero a studiare gli accenti di ogni singolo
protagonista dei film di Harry Potter potrebbero sorgere delle
incongruenze rispetto a quanto affermato fino ad ora in queste
pagine.
Vorrei cercare di respingere la suddetta obiezione che
potrebbe giustamente essere rivolta asserendo che comunque mi
sono concentrata sulle inflessioni fonetiche che reputavo più
curiose e peculiari e che quindi proprio per questo potessero
fornire un più valido supporto alle mie convinzioni.
Focalizzando l'attenzione sulla diversa influenza che i
diversi accenti esercitavano sulla psicologia dei personaggi,
è stato possibile dedurre che maggiori erano i tratti che
questi ultimi condividevano nel modo di comunicare, maggiore
era la probabilità che essi, nella finzione scenica, si
assomigliassero caratterialmente (si veda al riguardo quanto
accade con Harry e Hermione: entrambi hanno inflessioni molto
vicine e – pura e semplice coincidenza? – un bellissimo
rapporto di amicizia). Viceversa, più i protagonisti
differivano nella maniera di esprimersi e più i punti di
contatto nei loro comportamenti venivano a mancare. Per dar
credito a quest'affermazione, basti pensare per esempio ai
52
ruoli di Ron e di Scabior: entrambi manifestano un certo
interesse per il denaro, ma mentre il primo, alla fine del
ciclo, riesce a capire che la ricchezza materiale non è e non
può essere ciò che più conta nella vita, il secondo è disposto
a tutto pur di ottenere dei guadagni, e agisce secondo il
detto “Il fine giustifica i mezzi”.
L'argomento trattato è a mio modesto giudizio decisamente
interessante, e la mia personale speranza pertanto è che
questo lavoro, come tutte le indagini, possa rappresentare uno
spunto per compiere un'analisi più approfondita sul campo,
magari in uno spazio più ampio, in maniera più completa e con
una competenza migliore di quella dimostrata.
BIBLIOGRAFIA
Bernstein, Basil. Class, codes, and control. London: Routledge & Kegan
Paul, 1971.
Chambers, J.K., Peter, Trudgill. Dialectology. Cambridge: Cambridge
University Press., 1980.
Cheshire, Jenny. “Variation in the Use of Ain’t in an Urban
British English Dialect”. Trudgill, Peter, J.K., Chambers (a
cura di). Dialects of English: Studies in Grammatical Variation. London:
Longman, 1991, pp. 54-73.
Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge:
Cambridge University Press, 1987.
53
Galsworthy, John. Maid in Waiting. London: W. Heineman, 1931.
Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part V.
Copenhagen: Ejnar Munksgaard, 1940.
Labov, William. “Objectivity and Commitment in Linguistic
Science; The Case of the Black English Trial in Ann Arbor”.
Language in Society, 11 (2), Aug., 1982, pp. 165-201.
Leoni, Federico Albano, Pietro Maturi. Manuale di Fonetica. Roma:
Carocci, 1995.
Rowling, J.K. Harry Potter and the Chamber of Secrets. London:
Bloomsbury, 1998.
---. Harry Potter and the Deathly Hallows. London: Bloomsbury, 2007.
---. Harry Potter and the Goblet of Fire. London: Bloomsbury, 2000.
---. Harry Potter and the Half Blood Prince. London: Bloomsbury, 2005.
---. Harry Potter and the Order of the Phoenix. London: Bloomsbury, 2003.
---. Harry Potter and the Philosopher’s Stone. London: Bloomsbury, 1997.
---. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. London: Bloomsbury, 1999.
Sivertsen, Eva. Cockney Phonology. Oslo: University of Oslo, 1960.
Soanes, Catherine, Angus, Stevenson. Concise Oxford English Dictionary.
1911. Oxford: Oxford University Press, 2004.
Stevens, Martin. “The Derivation of Ain’t”. American Speech, 29
(3), Oct., 1954, pp. 196-201.
Trudgill, Peter, J.K., Chambers. “Intoduction: English Dialect
Grammar”. Trudgill, Peter, J.K., Chambers (a cura di). Dialects of
English: Studies in Grammatical Variation. London: Longman, 1991, pp. 1-3.
Wells, J.C. Accents of English 2: The British Isles. Cambridge: Cambridge
University Press, 1982.
FILMOGRAFIA
54
Cuarón, Alfonso. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. London: Warner
Bros. Pictures, 2004.
Yates, David. Harry Potter and the Deathly Hallows, Part 1. London: Warner
Bros. Pictures, 2010.
---. Harry Potter and the Order of the Phoenix. London: Warner Bros.
Pictures, 2007.
SITOGRAFIA
http://www.photransedit.com/Online/Text2Phonetics.aspx
http://www.photransedit.com/Online/TypeIPA.aspx
55