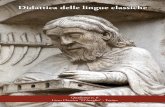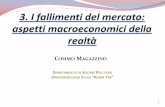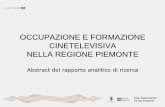l Longobardi in Piemonte : gli aspetti paleobiologici
Transcript of l Longobardi in Piemonte : gli aspetti paleobiologici
NECROPOLILONGOBARDE
IN ITALIAIndirizzi della ricerca e nuovi dati
Atti del Convegno Internazionale26 - 28 settembre 2011
Castello del Buonconsiglio, Trento
a cura di
Elisa Possenti
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
CASTELLO DEL BUONCONSIGLIOMONUMENTI E COLLEZIONI PROVINCIALI
2014
Ugo RossiPresidente della Provincia autonoma di Trento
Tiziano MellariniAssessore alla CulturaProvincia autonoma di Trento
Sergio BettottiDirigente generale Dipartimento Cultura, turismo, promozione e sport
Claudio MartinelliDirigente Servizio Attività Culturali
Atti del Convegno Internazionale Necropoli loNgobarde iN italiaIndirizzi della ricerca e nuovi datiTrento, Castello del Buonconsiglio 26-28 settembre 2011
a cura diElisa Possenti
Curatela redazionale, coordinamento e rapporti istituzionaliCarmen CaloviMichele Dalba
Organizzazione del convegnoUniversità degli Studi di Trento, Dipartimento di Lettere e FilosofiaCastello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali
con il sostegno diProgetto Apsat “Ambiente e Paesaggi dei Siti d’Altura Trentini”RFA - Associazione Culturale RicercheFortificazioni AltomedievaliCassa Centrale Bancacredito cooperativo del nord est
Responsabile scientifico del convegnoUniversità degli Studi di Trento, Dipartimento di Lettere e FilosofiaElisa Possenti
Segreteria organizzativaUniversità degli Studi di Trento, Dipartimento di Lettere e Filosofia Antonella NeriCastello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provincialiAnnamaria Azzolini
Convegno Internazionale realizzato nell’ambito del PROGETTO APSAT“Ambiente e Paesaggi dei Siti d’Altura Trentini”Provincia autonoma di Trentobando “Grandi progetti 2006” delibera G.P. 2790/2006
Provincia autonoma di Trento
Cassa Centrale Bancacredito cooperativo del nord estProgetto APSAT
con il sostegno di:
Franco MarzaticoDirettore Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali
Fulvio FerrariUniversità degli Studi di TrentoDirettore Dipartimento di Lettere e Filosofia
Elisa PossentiUniversità degli Studi di Trento Dipartimento di Lettere e Filosofia
© 2014 Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provincialiTutti i diritti riservati
ISBN 978-88-940135-0-4
Associazione Culturale Ricerche Fortificazioni Altomedievali
15
IntroduzIone ............................................................................................................................................................................................................................................................. p. 31 Elisa Possenti
necropolI longobarde In ItalIa: lo stato della rIcerca ....................................................... » 35Elisa Possenti
la rIcerca e le ultIme scoperte longobarde In pannonIa: una sIntesI .............................................................................................................................................................................................................. » 55Tivadar Vida
la rIcerca sull’età merovIngIa In germanIa sud-occIdentale dopo la seconda guerra mondIale ............................................................................ » 73Dieter Quast
muerte y enterramIentos de los reyes hIspanovIsIgodos ................................................................................................................................................................................................................................................. » 86Raquel Alonso Álvarez
due nuove grandI necropolI In pIemonte........................................................................................................................... » 96Egle Micheletto, Francesca Garanzini, Sofia Uggé, Caterina Giostra
cassano d’adda (mI) e montIchIarI (bs): sepolture con manufattI selezIonatI, sIgnIfIcato socIale e cIrcolazIone dI prodottI ....................................................................................................... » 118Paola Marina De Marchi, Laura Simone Zopfi
recentI rItrovamentI longobardI In terrItorIo bergamasco ............................................................................................................................................................................................................................................... » 137Maria Fortunati (a cura di), Riccardo Caproni, Emiliano Garatti, Angelo Ghiroldi, Monica Resmini, Annalisa Rizzotto, Mariagrazia Vitali
langobard lords In central emIlIa: the cemetery of spIlamberto (modena - northern Italy) ............................................. » 163Paolo de Vingo
I longobardI nel parmense: revIsIone dI vecchI datI e nuove acquIsIzIonI ............................................................................................................ » 188Manuela Catarsi, Cristina Anghinetti, Pietro Baraldi, Danilo Bersani, Luana Cenci, Anna Losi, Patrizia Raggio, Giulia Rebonato, Emma Salvioli Mariani, Licia Usai, Greta Zancan, Paolo Zannini
Indice
16
testimoNiaNze fuNerarie d’età loNgobarda Nel piaceNtiNo e studio prelimiNare della Necropoli di saNt’aNdrea di travo (pc) ................................................................................................................................................................................... p. 228Roberta Conversi, Cristina Mezzadri
la Necropoli di povegliaNo veroNese, loc. ortaia ................................................................................ » 259Caterina Giostra
Nuovi dati dal belluNese iN età loNgobarda: Notizie prelimiNari........................................................................................................................................................................................................................................ » 275Giovanna Gangemi (a cura di), Davide Pacitti, Sara Emanuele, Simone Masier, Paolo Michelini, Paolo Paganotto
la Necropoli di romaNs d’isoNzo. coNsiderazioNi alla luce delle Nuove acquisizioNi e degli studi receNti ................................................................................................................................................................................................................................. » 293Serena Vitri, Donata Degrassi, Davide Gherdevich, Sara Gonizzi, Paola Ventura, Fabio Cavalli, Valentina Degrassi, Annalisa Giovannini, Franca Maselli Scotti
la Necropoli di saN mauro iN rapporto alle altre aree sepolcrali loNgobarde cividalesi ......................................................................................... » 319Isabel Ahumada Silva
la collaNa moNetale della tomba 5 della Necropoli altomedievale di offaNeNgo (cr) e la moNeta iN tomba iN età loNgobarda .............................................................................................................................................................................................. » 339Ermanno Arslan
il sepolcreto altomedievale di poNtedera, località la scafa. primi dati della campagNa 2011 ...................................................................................................................................................................... » 351Sara Alberigi, Giulio Ciampoltrini
Necropoli loNgobarde e d’età loNgobarda Nel maNtovaNo. elemeNti per la coNosceNza Negli scavi dagli aNNi ’90 ad oggi ....................................................................................................................................................................................................................... » 366Elena Maria Menotti
preseNze loNgobarde iN emilia romagNa orieNtale: il puNto sulla questioNe ............................................................................................................................................................................................................. » 380Cinzia Cavallari
i loNgobardi del ducato di spoleto: uN problema di visibilità archeologica Nella ricerca coNtemporaNea .......................................................... » 402Vasco La Salvia
due casi a coNfroNto: borgovercelli e beNeveNto ................................................................................ » 417Marcello Rotili
tradizioNi fuNerarie Nel ducato di beNeveNto: l’apporto delle popolazioNi alloctoNe .......................................................................................................................................... » 445Carlo Ebanista
17
ritrovameNti fuNerari altomedievali iN treNtiNo. uN aggiorNameNto alla luce dei receNti scavi di vervò ...................................................... p. 472Lorenza Endrizzi
ritrovameNti fuNerari altomedievali iN treNtiNo. uN aggiorNameNto alla luce dei receNti scavi di beseNello............................................................................................................................................................................................................................................. » 479Nicoletta Pisu
sepolture, costumi e oratori fuNerari. uN rappreseNtativo caso alpiNo di vi-vii secolo .................................................................................... » 483Enrico Cavada, Francesca Dagostin, Anny Mattucci, Cristina Ravedoni
paesaggi iN trasformazioNe: iNsediameNto loNgobardo, ambieNte e oscillazioNi climatiche Nel treNtiNo orieNtale tra v e vii secolo ......................................................................................................................................... » 504Paolo Forlin
legNi, tessuti, cuoi ed altri materiali orgaNici coNservati Nelle tombe loNgobarde dell’italia setteNtrioNale: lo stato delle ricerche .................................................................................. » 516Mauro Rottoli, Elisabetta Castiglioni
loNgobardi iN piemoNte: gli aspetti paleobiologici ............................................................................ » 532Elena Bedini, Emmanuele Petiti
aspetti aNtropologici, paleopatologici e musealizzabili dei loNgobardi iN lombardia ................................................................................................... » 542Alessandra Mazzucchi, Daniel Gaudio, Emanuela Sguazza, Davide Porta, Cristina Cattaneo
sepolture aNimali iN Necropoli loNgobarde: gli esempi del piemoNte ................................................................................................................................................................................................................ » 550Emmanuele Petiti, Elena Bedini
532
longoBaRdi in piemonte: gli aspetti paleoBiologici
intRoduzione
La sistematica attività di indagine, valorizzazione e tutela effettuata sull’intero territorio regionale da parte della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte ha portato alla luce, negli ultimi due de-cenni, un grande numero di siti archeologici – sia di abitato che sepolcrali – databili al cd. “periodo delle migrazioni” e riferibili su base culturale a popolazioni germaniche alloctone. Dalla ricostruzione della sto-ria di singoli gruppi, sia ostrogoti che longobardi, sono emersi molti nuovi elementi che hanno permesso di gettare luce su alcuni aspetti ancora poco conosciuti dei tempi e delle modalità di occupazione del ter-ritorio e della loro acquisizione di nuove abitudini culturali. Oltre che dalle evidenze archeologiche questi risultati derivano anche dalla continua attività di catalogazione e di analisi paleobiologica – alla quale sta ora affiancandosi quella biomolecolare – dei resti scheletrici rinvenuti nei siti funerari. Già diversi anni fa i dati antropologici allora raccolti permisero di pervenire ad uno studio di sintesi su scala regionale delle caratteristiche fisiche, del lifestyle e del cd. “stato di salute” sia dei gruppi altomedievali di origine germanica che delle popolazioni bassomedievali-rinascimentali piemontesi1, i cui risultati hanno trovato conferma con l’estendersi delle analisi ai materiali dei siti archeologici successivamente portati in luce.
Restringendo l’indagine ai soli gruppi altomedievali culturalmente definibili come longobardi, si di-spone di un insieme di dati paleobiologici relativi complessivamente a 829 individui, vissuti tra gli ultimi decenni del VI secolo e la fine dell’VIII, inumati in siti funerari di varia tipologia. La tab. 1 riporta la
1 malleGni et al. 1998.
ELENA BEDINI, EMMANUELE PETITI
Tab. 1. Elenco dei siti funerari longobardi presi in esame.(n. ind.: numero di individui)
AREE SEPOLCRALI ALL’APERTO
datazione bibliografia archeologica n. ind. edizione analisi
antropologichebibliografia antropologica
Collegno fase 1 570-primi decenni VII sec. 46 pubblicazione parziale
Collegno fase 2 seconda metà VII sec. Pejrani BariCCo 2004a; Pejrani BariCCo 2007 59 (da T. 1 a T. 73) BeDini, BertolDi 2004
Collegno fase 3 VIII sec. 33
Rivoli corso Levi tardo VII-VIII sec. Pejrani BariCCo, suBBrizio 2006 114 dati inediti
Rivoli La Perosa tardo VII-VIII/IX sec. MiCheletto, Pejrani BariCCo 1997 37 pubblicazione parziale Mallegni et al. 1998
Testona Villa Lancia VII sec. Pantò, oCCelli 2009 10 dati inediti
SEPOLTURE IN URBE
datazione bibliografia archeologica n. ind. edizione analisi
antropologichebibliografia antropologica
Chieri Ospedale VII sec. Pantò 2010a 3 pubblicazione finale BeDini, BertolDi, Petiti 2010
Asti Palazzo Mazzetti VI-VII sec. Maffeis, Pistan 2010 4 pubblicazione finale BeDini, Petiti 2010
Alba piazza Risorgimento VII-VIII sec. MiCheletto 1999a 9 pubblicazione finale BeDini 1999
SEPOLTURE PRESSO EDIFICI DI CULTO
datazione bibliografia archeologica n. ind. edizione analisi
antropologichebibliografia antropologica
Gozzano San Lorenzo VII sec. Pantò, Pejrani BariCCo 2001 40 pubblicazione finale BeDini et al. 2005
Dorzano san Secondo VIII sec. Pantò, Pejrani BariCCo 2001 10 dati inediti
Chieri area ampliamento ASL VII sec. Pantò 2010a 120 pubblicazione finale BeDini, BertolDi, Petiti 2010
Chieri Battistero VII-VIII sec. Pantò 1994 48 pubblicazione finale Paglialunga, vitiello 1994
Testona Santa Maria VII-VIII sec. Pantò, Pejrani BariCCo 2001 81 dati inediti
Mombello metà VII-VIII sec. MiCheletto 2007a 45 pubblicazione finale BeDini, Bartoli 2007
Centallo San Gervasio VII sec. MiCheletto, Pejrani BariCCo 1997; 162 pubblicazione finale BeDini et al. 1997
Pantò, Pejrani BariCCo 2001
533
Fig. 1. Planimetria della necropoli di Collegno (da PeJrAni BAriCCo 2007, p. 263, fig. 5).
datazione di ciascun sito archeologico, il numero di individui che compongono i diversi gruppi, la biblio-grafia archeologica di riferimento, lo stato attuale dell’edizione delle analisi antropologiche e la relativa bibliografia.
Nell’impossibilità di presentare per intero, in occasione del Convegno, l’ingente quantità di dati otte-nuti dalle analisi antropologiche, paleopatologiche, paleonutrizionali e paleogenetiche è stato stabilito di focalizzare l’attenzione soltanto su quegli aspetti che sono sembrati particolarmente interessanti per de-finire la struttura demografica dei nuclei stanziati nei vari insediamenti e il ruolo che essi effettivamente esercitavano: la composizione per età e genere dei gruppi che hanno utilizzato le diverse aree sepolcrali, il grado di impegno fisico sostenuto dagli uomini e la frequenza e gravità delle patologie traumatiche da essi subite, rappresentate soprattutto da lesioni da combattimento. (E.B., E.P.)
1. composizione dei gRuppi peR età/geneRe Nessuno dei gruppi presi in esame presenta una composizione per età e genere che possa essere
considerata rappresentativa di una comunità di abitato, composta quindi da un certo numero di nuclei familiari. Questa considerazione si basa su due caratteristiche che si ripetono in tutti i siti esaminati: la relativa scarsità dei soggetti infantili e l’evidente disequilibrio tra numero di adulti maschili e femminili.
Nelle aree sepolcrali all’aperto2 (fig. 1) la frequenza della mortalità in età evolutiva varia da un minimo dell’8,1% a Rivoli La Perosa a un massimo del 25,4% nella seconda fase di utilizzazione della necropoli di Collegno (fig. 2). Questi valori relativamente bassi, anche se non irrealistici, sembrano presentare una correlazione diretta con l’entità numerica dei diversi gruppi: in quelli più numerosi, infatti, la mortalità infantile e giovanile tende ad essere maggiormente rappresentata. La situazione non appare sostanzialmente diversa nel caso delle inumazioni presso gli edifici di culto (fig. 3): si riscontrano infatti valori analoghi ai precedenti, compresi tra l’8,6% di Santa Maria di Testona e il 28,6% del San
2 Sono ovviamente esclusi da queste considerazioni i piccoli gruppi di sepolture.
534
Fig. 2. Frequenza percentuale della mortalità in età evolutiva nei siti funerari all’aperto(n.: numero di individui).
Fig. 3. Frequenza percentuale della mortalità in età evolutiva nei siti funerari presso edifici di culto (n.: numero di individui).
Gervasio di Centallo. Anche in questi contesti funerari i valori tendono ad essere più elevati nei gruppi più numerosi. È comunque possibile che queste frequenze rappresentino stime per difetto dell’effettiva incidenza dei decessi in età infantile: soprattutto nei siti che hanno subito, anche in antico, pesanti interventi di disturbo e rimaneggiamento dei depositi archeologici, resti scheletrici infantili possono infatti essere andati distrutti.
Anche se la mortalità infantile tende a essere più visibile nelle serie scheletriche più numerose, questo non significa necessariamente che in quei gruppi essa fosse effettivamente maggiore. Nel caso delle chiese di piccole dimensioni come San Lorenzo di Gozzano, infatti, è possibile che la maggior parte delle sepol-ture infantili si situasse non all’interno, ma all’aperto e nella parte più periferica rispetto agli edifici di culto dell’area cimiteriale, non indagata in scavi archeologici di limitata estensione. Questa ipotesi sembra trovare conferma nel caso delle sepolture della chiesa di Mombello (fig. 4): quelle infantili si localizzano esclusivamente nell’area antistante la facciata e non all’interno dell’edificio. Le poche deposizioni infantili praticate all’interno delle chiese sepolcrali rispondevano probabilmente a particolari criteri di selezione, verosimilmente in primo luogo al rango sociale delle famiglie cui essi appartenevano. Questa conside-razione vale anche nel caso delle chiese di maggiori dimensioni ma il cui interno è stato scavato molto parzialmente, come Testona Santa Maria. Si può supporre infine un’eventuale concentrazione delle tombe infantili anche negli spazi non intercettati dall’intervento archeologico. Non sembra quindi un caso che la maggiore frequenza di sepolture infantili si osservi nel San Gervasio di Centallo, nel quale lo scavo ha interessato l’intera superficie interna della chiesa ed all’esterno si è esteso fino a una notevole distanza dal suo perimetrale.
Anche l’evidente sproporzione tra numero di soggetti maschili e femminili rappresenta una carat-teristica comune sia alle necropoli all’aperto che alle chiese sepolcrali. Nelle prime (fig. 5) gli uomini raggiungono oltre il 70% del totale degli adulti per i quali è possibile la determinazione antropologica del genere nella prima e nella seconda fase di utilizzazione della necropoli di Collegno; nei due siti di Rivoli e nell’ultima fase della necropoli di Collegno si registrano valori pari al 60-62%. È da notare che la
535
Fig. 4. Planimetria dell’area sepolcrale di Mombello (da MiCheLetto 2007a, p. 53, fig. 22).
prevalenza di adulti maschili che si rileva nelle due fasi più antiche di Collegno era stata ipotizzata anche su base archeologica in accordo al numero più elevato di tombe con corredi di armi rispetto a quello di sepolture con corredo di gioielli femminili. Le determinazioni antropologiche di genere confermano pienamente questo dato, evidenziando la prevalenza di maschi adulti nel totale delle sepolture, incluse quindi anche quelle prive di elementi di corredo. Questi dati, combinati con quelli relativi all’incidenza della mortalità in età evolutiva, permettono di ritenere che le necropoli all’aperto abbiano raccolto le sepolture di gruppi formati da poche famiglie, composte da bambini, adolescenti ed adulti sia maschili che femminili, e da nuclei in sovrannumero di uomini in grado di utilizzare le armi, indipendentemente dalla deposizione di queste ultime nelle loro tombe.
La sovrarappresentazione di adulti maschili permane anche nel caso delle sepolture praticate presso gli edifici di culto (fig. 6). Gli uomini costituiscono dal 63,2% (Testona Santa Maria) all’83,3% (Gozzano San Lorenzo) degli adulti sessualizzabili scheletricamente; le donne tendono invece a essere più numerose nei gruppi più grandi e nei siti nei quali le indagini archeologiche hanno interessato anche l’esterno degli edi-fici di culto (Chieri area ampliamento ASL, Santa Maria di Testona, San Gervasio di Centallo). Questi dati sembrano quindi documentare un particolare costume funerario delle genti longobarde cristianizzate, ricostruibile soltanto per mezzo delle analisi bioarcheologiche, secondo il quale all’interno delle chiese ci-miteriali o nelle loro immediate prossimità erano preferenzialmente inumati i personaggi più importanti delle comunità, in primo luogo gli uomini a capo delle famiglie di rango. Anche le donne e i bambini ap-partenenti a questi stessi nuclei familiari potevano essere inumati all’interno delle chiese, ma più spesso le loro tombe si localizzavano all’esterno di queste. Sembrano emblematici in questo senso le sepolture di Agnella, morta a circa 30 anni, cinque giorni prima delle calende di febbraio di un anno imprecisabile del VII secolo, sepolta in una tomba a cassa in muratura addossata all’esterno della parete nord dell’atrio del San Gervasio di Centallo, rinvenuta ancora coperta dalla lapide con l’iscrizione funeraria3; quella della
3 miCheletto, pejrani BariCCo 1997, p. 337.
536
Fig. 5. Numero di adulti maschili e femminili nei siti funerari all’aperto(n. ind.: numero di individui maschili e femminili; n: numero totale di individui che compongono il gruppo).
Fig. 6. Numero di adulti maschili e femminili nei siti funerari presso edifici di culto (n. ind.: numero di individui maschili e femminili; n: numero totale di individui che compongono il gruppo).
dama con gli orecchini in argento sepolta in una tomba parzialmente delimitata da laterizi posta all’ester-no del perimetrale dell’abside della chiesa dell’area dell’ampliamento ASL di Chieri, e infine la sepoltura infantile con fibbia di cintura di tipo maschile che si sovrappone a essa4. (E.B.)
2. eRgonomia e patologie tRaumatiche Lo studio di un primo gruppo di inumati della necropoli di Collegno5 mise in evidenza, per gli adulti
maschili, una serie di variazioni diacroniche nelle alterazioni ergonomiche, nelle patologie “da usura” e in quelle traumatiche. Il completamento delle analisi antropologiche relative all’intero gruppo ha successi-vamente evidenziato – per ciascuna delle tre fasi di utilizzazione dell’area sepolcrale – che queste caratte-ristiche sono comuni alla maggior parte degli inumati. Tali variazioni possono essere poste in relazione al cambiamento del lifestyle avvenuto, generazione dopo generazione, nell’intervallo cronologico compreso tra gli ultimi decenni del VI secolo e la metà dell’VIII.
Gli uomini appartenenti alle prime generazioni (ultimo trentennio del VI secolo - primi decenni del VII secolo) presentano, indipendentemente dalla presenza o meno di elementi di corredo posti nelle loro sepolture, un grado di sviluppo muscolare notevole a livello delle spalle, del tronco e degli arti superio-ri, ma limitato in quelli inferiori, con ipertrofia delle masse muscolari – soprattutto del cinto scapolare e dell’arto superiore – evidenziata frequentemente dalla presenza di entesopatie e, nei soggetti di età avanzata, da degenerazioni osteoartrosiche. L’insieme di queste alterazioni permette di ipotizzare che essi svolgessero un’attività fisica o lavorativa particolarmente usurante, esercitata con un impegno degli arti superiori maggiore di quello degli arti inferiori.
Un importante contributo nell’identificazione di questa attività è rappresentato dalle lesioni craniche, ante mortem e peri mortem, prodotte da corpi contundenti di diversa tipologia, osservate su 4 dei 23 crani
4 pantò 2010a, p. 79.5 Sepolture da tomba 1 a tomba 73; Bedini, Bertoldi 2004.
537
maschili controllabili, cioè su circa 1/6 del totale (fig. 7, fig. 8). Ai 5 casi già illustrati6, relativi a tre soggetti dei quali almeno due deposti con corredo di armi, si aggiunge infatti quello ancora inedito di un giova-ne uomo armato, che presenta una lesione da taglio ante mortem al centro della squama dell’osso frontale. Nella prima fase di uso della necropoli di Collegno si riscontrano quindi complessivamente 6 lesioni craniche, delle quali 4 ante mortem e 2 peri mortem, a carico esclusivamente di adulti maschili, che per le loro stesse caratteristiche sono da interpretare come causate da volontarie aggressioni e non da comuni incidenti della vita quotidiana.
Riunendo in un unico quadro i dati relativi all’in-sieme sia delle alterazioni ergonomiche che delle patologie traumatiche, si può concludere che gli uo-mini appartenenti alle prime generazioni della fara di Collegno fossero impegnati in un’attività che, oltre che fisicamente intensa e usurante, era anche parti-colarmente rischiosa. Questa può essere identificata con quella di tipo militare, articolata sia in un adde-stramento quotidiano all’uso delle armi da offesa e da difesa, che nella pratica equestre e in una effettiva partecipazione a scontri armati, testimoniata dalla presenza delle lesioni craniche da combattimento, prodotte da armi da taglio (quattro casi), da punta e a larga superficie di impatto (un caso ciascuno).
È da notare che nelle successive fasi di uso del-la necropoli si assiste a significative variazioni sia nell’ergonomia degli adulti maschili che nelle carat-teristiche e nell’incidenza delle patologie traumatiche, tra le quali non è attestata alcuna lesione definibile come da combattimento. Il quadro delle alterazioni ergonomiche è leggermente diverso negli uomini della fase sepolcrale di VII secolo: l’arto inferiore sembra ora sottoposto a un impegno muscolare più in-tenso, probabilmente in seguito all’incremento dell’attività motoria. È stato ipotizzato7 che il cambiamen-to dell’armamento, con l’abbandono della spatha e l’uso esclusivo dello scramasax lungo, avesse portato anche a una variazione delle tecniche di combattimento, ora non più caratterizzate dall’impiego esclusivo o prevalente del cavallo. L’impegno fisico degli uomini armati rimaneva quindi ancora stressante, ma era con ogni evidenza meno rischioso rispetto a quello dei decenni precedenti: nessuno dei pochi traumi riscontrati in questa fase cronologica sembra infatti essere stato prodotto da aggressioni.
Infine, nell’ultimo momento di uso della necropoli, databile all’VIII secolo, sia le entesopatie che le patologie traumatiche, ancora indicative di un discreto grado di stress fisico, presentano localizzazioni mai o raramente attestate nelle fasi precedenti e sembrano quindi interpretabili come causate da un profondo e completo cambiamento del lifestyle del gruppo. Le attività occupazionali maschili sono ancora stressanti e particolarmente gravose, ma la loro tipologia sembra completamente diversa rispetto a quelle praticate dai loro predecessori: ormai infatti essi sembrano dedicarsi direttamente ad attività produttive, probabilmente sia agricole che artigianali.
A Collegno nel corso del tempo si individua quindi un lineare processo di stabilizzazione sul territorio del gruppo longobardo e di cessazione dell’effettivo ruolo militare che esso svolgeva, documentato dalla variazione sia del lifestyle che delle abitudini funerarie.
Nuclei coevi a quelli di Collegno, stanziati sia intorno al territorio del ducato di Torino che in aree più peri-feriche del Piemonte, presentano dinamiche interne talvolta analoghe e in altri casi significativamente diverse.
6 Bedini, Bertoldi 2004, pp. 220-221.7 Bedini, Bertoldi 2004, p. 223.
Fig. 7. Collegno, fase 1, sepoltura T. 57: ricostruzione della lesione cranica peri mortem da arma da taglio sulla parte sinistra del cranio. Fig. 8. Collegno, fase 1, sepoltura T. 70: lesioni multiple sulla metà destra della volta cranica: due ante mortem da arma da taglio, perfettamente riparate, nella regione temporo-occipitale e una peri mortem, con iniziale rimodellamento osseo, lungo la sutura lambdoidea.
538
Nella necropoli di corso Levi a Rivoli, contempo-ranea alla seconda e alla terza fase di utilizzazione di quella di Collegno e come questa caratterizzata da deposizioni all’aperto, la totale assenza di elementi di corredo – in particolar modo di armi – e il rinvenimen-to in alcune sepolture di fili di broccato d’oro avevano in un primo momento lasciato ipotizzare che questo nucleo avesse perso qualsiasi connotazione militare e che i suoi personaggi preminenti esercitassero il ruolo pubblico di amministrazione di terreni regi8.
Le analisi bioarcheologiche9, in particolare lo stu-dio delle alterazioni ergonomiche e delle patologie traumatiche, hanno permesso di ottenere un quadro diverso del lifestyle di questo gruppo. Gli uomini sono infatti caratterizzati dalle stesse alterazioni ergonomi-che riscontrate in quelli delle prime due fasi di uso della necropoli di Collegno: scheletro postcraniale particolarmente robusto, evidenti inserzioni muscola-ri, frequenti entesopatie associate nei soggetti di età avanzata ad alterazioni osteoartrosiche talvolta piutto-sto gravi. Si può quindi ritenere che anche essi fossero impegnati nelle stesse occupazioni. Anche questo sito può essere quindi interpretato come il sepolcreto di un nucleo composto, oltre che da una o più famiglie che svolgevano una funzione pubblica, anche da un gruppo di uomini armati che esercitavano l’attività militare. In questo quadro interpretativo giocano un ruolo essenziale anche la qualità e la quantità delle lesioni craniche riconducibili ad aggressioni e in ana-logia a quelle delle due più antiche fasi di Collegno definibili anche esse come da combattimento. Le le-sioni, sia premortali riparate (8 casi su 8 individui) che perimortali (due su uno stesso cranio), interessano 9 soggetti maschili dei 51 controllabili e sono sia da ta-glio (6 lesioni, tutte ante mortem; fig. 9) che depresse (2 casi, entrambi ante mortem; fig. 10) che da sfonda-mento, prodotte da corpi contundenti a larga super-ficie di impatto (2, peri mortem, su uno stesso cranio; fig. 11); si localizzano su tutto il distretto craniale, con una evidente prevalenza sulla metà sinistra e la re-gione occipitale della volta. Sembra quindi indubbio che, nonostante l’assenza di armi nelle loro sepolture, anche gli uomini deposti nell’area sepolcrale di Rivoli corso Levi abbiano partecipato a scontri armati. Una lesione cranica perimortale localizzata sulla metà de-stra dell’occipitale fu osservata anche in un individuo della seconda necropoli longobarda di Rivoli, quella situata in località La Perosa10.
Anche gli uomini sepolti, privi di qualsiasi elemento di corredo, nella chiesa cimiteriale dell’area dell’ampliamento ASL di Chieri presentano le stesse alterazioni ergonomiche e manifestazioni osteoartro-
8 pejrani BariCCo, suBBrizio 2006, p. 279.9 I dati sono ancora inediti.10 malleGni et al. 1998, p. 252.
Fig. 9. Rivoli corso Levi, sepoltura T. 40: lesione cranica ante mortem da arma da taglio, parzialmente riparata, sulla metà destra della squama dell’occipitale.Fig. 10. Rivoli corso Levi, sepoltura T. 87: lesione cranica ante mortem “a stampo” sulla metà sinistra della squama dell’osso frontale.Fig. 11. Rivoli corso Levi, sepoltura T. 75: lesioni craniche peri mortem da sfondamento, localizzate una sulla metà destra della squama dell’osso frontale e sul parietale sinistro, l’altra a livello della bozza del parietale destro.Fig. 12. Chieri, area ampliamento ASL, US 306: lesione cranica peri mortem da arma da taglio a livello dell’osso parietale sinistro.
539
siche riscontrate sia a Collegno che a Rivoli corso Levi. In analogia con quanto osservato in questi gruppi si può quindi ritenere che anche essi svolgessero la pratica dell’equitazione e che fossero sottoposti a un intenso addestramento militare che comportava l’uso abituale di un’arma pesante come la spatha. In que-sto sito le patologie traumatiche sono rappresentate da numerosi casi riconducibili a eventi di tipologia e gravità diverse: oltre a traumi prodotti da incidenti verificatisi nel corso della vita quotidiana, sono stati riscontrati tre casi di lesioni craniche definibili come da combattimento. Esse consistono esclusivamente in lesioni da taglio e interessano due dei 10 adulti maschili controllabili dei quali uno presenta una lesio-ne ante mortem, l’altro due lesioni peri mortem prodotte probabilmente nel corso di un’unica aggressione (fig. 12). La frequenza e la tipologia dei traumi riscontrati richiamano quindi quelle rilevate nelle necropoli di Collegno e di Rivoli corso Levi e permettono di ritenere che il gruppo di Chieri ASL costituisca un esempio di precoce cristianizzazione, con fondazione di una chiesa sepolcrale, di un gruppo longobardo ancora impegnato nella conquista del territorio.
Le patologie traumatiche riscontrate nei siti sopra descritti risultano completamente diverse da quelle, scarse, di modesta gravità e probabilmente causate tutte da incidenti della vita quotidiana, che caratte-rizzano i gruppi del Battistero di Chieri, della chiesa cimiteriale di Mombello e di quelle di San Gervasio a Centallo e di San Lorenzo a Gozzano.
È inoltre da notare che gli uomini di Mombello presentano le stesse alterazioni ergonomiche e le stes-se patologie degenerative osservate a Collegno, Rivoli corso Levi e nella chiesa cimiteriale di Chieri ASL. Essi evidentemente praticavano abitualmente l’equitazione e, anche se non svolgevano più una vera e propria attività di combattimento, erano sottoposti a un addestramento di tipo militare11. Avevano quindi mantenuto una tradizione culturale – a differenza di quanto rilevabile invece sia al Battistero di Chieri che al San Gervasio di Centallo e al San Lorenzo di Gozzano, nonostante che il loro lifestyle fosse ormai ben diverso da quello dei gruppi ancora coinvolti in scontri armati – con una forte connotazione militare che dava ancora un significato almeno simbolico alla deposizione di cinture militari all’interno di sepolture praticate in una chiesa.
In conclusione è possibile ritenere che l’assenza di corredi di armi e/o la sepoltura presso un edificio di culto non implichino necessariamente la cessazione del ruolo militare di un gruppo longobardo e un lifestyle esente dalla possibilità di un effettivo coinvolgimento in scontri armati. (E.P.)
3. conclusioni Il Convegno di Trento ha costituito l’occasione per presentare per la prima volta un quadro aggiorna-
to di sintesi, anche se necessariamente limitato ad alcuni aspetti delle analisi, dei dati bioarcheologici, in parte ancora inediti, relativi ai siti longobardi piemontesi fino a ora oggetto di analisi.
In linea generale è stato notato12 che i risultati fondamentali forniti dallo studio di alcune cospicue serie scheletriche (Collegno, Mombello, la chiesa sepolcrale dell’area ampliamento ASL di Chieri) non consistono in una serie di dati antropometrici utilizzabili ai fini di analisi statistiche di dettaglio13, ma in un insieme di elementi che permettono di illuminare aspetti fondamentali del lifestyle dei diversi gruppi e di definire con ulteriori dettagli le modalità con le quali i Longobardi assunsero il controllo del territorio e in definitiva finirono con acquisire i modelli culturali delle popolazioni autoctone. La ricostruzione quindi di questo brano di storia è stato reso possibile da una effettiva ricaduta dei dati antropologici sul contesto archeologico nella sua globalità.
Dai dati presentati emerge chiaramente come ogni singolo gruppo sia caratterizzato da una propria particolare identità, probabilmente conseguente al diverso ruolo dei singoli stanziamenti ai quali afferiva-no le diverse necropoli o chiese sepolcrali, alle tradizioni culturali proprie delle famiglie a capo di questi, alla posizione geografica e all’importanza strategica dei luoghi occupati, agli eventuali contrasti intercorsi sia nei rapporti con le genti locali che all’interno delle fare stesse. In questa chiave di lettura non sembra casuale che i traumi da combattimento siano attestati esclusivamente nelle aree sepolcrali utilizzate dalle fare stanziate a presidio dei luoghi strategici che permettevano l’accesso al ducato di Torino, i cui uomini armati erano frequentemente esposti a scontri violenti a difesa di questo. (E.B., E.P.)
11 Bedini, Bartoli 2007, pp. 170-171.12 Bedini, Bertoldi, petiti 2010, pp. 91-92.13 Come è già avvenuto ad esempio nel caso dei gruppi della chiesa di San Gervasio di Centallo e del Battistero di
Chieri (Bedini et al. 1997; malleGni et al. 1998).
540
RingRaziamenti
Esprimiamo la nostra più viva riconoscenza alla Soprintendenza per i beni Archeologici del Piemonte, nella persona dell’attuale soprintendente dott.ssa Egle Micheletto, per la straordinaria opportunità scien-tifica che da molti anni offre al nostro gruppo di studio, affidandoci l’analisi dei resti scheletrici di siti di fondamentale importanza per la storia del popolamento del Piemonte, e per averci permesso di presen-tare i risultati dello studio in occasione del Convegno.
I nostri ringraziamenti vanno anche ai funzionari dott. Luisella Pejrani, Gabriella Pantò e Alberto Crosetto, con i quali si è instaurato un rapporto di piena collaborazione e che ci hanno da sempre fornito utilissimi consigli e indicazioni.
Siamo inoltre grati a tutti i colleghi che nel tempo ci hanno affiancato, partecipando ai lavori di re-stauro, documentazione e schedatura dei materiali. Porgiamo inoltre un particolare ringraziamento al Prof. Francesco Mallegni, già Professore Ordinario di Paleoantropologia presso l’Università degli Studi di Pisa, per la sua costante presenza e la disponibilità con la quale ha costantemente seguito e indirizzato il nostro gruppo di studio, fornendo un’indispensabile supervisione scientifica.
Desideriamo infine ringraziare la dott.ssa Luisella Pejrani e la dott.ssa Caterina Giostra, dell’Istituto di Archeologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, per la lettura critica di questo contributo.
541
BIBLIOGRAFIABAreLLo F. (a cura di) 2010, Souvenir m’en doit. Dal foro romano ai marchesi Mazzetti, Castell’Alfero (AT).
Bedini E. 1999, Analisi antropologica e paleopatologica dei re-sti scheletrici umani medievali, in MiCheLetto E. 1999b, pp. 303-318.
Bedini E., BArtoLi F. 2007, Caratteristiche fisiche, modo di vita e alimentazione, in MiCheLetto E. 2007b, pp. 167-177.
Bedini E., BArtoLi F., PAGLiALunGA L., SeVerini F., VitieLLo A. 1997, Il gruppo umano di epoca longobarda della chiesa cimiteriale di Centallo, loc. Madonna dei Prati, in PAroLi L. (a cura di) 1997 pp. 345-364.
Bedini e., BertoLdi F. 2004, Aspetto fisico, stile di vita e stato di salute del gruppo umano, in PeJrAni BAriCCo L. 2004b, pp. 217-235.
Bedini e., BertoLdi F., GrAVA F., PeJrAni BAriCCo L., LiPPi B. 2005, Gli inumati della chiesa di San Lorenzo a Gozzano (NO), in miChetti e., di FABrizio A., d’AnAStASio r., CAPASSo L. (a cura di), Atti del XV Congresso dell’Associazione Antropologica Italiana, Teramo, pp. 77-81.
Bedini e., BertoLdi F., Petiti e. 2010, Longobardi a Chieri: i dati bioarcheologici, in PAntò G. (a cura di), Archeologia a Chieri. Da Carreum Potentia al Comune bassomedievale, Torino, pp. 83-93.
Bedini e., Petiti e. 2010, Studio paleobiologico dei resti scheletrici umani, in BAreLLo F. (a cura di), Souvenir m’en doit. Dal foro romano ai marchesi Mazzetti, Castell’Alfero (AT), pp. 57-59.
BiAnCoLini d., PAntò G. (a cura di) 1994, Il Battistero di Chieri tra archeologia e restauro, Torino.
mAFFeiS L., PiStAn F. 2010, Le sepolture, in BAreLLo F. (a cura di) 2010, pp. 51-52.
MALLeGni F., Bedini e., VitieLLo A., PAGLiALunGA L., BArto-Li F. 1998, Su alcuni gruppi umani del territorio piemontese dal III-IV al XVIII secolo: aspetti di paleobiologia, in MerCAndo L., MiCheLetto E. (a cura di), Archeologia in Piemonte. Il Medioevo, Torino, pp. 233-261.
MiCheLetto E. 1999a, Piazza Risorgimento, in MiCheLetto E. 1999b, pp. 125-133.
miCheLetto e. (a cura di) 1999b, Una città nel medioevo. Archeologia e architettura ad Alba dal VI al XV secolo, Torino.
MiCheLetto E. 2007a, Lo scavo di Mombello e l’archeologia della Iudiciaria Torrensis, in MiCheLetto E. 2007b, pp. 43-61.
miCheLetto e. (a cura di) 2007b, Longobardi in Monferrato. Archeologia della “Iudiciaria Torrensis”, Chivasso (TO).
MiCheLetto E., PeJrAni BAriCCo L. 1997, Archeologia funeraria e insediativa in Piemonte tra V e VII secolo, in PAroLi L. (a cura di) 1997, pp. 295-344.
PAGLiALunGA L., VitieLLo A. 1994, Studio antropologico dei reperti scheletrici umani, in BiAnCoLini d., PAntò G. (a cura di) 1994, pp. 103-107.
PAntò G. 1994, Venti anni di interrogativi sulle testimonianze archeologiche del Battistero, in BiAnCoLini d., PAntò G. (a cura di) 1994, pp. 49-77.
PAntò G. 2010a, Chieri nell’alto medioevo: un insediamento di genti germaniche, in PAntò G. 2010b, pp. 67-81.
PAntò G. (a cura di) 2010b, Archeologia a Chieri. Da Carreum Potentia al Comune bassomedievale, Torino.
PAntò G., oCCeLLi F. 2009, Moncalieri, frazione Testona, parco di Villa Lancia. Abitato e necropoli di età longobarda, “Quader-ni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte”, 24, pp. 227-231.
PAntò G., PeJrAni BAriCCo L. 2001, Chiese nelle campagne del Piemonte in età longobarda, in BroGioLo G.P. (a cura di), Le chiese rurali tra VII e VIII secolo in Italia settentrionale, Atti dell’8° Seminario sul tardo antico e l’alto medioevo in Italia set-tentrionale, Garda, 8-10 aprile 2000, Mantova, pp. 17-54.
PAroLi L. (a cura di) 1997, L’Italia centro-settentrionale in età longobarda, Firenze.
PeJrAni BAriCCo L. 2004a, L’insediamento e le necropoli dal VI all’VIII secolo, in PeJrAni BAriCCo L. 2004b, pp. 17-51.
PeJrAni BAriCCo L. (a cura di) 2004b, Presenze longobarde. Collegno nell’alto medioevo, Torino.
PeJrAni BAriCCo L. 2007, Il Piemonte tra Ostrogoti e Longobardi, in BroGioLo G.P., ChAVArriA ArnAu A. (a cura di), I Longobar-di. Dalla caduta dell’impero all’alba dell’Italia, Cinisello Balsamo (MI), pp. 255-265.
PeJrAni BAriCCo L., SuBBrizio M. 2006, Rivoli, corso Primo Levi. La necropoli di età longobarda, “Quaderni della Soprintenden-za Archeologica del Piemonte”, 21, pp. 278-279.