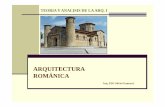Tecnica edilizia romanica nel Piemonte meridionale
-
Upload
beniculturali -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Tecnica edilizia romanica nel Piemonte meridionale
Alberto Crosetto
Tecniche murarie e cantieri del romanico in Piemonte tra archeologia e architettura. La prima fase romanica nel territorio astigiano e alessandrino
la costruzione dell’abitato; in esso venne riservato uno spazio delimitato e predisposto per le sepolture, utilizzato successivamente, in considerazione del valore sacrale del cimitero, come luogo per l’erezione della chiesa 2.
Nel corso dell’alto medioevo i dati posseduti evi denziano usi edilizi che privilegiano tecniche costruttive abbastanza sommarie, ma che mostrano una precisa volontà di dare agli edifici di culto una struttura consistente con forme differenti da quelle in uso per gli edifici d’abitazione coevi, prevalentemente ad impianto ligneo 3. Eretta nello stesso periodo di capanne lignee, situate a poche decine di metri, la struttura della facciata della chiesa di S. Anastasio ad Asti (prima metà VIII secolo: Crosetto 2003a, p. 20) utilizza una stesura irregolare di frammenti lapidei e laterizi legati con argilla depurata. Nonostante la sensazione di estrema precarietà per questo tipo di fondazione sappiamo che la chiesa fu utilizzata fino all’età romanica.
Pensiamo che tale scelta tecnica sia comunque frutto di valutazioni specifiche, anche perché risulta testimoniata nel complesso episcopale astigiano la tecnica produttiva di materiali edilizi nuovi prodotti da impianti artigianali, che non avevano affatto perduto le capacità acquisite nei secoli precedenti. La differenza stava unicamente nell’organizzazione che passò da una produzione semiindustriale pubblica e privata ad attività mirate per specifici interventi e spesso attivate nel cantiere stesso. Solo interventi che univano insieme una committenza di alto rango e una costruzione di particolare impegno determinarono l’attivazione specifica di tali officine artigianali; in altri casi è più probabile la ricerca e l’uso di elementi di recupero con l’attivazione di fornaci da calce per la produzione, questa sì necessaria, del legante 4.
Il caso più evidente è costituito, nel gruppo episcopale di Asti, dalla ristrutturazione di uno degli edifici di culto, con ogni probabilità il battistero di S. Stefano, al quale sono da attribuire tegole di copertura ad alette che portano il bollo di produzione +D (ominus) N (oster) BAENE (natu)S EP (iscopu)S, attribuibile al vescovo Benenato di Asti
2 Esempi concreti sono il ritrovamento di tombe tagliate dalle fondazioni della chiesa romanica in località Viatosto di Asti (XII secolo) (Crosetto 1997, pp. 1314) e presso la chiesa di S. Stefano di Perno in comune di Monforte d’Alba (XII secolo) (Id. 1988, pp. 9192). Si è riscontrata una situazione analoga anche nel caso della costruzione della cattedrale di Alessandria (seconda metà XII secolo) (Venturino Gambari, Crosetto 2009, pp. 176177).
3 Mombello: Micheletto 2007, pp. 4450; Tortona: Crosetto 2013, pp. 4849; Alessandria: Id. 2012; Asti: Maffeis, Pistan 2010, pp. 3537.
4 Si può citare il caso della fornace di produzione di calce ritrovata a Mombello in relazione al rifacimento della chiesa di metà VIII secolo (Micheletto 2007, p. 56). Si potrebbe anche attribuire al recupero sistematico e alla distruzione del materiale lapideo nelle calcare durante tutta l’epoca medievale la scarsità di epigrafi classiche e paleocristiane del territorio albese e astigiano.
1. Premessa
Come risulta evidente dalla documentazione archeo logica accumulata nell’ultimo trentennio su tutto il territorio regionale, grazie all’attenta attività di tutela svolta dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici, aperta ai continui aggiornamenti e al confronto con studiosi e preziosi collaboratori, e dagli studi che nel corso del tempo sono stati condotti sia in campo architettonico sia sui dati storici, si sono consolidati i primi significativi risultati di interpretazione e di formazione dei modelli sperimentali di una seriazione cronotipologica 1. Appare indubbiamente chiaro che la frontiera appare quella di definire passo dopo passo delle valutazioni sempre più agganciate a cronologie assolute, che permettano una sequenza area per area, considerando una variabilità per l’età romanica dovuta al localismo di certe committenze, alle differenti possibilità in esito all’investimento economico del cantiere, agli obbiettivi e alle disponibilità materiali del territorio.
Il territorio astigiano e alessandrino nel Medioevo fu fortemente modificato e contrassegnato da un crescente sviluppo economico e demografico delle città principali, che diede avvio ad una progressiva messa a coltura delle campagne e delle colline. Questo significò, nel giro di pochi decenni, la diffusa crescita di piccoli insediamenti, che presto divennero abitati permanenti contrassegnati, in modo pressoché sistematico, dalla costituzione di edifici di culto e di impianti fortificati. Uno degli elementi più indicativi che documenta questa espansione, a fronte di una palese rarità accertata archeologicamente di chiese paleocristiane e altomedievali, è costituito dal diploma del 26 gennaio 1041 di conferma alla Chiesa di Asti di tutti i possessi e i privilegi, che permette l’identificazione di numerosi abitati e chiese tra il Monferrato, la Langa e il Cuneese (Assandria 1904, doc. 319).
L’evoluzione degli insediamenti, globalmente intesa, è sostanzialmente simile. I dati della ricerca archeologica permettono di considerare accertata in un primo momento
1 Abbazia di Fruttuaria a S. Benigno Canavese: Pejrani Baricco 1998a, 2005; S. Giusto di Susa: Ead. 2002a; cattedrale di Ivrea: Ead. 2002c; S. Michele della Chiusa: Pejrani Baricco, Bosman 2001; Pejrani Baricco 2002b; S. Giovanni Vincenzo a S. Ambrogio di Torino: Ead. 1998b; torri urbane di Alba: Micheletto 1999, 2000; palazzo Marro di Alba: Ead. 2009a; cattedrale di Alba: La cattedrale 2013 (in particolare i contributi di E. Micheletto, pp. 3359; E. Lusso, pp. 6181; P. Greppi, pp. 107114; G.L.A. Pesce, A. Decri, pp. 115120); S. Dalmazzo di Pedona a Borgo S. Dalmazzo: La chiesa di S. Dalmazzo 1999; Micheletto, Uggè 2013; S. Costanzo sul Monte S. Bernardo di Villar S. Costanzo: Micheletto, Uggè 2003, 2013; SS. Pietro e Colombano di Pagno: Micheletto 2011; Micheletto, Uggè 2013; castello di Cervere: Micheletto 2010; castello di Manzano a Cherasco: Cerrato, Cortelazzo, Micheletto 1990; Micheletto, Bedini 1992; S. Pietro a Cherasco: San Pietro 2004; Micheletto 2006.
Archeologia dell’ArchitetturaXVII 2012, pp. 111123
112 A. CROSETTO
fig. 1 – Asti, gruppo episcopale. Chiesa di S. Giovanni, frammento di tegola con bollo di produzione del vescovo Benenato (VII secolo).
fig. 2 – Alessandria, Museo civico, collezione Di NegroCarpani. Bollo laterizio del vescovo Benenato su tegola ad alette (VII secolo).
(attestato da una sottoscrizione nell’anno 679) 5. Il caso astigiano si colloca in un quadro, oggi più ricco e articolato di un tempo, nel quale possono essere collocati sia i bolli laterizi provenienti dalle località di S. Albano Stura (metà V secolo) e Benevagienna (seconda metà VIIprima metà VIII secolo) sia un bollo laterizio, proveniente dalla zona della cattedrale di Torino, leggibile come attestazione di Ursicinus episcopus, presule ricordato in Torino dalla sua epigrafe funeraria che documenta la sua sepoltura nel 610 6.
Prendendo in esame alcuni cantieri tra la fine del X e la prima metà del secolo XI si nota una sistematica applicazione di murature che utilizzano i materiali disponibili, sistemandoli in corsi regolari, si tratti sia di elementi lapidei grossolanamente squadrati sia mattoni di recupero. Solo in alcuni casi, l’uso di elementi troppo ridotti dimensionalmente (ciottoli fluviali, tegole romane) costrinse gli artigiani ad realizzare ampie parti a “spina pesce”.
2. Asti, chiesa di S. Giovanni de Dom 7
Il complesso intervento di sistemazione dello spazio tra la cattedrale attuale e la vicina chiesa di S. Giovanni, per la realizzazione del nuovo edificio del Museo diocesano, ha permesso di collocare la costruzione di quest’ultima chiesa verso la fine del V secolo, su un ripiano artificiale realizzato sulle falde della collina, a completamento del gruppo episcopale paleocristiano, che già vedeva la presenza della
5 Il bollo (fig. 1) è stato rinvenuto nel corso degli scavi (20012010) presso la chiesa di S, Giovanni della cattedrale astese. Con l’occasione ritengo opportuno precisare una svista riportata in Crosetto 2007, p. 331 in merito ad una tegola bollata (fig. 2) della collezione Di NegroCarpani, conservata al Museo civico di Alessandria. L’identità tra i due bolli è assolutamente provata e si deve pertanto attribuire anche la tegola della collezione tortonese oggi nel Museo civico di Alessandria come frutto di un donativo a Cesare Di NegroCarpani da parte di Ernesto Giuseppe MaggioraVergano, collezionista astigiano, che segnalò, l’esistenza nella sua collezione di bolli, del vescovo Benenato.
6 Sui bolli cuneesi: Micheletto, Mennella 2003; Micheletto 2003, pp. 111112; Ead. 2009b, pp. 5051. Il bollo torinese è stato ritrovato nel corso di un intervento nelle vicinanze del gruppo episcopale;
7 Questa scheda e quelle successive costituiscono un’elaborazione della comunicazione “Romanico ad Asti nel secolo XI: ricerche sulla città e sul territorio” fatta dallo scrivente nel Convegno “Architettura dell’XI secolo nell’Italia del nord. Storiografia e nuove ricerche (Pavia 810 aprile 2010)”, in corso di stampa.
chiesa di S. Maria e del battistero. Dopo circa sei secoli di vita, a partire dalla fine del X secolo, tutti questi edifici di culto furono progressivamente interessati da una trasformazione edilizia, più o meno complessa, che sembra essere stata avviata proprio a partire dalla chiesa di S. Giovanni 8.
L’impianto paleocristiano era a tre navate, precedute da un atrio; la navata centrale era terminata ad est con un’abside semicircolare affiancata da due vani quadrangolari. Nella ristrutturazione romanica (fig. 3), l’andamento planimetrico non fu sostanzialmente modificato e venne mantenuto l’impianto a tre navate, scandite da due file di sette pilastri e concluse con absidi semicircolari. In questo caso i sostegni interni della fase precedente furono trasformati: le colonne antiche vennero asportate o, in qualche caso, inglobate nei nuovi pilastri rettangolari costruiti in muratura laterizia; come basamento degli stessi pilastri furono mantenute ancora in gran parte le lastre di ripartizione del carico della fase precedente. Tale sostituzione creò di fatto un ritmo ravvicinato dei sostegni delle navate, non ignoto a molti altri esempi coevi, come la chiesa di S. Anastasio nella stessa Asti, e gli archi di collegamento tra i pilastri risultarono leggermente più ampi rispetto ai nuovi sostegni, assumendo in tal modo una forma ad arco oltrepassato, ricordata spesso nella bibliografia specifica di questa chiesa (Verzone 1977, p. 357).
8 Prime sintesi delle indagini effettuate sono in Crosetto 2002, pp. 111112 e in Id. 2007, pp. 628634.
LA PRIMA FASE ROMANICA NEL TERRITORIO ASTIGIANO E ALESSANDRINO 113
fig. 3 – Asti, gruppo episcopale. Chiesa di S. Giovanni e battistero di S. Stefano, fase medievale (fine XXI secolo) (ril. Lostudio s.r.l.).
fig. 4 – Asti, gruppo episcopale. Chiesa di S. Giovanni: muratura dell’abside settentrionale (fine X secolo).
Le navate furono coperte a capriate; di queste rimangono sulle pareti dell’attuale chiesa – sia nel settore esterno a nord e a sud sia nel sottotetto per quanto riguarda la navata centrale – ancora tracce dei buchi destinati all’alloggiamento degli elementi lignei delle semicapriate e delle capriate. In questa stessa zona si riscontra la tamponatura delle finestrelle a tutto sesto che davano luce alla navata centrale, visibili nell’antico cleristorio, parte sommitale delle attuali pareti nord e sud. Il muro esterno lungo la navata meridionale fu rinforzato con la costruzione di una seconda parete addossata a quella più antica e nella parte terminale furono eliminati i due vani affiancati all’abside centrale, sostituiti da due piccole absidi secondarie, poste al termine delle navate settentrionale e meridionale; di queste, nel corso delle indagini, è stata individuata parte di quella nord e quella sud, che presenta all’esterno l’attacco di due piccole lesene che dividono la parete esterna in tre specchiature, verosimilmente in origine decorate con un fregio ad archetti pensili.
Al di sotto del presbiterio fu ricavata una cripta a sala, raggiungibile per mezzo di due scale dalle due navate laterali; per poterla realizzare, l’abside paleocristiana fu completamente rivestita all’interno da una nuova muratura in laterizi disposti in corsi orizzontali, che prevedeva l’inserimento di lesene rettangolari per il sostegno delle crociere di copertura della cripta, impostate su sei colonne. Dall’analisi di quelle superstiti – le quattro più interne – e in considerazione delle loro dimensioni si può affermare che furono utilizzati elementi architettonici di epoca romana, provenienti con ogni probabilità dalla chiesa paleocristiana; tali sostegni vennero profondamente interrati per poterli utilizzare, senza tagliarli, nella misura necessaria a sostenere le volte della cripta. Anche per i capitelli furono usati elementi di reimpiego: i quattro superstiti sono costituiti da due capitelli corinzi asiatici di epoca tardoantica (IIIV secolo), probabilmente già usati nella prima chiesa, e da due capitelli altomedievali
(VIII secolo) provenienti dall’arredo liturgico dello stesso S. Giovanni.
Non sono conservate tracce di decorazione nelle pareti della cripta, che dovevano essere semplicemente intonacate, mentre nella parte superiore della navata centrale era presente una decorazione pittorica, individuata nel 1972 nel sottotetto ricavato dalla costruzione delle volte quattrocentesche 9. Il ciclo di affreschi risulta di difficile lettura, in relazione al precario stato di conservazione, anche se analogie riscontrate con opere del tardo secolo X suggeriscono di collocare il ciclo tra la fine del X (alcune parti del registro superiore) e i primi decenni del secolo XI.
Tale data – da chiarire in futuro in modo inequivocabile, ma che si assomma ad altri dati di tipo architettonico come la conformazione e la cadenza dei pilastri e il reimpiego sviluppato nei sostegni della cripta – costituisce di fatto un terminus post quem per il rifacimento romanico
9 Di questi affreschi manca ancora un’edizione definitiva, ma sono stati ricordati in Gabrielli 1977, p. 11, p. 68 (attribuiti all’inizio dell’XI secolo); Solaro Fissore 1981, p. 12 (fine X secolo); Pagella 1993, pp. 9899 (non oltre il primo ventennio dell’XI secolo). Altre puntuali osservazioni sono state proposte da Costanza Segre Montel in attesa di uno studio monografico definitivo: Segre Montel 1994a, pp. 3344; Id. 1994b, pp. 259261.
114 A. CROSETTO
fig. 5 – Asti, gruppo episcopale. Chiesa di S. Giovanni: pilastri e parete della navata centrale (fine X secolo).
di questa chiesa, che risulterebbe pertanto da collocare alla fine del X secolo, forse in relazione con il grande episcopato di Rozone (966992).
Nell’osservazione degli apparecchi murari nella parete esterna delle absidi laterali (fig. 4) si nota un sistematico e quasi esclusivo uso di laterizi di dimensioni irregolari frutto di rilavorazioni dei materiali utilizzabili, legati con malta a media coesione, ma con giunti irregolari e abbastanza spessi. Nella stessa epoca (XXII secolo), si deve ricordare una frequente realizzazione di tombe, nel cimitero della stessa cattedrale, in cassa di muratura di frammenti laterizi e copertura a doppio spiovente in mattoni sesquipedali. Il dato conferma l’ampia disponibilità di approvvigionamento di tali materiali e il permanere di una rarefazione della produzione.
Analogie si riscontrano anche nella muratura degli alzati, come nel lato sud del cleristorio, nei pilastri e negli archi che dividono la navata centrale da quella meridionale (fig. 5). Anche in questo caso la muratura è scandita in corsi orizzontali abbastanza regolari soprattutto nel pilastri, meno nelle parti superiori della muratura che indubbiamente erano destinate ad un successivo rivestimento con intonacatura. L’uso di elementi di recupero è evidente soprattutto nella facciavista degli archi.
3. Acqui Terme, cattedrale di S. Maria
La grande cattedrale, caratterizzata da una stratificazione architettonica molto complessa, ha destato grande interesse in molti studiosi di storia dell’architettura. Una corretta lettura delle fonti collega questa chiesa ai vescovi Primo e Dudone, i due personaggi più rilevanti che hanno preceduto Guido nell’episcopato acquese, i quali hanno avuto una parte decisiva nella fase progettuale e costruttiva dell’edificio di culto; ne consegue che le attività della costruzione della cattedrale sono più correttamente da riportare tra la fine del X e i primi decenni dell’XI secolo.
In assenza di studi specifici e relazioni dei cantieri di restauro avvenuti in epoca recente, almeno tra il 1845 – epoca del rifacimento della pavimentazione del presbiterio e della scoperta del mosaico pavimentale – e il grande cantiere degli anni Ottanta del XX secolo, è sempre stato difficile valutare un organismo tanto complesso senza l’ausilio di documentazione che mostrasse le progressive acquisizioni conoscitive sulla chiesa avvenute nel corso degli interventi. Solo in occasione dei lavori di risistemazione della cripta (1991) è stato possibile iniziare un’analisi più attenta delle fasi della chiesa e accumulare una serie di informazioni in modo più accurato, confermando l’unitarietà della progettazione e della costruzione della chiesa, provata in modo certo per la parte absidale, il transetto e la cripta (fig. 6) 10.
Il cantiere fu avviato, come di consueto, nel settore orientale con la realizzazione dei cavi di fondazione della zona absidale: il declivio naturale della collina venne inciso profondamente e asportato nella parte che interferiva con il cantiere. Su questo piano fu scavata una profonda e ampia trincea per la posa delle fondazioni; queste erano di spessore assai considerevole (circa 2,10 m di larghezza nell’abside centrale), realizzate nella parte inferiore direttamente contro terra. Partendo da questo basamento, ampio e solido, che occupa tutto lo spazio della trincea di fondazione, i muri si elevano, riducendosi con un paio di riseghe, fino alla sezione voluta per l’e levato. Per quanto visibile, nella parte fuori terra la muratura appare assai curata, con l’utilizzo generalizzato di pietra locale (calcare di Visone), in molti casi lavorata appositamente in conci squadrati, legata con malta ad alta coesione, con evidenti e volute inserzioni di elementi di epoca romana (fig. 7).
10 Relazioni di questa prima campagna di scavi, diretta da chi scrive e condotta in collaborazione con la ditta Orione s.n.c. di Acqui Terme e la Soprintendenza per i Beni Architettonici del Piemonte, con il finanziamento della Parrocchia della Cattedrale, sono in Crosetto 2001, pp. 3955; Crosetto 2003b, pp. 195200; Crosetto 2011, pp. 110118.
LA PRIMA FASE ROMANICA NEL TERRITORIO ASTIGIANO E ALESSANDRINO 115
fig. 6
– A
cqui
Ter
me,
gru
ppo
episc
opal
e. C
atte
dral
e di
S. M
aria
, pla
nim
etria
del
le in
dagi
ni a
lla c
ripta
(prim
o tre
nten
nio
XI s
ecol
o) (r
il. G
. Abr
ardi
).
116 A. CROSETTO
fig. 7 – Acqui Terme, gruppo episcopale. Cattedrale di S. Maria, muratura del transetto meridionale (primo trentennio XI secolo).
Il coro ad absidi scalate venne realizzato unitaria mente: chiare tracce nell’impostazione delle riseghe e nel legame tra queste fonda zioni e quelle del muro di chiusura verso le navate convergono a rimarcare questa progettazione unitaria e con temporanea della cripta con quella della chiesa.
A ulteriore riconferma dell’unitarietà della costruzione concorrono anche i dati ricavati nel sondaggio all’interno del campanile gotico. Anche in questa parte, ancorché meno profonda e consistente in relazione alla diversa funzione strutturale, la fondazione appare solidale tra la parete laterale meridionale e quella di facciata. La muratura, anche in questo settore, è costituita da un paramento in conci di pietra di Visone, disposti in regolari corsi orizzontali con qualche raro ricorso in laterizi (sesquipedali romani di reimpiego), legati con giunti di malta a forte coesione, in genere molto spessi a causa della mancanza di un accurato spianamento delle superfici dei piani di posa, dovuto all’uso frequente di materiale di reimpiego. Il nucleo interno del muro era invece costituito da una congerie eterogenea di scaglie di pietra e materiale di recupero inglobata in un getto di abbondante calce 11.
Un’evidente risega segnava il piano di posa della pavimentazione originaria ad una quota di circa 0,60 m sotto
Confronti sulla tecnica muraria sono possibili con murature genovesi (Andrews, Pringle 1977, pp. 5860, Cagnana 1997, pp. 8386) e toscane (Quiròs Castillo 2002, pp. 9398).
l’attuale piano pavimentale. La presenza degli attacchi delle lesene all’esterno della parete sud permette inoltre di riconoscere l’articolazione della decorazione ad archetti multipli anche nel settore vicino alla facciata, ora in parte perduta per la costruzione del campanile.
Non appena fu terminata la prima fase costruttiva delle fondazioni e l’impostazione degli alzati, il cantiere all’interno dell’edificio fu rialzato con il deposito di successivi ricarichi di terreno, fino all’altezza dell’ultima risega. Venne quindi dato l’avvio alla costruzione degli alzati, che considerarono le semicolonne della cripta – sia nel perimetro absidale, sia nel mu ro trasversale di chiusura verso le navate – come parte integrante della muratura: ulteriore elemento a favore dell’ideazione unitaria della complessa struttura.
Si procedette infine all’impostazione delle fonda zioni di catena per i basamenti dei sostegni interni. Il terreno di riempimento più superficiale, ormai fortemente compattato, venne infatti tagliato con lunghi e profondi cavi di sezione rettangolare, rettilinei, talvolta con un visibile al largamento tondeggiante in corrispondenza del punto destinato a sostenere il basamento della colonnina. I cavi vennero infine utilizzati per la posa di fondazioni costruite con una muratura eterogenea di grossi ciottoli fluviali e pietre legate con malta.
Non è raro trovare in cripta, come nella muratura esterna 12, l’uso di resti architettonici di epoca romana o tardoantica: una base, alcuni elementi di colonne dal fusto liscio, lastre di ripartizione dei carichi e anche un capitello corinzio, tutti usati come sostegno per alcune colonnine ma spesso posti in modo da essere riconoscibili dal piano di calpestio. La loro sporadica utilizzazione non sembra dettata da necessità strutturali, ma da interpretare piuttosto come volta a sottolineare gli aspetti “ideologici” di tale reimpiego, a rimarcare la vetustas come venerabilitas. In ogni caso, l’attenzione per le strutture fondali dei sostegni conformate a rete di catene metteva in rilievo il grande impegno costruttivo e la sensibilità dell’architetto, che non ignorava le notevoli sollecitazioni dei sostegni in una cripta così ampia 13. Gli accessi della cripta, ora aperti con tre porte direttamente sulla navata centrale, in origine erano diversamente disposti. I passaggi più antichi erano solo due ed erano laterali, posti in corri spondenza delle absidi intermedie della cripta: il centro della navata era infatti occupato da una grande scalinata di salita al presbiterio.
12 Altri frammenti marmorei sono presenti, in modo evidente, nella parete esterna delle absidi e del transetto della chiesa. Tra i più significativi si riconoscono il plinto quadrato con base di colonna tuscanica in una lesena dell’abside centrale e un gruppo di lastre modanate nelle cornici superiori. È ormai un dato acquisito l’uso meditato della scultura architettonica di età romana ed altomedievale nelle chiese romaniche (Settis 1984, pp. 309317; De Lachenal 1995, pp. 157207). Su esempi piemontesi: Maritano 2002, pp. 131143; Maritano 2008, passim.
13 A verifica di alcune interpretazioni storicoarchitettoniche, che vedevano la cripta distinta in due fasi per la presenza di volte con e senza sottarchi (queste ultime considerate più recenti) si è cercato, con pochi sondaggi mirati, di cogliere la reale situazione. È stata constatata in effetti la presenza dell’originaria impostazione a sottarchi, anche nella parte fino ad ora considerata priva, invi sibili perché coperti da uno spesso strato di intonaco. Anche questo dato sembra così collimare con l’indicazione di un’omogeneità costruttiva della cripta acquese, diversamente da quanto ipotizzato in Arslan 1954, p. 600 e Ieni 1991, p. 119. Già Porter 1917, p. 22, tuttavia, suggeriva possibili rifacimenti delle voltine della cripta o almeno pesanti ricoperture «with intonaco».
LA PRIMA FASE ROMANICA NEL TERRITORIO ASTIGIANO E ALESSANDRINO 117
fig. 8 – Acqui Terme, gruppo episcopale. Cattedrale di S. Maria, parte absidale (primo trentennio XI secolo).
La facciata era caratterizzata sui fronti delle navate laterali da due specchiature ad archetti pensili continui, centrate, ciascuna, da una lunga monofora – ancora visibile – a doppio strombo. Una duplice lesena le separava dal fronte della navata centrale, sul quale non è rimasta traccia antica che permetta ipotesi ricostruttive, anche se è evidente che l’ingresso fosse unico e centrale.
Le navate laterali risultano modificate dal raddoppio avvenuto successivamente, mentre quella centrale si è ancora conservata nella sua decorazione ad archetti pensili continui sormontati da cornice a dente di sega (fig. 8) e nelle sue tre monofore. Solo in alcune parti delle navate minori si individua la decorazione a dente di sega e ad archetti pensili, divisi in gruppi di sei da lesene doppie, poste nel punto corrispondente alla cadenza delle campate. Il transetto è aggettante rispetto al profilo delle navi laterali e più basso di quella principale.
La decorazione del transetto è nelle pareti laterali a dente di sega e ad archetti pensili, interrotti, quest’ultimi, da lesene nel punto di inserimento delle navate minori. I
timpani dei suoi bracci avevano un’uguale continua serie di archetti, di cui rimane ancora qualche traccia, mentre sono ancora ben visibili le lunghe monofore – simili a quelle presenti in facciata – che davano luce alle testate dell’ambiente. Nei fianchi orientali del transetto si innestavano lateralmente due absidiole, di cui è rimasta solo metà di quella nord (fig. 8), mentre verso il centro le navate laterali avevano come corrispondente continuazione una campata, su cui s’inserivano due absidi.
La parte absidale è ancora ben conservata, nonostante la perdita di gran parte di due delle cinque absidi originarie; presenta una decorazione a denti di sega e a tre serie di archetti binati per le absidi che affiancano la maggiore, mentre questa è ad archetti doppi, con soprastanti denti di sega e di lupo, interrotti da due lesene doppie. Circa le aperture, vi erano tre lunghe monofore per l’abside principale e una per le minori. Una monofora, inoltre, centrava lateralmente la specchiatura della campata delle absidi scalate. Per quanto concerne il timpano posteriore della navata centrale sono ancora presenti tre serie di archetti triplici.
118 A. CROSETTO
I caratteri evidenziati convergono verso una relazione con l’architettura monastica, sorta sull’esperienza della seconda chiesa di Cluny (Segagni Malacart 2007, p. 111) e sulle realizzazioni portate a termine sulla spinta di Guglielmo da Volpiano, abate e architetto, la cui mano fu presente nella chiesa di S. Giusto di Susa e nell’abbazia di Fruttuaria a S. Benigno Canavese.
Sulla scorta delle sintetiche, ma indubitabili, indicazioni del dittico episcopale acquese 14, al vescovo Primo (9891018) deve infatti essere attribuita l’edificazione della cattedrale, presso la quale fu seppellito egli stesso, rompendo la tradizione che vedeva fin dai tempi più antichi deputate ad accogliere le sepolture vescovili le sole chiese di S. Pietro o, per un breve lasso di tempo, di S. Giovanni. Dopo la breve parentesi di Brunengo (10181022), la catte drale ritorna nelle notizie riferite al vescovo Dudone (10231033), nelle quali si dà grande risalto alle innovazioni liturgiche e si cita la celebrazione della prima messa di Natale in S. Maria definita antiquitus episcopalem ecclesiam: la ripresa dei riti conferma in questo caso indirettamente la sostanziale conclusione dei lavori edilizi, che mostrano nelle decorazioni terminali degli alzati caratteristiche legate al perdurare del cantiere lungo il primo trentennio dell’XI secolo. La consacrazione della cattedrale, come ovviamente richiedeva un tale rifacimento globale della struttura, avvenuta durante il luogo episcopato di Guido, ad opera dei vescovi di Genova e Tortona, l’11 novembre 1067, mette un sigillo definitivo a questa fase costruttiva.
4. Asti, chiesa di S. Anastasio
I resti della chiesa furono ritrovati (1908) durante i lavori di costruzione di un nuovo grande edificio scolastico. La storia attuale dell’area archeologica di S. Anastasio è iniziata con la sistemazione (1981) ad opera di Adriana Solaro Fissore della raccolta lapidaria medievale; mancava ancora, tuttavia, una lettura scientificamente corretta dei resti conservati. L’avvio di un progetto di sistemazione degli impianti e di un nuovo allestimento (autunno 1995) era l’occasione attesa per riprendere lo studio del monumento 15. I primi controlli sullo stato della giacitura archeologica, indispensabili all’elaborazione del progetto (febbraiomarzo 1996), confermavano la perdita di circa 1,30 m di stratificazione, effetto degli interventi barocchi e della costruzione dei vani cantinati delle scuole, ma anche la presenza di importanti testimonianze ancora del tutto ignorate.
La prima campagna di ricerca archeologica (gennaiomarzo 1997) ha interessato la cripta e tutta l’area della chiesa di S. Anastasio, compreso il vano retrostante l’abside. Altre due campagne, condotte successivamente in due riprese (marzomaggio 1997 e agostosettembre 1999), hanno permesso, proseguendo nell’opera di riconversione dei vani cantinati, di documentare la giacitura archeologica lungo corso Alfieri e sul tratto iniziale di via Giobert. Pur con una stratigrafia particolarmente esigua si è riusciti a proporre una rilettura globale del monumento e delle sue vicende costruttive.
14 Sull’attribuzione a Primo anche Tosco 1997, pp. 4748.15 Longhi 1999, pp. 5577; Crosetto 2003a, pp. 37.
Le piccole dimensioni della chiesa altomedievale di S. Anastasio (prima metà VIII secolo) portarono alla necessità di ricostruire ed ampliare la chiesa, in relazione alla fondazione del monastero, nei primi decenni dell’XI secolo. Fu dunque costruito un nuovo edificio di culto di grandi dimensioni, a tre navate, terminate da absidi semicircolari (fig. 9). Le navate furono divise da due file di sostegni – probabilmente pilastri quadrati – che si disponevano abbastanza fitti tra il muro di facciata e l’attacco dell’abside, poggiando su larghi plinti collegati da muri di catena, dei quali rimane qualche traccia sul lato nord. Le caratteristiche dei sostegni sono tali da ritenere che la chiesa, in questa fase, avesse la navata centrale coperta da un semplice tetto a doppio spiovente su capriate lignee e semicapriate sulle navate laterali. Mancano totalmente tracce della pavimentazione, che poteva, in modo non dissimile dalla cripta, essere costituita da lastre di pietra. Rimane un’unica fondazione di un altare, di forma quadrata, al centro dell’abside laterale nord.
Il presbiterio era collocato a una quota più elevata rispetto alla navata e veniva raggiunto per mezzo di una larga scalinata, che occupava tutto lo spazio della navata centrale. Sotto di esso trovava posto una cripta a sala, divisa in tre navatelle da sostegni interni. L’accesso alla cripta avveniva attraverso due ripide scalette, il cui ingresso si trovava al termine delle navate laterali nord e sud: la scala in discesa piegava ad angolo retto e passava all’interno del muro di fondazione del presbiterio arrivando fino al piano della cripta. Una nicchia triangolare ed una quadrata, destinate ad accogliere lucerne per l’illuminazione, si aprivano immediatamente a lato dell’accesso nord. Su tre coppie di colonne, raccordate da archetti alle corrispondenti lesene rettangolari in muratura, poggiavano le volte a crociera della copertura. I sostegni (fig. 10) erano tutti diversi e spesso disomogenei nelle forme dei capitelli e delle colonnine, composti unicamente con materiale di epoca romana e altomedievale 16, che sembra essere scelto non a caso, ma con cura per sottolineare relazioni ideali. Tutte le colonne poggiavano su singole fondazioni, anche queste composte di resti antichi (quasi esclusivamente di epoca romana e certamente provenienti dall’adiacente zona del foro); in questo caso prevale tuttavia l’aspetto esclusivamente pratico, i rocchi di colonna o le basi sono infatti sistemate in modo da non essere in vista. Non rimangono più significative tracce della pavimentazione della cripta: un paio di lastre in pietra, presenti all’altezza di una rientranza della parete sud, sono forse gli unici resti conservati.
Il rifacimento della chiesa e la costruzione di questa cripta, che nella fase successiva (XII secolo) sarà ampliata verso est e verso ovest, si possono collocare nei primi decenni dell’XI secolo probabilmente in relazione all’episcopato di Alrico (10081036) 17.
Anche nel caso di S. Anastasio e nel periodo cronologico indicato si riscontra una stretta analogia di tecniche con le murature già prese in esame. Le fondazioni sono
16 Il materiale è in corso di schedatura, in vista dell’edizione del Corpus della scultura altomedievale per le diocesi del Piemonte meridionale (Acqui, Alba, Asti e Tortona); analisi petrografiche del materiale sono in Quattrone 2010.
17 Longhi 1996, pp. 3776, Crosetto, 2003, pp. 2733.
LA PRIMA FASE ROMANICA NEL TERRITORIO ASTIGIANO E ALESSANDRINO 119
fig. 9 – Asti, S. Anastasio. Planimetria della prima fase romanica (inizio XI secolo) (ril. G. Abrardi).
fig. 10 – Asti, S. Anastasio. Cripta (inizio XI secolo).
120 A. CROSETTO
fig. 11 – Asti, S. Anastasio. Muratura della parete settentrionale della cripta (inizio XI secolo).
fig. 12 – Rocchetta Tanaro, chiesa di S. Maria de Flexo. Planimetria (primo trentennio XI secolo) (ril. A. Crosetto, P. Mighetto).
costituite da un consistente getto di malta con ciottoli fluviali, mentre la facciavista degli alzati – come si vede nella muratura della parete laterale della prima cripta (fig. 11) – presenta mattoni di dimensioni non regolari e giunti, piuttosto spessi, motivati dalla necessità di ripianare le irregolarità dei laterizi.
5. Rocchetta Tanaro, chiesa di S. Maria de Flexo
La chiesetta, che si trova oggi isolata tra i campi, non lontano da un’ansa del Tanaro, rivela le sue origini romaniche nella parte absidale, decorata con specchiature terminate con una serie di cinque archetti multipli e, sotto la falda del tetto, una cornice sostenuta da dentelli. Le murature presentano i segni di una consistente ripresa in elevato, confermata visibilmente dalla posizione delle monofore dell’abside, poste quasi a livello del suolo. Tale osservazione ha condotto già in passato a varie interpretazioni sulle caratteristiche dell’impianto originario 18.
L’apertura di un cantiere di restauro ha fornito un’importante occasione per verificare con un sondaggio archeologico (settembreottobre 1989) alcune ipotesi relative alla definizione della parte absidale nella sua fase più antica. Il saggio è stato infatti localizzato all’esterno, nell’angolo sudorientale della chiesa, in corrispondenza delle visibili tracce di un fornice tamponato e in una posizione che potesse chiarire ogni dubbio sull’eventuale presenza di una cripta sotterranea. Successivamente, sempre nel corso di interventi di restauro (giugno 2000), è stato possibile indagare anche l’interno, anche se solo su uno spazio limitato.
Lo scavo ha accertato la costruzione unitaria dell’edificio di culto, del quale sono state messe in luce parte delle murature dell’abside e una struttura laterale absidata, a questa collegata. Tale struttura non è stata verificata in
18 Macera 1998, p. 161: nella scheda si rilevavano le problematiche relative al livello antico del piano di calpestio in rapporto ad una supposta sopraelevazione della chiesa e quelle sulla tipologia della costruzione originaria deducibili dalla presenza di due archi tamponati in corrispondenza del presbiterio.
tutta la sua estensione; rimane tuttavia assai probabile si dovesse trattare di una cappella laterale piuttosto che di una navata (fig. 12). La grande apertura tamponata del fornice, simmetricamente presente anche nel lato nord, è infatti collocata solo in questo punto e deve costituire il passaggio di comunicazione del transetto.
La quota del pavimento antico è segnalata da un frammento di lastra lapidea, ancora poggiato sulla risega di fondazione dell’abside e posto circa 1,00 m più in basso rispetto all’attuale piano di campagna, come è stato confermato anche nel sondaggio effettuato all’interno. La pavimentazione era in origine allettata su un sottile strato di terreno, depositato a diretto contatto del battuto di cantiere, ancora conservato in parte. Un breve scalino è ancora presente sulla parete laterale; si evidenzia così il punto di partenza del piano di spiccato ad una quota assai vicina a quella riscontrata nell’interno. Questi elementi permettono di chiarire definitivamente il problema delle monofore dell’abside centrale, ora collocate in una posizione che ha ispirato la falsa ipotesi della presenza di una cripta. In realtà la loro quota di imposta è perfettamente congrua rispetto all’altezza, in questa fase, del terreno esterno e del pavimento interno. La decorazione a specchiature delimitate da lesene ed archetti multipli doveva trovarsi, così come nell’abside centrale, anche in quelle laterali. Le dimensioni dell’arco absidale della cappella sud suggeriscono la presenza di due sole specchiature; è stata infatti recuperata la labile traccia di una sola lesena mediana.
La chiesa viene attestata per la prima volta nel 1036, tra le dipendenze di Pomposa, e questa data costituisce il terminus post quem per l’erezione dell’edificio (Bordone 1998, p. LXIX), da collocare entro il primo trentennio del secolo XI. In questa fase doveva presentarsi con un’unica navata, conclusa con un transetto interrotto e triabsidato. I confronti planimetrici, come per la chiesa di Prasco (Pittarello 1978, p. 34), paiono scarsi nell’area piemontese. In realtà per questo tipo di transetto («terminale o commisso»: Tosco 1997, pp. 5960, nota 20) possiamo raccogliere
LA PRIMA FASE ROMANICA NEL TERRITORIO ASTIGIANO E ALESSANDRINO 121
fig. 14 – Sarezzano, chiesa dei SS. Ruffino e Venanzio. Muratura esterna della parete meridionale (XI secolo).
fig. 13 – Rocchetta Tanaro, chiesa di S. Maria de Flexo. Muratura dell’abside (primo trentennio dell’XI secolo).
poche altre testimonianze: il S. Quintino di Spigno (991) e la chiesa dei SS. Nazario e Celso di Prasco (XI secolo), gli altri sono esempi più tardi tra XII e XIII secolo 19.
La muratura appartiene sempre al tipo di quelle che usano pezzame laterizio legato con malta di buona consistenza, in questo caso disposto accuratamente in fitti corsi a “spina pesce”, viste le dimensioni ridotte del materiale disponibile, e destinata ad essere rivestita di intonaco (fig. 13).
6. Considerazioni finali
La scelta di trattare questo tema, restringendo l’arco cronologico e dando conto di cantieri che hanno avuto l’opportunità di una collocazione sicura su un arco cronologico determinato, è determinata dalla improrogabile esigenza di avviare una banca dati di tecniche murarie che escano da sequenze cronotipologiche troppo labili.
Il panorama astigiano e alessandrino, tratteggiato per sommi capi in questa sede, ma che si spera di affrontare più estesamente in una futura occasione, appare caratterizzato per tutto il secolo XI dall’uso sistematico di materiali locali (elementi lapidei, ciottoli, mattoni e laterizi di reimpiego) adattati con una lavorazione sommaria alle esigenze di una muratura priva di una finitura di facciavista e destinata ad essere ricoperta di intonaco. In genere non si riscontrano che raramente officine di produzione spesso rivolte principalmente alle realizzazione degli indispensabili leganti o alle tegole di copertura 20.
19 Per i confronti si vd. Tosco 1997, pp. 5859 (Spigno; nel la citazione si suggerisce anche l’esempio contemporaneo di S. Pietro in Valle a Gazzo Veronese, ipotizzando che tale modello planimetrico si sia diffuso in Italia proprio alla fine del X secolo); Pittarello 1978, pp. 3439 (Prasco). Altri edifici sono il S. Secondo dì Arzello (Pittarello 1978, pp. 3439) e S. Benedetto di Muleggio a Vercelli (Verzone 1934, pp. 4951).
20 Si possono citare i resti di scarti di produzione nella cattedrale astigiana di S. Maria (XII secolo): Crosetto 1995, p. 268.
Le murature di XI secolo presentano sistematicamente elementi lapidei misti o mattoni di dimensioni non regolari e giunti, piuttosto spessi, motivati dalla necessità di ripianare le irregolarità dei laterizi, sostanzialmente sempre di recupero (figg. 45 e 11). Quando i materiali sono più piccoli e con una maggiore difficoltà di lavorazione (come i ciottoli, ad esempio) si utilizzano tecniche murarie funzionali alle possibilità offerte dalla forma di questi elementi: l’uso di “spina pesce” (fig. 13) o l’allettamento di ciottoli in un getto sovrabbondante di malta, con corsi spesso segnalati da stilature a punta di cazzuola, o semplicemente disposta in modo eterogeneo con una tendenza a rispettare corsi orizzontali (fig. 14).
Il cambiamento avviene alla fine dell’XI secolo quando incomincia l’uso, ancora molto raro, dei mattoni realizzati appositamente come mostra il cantiere della cattedrale di S. Maria di Asti (10911095). Tale uso prevarrà nel corso del XIIXIII secolo, unitamente con i blocchi di arenaria squadrati e disposti con accenni di alternanza bicromatica, utilizzati nelle chiese e nelle residenze urbane di prestigio. Anche se sospetta come tutte le affermazioni dei cronisti, la frase di Ogerio Alfieri riferita all’edilizia civile della città di Asti, dà effettivamente conto di una lenta trasformazione degli usi edilizi, che vedranno nel secolo seguente il deciso cambiamento: «Eodem anno [MCLXXXX], quo civitatis Astensis incoepit habere potestatem, erat dicta civitas de sepis clausa, et non erat in ipsa civitate domus aliqua de matonis novis» (Fragmenta de gestis Astensium excerpta ex libro Ogerii Alpherii civis Astensis).
122 A. CROSETTO
BibliografiaAndrews D., Pringle D., 1977, Lo scavo dell’area sud del convento di
San Silvestro a Genova (1971-1976), «Archeologia Medievale», 4, pp. 4799.
Arslan E., 1954, L’architettura dal 568 al Mille, in Storia di Milano, II, Milano, pp. 499608.
Assandria G., 1904, Il libro verde della Chiesa d’Asti, Biblioteca della Società storica subalpina, 25, Pinerolo.
Bordone R., 1998, Rocchetta Tanaro, chiesa di Santa Maria de Flesco detta Madonna delle Ciappellette. Nuovi documenti, in Le chiese romaniche delle campagne astigiane. Un repertorio per la loro cono-scenza, conservazione, tutela, a cura di L. Pittarello, III edizione, Torino, p. LXIX.
Cagnana A., 1997, Residenze vescovili fortificate e immagine urbana nella Genova dell’XI secolo, «Archeologia dell’Architettura», II, Pp. 75100.
Cerrato N., Cortelazzo M., Micheletto E., 1990, Indagine archeologica al castello di Manzano (Comune di Cherasco – Prov. di CN). Rapporto preliminare (1986-1989), «Archeologia Medievale», XVII, pp. 244255.
Crosetto A., 1988, L’antica “ecclesia sancti Stephani de Paterno” (scavi 1980-1982), «Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte», 8, pp. 85110.
Crosetto A., 1995, Indagini archeologiche nel medioevo astigiano, 4. La cattedrale di S. Maria, «Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte», 13, pp. 255284.
Crosetto A., 1997, Da Riparupta a Viatosto, in La parrocchiale di Viatosto. Ricerche e restauri 1994-1997, a cura di E. Ragusa, Torino, pp. 1316.
Crosetto A., 2001, Acqui Terme. Indagini archeologiche nella cripta del-la cattedrale (1991), «Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte», 18, pp. 3955.
Crosetto A., 2002, Asti, complesso della cattedrale. Chiesa di S. Gio-vanni e cimitero della cattedrale, «Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte», 19, pp. 111112.
Crosetto A., 2003a, Museo di Sant’Anastasio. L’area archeologica, Asti.Crosetto A., 2003b, Indagini archeologiche nella cripta della cattedrale
di Acqui Terme, in Il tempo di San Guido Vescovile Signore di Acqui. Atti del convegno di studi, Acqui Terme, pp. 195200.
Crosetto A., 2007, Nuovi dati su Asti paleocristiana. La città tra tardoantico e altomedioevo, in La cristianizzazione in Italia tra tardoantico e altomedioevo. IX Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana (Agrigento 2004), a cura di R.M. Bonacasa Carra, E. Vitale, Palermo, pp. 625650.
Crosetto A., 2011, La cattedrale di Acqui nel secolo XI, «Palazzo Madama. Studi e notizie», 1, pp. 110118.
Crosetto A., 2012, Nuovi dati su tre “curtis” altomedievali della piana alessandrina, in VI Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, a cura di F. Redi, A. Forgione, Firenze, pp. 201205.
Crosetto A., 2013, Tortona ai tempi della prima comunità cristiana (IV-VIII secolo d.C.), in Marziano e Innocenzo. Tortona paleocristiana tra storia e tradizione, Tortona, pp. 4151.
De Lachenal L., 1995. Spolia. Uso e reimpiego dell’antico dal III al XIV secolo, Milano.
Gabrielli N., 1977, Arte e cultura ad Asti attraverso i secoli, Torino.Ieni G., 1991, Acqui, in Enciclopedia dell’Arte Medievale, Roma, pp.
116120.La cattedrale 2013, La cattedrale di Alba. Archeologia di un cantiere, a
cura di E. Micheletto, Archeologia Piemonte, 1, Firenze.La chiesa di S. Dalmazzo 1999. La chiesa di S. Dalmazzo a Pedona. Ar-
cheologia e restauro, a cura di E. Micheletto, Borgo San Dalmazzo.Longhi A., 1996, La maturazione del romanico ad Asti tra XI e XII
secolo. La cripta e la chiesa di S. Anastasio, «Bollettino della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti», XLVIII, pp. 3776.
Longhi A., 1999, Scoperta e tutela degli “avanzi” del medioevo prima dell’archeologia medievale. Il caso di S. Anastasio di Asti, «Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte», 16, pp. 5577.
Macera M., 1998, Rocchetta Tanaro, chiesa di Santa Maria de Flesco detta Madonna delle Ciappellette, in Le chiese romaniche delle cam-pagne astigiane. Un repertorio per la loro conoscenza, conservazione, tutela, a cura di L. Pittarello, III edizione, Torino, pp. 159163.
Maffeis L., Pistan F., 2010, I rinvenimenti di epoca medievale, in Souveris m’en doit. Dal foro romano ai marchesi Mazzetti, a cura di F. Barello, Castell’Alfero, pp. 3540.
Maritano C., 2002. Novara come Roma: il reimpiego di marmi antichi nella Cattedrale del vescovo Litifredo, «Prospettiva», 106107, pp. 131143.
Maritano C., 2008. Il riuso dell’antico nel Piemonte medievale, Pisa.Micheletto E., Bedini E., 1992, Indagine archeologica al castello di
Manzano (Comune di Cherasco – Prov. di CN). Secondo rapporto pre-liminare (1990-1991), «Archeologia medievale», 19, pp. 223241.
Micheletto E., Mennella G., 2003, Un bollo laterizio altomedievale da Augusta Bagiennorum, «Bollettino della Società per gli Studi Storici Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo» 128, 1, pp. 133144.
Micheletto E., Uggè S., 2003, La chiesa di S. Costanzo sul Monte San Bernardo (Piemonte, Cuneo) e il suo arredo scultoreo, «Hortus Artium Medievalium», 9, pp. 383400.
Micheletto E., Uggè S., 2013, Monasteri di età altomedievale del Piemonte meridionale: Borgo San Dalmazzo, Villar S. Costanzo, Pagno, in Il viaggio della fede. La cristianizzazione del Piemonte meridionale dal IV-VIII secolo. Atti del convegno, Cherasco-Bra-Alba 2010, a cura di S. Lusuardi Siena, E. Gautier di Confiengo, B. Taricco, Carrù, pp. 171186.
Micheletto E., 1999, Archeologia medievale ad Alba: note per la defini-zione del paesaggio urbano (V-XIV secolo), in Una città nel Medioevo. Archeologia e architettura a Alba dal VI al XV secolo, a cura di E. Micheletto, Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte. Monografia, 8, Alba, pp. 2150.
Micheletto E., 2000, Il quartiere di San Lorenzo ad Alba (secoli V-XIII), in II Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, a cura di G.P. Brogiolo, Firenze, pp. 6066.
Micheletto E., 2003, Chiese e città romane “abbandonate”: alcuni esempi in Piemonte, in Chiese e insediamenti nelle campagne tra V e VI secolo. 9° Seminario sul tardo antico e l’alto medioevo, a cura di G.P. Brogiolo, Mantova, pp. 109118.
Micheletto E., 2006, La facciata della chiesa di San Pietro a Cherasco: una lettura “archeologica”, in Archeologie. Studi in onore di Tiziano Mannoni, a cura di N. Cucuzza, M. Medri, Bari, pp. 481485.
Micheletto E., 2007, Lo scavo di Mombello e l’archeologia della Iu-diciaria Torrensis, in Longobardi in Monferrato. Archeologia della “Iudiciaria Torrensis”, a cura di M. Micheletto, Casale Monferrato, pp. 4361.
Micheletto E., 2009a, Dal tempio al palazzo: un esempio di uso dell’an-tico nel medioevo albese, in M.C. Preacco, Percorsi e monumenti archeologici di Alba, 1. Il tempio romano di piazza Pertinace, Alba, pp. 3541.
Micheletto E., 2009b, Lungo la Stura di Demonte: archeologia del territorio fossanese dalla tarda antichità all’alto medioevo, in Storia di Fossano e del suo territorio, I. Dalla preistoria al Trecento, Fossano, pp. 4662.
Micheletto E., 2010, Cervere. Castello medievale. Abitato fortificato tardoantico e strutture medievali, «Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte», 25, pp. 196200.
Micheletto E., 2011, Archeologia dei monasteri altomedievali: l’ab-bazia di SS. Pietro e Colombano a Pagno, in Per diversa temporum spatia. Scritti in onore di Gisella Cantino Wataghin, a cura di E. Destefanis, C. Lambert, Vercelli, pp. 85119.
Pagella E., 1993, La croce di Vercelli. Prime osservazioni dalla restauro in corso, in Il classicismo. Medioevo Rinascimento Barocco. Atti del colloquio Cesare Gnudi (Bologna 1986), Bologna, pp. 9899.
Pejrani Baricco L., Bosman F., 2001, S. Ambrogio. Abbazia di S. Mi-chele della Chiusa. Analisi stratigrafica degli elevati e scavi nell’area dei “ruderi del monastero nuovo”, «Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte», 18, pp. 117119.
Pejrani Baricco L., 1998a, La chiesa abbaziale di Fruttuaria alla luce degli ultimi scavi archeologici, in Archeologia in Piemonte, III. Il medioevo, a cura di L. Mercando, E. Micheletto, Torino, pp. 187208.
Pejrani Baricco L., 1998b, Lo scavo della chiesa romanica di S. Gio-vanni Vincenzo a Sant’Ambrogio di Torino, in Spiritualità, culture e ambiente nelle Alpi occidentali, a cura di A. Salvatori, Stresa, pp. 167179.
LA PRIMA FASE ROMANICA NEL TERRITORIO ASTIGIANO E ALESSANDRINO 123
Pejrani Baricco L., 2002a, Lettura stratigrafica delle strutture della chiesa abbaziale di San Giusto, in La Basilica di San Giusto. La memoria millenaria della cattedrale segusina. Atti del Convegno, Susa, pp. 2758.
Pejrani Baricco L., 2002b, Archeologi alla Sacra, in La Sacra di San Michele 1991-2001, Torino, pp. 145156.
Pejrani Baricco L., 2002c, La crypte occidentale de la cathédrale d’Ivrée, in Avant-nefs et espaces d’accueil dans l’église entre le IVe et le XIIe siècle, a cura di C. Sapin, Paris, pp. 386395.
Pejrani Baricco L., 2005, Guglielmo abate costruttore nel paesaggio artistico subalpino, in Guglielmo da Volpiano. Atti della giornata di studio, a cura di A. Lucioni, Cantalupa, pp. 103141.
Pittarello L., 1978, L’architettura del S. Secondo ed i restauri in corso, in La chiesa romanica di San Secondo. Documento di un millennio di storia Arzello – Melazzo, Alba.
Porter A.K., 1917, Lombard Architecture, New HavenLondon.Quattrone S.O., 2010, I marmi della cripta di Sant’Anastasio in Asti:
schedatura e analisi petrografiche di materiali di reimpiego, tesi di laurea, rel. M. Gomez Serito, E. Rulli, Politecnico di Torino 2. Facoltà di Architettura, Corso di Laurea in architettura restauro e valorizzazione.
Quiròs Castillo J.A., 2002, Modi di costruire a Lucca nell’altomedio-evo. Una lettura attraverso l’archeologia dell’architettura, Firenze.
San Pietro 2004, San Pietro a Cherasco. Studio e restauro della facciata, a cura di E. Micheletto, L. Moro, Torino.
Segagni Malacart 2007, La cattedrale di Acqui Terme, in Medioevo. L’Europa delle cattedrali. Atti del Convegno internazionale di studi (Parma 2006), a cura di A.C. Quintavalle, Milano, pp. 106119.
Segre Montel C., 1994a, La pittura medievale in Piemonte e Valle d’Aosta, in La pittura in Italia. L’Altomedioevo, a cura di C. Bertelli, Milano, pp. 3344.
Segre Montel C., 1994b, La pittura monumentale, in Piemonte roma-nico, a cura di G. Romano, Torino, pp. 257284.
Settis S., 1984, Tribuit sua marmora Roma: sul reimpiego di sculture antiche, in Lanfranco e Wiligelmo. Il Duomo di Modena, Modena, pp. 309317.
Solaro Fissore A., 1981, Appunti sul museo lapidario medievale, Asti.
Tosco C., 1997, Architetti e committenti nel romanico lombardo, Roma.Venturino Gambari M., Crosetto A., 2009, Alessandria, piazza della
Libertà. Resti dell’antica cattedrale di S. Pietro, «Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte», 24, pp. 176180.
Verzone P., 1934, L’architettura romanica nel Vercellese, Vercelli.Verzone P., 1977, Asti Saint-Jean, in Congrès Archéologique du Piemont,
129e session (1971), Paris, pp. 354357.
SummaryArchaeology and architecture in Romanesque Building Techniques and Construction Sites in Piedmont. The Early Romanesque Phase in the Territories of Asti and Alessandria.Through a review of some of the most significant archaeological and architectural research on religious buildings dated to the end of the 10th to the middle of the 11th century, this paper attempts to establish a chronology for the territory of southern Piedmont on which to base the analysis of the building techniques. The cases of the churches of S. Giovanni di Asti (in the episcopal group), the cathedral of Acqui Terme, the church of S. Anastasio of Asti and S. Maria di Rocchetta Tanaro demonstrate the widespread use of recycled stone and brick materials which determined the use of thick joints and the construction methods employed for the utilization of the available building materials.
RiassuntoAttraverso la presentazione di alcune significative indagini archeologiche e architettoniche di edifici di culto, collocati tra la fine del X e la prima metà dell’XI secolo, si intende concretizzare una base cronologica certa, per il territorio del Piemonte meridionale da cui partire per le analisi delle tecniche murarie. I casi delle chiese di S. Giovanni di Asti (nel gruppo episcopale), della cattedrale di Acqui Terme, della chiesa di S. Anastasio di Asti e di S. Maria di Rocchetta Tanaro mettono in evidenza l’uso diffuso del reimpiego degli elementi lapidei e laterizi, che determina l’uso di giunti spessi e tipologie costruttive utilizzate per porre in opera il materiale edilizio a disposizione.