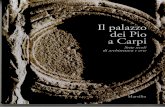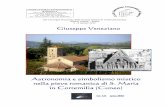D. GALLINA, 2013, La pieve di Sant’Andrea di Iseo (Bs). Dall’analisi stratigrafica e...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of D. GALLINA, 2013, La pieve di Sant’Andrea di Iseo (Bs). Dall’analisi stratigrafica e...
Architettura dell’XI secolo nell’Italia del NordStoriografia e nuove ricerche
Pavia 8-9-10 aprile 2010Convegno Internazionale
a cura diAnna Segagni Malacart e Luigi Carlo Schiavi
Edizioni ETS
000pped I_Layout 1 18/02/14 12:18 Pagina III
www.edizioniets.com
© Copyright 2013EDIZIONI ETS
Piazza Carrara, 16-19, I-56126 [email protected]
DistribuzionePDE, Via Tevere 54, I-50019 Sesto Fiorentino [Firenze]
ISBN 978-884673509-6
Volume pubblicato con il contributo del MIUR, Fondi PRIN 2007,e della Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia
Cura redazionale: Simone Caldano
Almo Collegio BorromeoUniversità di PaviaFondazione Comunitariadella Provincia di Pavia
Comune di PaviaProvincia di PaviaRegione Lombardia
000pped I_Layout 1 18/02/14 12:18 Pagina IV
Presentazioni VII
Introduzione XIII
Testi 1
Josep Puig i Cadafalch et la LombardieLa construction historique du «premier art roman»Éliane Vergnolle 3
Per l’XI secolo dell’architettura lombardaDa Arthur Kingsley Porter a Wart Arslan, a Paolo Verzone, a Gaetano PanazzaAdriano Peroni 9
Dossiers des archives de Fernand de Dartein - IIILes églises du XIe siècle en Italie du Nord dans l’œuvre de Fernand de DarteinMarie-Thérèse Camus 15
Dossiers des archives de Fernand de Dartein - IVTra le chiese di Milano, il caso di Sant’AmbrogioTancredi Bella 25
L’architettura del X e XI secolo a Nord delle Alpi e le sue relazioni con l’architettura in ItaliaWerner Jacobsen 35
Architetture dell’XI-XII secolo a confrontoOsservazioni tra esempi svizzeri e lombardiHans Rudolf Sennhauser 41
Oratorio di San Martino (Quinto-Deggio)Nuove ipotesi dalla ricerca archeologicaRossana Cardani Vergani 47
L’abbatiale romane de Baume-les-Messieurs (Jura)Premiers résultats des recherches d’archéologie du bâtiMarie-Laure Bassi 51
Verona e l’architettura lombarda nel secolo XI: l’importanza dei modelliGianpaolo Trevisan 57
Pievi romaniche e paesaggio agrario. Un caso studio: il Canavese occidentaleCarlo Tosco 69
L’architettura della cattedrale di BobbioAnna Segagni Malacart 83
Indice
001indice V_Layout 1 14/03/14 09:19 Pagina V
La chiesa di San Fiorentino a Nuvolato (Mantova) e il problema dei “cori murati” dell’XI secoloPaolo Piva 91
Osservazioni e riflessioni critiche sulla polivalenza liturgica dei battisteri nord-occidentali d’Italia dei secoli XI e XIIBarbara Bruderer Eichberg 99
Fra pre- e protoromanico lombardo: i Santi Fermo e Rustico a Credaro, Santa Maria e San Salvatore ad Almenno San Salvatore, San Salvatore a BarzanòFabio Scirea 117
La pieve di Lenno e altre questioni larianeMarco Rossi 127Appendice. Alcune osservazioni sulla tecnica costruttiva delle volte e sulle finiture di superficie della cripta di Santo Stefano di LennoDario Gallina 133
Cappelle castrensi tra Lombardia e Piemonte nel secolo XI: architetture per “un ordine nuovo”Maria Teresa Mazzilli Savini 137
Considerazioni su alcune chiese a impianto basilicale nel territorio milaneseLuigi Carlo Schiavi 157
Osservazioni sulla pittura lombarda tra X e XII secolo. Il territorio veroneseMara Mason 167
La pieve di Sant’Andrea di Iseo (Bs)Dall’analisi stratigrafica e archeologica alla politica edilizia dell’episcopato bresciano tra XI e XII secoloDario Gallina 177
Sistemi voltati nell’architettura del primo XI secoloAlcuni esempi nell’Italia nord-occidentaleSaverio Lomartire 199
Echi dell’architettura transalpina nella marca aleramicaSanta Giustina di Sezzadio e Santo Stefano extra muros di GamondioSimone Caldano 215
San Pietro di AcquiGian Battista Garbarino 223
Romanico ad Asti nel secolo XI: ricerche sulla città e sul territorioAlberto Crosetto 235
Lombard architecture? Parma, XI secolo. Il monastero di Sant’UldaricoMichele Luigi Vescovi 245
Tracce lombarde nella Toscana protoromanicaMarco Frati 253
Esplorazioni nell’architettura romanica del MontefeltroLe tecniche costruttive nell’XI secoloCristiano Cerioni 271
Immagini 281
Bibliografia 491
VI Indice
001indice V_Layout 1 14/03/14 09:19 Pagina VI
«La pieve di Sant’Andrea di Iseo, finora pochissimo nota,è un monumento di notevole interesse, sia dal punto di vi-sta della sua disposizione urbanistica che da quello archi-tettonico e strutturale»; così scriveva nel 1942 l’architettoClaudio Ballerio all’esordio di un articolo, attento ma or-mai datato, dei «Commentari dell’Ateneo di Brescia»1.Come vedremo più avanti, non è questo l’unico studiosoad aver rivolto le sue energie al complesso architettonicodi Iseo, e almeno il nome di Gaetano Panazza va ricordatoda subito, benché con una trattazione assai breve sia nel19422 sia nella Storia di Brescia del 19633, e che fu in se-guito ampliata in un contributo nei «Quaderni della Bi-blioteca Comunale di Iseo» del 19744, ovvero in una sedeche ne ha purtroppo limitato la diffusione nonostante l’il-lustre studioso vi affermasse che si trattava di «uno deicomplessi più importanti di architettura romanica esisten-ti in Italia»5. Poiché la conseguenza è stata lo sviluppo, fi-no ad ora, di un dibattito locale6, lo scopo di questo con-tributo è anche di portare ad un livello più ampio di cono-scenza e di discussione un monumento per ora poco con-siderato oltre i confini provinciali.
Anche se il nostro punto di partenza è, come detto, de-finito da studi di quasi 70 anni fa e che ‘suonano’ oggi per-sino come un monito, i decenni non sono trascorsi inva-no7, e il caso della pieve di Iseo è affrontabile oggi sola-mente sforzandosi di tenere da conto una feconda conver-genza di fonti. Queste sono rappresentate in questa sedesoprattutto dall’analisi stratigrafica della facciata, nonchédai saggi archeologici aperti nel 19828 e nel 20059, dallefonti documentarie bassomedievali10 discusse soprattuttoda Gabriele Archetti11 e da confrontare con la storiografiadei Monimenti historiali dell’antico e nobile castello di Iseodel 1685 di padre Fulgenzio Rinaldi12, non trascurandoinfine la conoscenza del contesto medievale del paese diIseo (un borgo – caso raro per la Lombardia – dove anchel’edilizia civile è stata studiata sistematicamente e in modoattento13).
Lo scopo, nel contempo ambizioso e necessario, è quin-di di non limitarsi ad un elenco di unità e rapporti strati-grafici, come ancora troppo spesso accade, ma di leggereattraverso di esse le manifestazioni di cultura materiale el’esercizio politico che segnarono la storia bresciana tra XIe XII secolo.
Non per pigra tradizione, ma con serio convincimentoderivato dallo studio di questo caso, riteniamo che sia op-
portuno iniziare da alcuni dati sul contesto storico medie-vale di Iseo.
Iseo in Franciacorta
Non è per miope provincialismo che si sottolinea spessola felice collocazione geografica di Iseo come «chiave com-merciale del lago e cerniera tra la Valcamonica e la Francia-corta»14, e anzi, come scriveva Fulgenzio Rinaldi: «le stra-de di questi Contorni, quelle, che vengono da Francia Cor-ta, dalla Pianura, e sopra tutte quella di Brescia, chi le cami-na, non dirà essere a guisa di tante linee, che vanno à darenel centro d’Iseo à condurvi, ò ricondurvi robbe vendute, òcomperate, ò venali? (…) questo è il principal Porto del La-go, dove tutte le Terre di questo Contorno fanno a capo, equello, che non è trà esse si ritrova in Iseo (…)»15. Se si ri-corda che la strada litoranea fu costruita solo nell’Ottocen-to, e che il rilievo della Corna Trentapassi si pone come se-rio ostacolo ai trasporti16, appare chiaro che i rapporti com-merciali tra le estremità meridionale e settentrionale del Se-bino avvenivano in modo privilegiato per via d’acqua. Iporti di Iseo17 e di Pisogne18 (dove la monumentale torredel prelato cittadino è il segno più evidente del controllovescovile dei commerci) rappresentarono quindi ben a lun-go19 i termini obbligati per il trasporto di persone e soprat-tutto di materiale pesante.
Iseo tra tarda antichità e alto Medioevo
Ricordando con un solo cenno i rinvenimenti archeolo-gici di età romana che testimoniano l’origine del borgo diIseo20, è necessario soffermarsi invece, in breve, sulla figuradi san Vigilio, vescovo di Brescia – secondo una ingarbu-gliata e discussa cronotassi21 – tra sant’Ottaziano e san Ti-ziano, poiché le reliquie dell’illustre prelato sono sepoltenella pieve di Iseo, ed egli sarebbe, secondo la tradizionepopolare, di origine iseana, tanto che viene persino indica-ta la “casa di san Vigilio”22. Benché siano davvero pochi idati certi, come si può ben immaginare per un vescovo diquesta antichità, nel caso di san Vigilio pare non esserviconsenso neppure sulle questioni di fondo, visto che a pa-rere di mons. Antonio Fappani egli sarebbe da collocarenella seconda metà del V secolo23, mentre secondo mons.
La pieve di Sant’Andrea di Iseo (Bs)Dall’analisi stratigrafica e archeologica alla politica edilizia dell’episcopato bresciano tra XI e XII secolo*
Dario Gallina
19Gallina 177_Layout 1 18/02/14 12:31 Pagina 177
Guerrini24 l’ambito corretto è tra 568 e 570. Va da sé che daqueste diverse posizioni derivano scenari storici dissimili.Nel caso si segua l’ipotesi del Guerrini, ci troveremmo in-fatti negli anni a cavallo dell’arrivo dei Longobardi a Bre-scia (569), con implicazioni di non poco conto, vale a direla fuga del vescovo dalla città. Come egli sottolineava25:«due soltanto sono i vescovi di Brescia che gli antichi cata-loghi ricordano sepolti in luoghi lontani dalla città: sanVigilio a Iseo, sant’Erculiano a Maderno26. Da questa indi-cazione e dal fatto che i vescovi venivano sepolti quasi sem-pre nelle basiliche da essi fondate, possiamo ben arguirecon relativa certezza storica che san Vigilio abbia fondatala pieve di Iseo e sant’Erculiano quella di Maderno, ambe-due dedicate allo stesso titolare S. Andrea»27. San Vigilio èquindi ritenuto non il titolare, ma il patrono/fondatoredella chiesa di Sant’Andrea di Iseo. Quel che più conta èche la chiesa di Sant’Andrea di Iseo, in quanto luogo di se-poltura di Vigilio, divenne «santuario della memoria epi-scopale» di un vescovo da subito ritenuto santo28.
Mentre per l’alto medioevo la documentazione archeo-logica riguarda più che altro le necropoli29, la comparsanella documentazione d’archivio di Iseo data ad un diplo-ma imperiale di Lotario I del 15 dicembre 837, quando sidà conferma al monastero di Santa Giulia di Brescia dellesue proprietà e corti, tra le quali compare Hisegies30. Nonpossono poi essere trascurati, nel consueto panorama discarsità di fonti documentarie che caratterizza questi seco-li, i passi del cosiddetto Polittico di Santa Giulia del mona-stero cittadino di San Salvatore – Santa Giulia di Brescia31,datato tra l’879 e il 906, che riguardano questa porzionedel territorio bresciano32. L’importante documento si dif-fonde abbastanza dettagliatamente sul territorio gravitan-te attorno al lago d’Iseo, anche se non mancano, come inmolti altri casi, dubbi ed incertezze nella localizzazionedelle curtes citate33. La curtis di Iseo vi appare preminenteper numero di edifici e per beni, quantomeno in rapportoa quelle che si è individuato come disposte nel territoriocircostante, poiché comprende 4 case e 3 caminate, gestiteda uno scario con la presenza di un canevarius e 13 preben-dari. François Menant sottolinea che, in un contesto di as-senza dei castra prima della fine del IX secolo (quanto me-no dalla documentazione scritta) «le polyptyque de S.Giulia ne mentionne qu’un castellum, celui d’Iseo»34, e aquesto dato va quindi attribuita una certa importanza.
«Est locus insignis, qui nomine dicitur Hisen»35: Iseo nel basso Medioevo
Nel basso Medioevo Iseo era senza dubbio il centro dimaggiore importanza36 tra quelli della Franciacorta, so-prattutto grazie al porto del quale abbiamo già detto. Oltrealla preminenza commerciale, è un chiaro segno dell’im-portanza di questo borgo anche l’estensione del territorioplebano37, che abbracciava le attuali parrocchie di Polave-
no, Brione, Ome, Monticelli Brusati, Provezze, Provaglio,Timoline, Colombaro, Clusane, Pilzone, nonché l’isola diSan Paolo, vale a dire comprendendo non solo una consi-stente parte della Franciacorta pedecollinare, ma anchebuona parte del territorio montano che si affaccia sulla Val-trompia. Se oggi, infatti, Iseo appare come un paese, purcon un centro storico di una certa dimensione di qualcherilievo, tra XII e XIV secolo doveva invece apparire assai si-mile ad una piccola città o meglio – per usare un’espressio-ne di Giorgio Chittolini – una ‘quasi-città’38.
La prima menzione del mercato pubblico di Iseo com-pare in un documento dell’1 settembre 1000 edito dal-l’Odorici39. Dell’importanza di un mercato già in que-st’epoca è inutile dire e, benché solitamente si affermi che«la distribuzione dei mercati nel territorio bresciano, co-me del resto in tutta l’Italia settentrionale, è molto com-plessa sia dal punto di vista geografico sia da quello giuri-sdizionale»40, in questo caso la sua collocazione è indub-biamente motivata dalla peculiare posizione geografica.
Iseo si affaccia sulla scena della ‘grande storia’ nel 1161quando, nel rovinoso dispiegarsi della guerra che opponeFederico Barbarossa ai Comuni lombardi, viene messa sot-to assedio dall’esercito imperiale, e infine data alla fiamme.L’importanza degli avvenimenti ha lasciato una traccia si-cura nella documentazione, a partire dalle fonti propria-mente locali (quali gli Annales Brixienses, che ricordanonella loro laconica sinteticità sotto la data del 1161 che«Yse destructus a Federico in die Sancti Nazari», vale adire il 12 giugno41), ma anche in testi di esplicita ambizio-ne storico-letteraria, quali il Carmen de gestis Frederici Iimperatoris in Lombardia42.
Come ha lucidamente dimostrato Paolo Bianchi43, afronte di una presenza ben strutturata e anzi piuttosto in-vasiva del monastero di Santa Giulia nell’alto Medioevo,emerge nella documentazione del basso Medioevo la com-pleta assenza del cenobio cittadino da Iseo, sia all’internosia all’esterno del borgo. Anche se non vi sono documentitali da seguire questa estromissione delle monache di SantaGiulia da Iseo, appare certo che il potere del vescovo di Bre-scia era strutturato già attorno alla metà del XII secolo44.
Anche il passaggio dalla Lombardia di Federico II diSvevia lasciò il segno in Franciacorta. Secondo il raccontodel Malvezzi, nel contesto di eventi che condusse nel 1237alla vittoria imperiale a Cortenuova e, nell’anno successi-vo, all’assedio di Brescia, anche Iseo era ormai passata sot-to il controllo dei fautori di Federico e di Ezzelino45. Dopoche l’assedio alla città fallì, e in seguito all’allontanamentodelle milizie di Federico, la città riacquistò, progressiva-mente e non senza fatica, il controllo di quasi tutti i castel-li che avevano abbracciato la causa imperiale46 (riconqui-stando Iseo nel 1241-1242) e scatenò contro i fautori diFederico (i cosiddetti Malesardi47) una repressione senzacondizioni per circa un decennio. La pace di Coccaglio(1272), composta per iniziativa del legato apostolico diGregorio X, pose finalmente fine a questi contrasti e a
178 Architettura dell’XI secolo nell’Italia del Nord
19Gallina 177_Layout 1 18/02/14 12:31 Pagina 178
questi continui rivolgimenti politici, decretando l’obbligodi consegnare a Carlo d’Angiò le fortezze che rimanevanosotto il controllo dei Ghibellini, e di renderne inservibilialtre48. Tra queste ultime, si è soliti includere Iseo49, ma vaprecisato che il Malvezzi non ne fa cenno50, e che questodato proviene da un capitolo degli Statuti citato dall’Odo-rici51 e che non mi è stato possibile rintracciare.
In particolare, la storia di Iseo nel basso medioevo è le-gata soprattutto a due poteri preminenti e tra loro spessocontrastanti: quello vescovile, del quale abbiamo detto, equello dei ghibellini52 Oldofredi o De Yseo53. Alleati deiFederici che dominavano la Valcamonica, ebbero pocapredisposizione ad inserirsi nell’amministrazione e nellapolitica cittadina, mantenendo il loro carattere originariodi nobiltà rurale. La tenacia del potere degli Oldofredi edella loro militanza ghibellina sembrano dimostrate dalmancato coinvolgimento della famiglia di Iseo nel proces-so di comitatinanza del comune di Brescia, che si attivòper espropriare i possedimenti dei conti rurali e per conce-dere prerogative e privilegi alle comunità, quando cioèl’azione del Comune pare seguire un indirizzo strategicomirato al consolidamento della propria presenza lungo iconfini con Cremona e Bergamo, vale a dire lungo il corsoinferiore dell’Oglio, e in Valcamonica54. La pace non pote-va però cancellare del tutto i rancori verso una famigliache aveva attivamente partecipato, insieme ai Federici, al-le manovre dell’assedio di Brescia nel 1238 e pertanto, nonsenza motivo, con il successivo prevalere dei Guelfi gli Ol-dofredi subirono rappresaglie, nonché saccheggi e distru-zione dei loro beni in Iseo, senza venirne però estromessi55.Dopo una ripresa del loro prestigio, culminato presumi-bilmente nella breve parentesi in cui i ghibellini riacqui-starono il controllo di Brescia – prima con Ezzelino(1258-1259) e poi con Oberto Pelavicino (1259-1266) –il momento di maggiore difficoltà della famiglia sembramanifestarsi pochi anni più tardi, nel 1269, quando furo-no effettivamente cacciati da Iseo. Che però il potere degliOldofredi non fosse affatto cancellato da queste disposi-zioni sembra dimostrato dal fatto che, nel 1277, il Comu-ne di Brescia deliberò il divieto di porre fortificazioni e discavare fossati in Iseo, nonché di adibire il porto alla co-struzione di navi da guerra. Questo fu deciso, evidente-mente, per tentare di arginare alcune iniziative che l’auto-rità cittadina non riusciva a controllare appieno, e che an-zi rappresentavano una minaccia diretta. Il trend positivodegli Oldofredi, in questi decenni, conosce un’impennata,come è dimostrato dalla figura di Giacomo (1251-1325).Di lui sappiamo che, diciassettenne, partecipò nel 1268insieme al padre all’assedio di Palazzolo, allora ceduta dapoco a Bergamo, e che nel 1273 si impadronì del castellodi Iseo (del quale, nel 1281, il Comune di Brescia vietò poila riedificazione del perimetro esterno); nel 1305 fu stret-to collaboratore di Gottardo Gambara, capo dei ghibellinibresciani. Se la sua figura può apparire qui sopravvalutata,è sufficiente ricordare che Giacomo Oldofredi fu per due
volte podestà di Milano (1315 e 1321) – e anche il figlioOldofredo fu personaggio di spico56. Della attività di Gia-como sappiamo soprattutto grazie all’epigrafe funeraria57
(egli morì nel novembre del 1325) che ne rammenta le im-prese civili, collocata in fronte al suo sarcofago posto infacciata presso la pieve di Sant’Andrea e commentata giàdal Rinaldi58: «Oldofredorum istic sub marmore tectumlatet insigne speculum /ingens Iacobus cuius in funeresensit mundus letale jaculum / imperi zelator igneus, rec-tor clarissimus celsarum urbi arcem fortissimam /cum diviCrucifixi castello condidit, inde turrim eminentissimam, /hunc sub annis M.CCC.XXV novembris X / VIII lexomnipotentis mortis tulit ausu saevissimo; / ora lector su-premum principem unde pie premiet suum Militem».
Le alterne fortune della famiglia, così dipendenti intutti questi decenni dal mutevole e rapido evolvere delle li-ti cittadine e dal prevalere di un partito sull’altro, si stabi-lizzarono in senso favorevole a partire dal 1331, quando fusignore di Brescia Mastino della Scala, e la loro fortunaproseguì anche dopo la sua caduta (1337), vale a dire daquando Brescia e il suo territorio passarono sotto il con-trollo dei Visconti, dei quali furono fedeli alleati59. Per tut-to il XIV secolo, e per buona parte del secolo successivo, ilpotere degli Oldofredi si estese in Franciacorta su Prova-glio, Clusane, Borgonato, Erbusco, e anche al di fuori diessa (Roccafranca, nella bassa pianura orientale, e Lumez-zane, in Valtrompia).
Se questi sono i dati essenziali del potere degli Oldofre-di su Iseo, non meno incisiva è – come detto – la presenzaepiscopale, della quale anzi siamo in grado di ricostruirecon una certa esattezza l’estensione alla fine del XIII seco-lo, come vedremo nelle pagine che seguono.
Il designamentum di Berardo Maggi (1296)
Tra le fonti medievali portate all’attenzione degli stu-diosi da Gabriele Archetti60 spiccano i Registri dellaMensa Vescovile di Brescia, che il vescovo Berardo Maggifece compilare negli ultimi anni del XIII secolo, nell’am-bito di un’ampia attività di recupero di beni e diritti epi-scopali che fu estesa a tutta la diocesi e perseguita siste-maticamente. Di particolare importanza ai nostri scopi èla lettura del Registro 5, dedicato interamente ai fitti e al-le decime riscosse in Iseo e nel suo territorio, che fu com-pilato nel 129661. Come risulta dalla tabella sottostante,elaborata sulla base dei dati della ricognizione, il vescovodi Brescia deteneva in Iseo alla fine del XIII secolo, oltread un torchio, due mulini, e 120 appezzamenti di terreno,ben 60 edifici di vario genere e un palatiummagnum ac-canto alla pieve di S. Andrea, che è stato identificato conl’edificio ancora parzialmente conservato e indagato a piùriprese62 (fig. 1).
Per quanto la forza dei poteri signorili, cioè del distric-tus, esercitati dal vescovo a Iseo non sia paragonabile a
Dario Gallina – La pieve di Sant’Andrea di Iseo (Bs) 179
19Gallina 177_Layout 1 18/02/14 12:31 Pagina 179
quella detenuta nella corte di Pisogne63 sulla sponda anord del lago, rimane indubbia una presenza fondiaria,immobiliare, commerciale e fiscale di tutto rispetto.
Il castello e le mura di Iseo
Premettendo che non ci occuperemo del castello medie-vale, del quale è stato scritto con precisione64, ci limitiamoqui ad alcuni cenni sulla cortina fortificata di Iseo (fig. 2).A dispetto delle opinioni di Fulgenzio Rinaldi sulla collo-cazione originaria dell’abitato più a monte e su una piùgrande estensione65, secondo l’opinione degli studiosi chehanno redatto la ricerca su Iseo, storia urbanistica arte edi-ta nel 198066, il borgo si sarebbe sviluppato a partire da trefuochi fondamentali: il castellum (ipoteticamente identi-ficato con la curtis citata nel Polittico di Santa Giulia), lapieve, e un burgus, vale a dire uno stanziamento germani-co in prossimità del lago e per ciò stesso predisposto allamercatura. Delle mura di fortificazione presenti in età co-munale abbiamo tracce solo nella documentazione, o permeglio dire nelle prescrizioni per la loro demolizione, chefurono deliberate forse nel 127767 a seguito alla pace diCoccaglio (1272) e che sono riportate dall’Odorici68, se-condo le quali «quod locus in quo consueverat esse ziro-
num et fortilicia de Ise et Rochetta de Monteclaro (…) quedestructe fuerunt pro Com. Brix. numquam debeat rele-vari», ovvero di spianare i fossati e di mai più riedificare lestrutture difensive. Sempre sulle orme dell’Odorici69, lafortezza di Iseo venne riattata nel 1278 su iniziativa delComune di Brescia, come dimostrerebbe la registrazionedelle contribuzioni versate a tale scopo alla città dalla co-munità di Bovegno in Valtrompia. Il crescere del potereguelfo non poteva però non suscitare la reazione violentadei Federici che, scesi dalla Valcamonica nel 1288, costrin-sero i nemici a ritirarsi dentro il castello e – a prestar fedealla lettura dell’Odorici – lo distrussero70.
Con l’avvento di Giacomo Oldofredi (+1325), Iseo fusaldamente nelle mani della famiglia ghibellina per unperiodo sufficiente a riceverne l’impronta, rappresentatadal nuovo circuito murato che è tuttora percepibile nellatopografia, e che è anche stato recentemente indagato ar-cheologicamente71. Per individuare l’area difesa dalle mu-ra è infatti sufficiente osservare la topografia e la topono-mastica72 del centro e consultarne la cartografia ottocen-tesca: ha la forma di un poligono piuttosto irregolare che,a partire da una sorta di vertice che si trova topografica-mente un poco sopraelevato, occupato dal castello, si al-larga discendendo verso il lago. Della cortina fortificatarimangono oggi visibili dopo le demolizioni ottocente-
180 Architettura dell’XI secolo nell’Italia del Nord
19Gallina 177_Layout 1 18/02/14 12:31 Pagina 180
sche ben pochi resti, mentre alcune delle porte sono tut-tora visibili, benché ormai disarticolate dalla viabilità au-tomobilistica73. L’accesso al borgo murato avveniva quin-di, muovendoci da ovest e in senso antiorario, attraversoquattro porte-torri: la porta del Campo, posta a scavalcodella via omonima, che collegava Iseo con il territorio a ri-dosso del Sebino, e che fu demolita da Rodolfo Vantini;la porta del Sambuco74, tuttora conservata e posta pochecentinaia di metri più a sud, che giace ormai priva di sen-so urbanistico a causa dell’apertura nella seconda metàdell’Ottocento di viale Repubblica; la porta di Mirolte,pure abbattuta dal Vantini75, che si trovava poco distantedal castello, e che rappresentava probabilmente l’accessoprincipale al paese grazie alla sua vicinanza con la viabili-tà maggiore, proveniente da Brescia (e diretta in Valca-monica per chi non si imbarcava qui76); la porta del Por-ciolo, in prossimità dell’area della Pieve di Sant’Andrea,anch’essa demolita nel 184077. L’osservazione delle strut-ture conservate, unitamente ai rilievi e alle descrizioni ot-tocentesche di cui abbiamo detto, ci porta a dire che sia-mo di fronte ad un apparato difensivo abbastanza comu-ne e modesto dal punto di vista della tecnica militare,poiché torri di questa tipologia e dimensioni trovano nu-merosi confronti anche nei centri meno importanti. L’al-tezza della torre del Campo è infatti di 14,60 m, quella diMirolte di 13,90 m, quella del Porciolo di 11,50 m circa, ela funzione difensiva sembra quindi ricadere quasi esclu-sivamente sul castello. La nostra valutazione deve però ri-guardare anche lo sviluppo complessivo, poiché Iseo pre-senta un perimetro fortificato di dimensioni del tuttopreminenti al confronto degli altri ricetti e borghi muratidella Franciacorta, anzi quasi di dimensioni urbane.
L’area plebana e la chiesa di Sant’AndreaGli studi negli anni tra anni ’40 e ’70
È sufficiente osservare i Catasti del XIX secolo percomprendere che l’area plebana di Iseo è di grande interes-se. Oltre alla chiesa di Sant’Andrea, della quale ci occupe-remo, l’area (figg. 3-5)è segnata dalla presenza della chiesadei Disciplini o di San Silvestro78 che nel medioevo funge-va probabilmente da cappella privata del vescovo79, conuna bella abside duecentesca, simile per tecnica a quella diSanta Maria di Erbusco80 e di San Giacomo al Mella diBrescia81, e dall’oratorio barocco di San Giovanni, che ‘ri-calca’ evidentemente un antico battistero82, e da edifici ro-manici di tutto rispetto83 che – come detto – possonoprobabilmente essere identificati con il palatium magnumdel vescovo. Poiché della topografia e della monumentali-tà di questo assetto è già stata compiuta un’analisi attenta,ed è stata proposta una ricostruzione grafica (nonché unplastico) (fig. 5), concentreremo le nostre energie sullapieve, che rimane per molti aspetti un edificio di difficilecomprensione e lettura.
A chi osservi la chiesa di Sant’Andrea appaiono subitocome caratteristiche l’imponenza complessiva del monu-mento, ben superiore a quella delle altre pievi della Fran-ciacorta, e l’originalità del campanile posto nel mezzo del-la facciata che è, a parere del Panazza, in ambito bresciano«uno dei monumenti più importanti»84 nonché «il piùbel campanile romanico»85 (fig. 6).
Sulle orme di una lettura avanzata nel 1934 da mons.Paolo Guerrini, a margine del suo studio storico sulla pie-ve di Iseo86, Ballerio e Panazza affermano concordementeche la fase più antica della facciata (definita dal primo co-me «piuttosto tormentata», e che, «dati i numerosi rifa-cimenti subiti nella sua storia plurisecolare, presenta unagrande eterogeneità di murature»87) è costituita dal cam-panile e dalle ali di muratura (larghezza 2,80 m) che gli so-no indubbiamente connesse, che mostrano una struttura euna tessitura datate in base alle loro caratteristiche al XIIsecolo, e che è «ben diversa da quella sempre delle zoneinferiori corrispondenti alle due navate laterali, che è cer-tamente da assegnarsi al sec. XIV o ai primi decenni delXV»88. I nostri autori ne ricavano una chiesa ad una solanavata, quindi piuttosto stretta e verticalmente moltoslanciata (fig. 7), che troverebbe il suo confronto più con-vincente nella celebre Santa Maria del Tiglio di Gravedo-na, sulla sponda occidentale del lago di Como89, che peròci pare avere caratteristiche solo parzialmente simili allachiesa di Iseo. Peraltro, Gaetano Panazza rivide poi questaipotesi, esprimendosi, seppur cautamente, a favore di unachiesa a tre navate90. Qualche differenza interpretativa vie-ne da Valentino Bedeschi91 che, pur ritenendo le navate la-terali aggiunte, ritiene che il campanile del XII secolo siastato inserito nella chiesa altomedievale, e da Guido Cana-li, che data l’edificazione del campanile all’XI secolo, el’aggiunta delle archeggiature e la sopraelevazione al XIIsecolo92.
Gli studi archeologici e stratigrafici
Una tradizione piuttosto tenace93 vuole inoltre che lachiesa sia sorta in sostituzione di un tempio pagano anti-co, che si ritiene fosse dedicato a Diana o Iside94. Purtrop-po, delle presunte preesistenze romane (epigrafi, fram-menti architettonici antichi, e un bassorilievo raffiguranteErcole collocato al di sopra del portale95) testimoniate dal-lo storico seicentesco Fulgenzio Rinaldi, non rimane oggialcunché. Per di più, di un edificio così antico non sonomai state trovate sicure ed estese tracce archeologiche, poi-ché i resti individuati archeologicamente sono datati allatarda antichità96.
Una nuova e più fondata analisi dell’insieme della pievee poi della facciata di Sant’Andrea è stata affrontata neglianni ’90 da Andrea Breda97 che, con Angelo Valsecchi eFulvio Sina, ha applicato i metodi dell’analisi stratigraficadegli elevati (poi definita come archeologia dell’architettu-ra98). Le acquisizioni di allora sono state riviste e integrate
Dario Gallina – La pieve di Sant’Andrea di Iseo (Bs) 181
19Gallina 177_Layout 1 18/02/14 12:31 Pagina 181
da chi scrive99, anche grazie al fotoraddrizzamento dellafacciata100 elaborato nel 2003 e che costituisce una base or-mai imprescindibile per questo genere di studi (fig. 6).
Se la cronologia assoluta (metà del XII secolo101) asse-gnata al campanile rimane un dato del tutto condivisibilein ragione della sua composizione architettonica e della ti-pologia muraria, sembra invece che il rapporto tra le duefasi sia da invertire, vale a dire che la torre campanaria è sta-ta inserita in rottura al centro di una chiesa preesistente, icui resti sono proprio da identificare con le porzioni prece-dentemente datate al XIV-XV secolo. Per meglio argomen-tare questa proposta di lettura, andiamo ora presentandocon ordine le fasi individuate grazie all’analisi stratigrafica.
Fase A (ante XI secolo)
Secondo una tradizione della quale abbiamo già detto,la pieve di Iseo sarebbe stata fondata da san Vigilio, vesco-vo di Brescia102. L’unico ed esiguo indizio di una fase alto-medievale viene dallo scavo condotto nel 1982 all’internodell’ambiente [c] del campanile103, poiché questo si trovafondato sulla rasatura di un’imponente muratura, alla qua-le sono associati i resti di almeno due livelli pavimentali. Inmancanza di materiali datanti, l’unico elemento valutabilerimane quello dell’anteriorità stratigrafica di questa strut-tura muraria al campanile del XII secolo. Se da un lato èvero che non rimangono evidenze sicure di una fase alto-medievale dell’edificio, la sepoltura al suo interno di sanVigilio, vescovo di Brescia, è peraltro un segno indubbiodella sua vetustà.
Fase B (XI secolo)
La prima fase conservata in elevato è rintracciabile nel-la facciata e in parte del perimetrale nord, fino ad un’altez-za massima di 5,70 m (presso lo spigolo settentrionale del-la chiesa), e presenta una muratura104 ‘a piccolo apparato’con tessitura ordinata di blocchetti di medolo105 regolar-mente sbozzati, di modulo quadrato di circa 15 cm di lato(fig. 8). Sebbene tale apparecchiatura sia ormai quasi com-pletamente priva delle malte di finitura, frammenti digiunti piuttosto abbondanti e irregolarmente stilati sonoconservati qui e là, e sono indizi più che sufficienti percomprenderne l’originario aspetto.
Una muratura con queste caratteristiche di regolarità sidiscosta sensibilmente dalle disordinate (ma non ineffi-cienti106) tessiture altomedievali, quali sono conservate inelevato in Franciacorta, nella chiesa di San Clemente diErbusco (che è di fatto inedita) e in quella di Sant’Eufemiadi Nigoline di Cortefranca107, databile alla fine del X seco-lo a parere del Panazza108, e alla fine dell’VIII secolo secon-do Archetti109. Passando alle tessiture murarie proprie delromanico e rimanendo sempre nell’ambito franciacortino,la muratura in questione della pieve di Iseo è invece piena-mente assimilabile e confrontabile con quelle della fase
più antica della canonica di Sale Marasino110 (fig. 9), non-ché con il campanile della chiesa di Sant’Eufemia di Vello(datata alla metà dell’XI secolo dal Panazza111), e mostraqualche affinità con l’abside nord di San Pietro in Lamosadi Provaglio d’Iseo, assegnata al 1083 su base documenta-ria112. Allargando lo sguardo al territorio bresciano, note-voli somiglianze vi sono con la chiesa di San Lino di Bin-zago di Agnosine, e qualche somiglianza con San Siro diCemmo (datata dal Panazza inizialmente alla prima metàdel XII113 e poi alla fine dell’XI secolo114), la cui muraturaappare già avviata verso i moduli rettangolari del materia-le che prevarranno nel XII secolo.
Coeve a questa muratura sono, in facciata, le due stret-te porticine115 con fianchi in pietra e ghiera laterizia a pie-no centro. La porta sulla destra (Us 152, fig. 10) è ancoraben leggibile, e probabilmente si conserva visibile in tuttala sua grandezza (0,83 x 2,40 m), decorata da una ghierarealizzata con laterizi (probabilmente embrici di età roma-na) messi di piatto e tagliati in forma di trapezio, alternatiad altri laterizi che creano fasce più sottili. Quella a sini-stra (Us 102, fig. 11), oltre ad essere priva del piedritto didestra e di parte dell’arco, emerge dal terreno per soli 1,65m (ed è quindi presumibilmente interrata per altri 0,75m). Pur con caratteristiche abbastanza simili, si differenziada quella a destra per la presenza di un doppio bardellonelaterizio, all’interno del quale si intravede, tra le malte mo-derne di ‘restauro’, una decorazione a denti di sega, pure inmattoni. Le decorazioni di questo genere su ghiere a pienocentro non sono frequentemente attestate per una crono-logia così alta, ma va anche detto che una definizione cro-notipologica116 delle aperture bassomedievali non solobresciane117, ma più in genere della Lombardia orientale èancora lontana dall’essere conosciuta quanto in altre zoned’Italia118.
Qualche attenzione deve essere dedicata anche alla po-sizione delle porte, così prossima agli estremi della facciatada essere anomala, cosicché non è semplice né compren-derne il motivo, né ipotizzare la composizione complessi-va dell’edificio. Senza dubbio una migliore conoscenza de-gli edifici lombardi e una più specifica attenzione potran-no fare luce su questa stranezza, per la quale noi possiamocitare il solo confronto della chiesa di San Ponzo, nel-l’omonima frazione di Ponte Nizza (Pv)119.
Lungo il fianco settentrionale, la muratura a blocchetticomprende una sottile finestra, che misura circa 50 x 170cm, ed è definita da un arco a pieno centro in blocchetti dipietra con laterizio all’imposta, e che senza dubbio si ri-proponeva lungo il fianco della chiesa. Questa aperturatrova confronti in finestre come quella, murata, in San Li-no di Binzago di Agnosine.
Con questi pochi elementi a disposizione, è possibile ri-cavare soltanto la larghezza in facciata della chiesa dell’XIsecolo, pari a 21,60 m, cioè dimensioni ragguardevoli perl’epoca, e presupporre proprio in ragione di questa estensio-ne la sua articolazione interna in tre navate. Nulla di certo è
182 Architettura dell’XI secolo nell’Italia del Nord
19Gallina 177_Layout 1 18/02/14 12:31 Pagina 182
invece possibile dire né della sua lunghezza (che, se similealla chiesa di XII secolo, sarebbe di circa 40 m, abside esclu-sa), né della presenza della cripta (vd. infra) ricordata daFulgenzio Rinaldi, della quale è ignota l’esatta cronologia.
Fase C (XII secolo120)
Come anticipato, nel XII secolo (tav. XIII; figg. 14-15)viene inserito in rottura al centro della chiesa il campanile,che si pone a cavallo della facciata preesistente con un ag-getto esterno di circa 0,90 m, e protendendosi all’internoper circa 4,40 m, per una profondità complessiva quindi di5,30 m. Oltre alla canna del campanile [A], ben percepibi-le all’esterno, la struttura inserita nel corso di questa fase ècostituita da altri due corpi meno evidenti dalla piazza,senza dubbio edificati contestualmente alla torre centra-le121 e collocati a N (corpo [B]) e a S (corpo [C]) di essa,che hanno un’altezza minore corrispondente all’inclina-zione delle falde del tetto della navata centrale, che emer-geva sopraelevata dalle navate laterali grazie alla presenzadel cleristorio.
Il campanile del XII secolo, incompleto perché modifi-cato nel XIII secolo, è conservato fino ad un’altezza massi-ma di 27 m circa dall’attuale soglia d’ingresso (che, lo ri-cordiamo, si trova a 0,75 m al di sopra del pavimento me-dievale rinvenuto nel corso degli scavi condotti nel suo in-terno nel 1982), e riteniamo possa essere efficace una suadescrizione partendo dal basso.
Del portale originario è possibile oggi solo individuarela larghezza (3,45 m), poiché il profilo della ghiera è statocancellato dall’inserimento del portale barocco (Us115)122. Anche se non è sempre chiaro il confine tra la mu-ratura medievale e gli interventi posteriori (Us 159 e 160),a causa del probabile reimpiego di alcuni conci e per lapresenza di stesure di malta cementizia che mascherano li-miti e bordi, è comunque possibile ricostruire un fornice apieno centro con altezza massima pari a 6,20 basandosi tral’altro sui resti della cornice, semplice e lievemente agget-tante (Us 157 e 158), che segna la quota d’imposta dell’ar-co. Come indica il ‘rigiro’ della cornice verso l’interno, ilportale non sporgeva dal filo della facciata e l’ingresso do-veva poi restringersi tra strombature e colonne, così comeproponiamo nella nostra ricostruzione tridimensionalesul modello del portale meridionale della chiesa di San Si-ro a Cemmo.
All’interno della prima specchiatura, riquadrata in ori-gine da una piccola cornice della quale rimane un soloframmento a sporgere dal filo della muratura (Us 161), in-contriamo la prima apertura (Us 117): una stretta mono-fora (14 x 83 cm), definita alla sommità da due elementi inpietra di Sarnico sui quali è lievemente inciso il profiloestradossato dell’arco per suggerire la presenza di una ghie-ra. La specchiatura è perimetrata dalla cornice laterizia Us118, decorata da 8 archetti ciechi leggermente ribassati(corda 42 cm, freccia 17 cm), sostenuti da piccoli peducci
in pietra (altezza 12 cm) e separati da laterizi ritagliati aforma di rombo e posati di piatto, e sormontati poi da duecorsi in mattoni (quasi sicuramente di reimpiego vista laloro disomogeneità dimensionale). Si noti già in questoprimo elemento decorativo della superficie del campanilel’asimmetria esecutiva con la quale vengono condotti i la-vori, poiché mentre il lato sinistro della cornice poggia sulbordo della specchiatura, a destra essa si inserisce in rottu-ra nella muratura in pietra.
La seconda specchiatura, introdotta da una cornice inpietra (Us 162) non aggettante e tagliata obliquamenteper raccordare il piombo della cornice con quello dellaspecchiatura medesima, mostra poi un evidente ed ano-malo orizzontamento dei corsi di muratura, che nel suo12° filare pende verso sinistra di quasi 15 cm, per poi ‘re-cuperare’ un andamento corretto nei piani di posa succes-sivi, mentre la soprastante cornice laterizia inclina versodestra di circa 7 cm, creando così un effetto di ‘incrocio’piuttosto raro nell’edilizia romanica. Di particolare inte-resse è la presenza, in prossimità della cornice ad archettiUs 119 (in tutto simile a Us 118, salvo il suo ammorsarsisia a destra che a sinistra nella muratura), di due interventidi riparazione (Us 120 e Us 121, rabberciato da cementomoderno) degli spigoli della torre. Poiché la muratura la-terizia con cui essi sono realizzati sembra recare traccia distilature delle malte, non sembra possibile dubitare dellaloro appartenenza al medioevo. Osservando l’appiombodegli spigoli del campanile, sembra inoltre abbastanzachiaro che, proprio a questa altezza, essi subiscono un ‘rio-rientamento’: mentre l’angolo destro prosegue nella co-struzione mantenendo quasi perfetta la sua perpendicola-rità (cioè inclinandosi di soli 4-5 cm nei successivi 14 m),quello di sinistra ‘piega’ verso l’interno, producendo un re-stringimento delle dimensioni della canna di circa 24 cmall’altezza della trifora tamponata Us 129. Quindi il cam-panile, più che pendere, presenta un andamento asimme-trico, poiché il suo lato sinistro si restringe salendo versol’alto assai più di quanto faccia il corrispettivo destro. Acosa imputare questa sorta di correzione in corso d’opera?Una spiegazione viene forse dallo scavo condotto nel1982123, poiché in corrispondenza del pilastro sud-est, chepoggia – come detto sopra – sulla muratura rasata di unedificio preesistente, è stato individuato un intervento disottomurazione della fondazione del pilastro stesso, e l’ar-cone meridionale che ne deriva è stato tamponato in mo-do del tutto coerente tipologicamente e tecnicamente conquesta fase, come indica la muratura stilata, vale a dire abrevissima distanza di tempo dall’erezione del campanile.È quindi possibile pensare ad un lieve cedimento, cheavrebbe indotto una correzione visibile sia nelle anomaliedi orizzontamento dei corsi di muratura, sia nelle devia-zioni nell’appiombo degli spigoli, sia nella sottomurazionedel pilastro. Notiamo infine che queste lesioni sono adun’altezza del campanile corrispondente al punto di ap-poggio del tetto obliquo che si diparte dal cleristorio della
Dario Gallina – La pieve di Sant’Andrea di Iseo (Bs) 183
19Gallina 177_Layout 1 18/02/14 12:31 Pagina 183
navata centrale, ovvero dove la canna si ‘stacca’ da tutto ilcomplesso di murature della chiesa per salire isolata. Cer-to è che solo uno studio specifico di tipo strutturale potràdire si si tratta di una lesione da dissesto o da sisma; in que-st’ultimo caso, il termine cronologico di riferimento (uti-lissimo anche per la datazione del campanile di Iseo) sa-rebbe il famoso terremoto del 1122124. Gli studi sui terre-moti storici sono un tema importante e allo stesso tempodelicato125 e, poiché nel territorio bresciano sono staticompiuti solo i primi passi di un approfondimento criti-co126, è bene attendere dati più sicuri.
Nella terza specchiatura si apre una finestra (Us 122,fig. 12) caratterizzata da un profilo piuttosto inconsuetonell’architettura romanica, ma non privo di confronti inarea lombarda, come già puntualizzò il Porter127 e come haulteriormente dimostrato il Verga analizzando una fine-stra del duomo di Crema128. La finestra ha infatti una for-ma che, con qualche impaccio (visto che si è avanzata an-che la proposta di chiamarla “elicoidale e meglio a biscot-to”129), si è soliti definire ‘ellittica’, oppure ‘ad arco rove-scio’ o infine ‘a doppio arco contrapposto’; misura 108 x54 cm, e i laterizi inseriti negli angoli rivelano la cura com-positiva con cui fu realizzata. La successiva cornice (Us123), presenta caratteristiche abbastanza simili a quelle giàdescritte, differenziandosene però in quanto si aggancia suentrambi i lati alla muratura degli spigoli, ma penetrando-vi meno dell’Us 119, ed è sormontata da un solo filare dilaterizi. Salendo fino alla cornice Us 124, notiamo che ècomposta da 7 archetti anziché 8, ed è priva dei laterizi dicoronamento, avendo pertanto un’altezza complessiva di54 cm.
Nella quarta specchiatura che segue è posta la grandebifora Us 125 (larghezza 1,85 m, altezza 2,05 m), ora tam-ponata (Us 126), con archeggiature a tutto sesto (raggio0,45 m) e sottile ghiera in pietra. La colonna centrale, na-scosta dal tamponamento, doveva comunque essere piut-tosto sottile, come dimostra la dimensione del piano d’im-posta dei due archi, largo 10-11 cm. La cornice successiva(Us 127), pure di 7 archetti, vede l’uso del laterizio soloper il profilo degli archi, mentre tutto il resto è eseguito inpietra, e costituisce il piano della trifora Us 128, dal profi-lo piuttosto asimmetrico, irregolare, e persino oltrepassa-to. In questo caso, alcune sbrecciature del tamponamentopermettono di intravedere che il profilo delle ghiere dellatrifora è ricassato. E qui si interrompe la muratura del XIIsecolo, che doveva trovare il termine in una cella campana-ria cuspidata, probabilmente senza che sia necessario ipo-tizzare un ulteriore piano130.
Vediamo ora di sviluppare alcune considerazioni sulleprassi costruttive e sulla loro simmetria e ripetitività inquesto monumento. Già abbiamo detto dell’irregolaritàcostruttiva delle cornici, ovvero di un elemento che do-vrebbe essere tutto sommato ‘seriale’ e che invece, quasiogni volta, è stato risolto operativamente in modo diverso.Se poi osserviamo la composizione architettonica del
campanile, notiamo questa irregolare successione dimen-sionale dell’altezza delle specchiature: prima specchiatura:3,00 m; seconda specchiatura: 3,57 m; terza specchiatura:4,27 m; quarta specchiatura: 4,02 m; quinta specchiatura:3,58 m. Al di là dell’impressione di coerenza compositivache si percepisce dalla piazza, il campanile rivela quindi,ad un esame più attento, alcune asimmetrie e irregolaritàesecutive abbastanza inconsuete per un edificio di questolivello e impegno. Basta infatti confrontarlo con un altrogrande campanile bresciano, quello della Pieve di SanGiovanni Battista di Tremosine131, per notare come que-sto sia invece il risultato di un cantiere molto più omoge-neo nelle sue scelte.
Altre osservazioni che ci paiono utili possono essereavanzate in merito ai fori pontai, vale a dire uno degli ele-menti che si è soliti commentare come importante per lacomprensione del cantiere medievale e che, in contrastocon queste dichiarazioni, viene di fatto quasi sempre tra-scurato o insufficientemente spiegato132. Le serie di foripontai tuttora visibili mostrano invece un ‘passo’ abba-stanza costante133 tra 1,10 e 1,45 m nel posizionamentodelle impalcature. Da questi dati si può desumere che nonpotevano coesistere in funzione due piani di tavolato con-tigui, poiché l’altezza che intercorre tra di essi è sempretroppo bassa perché vi si possa muovere e lavorare, ma cheun unico piano di ponteggio veniva progressivamente in-nalzato in modo che i muratori si muovessero con una cer-ta comodità operativa. A sostegno di questa ipotesi, chevede un tavolato a sbalzo progressivamente smontato e ri-montato, al quale si accedeva tramite scale lignee posteprobabilmente dentro la canna del campanile, è il fattoche, come è possibile osservare dall’interno, i fori pontaisono passanti attraverso tutto lo spessore della muratura.Questo assetto ci suggerisce alcune considerazioni relativeall’organizzazione del cantiere134, poiché risulta ovvio chenon era possibile la presenza contemporanea di molte per-sone su un unico piano di ponteggio. Questo dato ben siconcilia del resto con la specializzazione richiesta ai co-struttori di campanili, e potrebbe indicare quindi che le‘imprese’ che si dedicavano a questi cantieri erano costitui-te da un numero abbastanza limitato di muratori (7-8 almassimo?), con i quali dovevano poi – ovviamente – col-laborare a piè d’opera i lapicidi che predisponevano il ma-teriale per la posa.
L’ispezione dell’interno135 del campanile di Iseo mostrapoi che, a differenza di altri campanili romanici e torri anoi noti, e non solo in Franciacorta e sul Sebino (Sale Ma-rasino, Ome, Paratico), la muratura interna non si assotti-glia salendo verso l’alto, con la duplice conseguenza dicreare delle riseghe sulle quali era comodo collocare gliorizzontamenti lignei, e di alleggerire la struttura del cam-panile laddove non erano più necessari grandi spessori pergarantirne la solidità statica. Nel caso di Sant’Andrea, vi èinfatti solamente un gradino, di circa 10 cm, lungo il latoovest, mentre gli altri tre lati rimangono di uguale spessore
184 Architettura dell’XI secolo nell’Italia del Nord
19Gallina 177_Layout 1 18/02/14 12:31 Pagina 184
sino alla sommità conservata. In questo caso, poi, sembrachiaro che la risega non fu predisposta per l’installazionepermanente di un solaio ligneo, ma probabilmente soloper poggiare una sorta di piattaforma temporanea, funzio-nale al cantiere. Ciò si desume osservando che i corsi dimuratura che corrispondono a questo tavolato, e che neerano quindi coperti, sono – a differenza degli altri solairintracciabili (vd. infra) – totalmente privi di stilature, ilche dimostra da un lato che la finitura delle superfici dellemalte non veniva necessariamente effettuata in immediatacontiguità temporale con l’erezione della struttura mura-ria, e dall’altro suggerisce che questo orizzontamento fusmontato a cantiere finito.
L’osservazione dei fori pontai mostra inoltre che sonoben distinguibili due diversi insiemi: il primo comprende inumerosi alloggiamenti dei travetti su cui poggiava l’im-palcato di cantiere, che abbiamo finora descritto e che mi-surano circa 14 x 14 cm, disposti in serie di tre su ogni latodel campanile; al secondo appartengono invece i fori dimaggiore dimensione (20 x 20 cm136), pure in serie di tre,presenti solamente sui due lati opposti della struttura, e neiquali erano quindi infisse travi lignee, sui quali poggiavanoi piani di solaio137. Si nota a questo proposito che ogni so-laio vede un diverso orientamento, vale a dire che si alter-nano una direzione est-ovest ed una nord-sud delle travi disostegno. L’assenza di fori tali da suggerire l’addossamentodi scale lignee a gradini che salissero diagonalmente lungole pareti interne, induce ad ipotizzare che i diversi pianifossero dotati di botole, e che i dislivelli tra i vari solai fos-sero superati ricorrendo semplicemente a delle scale a piolio comunque non ammorsate nella muratura.
Le caratteristiche della muratura sono qui assai meglioosservabili che all’esterno, dove i fenomeni di degradohanno compromesso la conservazione e la leggibilità dellefiniture. In particolare, le stilature sono del tipo ‘schiaccia-to’, ottenute eseguendo quelle verticali prima delle oriz-zontali, cioè per molti aspetti simili a quelle della Canoni-ca di Erbusco138. A differenza di quelle però, che costitui-scono un esempio di perfezione esecutiva, qui talvolta letracce verticali oltrepassano gli orizzontamenti, e questiultimi sono eseguiti abbastanza sovente con un andamen-to abbastanza ondeggiante. Mentre la faccia esterna dellamuratura139 presenta corsi di muratura di altezza abba-stanza costante, e comunque mai inferiori ai 12-15 cm, perl’interno sono stati utilizzati conci lapidei spesso più mi-nuti, e – nel caso di corsi di orizzontamento – talvolta dav-vero piccoli (5 cm). Questo comportamento rispondequindi alla naturale tendenza di collocare il materiale mi-gliore all’esterno, e di porre in opera all’interno anche mol-ti pezzi minuti e quasi di scarto. Anche per questo motivo,il reticolo delle stilature che ne risulta è assai più variegatoed irregolare di quello che doveva impreziosire l’esterno, eche oggi possiamo percepire con difficoltà.
Ricostruzione virtuale della chiesa del XII secolo e articolazione interna del campanile
«Ma gli elementi di maggiore interesse del nostro cam-panile ci vengono dall’interno»140, e ad essi vanno riserva-ti uno spazio adeguato ed un’attenzione particolare. Perquesto motivo, appoggiandoci ai rilievi effettuati nel 1982dagli architetti Luigi Pezzotti ed Ezio Pedrocchi141, abbia-mo ritenuto opportuno elaborare un modello tridimen-sionale (figg. 13-15) dell’assetto di XII secolo per mostra-re con maggior chiarezza ciò che pareva difficile spiegarecon le sole parole, e per verificare la plausibilità delle no-stre ipotesi142.
Questi i dati storici che ci paiono fondamentali per‘smontare’ dall’attuale chiesa da tutti gli interventi poste-riori, e che abbiamo ricavato soprattutto dai Monimentihistoriali di Fulgenzio Rinaldi: 1498, 30 luglio, la chiesaviene consacrata per l’ultima volta (e questo sembra l’indi-zio dell’esecuzione di lavori di un certo peso, che peròl’analisi della facciata non conferma); 1524, deposizionedel corpo di san Vigilio nella cripta143; 1526, inserimentodelle volte nelle navate, in sostituzione del tetto, ed elimi-nazione delle 8/10 grandi finestre preesistenti144; 1538,intonacatura delle pareti, che nascose le decorazioni pit-toriche preesistenti, soprattutto devozionali o ex-voto, di-pinte sia sulle pareti che sui pilastri, e che erano ormai am-malorate e quasi illeggibili145; 1628, asportazione dal cam-panile del bassorilievo con Ercole, e interventi di rinforzoalla torre campanaria146; 1628, demolizione della tombaBonfadini, posta in facciata, a sinistra del campanile147;1633, traslazione del corpo di san Vigilio dalla cripta,«per esser luogho humido et che al tempo delle granpioggie inondava, et anco non essendo tenute in debitaveneratione sì perché la cappella mancava delli debiti or-namenti come anco per esser luogho molto remoto et in-habitabile per le suddette cause»148; 1667, distruzionedella cripta a causa dell’umidità e dell’abbandono in cuiversava, anche in seguito alle prescrizioni enunciate dallavisita pastorale di San Carlo Borromeo149; subito dopo il1667, costruzione della sacrestia150; in anni imprecisati,ma comunque nell’ambito del XVII secolo, demolizionedelle altre tombe di minore pregio, che erano addossate allato settentrionale della chiesa151; 1728-1765 (ovvero du-rante la reggenza da parte dell’arciprete Giambattista Lus-signoli), demolizione delle tre antiche absidi così da allun-gare la chiesa152, aggiungendovi inoltre il transetto tuttoravisibile e rinnovando il presbiterio153; 1826-1840, ristrut-turazione della chiesa in chiave neoclassica ad opera del-l’architetto Rodolfo Vantini154. In questa occasione, se-condo il Rosa, «s’abbattè un lato dell’antica Chiesa, cheera di costruzione lombarda ed era parte della basilica chesi eresse dopo il Mille sulla Chiesa più antica, più bassa epiù piccola»155, ma sembra davvero che qui lo storicoabbia preso un abbaglio.
Secondo la descrizione del Rinaldi, la cripta era voltata,
Dario Gallina – La pieve di Sant’Andrea di Iseo (Bs) 185
19Gallina 177_Layout 1 18/02/14 12:31 Pagina 185
a tre navate con pilastri, ampia quanto il soprastante coro,e dotata di una scala d’accesso di dodici (o più) gradini,posta centralmente al presbiterio sopraelevato, al quale sigiungeva attraverso due scale laterali in pietra156. I dati ri-portati dal Rinaldi appaiono troppo dettagliati per esserefalsi, anche perché il nostro autore andò in stampa a soli18 anni di distanza dalla demolizione della cripta, ed èquindi estremamente plausibile che ne avesse un ricordodiretto e preciso.
Non ultimi, vi sono due disegni attribuiti all’architettoRodolfo Vantini157 (figg. 16, 17), che all’inizio del XIX se-colo si occupò della ‘riforma’ della chiesa di Iseo. Purtrop-po non è facile interpretarli, perché non è sicuro se si trattidi rilievi precedenti l’intervento di ammodernamento del-la chiesa (come sembrerebbe essere il disegno 1, almenonella parte presbiteriale, vista la presenza di piccoli am-bienti addossati all’abside semicircolare) o di schizzi e ta-vole di progetto (come pare essere il disegno 2, in ragionedelle diverse ipotesi planimetriche tracciate a matita).
Lo studio delle murature medievali consente di affer-mare con sicurezza che il piano terreno del campanile erasuddiviso in tre campate ([a], [b], [c]158) (fig. 15), corri-spondenti ai soprastanti corpi [A], [B] e [C]. L’accesso alpiano terreno avveniva attraverso il portale ricavato in A,voltato a botte e distinto in due diversi settori: quello piùesterno e più alto [a1] conteneva il portale romanico, equello più interno e di minore luce [a2] serviva come sem-plice corridoio d’ingresso alla chiesa. Si noti che nelle cam-pate laterali al piano terreno non sono presenti coperturevoltate, e che la statica è garantita dagli arconi a pieno cen-tro che collegano i quattro lati di ogni campata, dello spes-sore variabile tra i 90 e i 100 cm. I pilastri su cui s’imposta-no gli archi sono pressoché privi di decorazione, se siesclude il rozzo accenno di distinzione tra sostegno e arcorappresentato da una cornice quadrata.
La caratteristica maggiormente notevole del complessoè data però dagli ambienti ricavati al primo piano ([A],[B], [C]), (figg. 15, 18) che già da tempo hanno sollecita-to la curiosità degli studiosi. L’accesso all’ambiente del cor-po [C], che si raggiunge oggi con una scala in ferro che sa-le dalla campata sottostante, nella nostra ipotesi dovevaavvenire originariamente159 attraverso un ballatoio ligneo(fig. 15) che, giunto in prossimità dell’angolo interno trala facciata della chiesa e il perimetrale sud, doveva poi cor-rere agganciato a quest’ultimo e scendere a terra grazie aduna scala. Non si può peraltro escludere che questa strut-tura, oggi irrintracciabile nelle pareti intonacate e total-mente trasformate della chiesa, fosse in lastre di pietra so-stenute da mensole, pure in pietra, infisse nella muratura,oppure che tale apprestamento fosse in realtà sostenuto daarchi in muratura via via di maggiore ampiezza fino a rag-giungere la quota dell’accesso. È difficile dire quale sial’ipotesi da privilegiare tra quelle esposte160.
Il corpo [B], che è stato distrutto quasi completamentedall’inserimento della cupola del sottostante battistero
moderno, doveva probabilmente rispecchiare l’articola-zione dell’ala ora descritta161, come sembra peraltro daipochi elementi strutturali ancora osservabili dal primopiano, come la porta [10] e la bifora [09] (fig. 15).
L’ingresso al vano del corpo [C] del primo piano avve-niva attraverso una porta ([01], larga 82 cm per un’altezzadi 193 cm), con arco in pietra a pieno centro, a cui si af-fiancava una bifora ([02], di 96 x 109 cm); questa apertu-ra, benché la valutazione sia parziale a causa del tampona-mento del fondo, è senza dubbio priva di strombatura. Lacolonnina centrale, alta 70 cm, è corredata di una base e diun piccolo capitello decorato sui quattro lati da una croce.La colonna regge un pulvino a gruccia, sul quale si impo-stano i due archetti lapidei162 (diametro 40 cm circa) dellabifora, che giacciono incassati nella finestra, cioè arretratidal filo della parete interna, per circa 20 cm, così come lamuratura immediatamente sottostante, che crea così unasorta di parapetto. Il corpo [C] contiene, ad un’altezza di3,85 m dall’attuale piano di calpestio della chiesa, un pic-colo vano (di 1,85 x 2,53 m) che presenta nella pareteorientale, poco al di sopra del livello dell’attuale pavimen-to163, una nicchia164 [03] a sezione semicircolare (alta 3,05m, larga 1,45 m, e profonda 0,77 m) e copertura emisferi-ca a arco a pieno centro.
Per passare al corpo [A] è quindi necessario superareun dislivello di 1,10 m, il che avveniva plausibilmente gra-zie ad una scala di pochi gradini. Anche in questo caso, vi-sta l’assenza di tracce di asportazione, è possibile pensareche fosse presente una piccola struttura in legno. A diffe-renza del corpo [C], le pareti settentrionale e meridionaledel settore [A] sono definite su entrambi i lati da spec-chiature incassate di circa 10 cm, larghe quanto la paretestessa ed alte 3,70 m, con profilo a pieno centro, che ri-quadrano le aperture sottostanti. Anche qui, accanto allaporta a pieno centro [04] (ma qui originariamente165 do-tata di un sottile architrave in pietra infisso alla quotad’imposta dell’arco, che determina così una lunetta per-via), si colloca una bifora [05], retta da una piccola colon-na con capitello non decorato. Mentre nella faccia esternala muratura è a vista e accuratamente stilata, la faccia in-terna al di sopra degli archetti (questa volta laterizi) dellafinestra conserva ben evidente un sottile intonaco, ben li-sciato e dipinto. La decorazione è assai semplice, ma nonper questo meno significativa, poiché sembra essere con-testuale alla muratura: al di sopra di una stesura di colorerossastro, è stato tracciato un reticolo di linee bianche chefingono la presenza delle fugature di malta tipiche dellemurature in mattoni (fig. 19).
Queste decorazioni imitanti o ‘ricalcanti’ i paramentimurari sottostanti l’intonaco, come ha dimostrato a più ri-prese Hans Peter Autenrieth166, dovevano essere assai piùcorrenti e diffuse nel basso medioevo di quanto oggi siapossibile immaginare. A causa del degrado e della rimozio-ne generalizzata a cui sono stati sottoposti nel corso deltempo, sono purtroppo ormai pochissimi gli esempi ben
186 Architettura dell’XI secolo nell’Italia del Nord
19Gallina 177_Layout 1 18/02/14 12:31 Pagina 186
conservati nel territorio bresciano, e proprio per questomotivo i lacerti sopravvissuti nel campanile di Iseo merite-rebbero miglior sorte e attenzione.
Il vano all’interno del corpo [A] (figg. 15, 18) è piùgrande di quella del corpo [C] (ma comunque di dimen-sioni abbastanza modeste: 3,70 x 3,15 m), ed pure è dota-to al centro della parete est di una nicchia [06] leggermen-te più piccola di quelle già descritte (larghezza 148 cm, al-tezza complessiva 250 cm, profondità 72 cm), posta a 40cm dal pavimento odierno, a fianco della quale stanno ledue bifore [07] e [08], delle medesime caratteristiche diquella già descritta. Queste ultime non erano un semplicecollegamento tra gli ambienti del campanile, ma guardava-no verso l’interno della chiesa.
Per tutti questi spazi non rimangono affatto delle evi-denze riconducibili ad una loro copertura in muraturache, viste le ridotte dimensioni delle luci da coprire, sareb-be stato facile realizzare. È necessario quindi pensare, an-che in questo caso, a semplici coperture lignee sostenuteda travi inserite nelle buche pontaie tuttora visibili. Si no-ta peraltro che la quota di questi alloggiamenti è tale dadeterminare un solaio che ‘taglia’ la parte superiore dellespecchiature che abbiamo descritto sopra167.
La presenza di finestre anche ad altezze ben superiori aquelle raggiungibili oggi ([14] e [15]), e che furono rileva-te con qualche imprecisione dal Ballerio168, fa pensare in-fatti a diversi piani, ai quali si giungeva – come abbiamodetto sopra – attraverso scale a pioli che andavano a pog-giare su botole aperte nell’impiantito. Procedendo quindial piano superiore, appena al di sopra di questo orizzonta-mento ligneo, va notata almeno la specificità della nicchia[11], il cui intonaco di fondo è curiosamente decorato conun irregolare motivo geometrico a triangoli (fig. 20).
Si fa presto a dire Westwerk, ovvero alcune riflessionisui campanili in facciata
Il problema, o meglio dire l’interesse del campanile diIseo è rappresentato dall’originalità e della rarità, quantomeno in area lombarda, del tema compositivo del campa-nile in facciata, e che è stato spesso affrontato richiaman-do in primo luogo il modello carolingio (e ottoniano) delWestwerk. A fronte di una bibliografia specialistica e assainutrita su questo tema169, per l’Italia in genere sembra in-vece di potere dire in primo luogo che questa denomina-zione sia stata talvolta applicata con eccessiva facilità170, ein seconda battuta che il dibattito storiografico sulla pre-senza in Italia di Westwerk, Westbau, avant-nef, corpo occi-dentale e clocher-porche è talmente animoso e intricato che,per evitare di essere ‘arruolati’ in una delle fazioni per il so-lo uso di un termine anziché di un altro, scegliamo di par-lare per il caso di Iseo, almeno in prima battuta, di “campa-nile in facciata”, cioè con l’espressione più neutra possibile.L’impressione è, inoltre, che il dibattito sarebbe assai più
convincente e produttivo se fosse preceduto da un ragio-nato censimento e studio delle molte chiese con campani-le in facciata, anziché accapigliarsi soltanto sui casi già noti(vd. infra). Questa nota polemica si chiude con la consta-tazione che, inoltre, anche quando si affronta questo gene-re di edifici, spesso ci si scorda di specificare se il campani-le è costruttivamente anteriore, coevo, o posteriore allachiesa, e questo non è certo un fattore di poco conto.
Poiché non ci sembra che siano molti gli ambiti territo-riali per i quali esistono degli studi dedicati, è bene tenerneconto. In Italia settentrionale è stato indagato con buonasistematicità il canavesano171 ad opera di Patrizia ChiericiFurno nel 1975172, il cui contributo è stato in seguito rivi-sto da Carlo Tosco173 e integrato da Simone Caldano peraltre diocesi174. La Chierici Furno ha individuato la presen-za di una tipologia «comune alle chiese dell’area francesedell’undecimo secolo, ma piuttosto rara nel quadro genera-le dell’architettura ottoniana (…). Il modello tipologico delWestwerk carolingio che ebbe in età romanica larga diffu-sione nei territori d’origine, subì nelle grandi cattedrali del-l’area francese centro-meridionale un processo di trasfor-mazione riducendosi alle più semplici proporzioni di uncampanile assiale alla facciata munito di passaggio voltatoal piano terreno»175, ovvero riducendosi a quello che si èsoliti denominare clocher-porche (anziché église-porche176).Seguendo quindi questa linea interpretativa il modello delcampanile posto in asse alla facciata deriverebbe sì, in so-stanza, dal modello ottoniano del Westwerk, ma attraversola mediazione, per non dire la quasi completa trasforma-zione, che questa struttura conobbe in area francese, e so-prattutto in Borgogna, nell’XI secolo. A questa linea evo-lutiva va inoltre aggiunto che, in epoca romanica, si assistealla quasi completa disaggregazione degli elementi costitu-tivi originari, che rende inevitabilmente più difficile l’inter-pretazione e la percezione del simbolismo che a questastruttura era affidato, fino ad avere – come detto sopra –già all’inizio dell’XI secolo la sua riduzione a clocher-porche,ovvero riducendosi ad un modesto oratorio posto sopra unpassaggio voltato che introduce alla chiesa177. A parere diCarlo Tosco, «sembra necessario svincolare le tours-por-ches da troppo strette discendenze carolingie e dall’idea diun contatto con i Westwerke»178; inoltre, il fatto che gliesempi eporediesi di campanile in facciata compaiano solonella prima età romanica toglie validità ai confronti con inumerosi edifici francesi più tardi e dotati di clocher-por-che, ma rimane valida una loro derivazione da alcuni esem-pi di fine X - inizio XI secolo; la loro comparsa pressochésimultanea in un territorio limitato come quello della dio-cesi di Ivrea deriverebbe quindi dal contesto di una «piùgenerale presenza di modelli francesi penetrati molto pre-cocemente», soprattutto attraverso la riforma cluniacense,ma senza escludere la possibilità di una derivazione «suscala atrofizzata e ridotta»179 dal duomo di Ivrea.
Una seconda area nella quale è stata riconosciuta la pre-senza di più campanili in facciata è il Lazio meridionale180.
Dario Gallina – La pieve di Sant’Andrea di Iseo (Bs) 187
19Gallina 177_Layout 1 18/02/14 12:31 Pagina 187
La conclusione di Fabio Betti è che si tratti di «uno sche-ma architettonico del tutto estraneo alle precedenti tradi-zioni costruttive» e che si diffonde tra la fine del X e l’ini-zio dell’XI secolo in dipendenza da una sua precoce pre-senza a Subiaco, dove esprimerebbe da un lato una deriva-zione nordica/imperiale, e dall’altra «una necessità difen-siva da parte della comunità religiosa»181 (tutto ciò senzaperaltro chiamare in causa una diretta ‘parentela’ con ilWestwerk). I casi diffusi sul territorio sarebbero quindi ri-prese, in modo semplificato, di quanto realizzato a Subia-co e Montecassino.
Nel complesso dell’architettura romanica italiana, è in-dubbio quindi che la presenza di un campanile in facciataè raramente attestata, ma di fatto si tratta di uno schemadiffuso su aree estesissime182; peraltro, anche limitandosiall’Italia settentrionale183 si vede come esso non sia statoancora (a quello che risulta alle nostre conoscenze) siste-maticamente studiato, e non mancano i casi che dovrebbe-ro essere considerati184.
Quale modello per il campanile di Iseo?
Compiuta questa rapida rassegna, torniamo ora al no-stro caso di studio. Secondo il parere di Ballerio185 e Pa-nazza, l’articolazione del campanile di Sant’Andrea di Iseopuò essere interpretata in due modi: da un lato186 come ri-proposizione delle cappelle nei Westwerke di area tede-sca187; d’altra parte, infine, Panazza188 riconosce comemaggiormente significativo il riferimento alla Francia189 ein particolare ad esempi cluniacensi190, nei quali si vedeun’articolazione interna in tre livelli autonomi che avreb-be piena rispondenza nella pieve di Iseo: al piano inferio-re, il portale che consente l’ingresso alla chiesa; ad un pri-mo livello, una cappella; alla sommità, la cella campanaria.Secondo Panazza, questo motivo compositivo sarebbequindi giunto in Italia per il tramite del monachesimo clu-niacense, che è ampiamente testimoniato dalla finedell’XI secolo nel Bresciano191, e ne avrebbe lasciata un’ul-teriore traccia nel San Salvatore di Capodiponte192 in Val-camonica. A mio parere appare assai forzato però addurrecome termine di confronto questa chiesa, dotata di un pic-colo campanile ottagonale elevato sull’incrocio tra navatae transetto, che risulta davvero assai diverso da quello diIseo. Anche la seconda chiesa solitamente citata per la pre-senza del campanile in facciata, cioè San Fermo di Creda-ro193 che si trova poco al di là del fiume Oglio in territoriobergamasco, può essere paragonata a Sant’Andrea soloparzialmente, soprattutto in ragione delle sue piccole di-mensioni, e del fatto che il campanile è totalmente spor-gente dal corpo della chiesa e non comunica con l’interno.
Per gli stessi motivi non è sostenibile un confronto trauna struttura come quella di Sant’Andrea di Iseo con tuttele chiese piemontesi e laziali citate in precedenza, visto chein esse il corpo del campanile è totalmente aggettante dal-
la facciata194, mentre nel nostro caso la torre campanariagiace assai più all’interno della chiesa che nel sagrato anti-stante. Inoltre, si tratta di edifici datati per lo più ai primidecenni dell’XI secolo, di piccole dimensioni e a navataunica monoabsidata, mentre la pieve di Iseo è convincen-temente attribuita al XII secolo, e certo non si può dire chesia un’architettura rurale o minore. Infine, l’articolazioneinterna di Sant’Andrea è altra cosa a confronto con quegliesempi che, essendo privi di spazi adatti ad un uso liturgi-co, svolgono “funzioni eminentemente campanarie”195.
Il problema è quindi, nel caso si voglia insistere nella ri-cerca del ‘confronto’ o del ‘modello’, di trovarne di piùpertinenti, sia sotto il profilo cronologico che sottol’aspetto architettonico.
A nostro parere196 il più adatto dei confronti, in virtùdella presenza vescovile a Iseo, così dettagliatamente docu-mentata dalla fonti scritte di XIII secolo ma già ben perce-pibile nel XII come abbiamo ricordato sopra, è invece ilDuomo Vecchio o Rotonda di Brescia197, fornita in faccia-ta di un’alta torre che crollò «con quieta e prodiggiosa ca-duta»198 all’inizio del XVIII secolo ma che è ben testimo-niata sia da fonti iconografiche199 (fig. 21) che scritte200, ele cui tracce sono ancora visibili nei sottotetti201. Diversesono però le interpretazioni di questa torre (prevalente-mente interpretata come “autentico Westwerk” di tipo im-periale negli studi più aggiornati202) e della loggia (o tribu-na o balconata) sopraelevata203 che all’interno della chiesaera ad essa adiacente, e questo non ci aiuta di conseguenzaa decifrare quella di Iseo.
Non conosciamo purtroppo l’eventuale articolazioneinterna della torre della cattedrale, ma il valore architetto-nico dei resti delle scale in muratura204 (fig. 22) che ad essasalivano lascia intendere un legame tra la torre e gli spaziinterni della chiesa.
Quale interpretazione per il campanile?
Come abbiamo visto nostro malgrado, se dalla semplicedescrizione della struttura desideriamo passare alla sua in-terpretazione, i problemi sono quelli che sempre si presen-tano allorché si desidera leggere contestualmente l’episodioarchitettonico e l’uso liturgico, la forma degli spazi e il lorosenso religioso. Claudio Ballerio sosteneva che «la cellettaabsidata del campanile doveva essere una specie di coretto,date le bifore che le mettevano in comunicazione con l’in-terno della chiesa, oppure un piccolo oratorio, cui si accede-va da due lati mediante due rampe di scale disposte in unapittorica scenografia di nicchie e di bifore»205, concluden-do peraltro la sua analisi con l’ammissione che «la funzionedi tutto l’assieme di ambienti e di aperture ora descritti nonè facilmente determinabile, in particolare per quanto ri-guarda i due ambienti simmetrici adiacenti al campanile».
Al momento, non siamo in grado di avanzare più chealcune ipotesi di studio, che attendono di essere rafforzate
188 Architettura dell’XI secolo nell’Italia del Nord
19Gallina 177_Layout 1 18/02/14 12:31 Pagina 188
o smentite sia da acquisizioni storico-documentarie, siadalla conoscenza di monumenti simili.
La prima206 di queste è giustamente assai cauta, e ricor-da come la presenza di nicchie e piccole absidi orientatenon è affatto infrequente nei campanili romanici207, ma illoro uso liturgico è ancora da dimostrare, ovvero questogenere di strutture non deve spingerci di necessità ad asse-gnare loro uno scopo ‘alto’.
In seconda istanza, è possibile che ambienti come quel-lo di Iseo fossero destinati a ripostiglio/camera di sicurez-za per tesori e reliquie, seguendo cioè quanto proposto perla cattedrale cittadina da Tassini208.
Infine, non volendo rinunciare ad avanzare almenoun’ipotesi, dobbiamo ad uno studio di Paolo Piva209 del1999 sulla collocazione del sepulchrum nelle chiese roma-niche lo spunto per una diversa proposta di lettura delcampanile di Iseo, cioè la sua interpretazione come luogofunzionale alle processioni liturgiche del Venerdì Santo.Ricordando che per sepulchrum si intende «l’appresta-mento liturgico fisso o mobile (nella maggioranza dei casidi natura effimera) in cui nel pieno Medioevo – entro ter-mini cronologici non ancora definiti e comunque geogra-ficamente variabili – il venerdì santo veniva deposta l’ostiapresantificata, con o senza la croce o altro manufatto, a si-gnificare la sepoltura di Cristo»210, lo studioso discute de-gli esempi di Fruttuaria e di Aquileia, datati all’XI secolo.Per quanto riguarda invece i secoli successivi, Piva si limi-ta a suggerire alcune direzioni di ricerca, constatando al-tresì la carenza di studi attenti a questo tema. Certo, a dif-ferenza di alcuni dei casi presentati, va riconosciuto chemanca per Iseo qualsiasi elemento iconografico a sostegnodell’identificazione del sepulchrum presso gli ambienti so-praelevati del campanile. Il fatto che, come riconosce Pivaargomentando a proposito della chiesa di San Giorgio diValpolicella (Vr), «si obietterà che la drammatizzazionedei riti pasquali è roba da cattedrale o da chiesa monasticapiù che da pieve», può essere contrastato ricordando cheanche quella di Iseo, così come San Giorgio, non era dav-vero ‘solamente’ una pieve, e anzi la presenza vescovile ap-pare qui assolutamente prevalente e caratterizzante. Rico-noscendo come legittima una lettura “in chiave episcopa-le” della chiesa plebana di Iseo, ne ricaveremmo l’interpre-tazione degli ambienti provvisti di nicchie del campanilecome spazi di passaggio della processione solenne che,muovendo dall’altare maggiore, attraversava la chiesa e,dopo aver salito le scale da noi proposte nella ricostruzio-ne tridimensionale, depositava nel vano centrale l’ostiapreconsacrata, per poi riprenderla in occasione della Pa-squa e ricollocarla nell’altare maggiore, a simboleggiare lamorte e la resurrezione di Cristo.
Infine rimane ovvio, come sempre accade quando ci sirapporta alle funzioni liturgiche, che questi vani con nic-chie potessero assolvere nel corso dell’anno e contempora-neamente a diverse funzioni e usi.
Quale che sia la corretta interpretazione, che solo un
ulteriore sviluppo di questo tipo di studi potrà illustrare,certo è che si tratta di una struttura fortemente connotatae degna di attenzione.
Iseo: una pieve vescovile
Alla luce del radicamento del potere vescovile a Iseo che,come ha scritto Paolo Bianchi211, si attua a metà del XII se-colo e si impone con prerogative signorili al di sopra di un‘pulviscolo di poteri’, (e che, come è evidenziato dal censi-mento del patrimonio della Mensa voluto da Berardo Mag-gi, è davvero patrimonialmente assai consistente alla fine delXIII secolo), non è per nulla strano che la pieve sia stata ‘se-gnata’ in chiave episcopale, negli stessi decenni, da una ri-strutturazione radicale. Se questa chiave di lettura – comesperiamo – è corretta, il campanile in facciata, più che la col-ta citazione/ripresa di un modello architettonico francese,cluniacense, o persino ottoniano come si è ipotizzato finora,sarebbe una più semplice ripresa della torre della cattedralecittadina, ovvero una citazione quantomeno ‘di secondamano’, nella quale pertanto la consapevolezza dei valorisimbolici e del prestigio di una così pregnante tradizionepotrebbe essere stata limitata da parte sia dei committentisia dei cittadini, visto che – tra l’altro – dall’edificazione del-la Rotonda cittadina era trascorso ormai circa un secolo.
D’altra parte, una così forte volontà di autorappresen-tazione da parte del potere vescovile è motivata non solodall’ampiezza delle rendite fiscali e commerciali proprie diIseo, ma anche dal fatto che il vescovo deve contenderequesto suo ruolo di protagonista con altri attori, quali so-no i particolar modo le aristocrazie locali che puntano afar valere privilegi e concessioni e il Comune cittadino im-pegnato nel processo di comitatinanza212. La preminenzadi Iseo emerge in tutto il suo rilievo non solo quando siconsideri l’estensione dell’abitato cinto da mura, ma so-prattutto quando si analizzano le tipologie e le tecniche diesecuzione sia nell’architettura residenziale sia in quellareligiosa213, poiché è evidente la continua presenza diun’edilizia di qualità tra XII e XIII secolo in tutto parago-nabile a quella della città.
Concludiamo con una rapida descrizione delle fasi po-steriori al XII secolo.
Fase D (XIII secolo)
In questa fase è evidente un intervento sul campanile, lacui sommità viene innalzata214, ed è possibile distinguerequesto intervento non solo su base propriamente stratigra-fica, ma anche grazie alla diversa provenienza di cava delmedolo impiegato, che presenta infatti una tonalità mag-giormente grigiastra. L’intervento è individuabile nellamuratura in pietra (Us 131 e 132) dotata di nuova cornicelaterizia ad archetti ciechi (Us 131 e 206) a chiudere lapreesistente specchiatura sottostante in cui è aperta la tri-
Dario Gallina – La pieve di Sant’Andrea di Iseo (Bs) 189
19Gallina 177_Layout 1 18/02/14 12:31 Pagina 189
190 Architettura dell’XI secolo nell’Italia del Nord
fora (Us 128). Proseguendo verso l’alto, la cella campanariaera definita da una bifora (largh. complessiva 2,45 m, altez-za 2,40 m), il cui intradosso è leggermente arretrato dal filodel piedritto (probabilmente per favorire l’appoggio dellacentina lignea funzionale al montaggio dell’arco). Di essa siconservano solo parzialmente le ghiere laterizie bardello-nate e a pieno centro (Us 135 e 137), in corrispondenzadell’imposta delle quali la muratura in pietra lascia il postoa un paramento in mattoni rigati215 (Us 134 e 136). Laspecchiatura della cella era sormontata da una cornice late-rizia, visibile solo in minima parte lungo il lato nord, doverimane solo l’attacco di uno degli archetti (Us 258), ma as-sai meglio ravvisabile lungo i prospetti nord e sud. Conte-stualmente a questo intervento di sopraelevazione furonoassai probabilmente occluse le aperture del XII secolo (cioèla trifora Us 128 e la bifora Us 125) con tamponamenti chele mascherarono del tutto (Us 126 e 129). Ciò sembra esse-re indicato sia dalla posizione della nuova cornice (Us 131e 206) stranamente a ridosso della bifora del XII secolo (Us128), sia – soprattutto – dalle stilature (del tipo rifluente epoi ‘graffito’) conservate sulla faccia interna dei tampona-menti, ben osservabili all’interno del campanile.
La datazione di questa fase si appoggia sulle finiture deiresti della ghiera laterizia (Us 135 e 137) e della muraturad’angolo (Us 134 e 136) che, benché consunte, presentanola rigatura a spina-pesce tipica delle aperture duecentesche,che è stato possibile documentare adeguatamente per laprima volta in occasione della realizzazione del nostro fo-toraddrizzamento, grazie all’uso della piattaforma elevatri-ce. La rigatura della superficie dei mattoni è poi cronologi-camente compatibile con le stilature graffite dei tampona-menti, pure tipiche delle murature tardoromaniche.
Fase E (prima metà XIV secolo)
Questa fase coincide con l’inserimento in facciata dellatomba di Giacomo Oldofredi216 che, come ricorda l’epigra-fe ancora oggi leggibile e già citata, morì nel 1325. Il mo-numento funerario, che aggetta dal fronte della pieve percirca 1,30 m, poggia sopra un archeggiatura a pieno centro(larghezza complessiva della struttura 3,80 m, altezza 3,65m) con ghiera laterizia e sottile bardellone, sostenuta dauna muratura in pietra non ben squadrata, che componeun paramento non troppo curato. Recenti e fortunate in-dagini d’archivio217 sembrano dimostrare che questa ar-cheggiatura è stata costruita in stile “medievale” nell’Otto-cento per sollevare l’antico monumento funerario.
L’arca, dalla semplice forma parallelepipeda con sottilicornici decorative che ne ripartiscono la fronte in tre spec-chiature, mostra in quella centrale l’epigrafe della quale ab-biamo detto, e recava ai lati i leoni, animale araldico dellafamiglia Oldofredi, che furono scalpellati – ma non sap-piamo in quale occasione – e che rimangono comunque in-tuibili nella loro sagoma in posizione eretta e rampante. Sullato breve rivolto a sud, lo stemma araldico del leone è inve-
ce ancora ben conservato. Il tutto è coperto da un timpanoarchiacuto in marmo, con cornice modanata, poggiante sumensole decorate sul lato sporgente da una testa leonina, esostenute da due coppie di colonne binate. Queste ultimehanno una piccola base scolpita con quattro foglie grasseangolari, mentre i capitelli conservano o una semplice de-corazione a rametti con foglie lanceolate poco incise, o unadecorazione a foglie grasse un poco più evidenti.
La tomba di Giacomo Oldofredi, come è stato più volterilevato218, presenta significative analogie con il più sempli-ce sepolcro di Ysonno Federici (morto nel 1336) postopresso la chiesa di Gorzone (fraz. di Darfo Boario Terme,in Valcamonica)219. Nonostante il materiale lapideo sia deltutto diverso, cioè la cosiddetta ‘pietra Simona’ dal colorerossastro-violaceo tipica della bassa Valcamonica, lo sche-ma compositivo è assai simile a quello di Iseo per la presen-za del tegurio con arco acuto e delle colonne binate.
Fase F (XV secolo)
In questa fase viene ulteriormente modificata la cellacampanaria, eliminando la cornice ad archetti ciechi due-centesca (Us 258) e sostituendola con una muratura deco-rata da una cornice semplicemente modanata (Us 207),sulla quale si imposta la cuspide in mattoni. Questa, dalprofilo marcatamente slanciato e di forma conica (altezzamassima 5,75 m) è composta da un elemento maggiore(Us 139) che regge una croce metallica, cui si accompa-gnano agli angoli della piattaforma di base quattro piccolipennacchi (altezza 1,15 m), che ne imitano la forma e che,pure, sostenevano piccole croci. Anche la bifora medieva-le (Us 135 e 137) viene demolita per lasciare posto adun’apertura a luce unica, con arco a pieno centro in laterizi(Us 138), che sfrutta in parte le ghiere preesistenti, e cheviene pure allungata, demolendo gli archetti ciechi sotto-stanti (Us 131 e 206) e inserendo una nuova banchina inpietra di Sarnico (Us 130).
Fase G (XVII secolo)
Nel corso delle ristrutturazioni descritte con una certaampiezza da padre Fulgenzio Rinaldi, che abbiamo già ci-tato, vengono inseriti due nuovi accessi alle navate laterali(Us 114 e 151), riquadrati da cornici modanate in pietradi Sarnico, nonché un nuovo portone d’ingresso alla basedel campanile che minacciava rovina (Us 115, 159 e 160).Pur con qualche dubbio, potrebbero appartenere a questafase anche gli oculi (individuabili dalla presenza degli in-tonaci Us 113 e 259) posti al di sopra delle aperture latera-li ora descritte.
Fasi H e I (XIX secolo)All’Ottocento, ovvero all’intervento dell’architetto
neoclassico Rodolfo Vantini già più volte menzionato,
19Gallina 177_Layout 1 18/02/14 12:31 Pagina 190
dovrebbe quindi appartenere la predisposizione dellafacciata (Us 156, 147, 110) ad accogliere un nuovo para-mento di finitura, poi non realizzato, e quindi dotato di
ampie lunette (Us 107 e 149), in conseguenza delle qua-li furono eliminati gli oculi seicenteschi (tamponamentiUs 104 e 150).
Dario Gallina – La pieve di Sant’Andrea di Iseo (Bs) 191
* Un doveroso e sincero ringraziamento a Luigi Schiavi, che ha sollecita-to la mia presenza al convegno e che, dopo la mia relazione, mi ha fornito utiliindicazioni bibliografiche, e non solo. Un ringraziamento particolare al prof.Adriano Peroni per alcuni preziosi suggerimenti e, come sempre, ad AndreaBreda per il costante aiuto e appoggio. Dedico questo scritto alla memoria delmio amico Luca Biemmi, che sempre si interessava ai miei studi e lavori. Ri-prendo qui, con numerose e ampie rielaborazioni, quanto scritto ed elaboratograficamente in alcune parti della mia tesi di dottorato (GALLINA 2004).
1. BALLERIO 1940-1941-1942.2. PANAzzA 1942c, p. 117.3. PANAzzA 1963c, p. 735.4. PANAzzA 1974.5. PANAzzA 1974, p. 23.6. L’uso dell’aggettivo ‘locale’, almeno in questo caso, non deve però in-
durre chi legge ad immaginare il consueto scatenamento di ingenuità metodo-logiche e di prese di posizione litigiose e manichee proprie delle discussioniche, forse, sarebbe più corretto definire come ‘localistiche’, e che rappresentanospesso una bizzarra e faticosa zavorra degli studi. Per l’approfondimento di que-sti aspetti rimando a GALLINA 2005.
7. Non è certamente più vero quanto affermato da Valentino Bedeschi(BEDESCHI 1959, p. 3), secondo il quale «Pochi sono i dati espliciti riguardan-ti l’antica struttura e l’antico aspetto di Iseo; essi si riscontrano in qualche anti-ca ma, sotto questo aspetto, frammentaria pubblicazione storica, in qualche ra-ro e interessante ma mai registrato rinvenimento nel sottosuolo, ed in semprepiù ridotti avanzi di mura e bastioni».
8. BREDA 1982; BREDA 1988-1989a.9. LEONI 2008. Si veda per una sintesi VALSECCHI 2008.
10. GUERRINI 1934; GUERRINI 1940-1941 (poi in GUERRINI 1984, pp.306-324); DONNI 1991.
11. ARCHETTI 1990; ARCHETTI 2000; ARCHETTI 2007a; ARCHETTI2007b.
12. DE RINALDI 1685.13. BEDESCHI 1952; Iseo 1980; BREDA, VALSECCHI 1990; BREDA 1992-
1993a; Archeologia 1993; RINALDI 1996.14. La storiografia bresciana si è costantemente impegnata in faticose di-
spute per indagare l’origine e il significato del nome ‘Franciacorta’, ma, a dispet-to delle energie profuse, non è ancora stata data esauriente risposta né alla pri-ma né alla seconda domanda. Se gli autori che hanno intrapreso questa ricercanon hanno raggiunto una conclusione condivisa e ben argomentata, non è dav-vero da imputare alla loro debolezza critica, ma ad una effettiva carenza di datidocumentari e, più latamente, storici. La mancanza di una posizione comunesu questo tema dipende infatti in primo luogo da una insanabile carenza dellefonti scritte, poiché le prime attestazioni del toponimo risalgono alla fine delXIII secolo quando questo nome sembra già essere considerato usuale e tradi-zionale, senza che vi sia cioè il bisogno di specificarne il significato. Senza en-trare nell’agone delle dispute campanilistiche, che sull’interpretazione del no-stro toponimo hanno versato (e talvolta sprecato) inchiostro, tempo e fantasia,rimandiamo a: Statuti 1876, coll. 1585-1914, dove la prescrizione riguarda lamanutenzione del torrente Mandolossa, alla quale sono tenute le comunità diFiumicello, Urago Mella, Cellatica, Gussago, Sale, Ronco e Rodengo, a benefi-cio del comune di Brescia e di tutti gli amici de Franzacurta. Chi siano questiamici però non è neppure accennato. Oltre a questo, il territorio al quale si fa ri-ferimento non coincide, se non parzialmente, con quanto si intende per ‘Fran-ciacorta’ nei secoli successivi, e men che meno con quanto oggi si ritiene. Insintesi, il nome della ‘Franciacorta’ sembra essere una diretta conseguenza del-la politica di espansione comitatina attuata fra XII e XIII secolo dal comune diBrescia verso ovest: il comune cittadino, in cambio della manutenzione dellastrada e dei ponti che collegavano la città alla Valcamonica, nonché del con-trollo della sicurezza del transito di uomini e merci, concedeva l’immunità daalcune forme di tassazione ai comuni rurali e ai signori territoriali che parteci-pavano a questo accordo. Vedi le diverse ipotesi in: MALVEzzI 1432, Dist. IV,Cap. XCVI; CAPRIOLO 1505, V, p. 17; ROSA 1886; ROSSI 1693, p. 208; GUER-RINI 1914, p. 308.
15. RINALDI 1685, p. 100 e p. 102.16. Le infinite discussioni sul percorso della medievale via Valeriana, evo-
luzione dell’antica viabilità romana che attraverso la valle di zone avrebbe po-tuto aggirare a est la cima della corna Trentapassi (attraverso le Croci di zone,a 885 m s.l.m.) e discendere poi verso la frazione Pontasio di Pisogne e salirequindi in Valcamonica, benché propongano una soluzione plausibile per quan-to riguarda le comunicazioni, non cancellano affatto le difficoltà derivanti daltrasporto di merci dal dislivello di quasi 800 m che era necessario superare, pri-ma in salita e poi calando in direzione di Pisogne, quando bastava inveceimbarcare il tutto e percorrere circa 15 km sul lago per ottenere il medesimorisultato.
17. MORGANTI 1983, che sottolinea come Iseo rappresenti un punto dipassaggio obbligato anche per la transumanza diretta sul monte Guglielmo.
18. Un ottimo studio del borgo medievale è quello di BIANCHI, MACARIO2008.
19. Ancora nel XIX secolo, l’80% delle granaglie e del mais di fabbisognoalla Valcamonica, alla Val di Scalve, alla Val Seriana superiore, e alla Val di Sole,veniva trasportato dalle barche di Iseo (ABENI 1984, p. 323).
20. Per un inquadramento, La Franciacorta 1982; BEzzI MARTINI 1983;STELLA 1990; STELLA 1992. Del territorio e dell’abitato di Iseo in età preroma-na e romana abbiamo notizie abbastanza frammentarie, ma non per questo po-co significative, poiché le ricerche archeologiche più recenti hanno offerto unaserie di elementi tali da non poter dubitare dell’esistenza di un abitato di unacerta consistenza già nel I secolo d.C. (Carta 1991, schede nn. 781-799). Limi-tando la nostra attenzione ai reperti di età romana rinvenuti nel centro, gli scavihanno messo in luce, oltre ad alcune epigrafi e a materiale ceramico relativo adeposizioni tombali, i resti di due abitazioni tardoantiche presso la pieve diSant’Andrea, e quelli di una villa romana, con diversi livelli pavimentali datatial I secolo d.C., in prossimità della chiesa della Madonna della Neve (BREDA1992-1993a). La presenza poi di un piccolo acquedotto – rintracciato in viaRoma (BREDA 1992-1993b) ma totalmente inedito nel suo tratto ‘extraurba-no’ – che abbiamo avuto modo di analizzare preliminarmente e che corre po-chi metri al di sotto della grotta del Büs del Quai, testimonia in modo inequi-vocabile dell’importanza di questo centro (sempre che il condotto non fosse diservizio esclusivo ad una grande villa per il momento ignota).
21. FAPPANI, TROVATI 1982, pp. 44-45, da cui ricaviamo le notizie che se-guono. Le reliquie del santo, conservate nella chiesa di Iseo, furono smembratee parzialmente trasferite in San Lorenzo a Brescia nell’VIII secolo, da dove subi-rono poi altre traslazioni interne (tra le quali ricordiamo quella del 1002, quan-do furono collocate accanto a quelle di Ottaziano). Le reliquie rimaste in San-t’Andrea di Iseo sarebbero state ricollocate nella cripta della chiesa ricostruitanel XII, dove rimasero fino al 1633, quando furono spostate in una delle cappel-le laterali. Nel 1951 fu solennemente riportato da San Lorenzo a Iseo il teschiodel Santo. Secondo ARCHETTI 2007b, p. 6, la presenza nella pieve iseana di unaltare dedicato a san Lorenzo è l’indizio di una “trasmissione reciproca di reli-quie”. Le notizie più vagliate criticamente su san Vigilio sono quelle discusse daPICARD 1988, a parere del quale anteriormente a Ramperto (IX secolo) è neces-sario essere molto cauti nell’interpretazione della cronotassi vescovile bresciana.In questo caso, poi, pesa anche la confusione/sovrapposizione con san Vigilio diTrento (FERRAGLIO 2008, p. 21). Contributi importanti vengono anche da RO-SA 1849; FALSINA 1969; ARCHETTI 2007b; FERRAGLIO 2008.
22. È forse ad essa che risale la denominazione, tuttora esistente, di viaDuomo per la strada che conduce da via Sombrico (secondo GUERRINI 1934,p. 179, il toponimo sarebbe l’esito della storpiatura popolare dell’originariosummus vicus) alla Pieve. Questa denominazione potrebbe rimandare alla pre-senza del palatiummagnum vescovile (come vedremo, attestato dalle fonti del-la fine del XIII secolo), alla monumentalità della pieve, o all’effettiva presenzadel vescovo per alcuni mesi all’anno. Secondo il Guerrini, la medesima attesta-zione è rintracciabile anche a Salò e Orzinuovi, e sbaglieremmo ad attribuire aquesto toponimo un significato particolare, visto che «il termine comune di“domus” era dato tanto alla casa del vescovo (…) quanto alla casa canonica del-le pievi dove il clero abitava a vita comune, e anche alla casa vicina alle pievi do-ve si albergavano i forestieri e si esercitava l’ospitalità» (GUERRINI 1934, p.
Note
19Gallina 177_Layout 1 18/02/14 12:31 Pagina 191
165). Tralasciamo invece una debole ipotesi avanzata da Gabriele Rosa (ROSA1892, p. 22), secondo cui Dom significherebbe “luogo del giudizio, tribunale”in ambito franco.
23. Basandosi cioè come dato cronologico certo sul terminus ante quemnon del 451, quando sulla cattedra sedeva ancora il suo predecessore sant’Otta-ziano, che partecipò in quell’anno al Concilio Metropolitano di Milano.
24. GUERRINI 1934, p. 162.25. GUERRINI 1934, p. 163, seguito da FALSINA 1969, p. 11.26. Giustamente Gabriele Archetti (ARCHETTI 2007b, p. 6) ricorda anche
il caso del vescovo Silvino sepolto a Serle. Sui rapporti tra la fuga da Brescia disant’Erculiano e gli insediamenti eremitici religiosi gardesani vedi BROGIOLO2002b, che ha sviluppato un’ipotesi presentata nel 1997 a proposito della finedelle villae romane (BROGIOLO 1997).
27. L’intitolazione a sant’Andrea, peraltro, non può non chiamare in causala vexata quaestio della primitiva cattedrale cittadina, che gli studi più aggior-nati e affidabili (PIVA 1990, pp. 35-56) tendono a identificare nella coppia San-ta Maria / San Pietro de Dom, ma che per lungo tempo è stata posta presso lachiesa suburbana di Sant’Andrea sulla scorta della narrazione quattrocentescadel Malvezzi (MALVEzzI 1432).
28. ARCHETTI 2007b, p. 6.29. MARIOTTI BRANCA 1984; BREDA 1988-1989b. Per i rinvenimenti ar-
cheologici di età longobarda, DE MARCHI 1992.30. Così secondo la lettura dell’Odorici (ODORICI 1853-1865, IV, p. 27);
altri editori danno invece Gisegies e Hisieges.31. PASQUALI 1979.32. Si vedano anche BARONIO 1996; BARONIO 1999 e BARONIO 2000.33. PASQUALI 1978.34. MENANT 1993, p. 64.35. Carmen 1965, p. 104, v. 3164.36. La prosperità dei commerci anche in epoca successiva è indicata dalla
presenza in Iseo, dal XV secolo, di banchi di cambio e prestito gestiti dagliEbrei (ABENI 1984, p. 323).
37. Vedi GUERRINI 1934, p. 169, e Iseo 1980, p. 15.38. CHITTOLINI 1990.39. ODORICI 1853-1865, V, pp. 17-18; MENANT 1993, p. 162. Il merca-
to non è descritto, ma semplicemente menzionato tra le varie coerenze di unterreno.
40. BOSISIO 1963, p. 567, nota 2.41. Cit. in BOSISIO 1963, p. 612 nota 5. A parere del Malvezzi, che ripren-
de quasi alla lettera gli Annali ora citati, la distruzione di Iseo sarebbe stata pro-vocata dall’esito infausto dell’assedio a Brescia da parte dell’imperatore, cheavrebbe così indirizzato sui centri del contado la furia della guerra che non ave-va potuto colpire a fondo una delle più temibili alleate di Milano (MALVEzzI1432, col. 879 (= Dist. VII, Cap. XLIV): «Oppida etiam nonnulla delevit. Si-quidem praecurrenti anno eversionem urbis Mediolani Castrum Ysei ab eo di-ruptum est in die qua festum Sancti Nazarii celebrabatur». Peraltro, non man-cano i riflessi di queste vicende anche nelle compilazioni cronachistiche germa-niche, quali gli Annales Colonienses Maximi (citati in BOSISIO 1963, p. 612,nota 5) che, come acutamente suggeriva il Bosisio, sembrano davvero alluderead Iseo allorché descrivono «quidam burgus clausus lacu, palude et montibus,natura et situ invictissimus, omni genere divitiarum opulentus adeo ut Brixien-ses in ipso amplius quam in Brixia fiduciam haberent et, sicut dicebant, Medio-lanenses ibi se recipere cogitabant si Mediolano pellerentur». È palesementeforzato ritenere che Iseo potesse essere considerato un rifugio per i Milanesitutti in caso di difficoltà, ma è altrettanto certo che per i Brixienses Iseo era stra-tegicamente importante, così come è indubbio che la geografia di Iseo (circon-dato dalle montagne e dalle paludi delle Torbiere) non si ripropone negli altricentri affacciati sul Sebino. Come ultimo argomento, la distruzione alla qualeil paese fu sottoposto dimostra ad abundantiam la sua preminenza, visto chenel XII secolo un assedio non era impresa che si poteva compiere con rapidità,se non in casi eccezionali, e i ritmi convulsi del conflitto tra i Comuni e Federi-co I in quei mesi (che – ricordiamolo – precedettero la caduta e la distruzionedi Milano nella primavera del 1162) non sembrano davvero lasciare spazio adun attacco privo di seri e comprovati motivi strategici. Sui tempi e i modi del-l’assedio nel medioevo si rimanda all’amplissimo studio di SETTIA 2002. An-drebbe infine precisato cosa intendano le fonti medievali dicendo Yse destruc-tus, poiché non stupirebbe che si sia esagerata l’incisività delle azioni condottedalle truppe imperiali, che magari consistevano nella semplice disattivazionedegli apparati fortificati, per ottenere la quale era sufficiente aprire alcune brec-ce nelle mura e mozzare le torri. Un indizio in questa direzione sembra essereun argumentum ex silentio, visto che Jacopo Malvezzi, solitamente così prontoa sottolineare la tragicità delle vicende bresciane, si è limitato ad un breve inci-
so sulla sorte di Iseo invece che ricavarne lo spunto per narrare sofferenze e cru-deltà, e questo atteggiamento, narrativamente così sbrigativo, potrebbe indica-re una carenza di dati di fatto da sviluppare. La difficoltà che abbiamo nella da-tazione delle murature e degli elementi architettonici non ci consente di preci-sare con sicurezza se le molte attestazioni di strutture del XII secolo apparten-gano alla prima o alla seconda metà del secolo, ma, a partire dagli edificidell’XI secolo in poi, non si ravvisano affatto cesure attribuibili ad eventi di-struttivi di portata tale da causare una estesa riedificazione dell’abitato dopo ladata della ‘distruzione’ del 1161 per mano del Barbarossa.
42. Carmen 1965, vv. 3162-3232, ma soprattutto v. 3207: «Hysen sic pe-nitus ferro vastatur et igni».
43. BIANCHI 2006-2007, pp. 25-29. Dal suo documentato studio traggo lenotizie fondamentali di questo paragrafo.
44. In un atto del 6 marzo 1206, Vascrignus f. Buscaroli d Iseo testimonia diricordare che sono trascorsi «30 annos vel plus quod vidit patrem suum tenen-tem Curtem de Ise per q. Ep[iscop]um Raimundum et ex ea fuisse Gastaldio-nem per viginti annos et plus per ipsum Episcopum». Il documento è riporta-to in ODORICI 1853-1865, VII, pp. 25-34 (doc. CCXXXVIII).
45. MALVEzzI 1432, col. 909 (= Dist. VII, Cap. CXXIV).46. MALVEzzI 1432, col. 914 (= Dist. VII, Cap. CXXXIV: Multa castra a
Brixiensibus capta).47. ANDENNA 1999a.48. MALVEzzI 1432, coll. 949-950 (= Dist. VIII, Cap. LXXXV).49. BOSISIO 1963, p. 687; corretto invece quanto riportato dall’Odorici
(ODORICI 1853-1865, pp. 206-207).50. MALVEzzI 1432, col. 950: (= Dist. VIII, Cap. LXXXIX), riportando
invece i nomi di Seniga, Orzinuovi e Palazzolo.51. ODORICI 1853-1865, VI, p. 207, dove si fa riferimento ad uno Statuto
Cartac. Quer. non meglio specificato.52. Malvezzi, quando tratta delle fazioni guelfa e ghibellina (MALVEzzI
1432, col. 950 = Dist. VIII, Cap. LXXXVIII), colloca nei secondi illi de Yseo,ovvero gli Oldofredi.
53. Il Guerrini ipotizza che la famiglia Oldofredi discenda dai Mozzi diBergamo, i quali a loro volta sarebbero una ramificazione dei Gisalbertini(GUERRINI 1930b; GUERRINI 1940-1941 (poi in GUERRINI 1984, pp. 306-324). Sulle complesse questioni genealogiche che interessano i Giselbertini eMartinengo rimandiamo a: MENANT 1994, pp. 39-129; zANI 2000. SecondoGabriele Rosa, la più antica citazione di un membro della famiglia risulta nel1191, allorché tra i nobili inviati presso Arrigo VI per risolvere una lite tra Bre-scia e Bergamo compaiono i fratelli Giacomo e Lanfranco de Ise. Poiché talvol-ta la famiglia viene detta semplicemente de Ise, quasi per identificazione con ilpaese che costituiva il centro del suo potere, non si può escludere che il Giaco-mo de Ise citato nel 1167 tra coloro che giurarono la lega contro Federico I fos-se già della schiatta degli Oldofredi.
54. Di Iseo e della Franciacorta non vi sono però tracce tra gli atti di questogenere conservati nel Liber Potheris. Benché datati di oltre un secolo, rimango-no ancora molto utili per la comprensione di queste vicende e dinamiche dipotere gli studi di FE’ D’OSTIANI 1889, e LATTES 1902.
55. ABENI 1984, p. 326. Per le complesse dinamiche di alternanza e di lottache caratterizzarono questi anni rimando a ANDENNA 1995.
56. Oldofredo (+1348) fu podestà di Vicenza (1335), fedele alleato deiVisconti, podestà e vicario imperiale a Pavia (1331), nonché il promotore diuno dei lavori pubblici che maggiormente segnò il territorio e l’economia dellaFranciacorta: l’escavazione della seriola Fusia, il cui incile si colloca nel corsodell’Oglio presso Paratico (GUERRINI 1930a).
57. Per la trascrizione ci affidiamo a GUERRINI 1924, p. 188.58. RINALDI 1685, pp. 20-21: «(…) havendo massime un Giacomo Oldo-
fredo cinto esso Iseo delle sue alte, forti, e nobili muraglie con merli, Fosse, Por-te, e proportionate distanti Torri sopra esse Porte, e Mura; e di più per haverancora eretta quell’altissima, et inaccessibile Rocca, detta anticamente del Cro-cefisso, et hora S. Giorgio, per la Chiesa dedicata poi a tal Santo, che pur si ve-de quasi diroccata à mezzo il monte sopra il Quaglio, nella contrada di Bosine;il che tutto conferma l’elegante Epitaffio intagliato nel nobile Deposito di essoGiacomo Oldofredo sù la Facciata della Pieve, del quale dopò altri encomij glo-riosamente dattigli, si dice: Hic Iseum muris circumdedit, Bosinarum Arcemfortissimam cum Crucifixi Castello condidit; inde Turrim eminentissimam; lequali parole, cioè del Castello del Crocifisso, e Torre eminentissima, non man-ca chi dica, puotersi anco intendere del Castello quì in Iseo, et della di lui Tor-re, che meritatamente segli può dir eminentissima, per esser ivi adornata datante altre, che come ossequiose gli si inferiorano; et in vero ha ciò molto delverisimile, e volontieri v’assentirei, quando l’Arma della Scala, che in due Ported’esso Castello, ò Convento patentemente intagliata si vede, altrimenti non mi
192 Architettura dell’XI secolo nell’Italia del Nord
19Gallina 177_Layout 1 18/02/14 12:31 Pagina 192
suadesse: perché à qual fine effigiansi simili Arme, et Insegne gentilitie, se nonper denotare à Posteri tal mole, ò fabbrica esser di tal Casata, overo Opera di talSignore?». A parere del Rosa (ROSA 1892, p. 39), la torre altissima nominatanell’epigrafe «dev’essere il campanile della plebana», ma l’ipotesi è assai forza-ta e priva di argomenti.
59. Secondo RINALDI 1685, pp. 115-116, anche Matteo Visconti avrebbegoduto del clima del lago dimorando presso gli Oldofredi. Vedi anche ABENI1984, p. 327.
60. ARCHETTI 2001a.61. Ringrazio Gabriele Archetti per avermi consentito di utilizzare la tra-
scrizione contenuta nella sua tesi di dottorato (ARCHETTI 1991). L’elenco deibeni redatto dai designatori è così diviso da scritte rubricate: «in Brolo; inBrayda in Burgo; in Brayda extra Burgum; in Brayda extra Burgum; in contra-ta Curtali sive Manice et Rue Nove; in contrata Segrarii; de Colognis Valxellisinferius a strata usque in Covalo; sub Covalo sub rocha ad Valxellam superius astrata et a polsa molinaria superius; In contrata Sagrarii et ad Cavonum supe-rius a strata de Carerolis et ad zagonalum; in Grumello; In contrata Pugy, Ro-verethi de Fontanellis et ad Crevacorium; Ad Ponticellum; In Pantano sive inAlifredo; In Bosinis et Valle Celambria; in teritoro Ysei; Sub Rocha de Bosinis/ sub Rocha Sancti Georgii; In Naveziis».
62. VALSECCHI 2008.63. Così si evince dal designamentum del 1299 studiato in BIANCHI 2006-
2007, pp. 38-39.64. VALSECCHI 1990; Archeologia 1993.65. RINALDI 1685, pp. 45-46.66. Iseo 1980, pp. 13-14.67. La cautela nella datazione è data dalla struttura stessa degli Statuti, che
raccolgono in modo disordinato e poco chiaro le delibere sia passate che pre-senti, al punto che l’Odorici parlo di uno “spinajo” (ODORICI 1853-1865, VII,pp. 104-105).
68. ODORICI 1853-1865, VI, pp. 211 (1).69. ODORICI 1853-1865, VI, pp. 219-220.70. ODORICI 1853-1865, VI, pp. 233-234, ma in questo caso lo storico non
dà conto delle sue fonti.71. Le ricerche archeologiche più recenti, condotte da Andrea Breda (BRE-
DA 1994) e Ivana Venturini (VENTURINI 1998), hanno efficacemente indagatoe documentato gli apprestamenti fortificati trecenteschi presso l’estremità nord-ovest di Iseo, cioè presso via del Campo. Qui è stata infatti rinvenuta la cintamuraria, datata stratigraficamente al XIV secolo (e quindi plausibilmente ascri-vibile a Giacomo Oldofredi), che risultava composta all’interno da un terrapie-no largo 8 m, contenuto da un muro piuttosto poderoso (dello spessore di circa80 cm) in grossi blocchi di pietra calcarea composti in una tessitura regolare e le-gati da malta assai tenace. Questa struttura, conservata in altezza per non più di2,5 m e rintracciata dai sondaggi archeologici per oltre 55 m di sviluppo plani-metrico, era fortemente scarpata verso l’esterno. La sua inclinazione andava di-minuendo avvicinandosi alla porta del Campo che, come chiarito dai rilievicommissionati da Rodolfo Vantini prima della sua demolizione attorno al 1840,stava a cavallo dell’attuale e omonima via. Il fossato esterno aveva una larghezzadi circa 22 m e una profondità massima di 4 m, e sul versante della controscarpala sua riva era foderata con una massicciata di blocchi lapidei assai peggio lavora-ti e composti di quelli della scarpa interna. È interessante notare che, a differen-za di tutte le piazzaforti del territorio, la fortificazione di Iseo non venne maidavvero ‘aggiornata’ secondo le esigenze indotte dallo sviluppo delle artiglierieda fuoco, ad indicare con ogni probabilità la perdita di importanza che ebbeIseo a partire dal XV secolo. Anche se non manca poi un intervento di raddop-pio del muro di scarpa, datato stratigraficamente tra XVII e XVIII secolo e rea-lizzato con una muratura abbastanza grossolana e poco resistente, così come –contemporaneamente – una nuova escavazione del fossato, limitandolo però a10 m di larghezza, non sembra davvero di trovarsi di fronte a un intervento dirafforzamento militare, quanto piuttosto ad una riattivazione del fossato e a unconsolidamento delle sue strutture per scopi puramente funzionali.
72. Si noti infatti la presenza di via Cerca, un toponimo indicante il fossatodi contorno delle mura.
73. Com’è noto, le porte che più impedivano la circolazione di mezzi e per-sone vennero demolite attorno al 1840 per essere sostituite con cancellate. I la-vori, svolti sotto la direzione dell’architetto Rodolfo Vantini, fecero parte diun’imponente ristrutturazione dell’aspetto urbanistico del borgo. Fortunata-mente, prima della demolizione, si predispose un rilievo architettonico abba-stanza accurato delle strutture, per le quali disponiamo anche di una breve de-scrizione (Iseo 1980, pp. 44-55).
74. Il portale esterno, inserito in rottura nella muratura preesistente, è a se-sto acuto con ghiera di conci lapidei pentagoni; reca scolpito nella chiave lo
stemma scaligero, ed è quindi databile entro un arco assai ristretto di tempo(attorno agli anni ’30 del XIV secolo, quando si allearono con la potente fami-glia veronese (RINALDI 1685, pp. 19-20) nel contesto dell’esposizione dell’av-vento di Mastino della Scala al potere su Brescia nel 1331. Vedi SANDRI 1936.
75. Iseo 1980, p. 46.76. Attraverso via Mirolte si giunge con un percorso pressoché rettilineo a
piazza Garibaldi che, prima dell’interramento e della costruzione del Mercatodei Grani (oggi Municipio), era la zona d’attracco della navigazione.
77. Iseo 1980, p. 45. Tra la porta di Mirolte e quella del Porciolo rimangonoinoltre i resti di una torre rompi-tratta, priva di aperture, e destinata quindi al-la sola sorveglianza e non al passaggio.
78. RINALDI 1685, pp. 232-233; GUERRINI 1937; PANAzzA 1974, pp. 27-28; S9NA 1990; zANI 2004.
79. VALSECCHI 2008, pp. 10-11.80. PANAzzA 1942, pp. 154-156.81. PANAzzA 1942, pp. 143-144.82. PANAzzA 1974, p. 30.83. La canonica, posta a sud della chiesa, nonostante siano emerse le mura-
ture medievali nel corso dei lavori, è stata ‘restaurata’ nel 2009 senza produrreadeguata documentazione.
84. PANAzzA 1974, p. 14.85. PANAzzA 1942, p. 117.86. GUERRINI 1934, p. 180: «Più tardi, cresciuta la popolazione del borgo,
vennero aggiunte le due navate laterali, come si vede chiaramente nella faccia-ta, dove la saldatura fra la parte vecchia centrale e le due aggiunte laterali è fattacon materiale diverso e in una forma che non lascia luogo a dubbi. Ritengo chequesta aggiunta sia stata fatta sulla fine del secolo XV, poiché ricorda il Rinaldiche venne consacrata la chiesa l’ultima volta il 30 luglio 1498 (…). Non si com-pie difatti una nuova consacrazione di una chiesa se questa non ha subito radi-cali trasformazioni e un ampliamento rilevante».
87. BALLERIO 1940-1941-1942, pp. 100-101.88. PANAzzA 1974, p. 18.89. Sulla chiesa di Gravedona si vedano: MAGNI 1952; MAGNI 1960, pp.
131-139; BELLONI zECCHINELLI 1975; GRAMATICA 1996; DELLA TORRE1997.
90. PANAzzA 1974, p. 23.91. BEDESCHI 1959, p. 29 (10) presenta una proposta grafica delle diverse fa-
si dell’edificio, così annotate: «A. Nel secolo VI, nel luogo ov’era stato il tempiodi Iside, sorge la primitiva Pieve. B. Nel secolo XII si costruisce, incastrato nellafacciata della chiesa, il campanile romanico. C. Nel secolo XIV, sotto la signoriascaligera, si modifica l’aspetto della cella campanaria: nel luogo della trifora siapre, ad ogni lato del campanile, un ampio unico arco; si pone un tetto a formaconica. D. Alla fine del secolo XV si aggiungono le navate laterali (ciò causa lospostamento di un tratto di via Pusterla). E. Dai rifacimenti della prima metà delsecolo XIX non rimane salva che la facciata del campanile; le navate vengono poiintegrate a raggiungere altezza maggiore, in relazione all’accresciuta lunghezza».
92. CANALI 1968, p. 19; cfr. PANAzzA 1974, p. 27.93. Ancora nel 1980 (Iseo 1980, p. 13) si sosteneva che «Testimonianze ar-
cheologiche di grande importanza non ve ne sono, ma il poco che si può racci-molare fa credere che l’antico sagrato fosse un centro cultuale pagano».
94. RINALDI 1685, pp. 8-9: «Essendo donque tali gli Sacrificij, e Feste, chevanamente si prestavano a questo Nume, tali al certo li dovevano pratticare ancogli Antichi Nostri Gentili Iseani: Onde non voglio hora allontanarmi dal pareredi quelli, che asseriscono, la Pieve Nostra essere statta Tempio di questa inganne-vole Deità, cioè che nel medesimo sito fosse il suo Tempio, e questo sij poi stattoaggiustato, et ingrandito nella forma magnifica, di vera Religione, che hora si ve-de; il che avenne al tempo del Santissimo Vescovo Vigilio suo Primo Fondatore:quale, come Novello Alcide, abbattendo del tutto in questa nostra Patria l’Idradell’abbominevole Idolatria, vi piantò, e rinovellò il Culto del vero Dio».
95. RINALDI 1685, pp. 5-6 dove, parlando dei culti pagani, si dice che «(…)li nostri Iseani prestavano honore, e tenevano per loro Dei Hercole, e Diana,commune di ciò è la fama, et evidenti sono i fondamenti di essa; perche quantoad Hercole, fino à giorni nostri molti affermano haver visto il lui nobile Simo-lacro marmoreo, che per memoria d’antichità fù poi ingegniosamente ripostoper abbellimento della Porta di mezzo della Pieve (…) et al presente ivi risiedetutto cuoperto, e rinserrato per la restauratione, che necessaria fù farsi l’anno1628 per più sicurezza del Campanile; e questo, che hora è si nascosto, et scor-dato era a quei tempi molto stimato, e riverito (…)».
96. BREDA 1982; LEONI 2008.97. Di quel lavoro non furono pubblicati i dati di analisi nel dettaglio;
schizzi e appunti mi sono stati messi generosamente a disposizione da AndreaBreda.
Dario Gallina – La pieve di Sant’Andrea di Iseo (Bs) 193
19Gallina 177_Layout 1 18/02/14 12:31 Pagina 193
98. In estrema sintesi bibliografica, si intende per metodo stratigraficoquanto definito in: BROGIOLO 1988; Archeologia 1988; MANNONI 1994; DO-GLIONI 1997; BOATO 2008.
99. GALLINA 2004.100. Il fotoraddrizzamento, ottenuto dal fotomosaico di circa 40 immagini
per una risoluzione finale di 200 dpi in scala 1:20, è stato elaborato da chi scrivegrazie all’aiuto della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Iseo, che ha finan-ziato l’uso di una piattaforma elevatrice indispensabile per le riprese fotografichee la predisposizione del rilievo topografico, e con la collaborazione dei socidell’U.S.P.A.A.A. (Unità per la Salvaguardia del Patrimonio Archeologico, Ar-chitettonico ed Artistico della Franciacorta e del Sebino Bresciano) sciogliereAngelo Valsecchi, Fulvio Sina, Sergio Alebardi.
101. Lievemente oscillante la cronologia in PANAzzA 1974: alle pp. 17-18,seconda metà del XII secolo; a p. 27, metà del XII secolo.
102. RINALDI 1685, p. 131: «(…) il zelantissimo Pastore S. Vigilio, qualeoccupando l’anno 504 la Sedia Episcopale di Brescia, secondo quasi tutti liAuttori, sedette ancora, e fece tanta Residenza in Iseo, che con la celeste suaDottrina, Essempi, e Santità di Vita, discacciando del tutto ogni oscuritàd’Idolatria, e d’Heresia, col trasportare la sudetta Cura Parochiale di S. Stefanonel luogo, dove hora è la Pieve, quivi eresse, e fondò la nostra vera, et antica Pie-ve sotto nome, et invocatione del Pescator delli huomini S. Andrea Apostolo,come si ha da manuscritti di essa Chiesa». I “manuscritti” ai quali il Rinaldi fariferimento, di fatto, non sono prove di quanto egli asserisce, poiché si tratta diuna piastra di piombo del 1524, rinvenuta durante una ricognizione delle reli-quie del Santo, che riporta inciso il suo ruolo di fundator della pieve; e del-l’iscrizione presso il suo sepolcro, posto sopra l’altare, del 1633.
103. BREDA 1982.104. Purtroppo, a causa della presenza dell’ampia stesura di intonaco Us
105 e del marcato degrado di questa porzione della facciata, è assai difficile va-lutare con precisione l’effettiva estensione di Us 100, anche considerando chela tomba Bonfadini, rimossa nel XVII secolo, doveva insistere più o meno qui,ed è probabile che anche ad essa e al suo smontaggio risalgano i ‘disturbi’ allaleggibilità stratigrafica.
105. Il medolo è geologicamente definibile come una roccia carbonatica,formatasi in ambiente marino tropicale, caratterizzata da componenti marno-se e selciose (queste ultime sotto forma di letti, lenti, e noduli), di colore varia-bile dal bianco all’avorio/giallo chiaro. Il nome di medolo (médol in dialetto,tuttora usato per indicare tanto la cava quanto il materiale che se ne ricava deri-va con ogni certezza dal latino classico metallum, cioè da un termine che indi-cava sia le cave che le miniere, ed è ben attestato anche nel latino medievale me-dallum. Vedi Vocabolario 1759, p. 172; MELCHIORI 1817, I, p. 32; ROSA 1870,pp. 80-81); BARTOLINI 1998.
106. MANNONI 1997.107. Per lo scavo della chiesa si rimanda a: BREDA, VALSECCHI 1998; VAL-
SECCHI 2001.108. PANAzzA 1963b, p. 535.109. ARCHETTI 2001a. Come riconosciuto dall’autore, la proposta di da-
tazione deriva più dalla valorizzazione di alcuni indizi storici che da elementiespliciti e verificati.
110. GALLINA 2000; GALLINA 2007.111. CERRI, LUSENTE, SANDRINI 2009.112. PANAzzA 1942, pp. 65-66 e pp. 107-108; PANAzzA 1963c, pp. 720-
721; BREDA 1988-1989c; BREDA 1989; BREDA 1990; BREDA, VALSECCHI2004.
113. PANAzzA 1942, pp. 91-100.114. PANAzzA 1963c, pp. 719-720.115. Secondo il Ballerio (BALLERIO 1940-1941-1942, p. 102), questa fase
sarebbe – come detto – posteriore al campanile, e da tale approccio conseguequesta descrizione: «ha una muratura del tutto diversa da quella, per intender-ci, del campanile ed è a blocchetti di pietra più piccoli, male squadrati, a cui so-no mescolati frammenti di mattoni. In essa, alle due estremità in basso, si nota-no tracce di archi in cotto, a tutto sesto, di aperture ora murate, che ci fannopensare a tarde forme del ’300 o forse del ’400».
116. FERRANDO, MANNONI, PAGELLA 1989.117. Per la città: CORTELLETTI, CERVIGNI 2000 e CERVIGNI 2007; per la
Franciacorta: Archeologia 1993; GALLINA, BREDA 2003.118. CAGNANA, FERRANDO 1997.119. SEGAGNI MALACART 2007d. Benché le aperture in facciata non ven-
gano considerate (mancando anche nel rilievo architettonico), la datazionedella chiesa è assegnata alla seconda metà dell’XI secolo in modo ben argomen-tato.
120. Si noti che il primo arciprete del quale abbiamo notizia è di que-
st’epoca: Lanfranco, citato come teste in un documento del 1192 riguardantele contese fra Brescia e Bergamo per il controllo del castello di Volpino (vediLiber 1899, doc. XXXIV – 2 ottobre 1192).
121. L’osservazione era stata avanzata già dal Ballerio (BALLERIO 1940-1941-1942, p. 103), sia notando i legami strutturali, sia sottolineando corret-tamente che «la prima e la seconda cornice di archetti del campanile, a diffe-renza di quelle superiori, non rigirano sui fianchi».
122. A parere del Ballerio (BALLERIO 1940-1941-1942, p. 102), «la portaattuale, col rivestimento di pietra di Sarnico, è del secolo XVI tardo o dei primianni del XVII, ma sotto si intravede ancora l’arco in cotto della porta prece-dente», mentre a noi sembra certo che l’arco in mattoni non sia quello antico,ma un sordino posto al di sopra dell’architrave barocco.
123. BREDA 1982.124. BRUGNOLI, MARCHI 1979; Catalogo 1985.125. MARMO 1989.126. BERRUTI 2002.127. PORTER 1915-1917, I, p. 207, facendo riferimento a: San Michele di
Pavia - 1100 circa; San Vittore a Priocca (Cn) - 1115 circa; Santa Trinità di Ca-stellazzo Bormida - 1130 circa; San Biagio a Roncoscaglia (Sestola, Mn) - 1200circa; dati poi ripresi da PANAzzA 1974, p. 19.
128. VERGA 1957. La finestra in questione è assai più grande di quella diIseo, poiché misura più di 2 m di altezza, ma ciò non toglie che sia assai similenella forma alla nostra, distinguendosene però anche per la ricchissima decora-zione a laterizi intagliati, cioè per una tecnica che è del tutto usuale per la bassapianura e, per contro, del tutto assente nel territorio pedecollinare bresciano.Secondo questo studio, la fascia decorativa laterizia sarebbe stata aggiunta allafine del XIII secolo ad una finestra preesistente. Il Verga segnala infine, in ag-giunta a quelli citati dal Porter, altri esempi di finestra a doppio arco contrap-posto: San Colombano a Vaprio d’Adda - XII sec., e Iseo (forse su suggerimen-to del Panazza, che pubblicò anch’egli un articolo in quel numero di «ArteLombarda»?).
129. Per comprendere la difficoltà di trovare una definizione adeguata èsufficiente citare le altre proposte avanzate da Guido, padre di Corrado Verga(VERGA 1957, p. 164, nota 21): «(…) la rarissima forma elicoidale o meglio abiscotto (essendo chiusa a pieno sesto anche in basso)».
130. Del parere che invece il campanile terminasse con un’ulteriore pianodotato di trifore sono sia Ballerio (BALLERIO 1940- 1941-1942, p. 102) siaPanazza (PANAzzA 1974, p. 18).
131. PANAzzA 1942, pp. 108-109; PANAzzA 1963c, p. 736.132. Sull’uso delle impalcature si rimanda a: COPPOLA 1993; COPPOLA
1994, p. 470, pp. 495-496; COPPOLA 1996; L’échafaudage 2002. Un buon riferi-mento per comprendere a quale complessità potesse giungere l’arte della carpen-teria lignea è dato dalla trattatistica ottocentesca, come PIzzAGALLI, ALVISETTI1827, che propone in grande formato anche numerose tavole acquarellate.
133. Queste le misure: 1° serie di fori pontai (Us 163, 164, 165): m 5,64da terra; 2° serie (Us 166-167): a m 1,55 dalla serie precedente; 3° serie (Us168, 169, 1770) a m 1,44; 4° serie (Us 171, 172, 173) a m 1,19; 5° serie (Us175, 176, 177) a m 1,39; 6° serie (Us 178, 179, 180) a m 1,07; 7° serie (Us 181,182) a m 1,24; 8° serie (Us 183, 184, 185) a m 1,28; 9° serie (Us 186, 187, 188)a m 1,48; 10° serie (Us 189, 190, 191) a m 1,47; 11° serie (Us 192, 193, 194) am 1,44; 12° serie (Us 195, 196, 197) a m 1,11; 13° serie (Us 198, 199) a m 1,38;14° serie (Us 200, 201, 202) a m 1,40; 15° serie (Us 203) a m 2,05.
134. Il tema del ‘cantiere medievale’ è oggetto di numerosissimi studi, cherimandano però pressoché costantemente all’organizzazione del lavoro nel-l’ambito delle grandi cattedrali o delle opere pubbliche di grande dimensione:PINTO 1984; Cantieri 1995; TOSCO 1997a; FRANCHETTI PARDO 2001; TO-SCO 2003b. In alternativa a questa impostazione, si privilegia l’analisi iconogra-fica delle raffigurazioni di cantieri, dove spicca l’ormai ‘classico’ BINDING 1993.Non mancano poi gli studi del cantiere medievale desunti da fortunati casi diconservazione dei documenti, anche relativi a lavori di piccola dimensione, co-me l’esemplare RONCAGLIA 1984. Alcune felici eccezioni, nelle quali l’atten-zione è rivolta al dato materiale, sono rappresentate da: PERONI 1984b; FRATI-NI, GIOVANNINI, PARENTI 1996; BARAGLI 2001.
135. Ringrazio Sergio Alebardi, che si è gentilmente adoperato perché po-tessi accedere all’interno del campanile nonostante la ritrosia dell’arciprete diIseo.
136. A volte la dimensione è maggiore, ma in conseguenza di interventi dirottura che dovrebbero testimoniare gli interventi di sostituzione delle travi disostegno dei solai lignei.
137. Non concordiamo quindi con Panazza quando scrive che «dall’ora-torio ora descritto saliva poi la canna del campanile, fino alla cella campanariasenza alcuna divisione dovuta a ripiani o a volte» (PANAzzA 1974, p. 23).
194 Architettura dell’XI secolo nell’Italia del Nord
19Gallina 177_Layout 1 18/02/14 12:31 Pagina 194
138. GALLINA 2004.139. Secondo il Ballerio (BALLERIO 1940-1941-1942, p. 101), «la mura-
tura di questa parte più antica è formata di blocchi di medolo e di botticino(questi ultimi di probabile risulta da edifici romani)», ma l’osservazione ravvi-cinata del campanile non dà alcuna conferma di questo, poiché il materiale im-piegato è costantemente il locale medolo bianco.
140. PANAzzA 1974, p. 19.141. Si tratta delle seguenti tavole di grande formato, depositate in copia
presso il Nucleo Operativo di Brescia della Soprintendenza Archeologica dellaLombardia: Tav. 1, rilievo del sagrato di Sant’Andrea e degli edifici parrocchiali(scala 1:50); Tav. 2, rilievo della base del campanile (scala 1:20); Tav. 3, rilievo delpiano superiore del campanile (scala 1:20); Tav. 4, sezione-prospetto nord-suddel campanile, vista da ovest (scala 1:20); Tav. 5, prospetti-sezioni est-ovest delcorpo sud del campanile, viste da nord e da sud (scala 1:20). Ringrazio Luigi Pez-zotti ed Ezio Pedrocchi per avermi messo a disposizione questi materiali.
142. Il modello è stato elaborato ‘sommando’ i dati tratti dai diversi studicitati, e ovviamente con miei rilievi e riflessioni, supportate dai consigli di An-drea Breda verso il quale ancora una volta sono debitore. Di particolare impor-tanza sono stati gli appunti – già citati alla n. 93 – per il posizionamento dellafinestra posta nel lato settentrionale del cleristorio, individuata in occasione delrifacimento del tetto della chiesa.
143. Cfr. GUERRINI 1934, p. 165.144. RINALDI 1685, p. 144: «Da principio fu questa Chiesa construtta
con quei Arconi, e Copertumi, che si stilava all’antica, e vi furono fatte otto, òdieci fenestre per ogni lato, come al difuori si può vedere, le quali al certo dove-vano rendere, e vaghezza, e gran chiarore, ma ogni cosa fu distrutta quando delM.D.XXVI fù fatto l’Involto per maggior abellimento di essa Chiesa (…)».
145. RINALDI 1685, pp. 144-145: «Era [scilicet la chiesa] di più dipinta, equasi in ogni parte ornata fino ne medesimi Pilastri, di varie Pitture Sacre, e ti-piche Imagini, solite dipigersi (…)nelle Tribune delle Chiese, e nelle muraglie,così della destra, come della sinistra, et erano à guisa di Trofei della Nostra San-ta Religione: molte delle quali Pitture però venivano fatte per divotione, ò perVoto di Persone particolari, come si vede dalle sottoscrittioni, che costumava-no farsi; ma per la edacità del tempo, che ogni cosa guasta, e consuma, essendotali Pitture mezzo smarrite, fù di mestieri abolirle del tutto, facendosi intonica-re, et imbianchire essa Chiesa l’Anno 1538 per mantenervi la politia, che se gliconviene. (…) per la soverchia umidità poi di detta Capella, essendo d’indi le-vate le Sacre Ossa del Santo, e restando derelitta, et inofficiata, fù spianata se-condo il Decreto, aliàs fatto dalla Fel. memoria di S. Carlo, abbassandovi soprail Choro intorno all’anno 1667 et aggiustandolo nel modo, che hora si vede».
146. RINALDI 1685, p. 147: «Hor vediamo un puoco l’antica Facciata diquesto nobil Tempio; sopra la Porta maggiore, che viene ad essere sotto al cam-panile scorgevasi un’antichità di non puoca stima rappresentante le gloriose for-ze d’Hercole. Era questo un Gigantesco Simolacro in una assai bella, e convene-vole Nicchia ingegnosamente disposto, si ben’ inciso, et intagliato in finissimomarmo, che non slontanandosi punto dall’alabastro, l’antichità solo pareva gliavesse tolto lo spirito, et il candore; era nudo, et à cavallo sopra d’un Leone rivol-to con la faccia a Tramontana con le mani al mento di quello afferrate, in tal attodi sbranarlo, che non tralasciava però il gesto di sostenere l’eminente gran moledel Campanile: à che davano il conveniente decoro, et ornamento altri Intagli difigure, fiorami, et altri abbellimenti, benche in gran parte dal tempo corrosi, cheaggiongendovi anco il restante della Porta fatta in forma corrispondente, comeall’artificiosa inventione conveniva, non puoteva esser di meno, che non facessehonorata pompa di se stesso, e non cagionasse ne rimiranti ammiratione, e dilet-to: queste forze però Herculee, per essere solo di vista, e non di real forza, ne sof-ficienza al gravissimo peso d’esso Campanile, qual parea minacciasse pericolo, erovina, l’anno 1628 furono distrutte, mettendo nuovi fondamenti, e ripari alCampanile, e facendo una nuova Porta più soda, e munita, e più in fuori, come sivede; si che l’altra, e le sudette cose tutte restano coperte, fratte, e perdute».
147. RINALDI 1685, pp. 147-148: «Da Lati poi di queste forze d’Hercole,in tal modo rappresentate, insorgevansi eminenti, et in bella Prospettiva eleva-ti duoi molto nobili, e magnifici Depositi, che a guisa di Mausolei raffiguran-do, non meno l’antica magnificenza di nostra Patria, ch’l vile di nostra mortali-tà dimostravano; l’uno della destra di essa Facciata era di Dominio de SignoriBonfadini, Casa in vero, che in quel tempo necessariamente dovea essere dinon poca consideratione, e preggio, mà non sò, se hora mi dica del tutto estin-ta, ò in qualche picciol virgulto solo ridotta; certo almeno si è, che avversa gli siè dimostrata la fortuna, mentre nel sudetto anno 1628 dovendosi provedere alpericolo già detto del Campanile, fu de mestieri gettare a terra la detta Arca, òDeposito di Casa Bonfadina, non però la di lei memoria».
148. RINALDI 1685, p. 145. V. la trascrizione del documento in GUERRINI1934, pp. 165-166.
149. GUERRINI 1934, p. 181-182; il testo integrale della Visita Pastorale èin Visita 2004, pp. 5-10; cfr. ARCHETTI 2007b, p. 7.
150. RINALDI 1685, pp. 145-146: «Compita quest’Opera [scilicet. l’abbatti-mento della cripta], si diede puoco dopò principio ad un’altra, non men bella, chenecessaria, e fù la nuova Sacristia: della quale, caro Lettore se desideri havernequalche notitia, dirò, che l’antica Sacristia di questa Chiesa fù nella Casa del Mol-to Rev. Arciprete in quel sito, dove poi è stato fatto il Dispensino, che stà adhe-rente alla recente Capella di S. Vigilio, che all’hora si diceva del Rosario, à mezzodella quale vi era l’Uscio di essa Sacristia con un’altro all’incontro pure nella me-dema Capella, che rispondeva à mezzo alla scala laterale, che andava al Choro, co-me habbiamo detto di sopra, e questo secondo Uscio mi ricordo haverlo visto perconformità anco alla Capella di S. Lorenzo, mà non così bello di pietra, come era-no questi due, quali essendo poscia d’indi levati, come cosa di Chiesa, furono dal-la divota Communità donati alli R.R. Padri di S. Francesco quì d’Iseo l’Anno1636, essendo dunque tal Sacristia vecchia, e molto angusta, fu ordinato dall’Illu-strissimo Vescovo al Molto Rev. Arciprete Tiberio, che concedesse sofficiente si-to per ingrandirla tirandosi indentro verso la Caneva, ma meglio pensato, diedela stanza superiore residente sopra la Capella di S. Vigilio, che servì poi anch’essafino all’edificatione della presente nuova, mà quasi con ugual incommodo, per-ché, oltre alla longa scala, che conveniva farsi, era etiandio angusta à tanto clero».
151. RINALDI 1685, pp. 148-149: «Affermano anco diversi de nostri An-tiani haver visto altri Depositi sù la medema muraglia della Pieve dalla parte diTramontana, riguardevoli bensì, ma inferiori a sudetti [scilicet le tombe Oldo-fredi e Bonfadini], quali per il decorso forsi de secoli, havendo perso il loro de-coro, furono al suolo adequati, e del tutto hora scordati (…)».
152. Eppure il disegno n. 2 del Vantini mostra una sola abside che, a giudi-care dal profilo, potrebbe ancora essere quella medievale, e questo fa dubitaredi questo allungamento della chiesa; nella nostra ricostruzione abbiamo sceltouna soluzione monoabsidata ma, viste queste incertezze, sarebbe ugualmenteplausibile un presbiterio a tre absidi.
153. GUERRINI 1924, p. 182 e pp. 214-216.154. Rodolfo Vantini (1791-1856) è considerato il massimo architetto ot-
tocentesco bresciano, e moltissimi sono i suoi progetti in città e in provincia.Immeritatamente negativo, quindi, il commento del Guerrini, secondo cui«era pure un bravo architetto, ma dominato dallo stile neo-classico non capivanulla del romanico e del lombardo» (GUERRINI 1934, p. 165, nota 6).
155. ROSA 1892, p. 44.156. RINALDI 1685, pp. 144-145: «Ma dove lascio quella bella Antichità
della Capella sotterranea di S. Vigilio? Questa era sotto il Choro della medemagrandezza, che era esso, e vi si descendeva per una larga scala di 12 ò più scalini,quale era posta in mezzo ad una grande, e vistosa apertura, tutta dipinta, cheserviva, e di porta, e per dar il dovuto lume a detta Capella, quale, essendo fattaad Involto co suoi pilastri, pareva fosse, come di 3 Navi, e v’erano anco alcuneSepolture; in capo di essa vi risiedeva il Sacro Altare tutto ferrato con decenteFerrata, per esser ivi stato longhissimo tempo depositato il preggiatissimo pe-gno del Corpo di esso S. Vigilio, dietro di esso altare in mezzo verso mattina viera una conveniente Fenestra, che maggiormente rischiariva il Santo Luogo; ilchoro poi, sotto del quale stava essa Capella era sì eminente, che vi si ascendevaper due commodissime Scale di pietra laterali con sue proportionate ferrate, incapo de quali n’era un’altra, che attraversava tutto il Choro, sopra di cui pone-vasi il Cerio Pasquale co’ duoi testimonij, et altri Cerij».
157. I disegni (depositati presso il Fondo Vantini dell’Archivio di Stato diBrescia) mi sono stati segnalati nella primavera del 2010 da A.A. zani e G. Pez-zotti. È doveroso ringraziarli per questa non comune gentilezza.
158. Trattandosi di elementi coevi, appartenenti alla medesima fase co-struttiva, si è deciso di individuarli semplicemente con lettere che rimandanoalla tavola allegata, invece di considerarle propriamente US all’interno di uncontesto stratificato.
159. Il Ballerio (BALLERIO 1940-1941-1942, pp. 108-109) è incerto sequesta apertura comunicasse con l’esterno o con l’interno della chiesa romani-ca, ma la ricostruzione tridimensionale consente di verificare come corretta, trale quattro ipotesi avanzate, quella che vede una chiesa originaria a tre navate.
160. Sembra peraltro da scartare l’idea che la scala avesse origine presso l’an-golo della chiesa, cioè collegando direttamente da nord a sud il pavimento dellanavata meridionale con il corpo [C] senza la presenza di un percorso orizzonta-le, non solo poiché il dislivello da coprire (3,95 m) è eccessivo in rapporto allospazio disponibile (4,5 m circa contro i 6 ipotizzati da noi coperti da una scalacon gradini di 30 cm di pedata e 20 di alzata), ma soprattutto perché una strut-tura di questo tipo richiederebbe l’eliminazione dei portalini d’accesso alle nava-te minori (Us 102 e 152), che peraltro potrebbero essere stati occlusi anche se-guendo la nostra ipotesi. La muratura di tamponamento degli antichi accessi al-le navatelle laterali è troppo ammalorata per essere datata su base tipologica.
Dario Gallina – La pieve di Sant’Andrea di Iseo (Bs) 195
19Gallina 177_Layout 1 18/02/14 12:31 Pagina 195
161. Il Ballerio ricorda a questo proposito che quando si sistemò la cappel-la battesimale «si riuscirono a salvare un capitello e una colonnina identici aquelli della bifora» dell’ambiente A (BALLERIO 1940-1941-1942, p. 107), deiquali ignoro l’attuale collocazione.
162. Si nota, nell’arco destro della bifora, l’impronta sporgente lasciatanella malta da un elemento della centina decorato da croci o ‘X’ ripetute, per ilquale non abbiamo trovato una spiegazione soddisfacente.
163. La nicchia appare a prima vista alla stessa quota del pavimento, ma èstata allungata verso il basso di circa 10 cm.
164. Nel rilievo di Pezzotti e Pedrocchi queste nicchie sono rilevate comegrandi porte-finestre strombate che sarebbero state poi occluse, ma sembra cer-to che si tratta di un errore di lettura, poiché questo tipo di assetto rispecchiauna fase posteriore, realizzata tagliando la curvatura della nicchia e sfondando-ne la parete di fondo per ottenere delle nuove aperture. La medesima osserva-zione, succintamente, è già in BALLERIO 1940-1941-1942, p. 106.
165. È infatti ben visibile da un lato della porta l’intervento di risarcituradella muratura dopo l’asportazione dell’architrave, e dall’altro l’imperfetta scal-pellatura dei suoi resti.
166. AUTENRIETH 1984a; AUTENRIETH, 1984b; AUTENRIETH 1987; AU-TENRIETH, AUTENRIETH 1988; AUTENRIETH 1988; AUTENRIETH 1991.
167. Ipotizzando che nei fori pontai fossero inserite non travi portanti, masemplici mensole che reggevano travi dormienti, poggiate parallelamente allepareti, le specchiature rimangono completamente visibili, ma viene parzial-mente ostruita la nicchia-finestra soprastante. Non mi è chiaro perché in PA-NAzzA 1974, p. 23 si affermi che «Curioso è poi il fatto che l’oratorio sopra de-scritto non abbia traccia di una copertura a volta o a soffitto ligneo piano, dimodo che sembra quasi trattarsi di un elemento estraneo (…)».
168. BALLERIO 1940-1941-1942, p. XXX.169. Basti il rimando a SCHIAVI 2005, pp. 163-195 e la sintesi in VER-
GNOLLE 1994, pp. 69-72.170. Si vedano per esempio i casi friulani di Santo Stefano di Cesclans e
dei Santi Gervasio e Protasio di Nimis (CAGNANA 2001), per i quali si affermal’esistenza di un Westwerk sulla sola base di alcune strutture in facciata, rinve-nute nel corso degli scavi archeologici (BROGIOLO 2001, p. 202).
171. Le chiese considerate dalla Chierici Furno e dal Tosco sono, oggi inprovincia di Torino, quelle di: Santa Maria a Lugnacco; San Michele a Pecco;Santi Pietro e Paolo a Pessano presso Bollengo; Santo Stefano di Sessano aChiaverano (vd. anche SCAVINI 1998); San Pietro a Piverone (terzo quarto del-l’XI secolo), alle quali si aggiungono, grazie a testimonianze indirette, SantoStefano di Candia e la chiesa dei Santi Ilario e Sulpizio a Strambinello.
172. CHIERICI FURNO 1975.173. TOSCO 1998.174. CALDANO 2009a. Il clocher-porche di San Silano a Romagnano Sesia
è datato all’inizio dell’XI secolo; le altre chiese individuate con campanile infacciata sono: Santi Fabiano e Sebastiano a Fontaneto d’Agogna (No) dell’ini-zio dell’XI secolo; San Giovanni di Cerrione (Bi), il cui campanile è della se-conda metà dell’XI secolo, ma la chiesa è posteriore; Sant’Antonio di Rosigna-no Monferrato (Al) del XII secolo.
175. CHIERICI FURNO 1975, pp. 335-336.176. Secondo la definizione data da Reinhardt e Fels (REINHARDT, FELS
1937, p. 425).177. REINHARDT, FELS 1937, pp. 449-463; EMERY 1994-1997.178. TOSCO 1998, p. 696.179. TOSCO 1998, p. 697.180. BETTI 1999, pp. 71-81. Le chiese analizzate sono quelle di: Santa
Scolastica di Subiaco (fase della fine del X secolo); Montecassino (interventidell’inizio dell’XI secolo); San Pietro alla Foresta tra Esperia e Pontecorvo (pri-ma metà dell’XI secolo); Santa Maria sul Monte Asprano a Castrocielo (primametà dell’XI secolo); Santa Maria di Trocchio a Cervaro (ultimo quartodell’XI secolo); Santa Maria di Correano presso Ausonia (terzo decenniodell’XI secolo); Santa Maria di Castagneto presso Maranola (fine XI secolo);San Pietro a Minturno e San Michele a Itri (1030-1040 ca); la chiesa parroc-chiale di San Giovanni Incarico (seconda metà dell’XI secolo).
181. BETTI 1999, p. 77. Quest’ultima affermazione ci sembra poco con-vincente, viste le ampie aperture e finestre dei casi citati.
182. Si veda per esempio la penisola istriana dove, oltre al caso di Sant’Eliaa Bale/Valle d’Istria (dove il campanile è stato inserito posteriormente), il cam-panile in facciata è presente anche in una soluzione ‘minore’ a San Girolamo aHum/Colmo, e a Sant’Antonio a Roč/Rozzo.
183. Pur prefiggendosi uno studio territorialmente circoscritto, Betti dimo-stra di aver ben presente che la casistica delle chiese con campanile in facciata è as-sai più ampia e meriterebbe maggiore attenzione (BETTI, 1999, p. 79, nota 1).
184. ‘Sommando’ le notizie riportate negli articoli di Gaetano Panazza,Patrizia Chierici Furno, Carlo Tosco, Simone Caldano e Fabio Betti, ricaviamoquesti altri casi che gli autori richiamano a mo’ di confronto: Santo Stefano aTesserete (Svizzera, Ticino); San Giacomo al Seminario e Santa Maria di Bard(Ao); Santi Cosma e Damiano a Gazzada Schianno (Va); Santi Nazaro e Celsoa Scaria (Co); Santa Maria del Tiglio a Gravedona (Co); San Pietro a TizzanoVal Parma (Pr); Santa Maria a Corsano ad Anghiari (Ar); San Giovenale a Ble-ra (Vt); San Vito di Valle Castellana (Te); San Pietro di Alba Fucens (Aq); San-ta Anastasia a Ponte (Bn). A questi mi permetto di aggiungere: San Paolo aCantù (Co); San Giovanni al Pozzo Bianco a Bergamo alta; San Martino a Ber-ceto, fraz. Corchia (Pr), senza dubbio più tardo; Santi Simone e Giuda ad Al-benga (Sv), fraz. San Fedele; San Giorgio all’Isola di Montemonaco (Ap); San-ta Maria a Belmonte Piceno (Ap); Santa Maria Maggiore a Guardiagrele (Ch);San Giacomo fuori le mura a Montoro (Av). Senza dubbio sono campanili po-steriori quelli della pieve di San Michele a Santarcangelo di Romagna (Rn) e diSan Marco a Ponzano di Fermo (Fm). Come si vede, motivi di studio e di ulte-riore, doverosa, riflessione non mancano.
185. BALLERIO 1940-1941-1942, p. 110.186. PANAzzA 1974, p. 23.187. PANAzzA 1974, p. 23: egli ricorda la Cappella Palatina di Aquisgra-
na, San Michele a Saint Philibert di Tournus, la Bischofskapelle del Duomo diGurk in Carinzia.
188. PANAzzA 1974, pp. 25-26.189. Guido Canali ravvisa forti legami con l’area borgognona (CANALI
1968, p. 19).190. Specificamente egli richiama certi esempi rintracciabili nel Vallese, in
Vandea, e in Aquitania – e in particolar modo: Saint Martin d’Aynai a Lyon,Notre Dame a Morienval (Oise), nonché i casi di Jumièges, Ebrenil sur Allier,Saint-Benoit-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés, Saint Porchaire a Poitiers,Saint-Savin-sur-Gartrempe. Per una sintesi delle diverse valutazioni storiogra-fiche delle influenze e caratteristiche cluniacensi, a partire da criteri estensivi aquelli odierni, assai più restii a riconoscere una peculiarità cluniacense persinoalle chiese appartenenti all’ordine, vd. PIVA 1998, pp. 11-13.
191. BARONIO 1979; Medioevo 1996; San Nicolò 2002. 192. La descrizione più attenta della chiesa monastica di San Salvatore
è in PIVA 1998. Si veda però anche AUTENRIETH 1981; CHIERICI 1978,pp. 224-227.
193. Il rinvio è al contributo di Fabio Scirea in questo medesimo volume.194. L’unico caso di parziale inserimento del campanile nel muro di fac-
ciata è Santo Stefano di Chiaverano, ma esso comunque – come è possibile ap-prezzare dalla planimetria – non oltrepassa lo spessore della facciata stessa, nonsporgendo quindi all’interno.
195. TOSCO 1998, p. 697.196. GALLINA 2004; uno spunto di questa interpretazione anche in ROSSI
2004, p. 29.197. PANAzzA 1990; PIVA 1990, pp. 35-56; ROSSI 2004, soprattutto alle
pp. 25-34; TASSINI 2004; PIVA 2007, pp. 67-88; ROSSI 2007b.198. Così secondo la relazione dell’Averoldi (La torre del nostro Domo di
Brescia è caduta il Lunedì cinque Marzo 1708) conservata presso la BibliotecaQueriniana (Ms. H.III.5), c. 167v.
199. Si vedano l’Estimo comunale del 1588 e il dipinto della Traslazionedei Santi Vescovi del Maffei.
200. Stando alla descrizione dell’Averoldo, la torre era alta 90 braccia finoalle campane, cioè circa 56 m, a cui andavano aggiunte altre 12 braccia per lacella e 16 di interramento prima dell’inizio delle fondamenta; il lato esterno èstato calcolato di 7,5 m. Per questi dati, v. ROSSI 2004, p. 29; misure diverse so-no in TASSINI 2004, p. 16: 42,75 m fino alle campane; 48,45 m fino al tetto;7,6 m per le fondamenta. Non mi è chiaro peraltro da dove l’autore tragga mol-te convinzioni, come quella che in origine la torre dovesse essere più bassa. Ingenerale, l’articolo sembra ‘schiavo’ di una ipotesi che, pur se assai stimolante,viene però agitata come una certezza, e ad essa i dati si debbono piegare.
201. Sopralluogo condotto da chi scrive con Andrea Breda nel 2003.L’Averoldi testimonia indirettamente la coerenza costruttiva della torre e dellacattedrale laddove scrive (cc. 166v-167r) che «dall’essere poi la Torre nostracolligata co’ suoi fondamenti, e muraglie del Tempio, apertamente si deduce,contro l’universale inveterata opinione, non essere stato il nostro Tempio, Tem-pio de’ Gentili (…) e se in uno stesso tempo s’è costruita la chiesa, e la Torre, na-sce la conseguenza tutto essersi innalzato da’ Cattolici».
202. PANAzzA 1990, p. 50; il parere è seguito da PIVA 1990, p. 50; TASSINI2004 ritiene invece che la torre fosse la ‘cassaforte’ del tesoro delle Sante Croci.
203. Secondo PIVA 1990, p. 48, la loggia era «riservata al vescovo e al suoseguito, e solo in qualche caso a suoi ospiti di rango particolare». A parere di
196 Architettura dell’XI secolo nell’Italia del Nord
19Gallina 177_Layout 1 18/02/14 12:31 Pagina 196
TASSINI 2004, p. 20, si tratta solamente della parte terminale del percorso pro-cessionale per giungere alla stanza del tesoro posta nella torre.
204. Le scale sono state fortemente restaurate/integrate alla fine del XIXsecolo ad opera di Luigi Arcioni, ma le vecchie fotografie e i disegni mostranoche, nell’insieme, l’intervento di ricostruzione è stato corretto. Per i dettaglidelle scale, vd. TASSINI 2004, pp. 11-13.
205. BALLERIO 1940-1941-1942, pp. 107-108 e p. 109.206. Devo alla squisita cortesia del prof. Adriano Peroni questi suggeri-
menti.207. TOSCO 1998, pp. 691-692, annota che «Nelle torri canavesane si ri-
scontra, con una frequenza che non può essere casuale, l’inserto di absidi per ilculto», così come erano provviste di absidi la Torre Civica di Pavia e le torridella cattedrale di Aosta.
208. TASSINI 2004. A p. 15 l’autore dedica anche la sua attenzione alla so-miglianza, definita “sbalorditiva” tra Sant’Andrea di Mantova e Iseo, che certomeriterebbe uno specifico approfondimento.
209. PIVA 1999.210. PIVA 1999.211. BIANCHI 2006-2007.212. Sul processo di comitatinanza in Lombardia si rimanda alle pagine di
ANDENNA 1999b, pp. 109-113; per la pianura bresciana: BARONIO 1998.213. I paesi caratterizzati invece nel Medioevo da un abitato sparso o da
piccoli nuclei che hanno dato origine alle attuali frazioni (come è accadutoper Ome, Paratico, Monticelli Brusati – NOVENTA, VALSECCHI, VEzzOLI2009 –, Rodengo Saiano) presentano un panorama edilizio di genere e livelloassai diverso da quello descritto per Iseo: prevalgono le tessiture murarie ‘damuratore’ anziché i muri ‘da scalpellino’ (MANNONI 1997), ed è arduo defini-re con precisione datazioni assolute, poiché prevale una continuità dei tipi edelle tecniche davvero difficile da decifrare. L’analisi dell’edilizia medievale diIseo (U.S.P.A.A.A. sciogliere 1993) e delle frazioni di Ome (GALLINA, BREDA2003), giusto per cogliere i casi maggiormente contrastanti della Franciacor-ta, mette in luce con indubbio rilievo che nella medesima fascia cronologica,cioè tra XII e XIV secolo, coesistono, a brevissima distanza geografica e in uncontesto assai simile sotto il profilo geomorfologico, sistemi di valori architet-tonici e di cultura materiale assai diversi. Il territorio della Franciacorta mo-stra quindi una disarmonicità evolutiva, un’articolazione in settori che po-
tremmo chiamare ‘a diversa velocità’, e queste divergenze sono imposte allacultura materiale dalle dinamiche istituzionali e di potere, non certo da un’in-genua spontaneità.
214. Claudio Ballerio (BALLERIO 1940-1941-1942, pp. 102-103) sostieneinvece l’appartenenza della cella campanaria in mattoni al XV secolo, sullascorta delle caratteristiche della terminazione a cuspide, cioè assimilando allamedesima fase due strutture che noi preferiamo distinguere.
215. Sulla rigatura dei mattoni si vedano GABBRIELLI, PARENTI 1992; PIT-TALUGA, GHISLANzONI 1992; AUTENRIETH, AUTENRIETH 1988.
216. RINALDI 1685, p. 148: «All’incontro di questa [scilicet la tomba Bon-fadini] dalla sinistra parte ne campeggiava un’altra, e di presente pur vi campeg-gia, non dirò in ugual grandezza, et altezza solamente, ma in più eccellenza, epretiosità ancora, come già eretta da più vigoroso braccio, che fù quello dell’im-pareggiabile Giacomo Oldofredi, la cui struttura marmorea, et adorna dell’Inse-gne leonine, benche dall’antichità deteriorata, denota però la sua nobile magni-ficenza, ma molto più il longo Epitaffio, che vi si scorge, non solo in lingua lati-na, ma con lettere Longobarde espresso ancora (…), et è questo: OldofredorumIstic sub Marmore fastum, Latet Insigne Speculum Ingens Iacobus, Cuius in fu-nere sensit Mundus Lethale Iaculum Imperii zelator Igneus; Rector Clarissi-mus Celsarum Urbium. Prudens fuit in armis, strenuus plus quam Pater suorumomnium. Hic Iseum muris circumdedit, Bosinarum Arcem fortissimam cumCrucifixi Castello condidit, inde Turrim eminentissimam. Hunc sub annis1325 18 Novembris Lex Omnipotentis Mortis tulit ausu saevissimo. Ora Lec-tor supremus Principem, ut piè puniat hunc suum Militem».
217. ALEBARDI 2008.218. SANT’AMBROGIO 1903; SINA 1910; BONOMELLI 1972.219. L’epigrafe posta nella parte sinistra della fronte maggiore del sarcofa-
go è la seguente: «Hic iacet dominus / Yson de Federicis / de Gorzono quide/cesit die XXI men/sis augusti millesimo / CCC XXXVI magi/ster Betaci-nus / de Tercio me fecit». Si noti che l’ultima riga, per un probabile e grossola-no errore di valutazione dell’ampiezza del campo scrittorio, è stata incisa al difuori della specchiatura nella quale è stato inserito il resto, ed è anche più lungadella specchiatura stessa. Una seconda epigrafe è sulla faccia aggettante dellamensola d’imposta destra dell’arco (mentre sulla corrispondente sinistra è untondo con la mano di Dio), e reca questo testo: «Magister B/emonus de / Bur-no fenivi/it hoc opus».
Dario Gallina – La pieve di Sant’Andrea di Iseo (Bs) 197
19Gallina 177_Layout 1 18/02/14 12:31 Pagina 197
434 Dario Gallina – La pieve di Sant’Andrea di Iseo (Bs)
1. Resti di edifici romanici nell’area dellapieve (fotografia e disegno per cortesia diAngelo Valsecchi - USPAAA).
2. Pianta ricostruttiva delle mura medieva-li di Iseo, con indicazione dell’area dellapieve (da VALSECCHI 2009).
27appendice_foto (19) 434_Layout 1 19/02/14 09:23 Pagina 434
Dario Gallina – La pieve di Sant’Andrea di Iseo (Bs) 435
3. L’area della pieve di Sant’Andrea (da VALSECCHI 2009).
4. Iseo, San Silvestro. Abside. 5. L’area plebana di Iseo nella ricostruzione effettuata con la consulenzascientifica di A. Breda (da USPAAA 1993).
27appendice_foto (19) 434_Layout 1 19/02/14 09:23 Pagina 435
436 Dario Gallina – La pieve di Sant’Andrea di Iseo (Bs)
6. Iseo, Sant’Andrea. Facciata (fotoraddrizzamento realizzato nel 2003 da DarioGallina in collaborazione con l’USPAAA).
7. Iseo, Sant’Andrea. Disegno ricostruttivo della pieve “antica” secondoClaudio Ballerio (da BALLERIO 1942).
27appendice_foto (19) 434_Layout 1 19/02/14 09:23 Pagina 436
Dario Gallina – La pieve di Sant’Andrea di Iseo (Bs) 437
8. Iseo, Sant’Andrea. Fotoraddrizzamento del fianco nord della chiesa. 9. Sale Marasino, pieve di San Zenone, parete esterna nord della canonica.Particolare della successione stratigrafica di diverse tecniche murarie.
10. Iseo, Sant’Andrea. La porta destra (Us 152)della pieve.
11. Iseo, Sant’Andrea. La porta sinistra (Us 102)della pieve.
12. Iseo, Sant’Andrea. La finestra ellittica (Us122).
27appendice_foto (19) 434_Layout 1 19/02/14 09:23 Pagina 437
438 Dario Gallina – La pieve di Sant’Andrea di Iseo (Bs)
13-14. Iseo, Sant’Andrea. Ricostruzioni grafiche della pieve nella sua fase di XII secolo (elaborazione grafica: D. Gallina).
27appendice_foto (19) 434_Layout 1 19/02/14 09:23 Pagina 438
Dario Gallina – La pieve di Sant’Andrea di Iseo (Bs) 439
15. Iseo, Sant’Andrea. Rico-struzione grafica della pievenella sua fase di XII secolo(elaborazione grafica: D.Gallina).
16. Disegno dell’architetto Rodolfo Vantini, depositato presso l’Archiviodi Stato di Brescia.
17. Disegno dell’architetto Rodolfo Vantini depositato presso l’Archiviodi Stato di Brescia.
27appendice_foto (19) 434_Layout 1 19/02/14 09:23 Pagina 439
440 Dario Gallina – La pieve di Sant’Andrea di Iseo (Bs)
20. Iseo, Sant’Andrea. Particolare delle finiture stilate delle malte all’inter-no di una delle nicchie del campanile.
22. Le scale interne del duomo vecchio di Brescia che conducevano allatorre crollata all’inizio del XVIII secolo.
21. La torre del duomo vecchio di Brescia, testimoniata nell’incisione diPompeo Ghitti, frontespizio al Giardino della pittura di Francesco Paglia(1692-1694, Biblioteca Queriniana di Brescia).
18. L’interno degli ambienti sopraelevati del campanile. 19. Particolare del finto paramento in mattoni realizzato con intonacodipinto.
27appendice_foto (19) 434_Layout 1 19/02/14 09:23 Pagina 440
Edizioni ETSPiazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa
[email protected] - www.edizioniets.comFinito di stampare nel mese di dicembre 2013
28biblio 491_Layout 1 14/03/14 09:42 Pagina 598