(2014) PIEVE DI PAVA
Transcript of (2014) PIEVE DI PAVA
PIEVE DI PAVA
CRISTINA FELICILaboratorio di Archeologia dei Paesaggi e Telerilevamento (LAP&T)Dipartimento di Scienze Storiche e Beni Culturali
Fondazione PAVA onlusPaesaggi Archeologici della Val d’Asso
Il gruppo di ricerca
Direzione scientificaStefano Campana ‐ Università di Siena Topografia antica
TeamCristina Felici ‐ coordinamento e direzione cantiereLorenzo Marasco e Chirs Musson ‐ stratigrafieFrancesco Brogi ‐ stratigrafia muraria e direzione scavo settori I e IIElisa Rubegni ‐ studio reperti vitrei e metallici e direzione scavo settore II e IIIMatteo Sordini ‐ gestione GIS e rilievi tridimensionaliKen Saito ‐ rilievi topograficiEmanuele Vaccaro e Stefano Ricchi ‐ studio dei reperti ceramiciRemì Corbineau ‐ studio pollinicoGino Fornaciari e Valeria Mongelli (Università di Pisa) ‐ studio tafonomico, antropologico e paleo patologico delle sepolture
Gaetano di Pasquale e Mauro Buonincontri(Università Federico II di Napoli) –
studio paleo ambientaleCarmine Lubritto (Seconda Università di Napoli) –
datazioni radiocarboniche e paleonutrizioneErmanno Arslan ‐ studio numismatico
Marina De Marchi (Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia) –
consulenza sui reperti mobili tardo antichi e altomedievaliATS s.r.l. ‐ prospezioni geofisiche, fotografie aeree, da drone
e da aereo, rilievi topografici e tridimensionaliFabio Remondino (Bruno Kessel Foundation) ‐
Documentazione 3DGeostudi Astier s.r.l. ‐ prospezioni georadar e geolettriche
Rocco d’Errico ‐ Documentazione fotografica materiali particolari
Il punto sulla ricerca 2000‐2014
• Indagini territoriali (2000‐2004)
‐ Ricognizioni di superficie, ricognizioni aeree, studio delle fonti
• Diagnostica archeologica e sperimentazione indagini geofisiche integrate:
‐Magnetometria (estensiva oltre 30 ettari di copertura continuativa e intrasite),
geoelettrica, georadar
• Scavo archeologico (2004‐2012)
• Parco archeologico (2014)
Sono state utilizzate le traduzioni di Pasqui (U. PASQUI, Documenti per la storia della città di Arezzo,Firenze, 1899 ‐ 1904) e di Schiaparelli (L. SCHIAPARELLI, Codice diplomatico longobardo, Roma, 1929‐1933)Carte conservate all’Archivio Capitolare di Arezzo
conventio tra Mauro vescovo di Siena e Servandovescovo di Arezzo del 650 circa, il documento piùantico della controversia,
giudicato di Ambrogio maggiordomo di Liutprando,i vescovi sono Luperziano di Arezzo e Adeodato diSiena del 714,
testimoniale del 20 giugno 715 relativo alledeposizioni raccolte da Gunteram,
giudicato, redatto in seguito alla inquisitio il 5 luglio715 a S. Genesio di Vico Ualari.
Dai documenti sappiamo che nel 714 esisteva unbaptisetrium Sancti Petri in Pava, che nel 715 il suoprete si chiamava Audo e che dipendeva da lei lachiesa di S. Marcellino
Pievi, chiese e monasteri citati nell’anno 715CDL, n. 19, SCHIAPARELLI, 1929.
Un territorio ricco di informazioni…
Santa Marta
Strada Francigena
Agraphe di produzione merovingia (VI sec.)
Imperatore incerto o Vandali (V secolo)
Denaro di Ludovico il Pio (822‐840);
Zecca di Pavia
Guarnizione di ispirazione longobarda
(VII sec.)
Fibula a teste di rapacedi età gota (VI sec.)
Contesto geografico e culturale…lungo la Francigena!
Risultati dello scavo per fasi (ordine cronologico)
Villa tardoromana (III – V secolo d.C.)
Chiesa paleocristiana (fine V – VI secolo)
Chiesa altomedievale (VIII‐X secolo)
Chiesa protoromanica (XI‐XII secolo)
Tecniche costruttive‐ Pietre e laterizi medio piccoli, tessitura regolare legate da malta abbondante
‐ Tegole messe di piatto legate da malta
Espansione dell’edificioDi questa fase non ci sono strati conservati in situ.Abbiamo solo livellamenti di ceramica tardo antica di IV – VI secolo che conservano anche tubuli a siringa pertinenti ad un sistema di volte leggere. Questo materiale presumiamo possa appartenere a questa fase.
Tecniche costruttive‐ Soprattutto tegole messe di piatto legate da malta
La villa di IV‐V secolo d.C.
Grande aula (20 x 10 m) dotata di abside monumentalizzata da gradoni, arcate e gradini di accesso. Al centro un pozzetto: possiamo ipotizzare un ninfeo, uno stibadium?
Ipotizziamo un ricco proprietario!I dati provenienti dalle ricognizioni di superficiecondotte in Val d’Asso hanno messo in luce unnumero esiguo di abitazioni sparse (IV‐VI secolo)lungo i versanti della Valle che possono essereinterpretate come parte del latifondo di Pava,gravitanti intorno al centro egemone dove forserisiedeva (stabilmente?) il proprietario. Data laricchezza dei reperti di questa fase possiamoipotizzare un proprietario molto facoltoso.
«trofeo» che ispira suggestive immagini di forza e virilità, forse anche legate alla sfera militare
Fine V sec. d.C.La trasformazione
in chiesa
Villa con aula di rappresentanza
Prima chiesa
Come ci si arriva…
Recinto presbiterialein muratura, colonnato,con cancello
Banco presbiterialein muratura,
staccato dall’abside
Vasca battesimale, interrata, 2m diametro inscritta in un’abside
Endonartece, doppia fila di arcate a tre fornici su pilastri
Abside est, non etradossata
Abside ovest
Ambienti annessi, nord
Ambienti annessi, sud
Entrata
Tecniche costruttive‐ Pietre di medie dimensioni sbozzate, legate da terra, paramento intonacato
‐ Tegole messe di piatto legate da terra, intonacate
Ma perché due absidi? Cosa conteneva e che funzione svolgevaquesto secondo fulcro cultuale?
In Italia non ci sono precisi confronti coevi (San Lorenzo di Aosta anche se si tratta di unapianta cruciforme e un martyrium così come il complesso di Cimitile ma anche qui lasituazione è complessa per la determinazione delle fasi e delle funzioni).
Confronti: i confronti e i riferimenti vanno cercati in ambito mediterraneo, in Nord Africa enella penisola Iberica. Per la cronologia di Pava forse il contesto più appropriato perimmaginarne una derivazione è il nord Africa (in Spagna in genere sono concepite insieme esono di VI secolo). La zona presbiteriale rimanda a confronti con il contesto nord adriatico diAquileia sia per il banco staccato dall’abside sia per il recinto proiettato nella navata e dotatodi cancelli.
Funzione: nel caso di Pava è certamente esclusa la presenza di una tomba privilegiatamentre l’evoluzione della contro abside nelle fasi altomedievali, fornisce una chiave dilettura efficace per immaginare la presenza di reliquie anche nella prima fase religiosa.
Confronti con il Nord‐Africa (DUVAl, 1973)
Confronti con l’area alto adriatica e alpina(SENNHAUSER H. R., 2003; GLASER F., 2003; NOTHDURFTEM H., 2003)
Absidi contrapposte
e banco presbiteriale
Confronti con il Piemonte e la Lombardia (PEJRANI BARICCO, 2003; PANTÒ 2003)Sizzano, Gozzano, Lenta…anche qui si rimanda al mondo aquileiese per i confronti
La complessità degli elementi presenti nella pieve di Pava di fine V secolo, gli arredi interniin muratura, gli elementi liturgici particolari, la proiettano in un mondo dove circolavanoidee e probabilmente maestranze, dove si utilizzavano tecniche costruttive ben calibratesulla base della funzione, dove si conosceva la sapiente tecnica del riutilizzo del materialecostruttivo. Tali considerazioni fanno immaginare una committenza importante, ufficiale,molto probabilmente il centro episcopale.
Complessità e ricchezza di influssi
La forbice cronologica dell’occultamento è molto stretta537‐541.
6 monete d’oro, 20 d’argentoEmissioni di Teodorico, Atalarico, Amalasunta, Teodato, Giustiniano, Vitige
«Crisi» della prima chiesa (VI secolo)
La «ripresa altomedievale»: cantieri e prime sepolture (VII secolo)
641‐667 d.C.
650‐669 d.C.
Inizio VII secolo
d.C.
La ragazza con corredo (641‐667 d.C.)
Appartiene al gruppo elitario che investe nulla ripresa della pieve? Noi crediamo di si!
Primafase altomedievale La pieve di Audo(VII‐ VIII secolo)
Fornace per lateriziUtilizzo (fine VII – inizi
VIII secolo)
TABACCO, 1973, p. 167 riferendosi al gruppo longobardo diSiena presente sul territorio “non solo come membri delpopolo militarmente dominante, ma come ceto dipossessori, ormai ben inquadrato nelle strutture plebane,di cui nessi sono, come filii ecclesiae per eccellenza ilrobusto sostegno sociale”.
Tecniche costruttive‐ Pietre e laterizi medio piccoli, legate da terra,tessitura poco regolare‐ Grosse pietre, legate da terra , tessiturairregolare
Tecniche costruttive‐ Pietre e laterizi medio piccoli, legati da terra,tessitura poco regolare, presenti ossa di animalinel legante‐ Grosse pietre legate da terra , tessitura irregolare
878‐991 d.C.cronologia
Tomba privilegiata, l’unica interna, a cassone foderata e coperta da lastre di travertino. Sul fondo sicollocano le ossa, in deposizione secondaria, di un individuo di 18‐20 anni, morto fra 650 +/‐ 688 (14C). Leossa (Lab. di Paleopatologia – Univ. di Pisa) hanno rivelato una grave malattia genetica (displasiaacromesomelica) che causa problemi allo sviluppo degli arti. Il ragazzo ha comunque avuto una dieta moltoricca di proteine come rivelato dalla paleo nutrizione ma ha bevuto la stessa acqua dei morti del cimiterosuccessivo certamente autoctoni (Dip. di Fisica ‐ Seconda Univ. di Napoli). In assenza di indicatorisull’identità, l’interpretazione va verso un personaggio di spicco per la “società di Pava”, laico o religioso, perla di cui tomba non si può escludere un effetto di promulgazione nell’utilizzo funerario massiccio della pieve.
Cimitero di Pava(X – inizi XIII secolo)
Oltre 900 sepolture integre
Considerando una media di tre sepolture ogni m2
possiamo presupporre la presenza di altre 300 sepolture
nelle aree non scavate
Totale presunto oltre 1000 sepolture in trecento anni di
frequentazione
Cimitero di Pava(X – inizi XIII secolo)
Il campione studiato (scavi 2004 ‐2008), è costituito da oltre 200individui. Il materiale osteologico, pervenuto alla Divisione diPaleopatologia dell’Università di Pisa, è stato sottoposto adoperazioni di pulitura, restauro e siglatura, prima dello studio. É statopossibile determinare il sesso e grosso modo l’età di morte che inmedia è risultata compresa tra i 30 e i 50 anni. Il campione è risultatoin genere robusto, in particolare quello maschile, e caratterizzato dastature elevate: la media femminile è di 160,7 cm, quella maschile di170 cm, ma alcuni maschi raggiungevano anche 180 cm.
Partendo dall’osservazione dello scheletro è possibile tentare diricostruire l’attività svolta in vita dagli individui. In particolare,vengono ricercate le alterazioni morfologiche a livello delle inserzionimuscolari; infatti, più un muscolo è stato coinvolto in movimentiintensi e ripetuti, più questo avrà causato fenomeni di erosione e/oossificazione. Confrontando il campione maschile con quellofemminile, si rileva che le ossa maschili risultano notevolmente piùmodellate dalle sollecitazioni della muscolatura. L’intensa attivitàmuscolare maschile si contrappone a quella femminile a livello di tuttii distretti scheletrici, superiori e inferiori. Queste differenzerispecchiano una netta divisione dei compiti tra gli uomini e le donne.Le donne erano verosimilmente dedite ai lavori domestici che, anchese faticosi, non incidevano sulla massa muscolare quanto le attivitàagricole o l’allevamento.L’elevata frequenza di lesioni traumatiche negli uomini (artrosi gravi,schiacciamento delle vertebre, ernia di Schmorl, elevata frequenza difratture costali) potrebbe indicare un’attività lavorativa rischiosa cheiniziava in giovane età. Ciò rivela la precocità con la quale in questasocietà si iniziavano le pesanti attività lavorative quotidiane.Numerosi, inoltre, i tumori alle ossa e i traumi “da difesa”.
Tecnica costruttiva
‐ Pietre squadrate o sbozzate e rari laterizi, piuttosto regolare. Legante: malta e terra
Il Parco archeologico di Pava(valorizzazione del patrimonio
archeologico) vedrà la luce tra circa un mese (luglio 2014)
Il progetto finanziato con fondi del PSR 2007‐2013 si deve all’impegno della
Fondazione Pava onlus,del Comune di San Giovanni d’Asso,
del LAP&T (Univ. di Siena).











































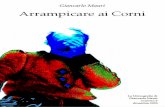


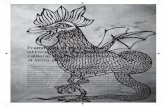








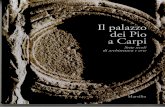
![Popsophia. Teoria e pratica di un nuovo genere filosofico [XVI, 2014 (III)]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6321b63a050768990e0f84f3/popsophia-teoria-e-pratica-di-un-nuovo-genere-filosofico-xvi-2014-iii.jpg)



