Arrampicare ai Corni, di Giancarlo Mauri (2005, ried. 2014)
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Arrampicare ai Corni, di Giancarlo Mauri (2005, ried. 2014)
Arrampicare
ai Corni
un racconto di
Giancarlo Mauri
Questo scritto è stato pubblicato nel volume
L’isola senza nome Storie di uomini e montagne
…dal Moregallo ai Corni di Canzo fino al Cornizzolo… Valmadrera, 2005, pp 438-443
e tra le pagine di
VERTICE Annuario della Sezione C.A.I. Valmadrera
Anno 2005, n. 20 - Febbraio 2006, pp 51-56
scritto il 22 marzo 2005 nuova riedizione: 19 aprile 2014
Le azioni che noi abbiamo compiuto in passato ci seguono come un’ombra,
per il bene o per il male secondo la loro natura. “Fo-sho-hing-tsan-king”
Se il tuffatore pensasse sempre allo squalo,
non metterebbe mai le mani sulla perla. al-Din Sa’di Muslih
Da un po’ di tempo le Grigne ci stavano strette. Arrampicare accompagnati dai coretti dei gitanti della domenica - tipo: “guarda quelli là in parete”, oppure “in màtt quèj lì” - non rientrava nel nostro Dna. Confesso: sia io che il Beppe soffrivamo di quella forma di timidezza (“due orsi” si diceva) che ci portava alla ricerca di luoghi nascosti dove dar sfogo alla nostra voglia di arrampicare. Fossimo nati vent’anni dopo, non avremmo di certo sfondato nel rutilante mondo dei free-climbers. E fu nella ricerca di altri campi di gioco che un bel giorno capitammo ai Corni di Canzo. Era il 24 marzo 1968, domenica. Il cielo era blu, la neve abbondante. Due sera prima, al Cai avevamo consultato la guida del Saglio per cercare qualche via da fare e la scelta era caduta, genericamente, sulla Parete Fasana. Ne seguiamo la gengiva in salita. Sopra di noi un chiodo si staglia contro il cielo: la nostra prima via sui Corni ci ha scelto. Inizio a salire su placche, con qualche strapiombino di tanto in tanto. Il cielo è chiuso da un piano inclinato “roverso” che promette giochi d’equilibrio nel vuoto. Non sappiamo niente di questa via: né chi l’ha aperta, né quale difficoltà presenti, ma in tasca abbiamo le certezze dei vent’anni, quindi niente ci può preoccupare. Trovo lo strapiombo terminale chiodato in espansione. Dopo quattro o cinque, uno di questi chiodi decide di uscire dal suo buco e per la prima volta in vita mia esperimento la goduria del volo. La buona sicurezza del Beppe mi blocca; le mie mani, che automaticamente si sono strette alle corde per frenare la discesa, sanguinano. Buttiamo giù le doppie. Non male come esordio. I Corni ci hanno sfidato. Ritorneremo.1 Il 21 del mese dopo siamo di nuovo a Canzo. Stavolta abbiamo ben chiaro in mente cosa fare: la Dell’Oro-Maggi al Corno Centrale, versante sud-est. Da quel che si legge sulla guida di Saglio dovrebbe essere una via tosta, un “sesto grado” dice l’autore. Il primo tiro, con il suo attacco in spaccata, è decisamente non usuale per dei grignaioli: là si trovano appigli e fessure, qui tutto ha forme tondeggianti (appigli a mammelloni scrive da qualche parte il Saglio; che sia stato questo ad attirarci?). Altri due tiri e la via è archiviata.2 Stupidamente considerate di “rango minore” rispetto alle Grigne, in quegli anni i Corni offrivano un ambiente silenzioso. Nessun picnic ai piedi delle pareti,
1 Schizzo della parete alla mano (cfr: L’isola senza nome, pp 408 - 409), oggi posso affermare che fino allo strapiombo terminale abbiamo seguito la Via Elvezio - aperta nel maggio 1965 da Pierlorenzo Acquistapace, Piero Ravà e Angelo Canali; difficoltà d’insieme: TD sostenuto, difficoltà max V, A2 - e di essere volato sui chiodi della Via Direttissima Città di Cantù.
2 Nota anche come Via dei Tre Tetti, è opera di Darvino Dell’Oro e Dante Maggi (11 agosto 1947). Oggi è data per TD superiore, con difficoltà max di VI, A2.
nessun cicaleccio sovrapposto al gracchiare delle radioline sintonizzate su “tutto il calcio minuto per minuto”. Troppo bello! Tutto questo per dire che il 20 luglio siamo di nuovo qui. Tre mesi prima, cercando l’attacco della Dell’Oro-Maggi avevamo “scoperto” uno spigolo evidentemente già salito. Sulla guida del Saglio (stampata nel 1948) non ne esisteva traccia, quindi ancora una volta seguiamo l’istinto. Sarà la prima di una serie di salite (anche in solitaria, per me) del divertente Spigolo Tessari-Riva al Pilastro.1 Ma il vero motivo di questa gita è un altro: vogliamo conoscere il Corno che precipita sotto i nostri piedi, l’Orientale. Visto dalla SEV mostra soltanto la sua parte terminale, con un grosso strapiombo a botte, chiuso all’orizzonte dal profilo di un “naso”. Dalla Bocchetta di Luera scendiamo alla sua base e ne cominciamo l’esplorazione. Una larga fessura che sale verso sinistra attira la nostra attenzione: domani la saliremo. Per la notte, il sacco a pelo steso sull’erba e le stelle come soffitto. L’inizio della via2 non è male: la fessura è formata dalla parete strapiombante e da una scheggia arrotondata che butta in fuori. Dopo una trentina di metri, in parte fatti col piede destro nella fessura e l’altro nel vuoto, arrivo a un terrazzino dove trovo un chiodo. Sopra vi è uno strapiombino e più in alto il chiodo di sosta. Il Beppe mi raggiunge e mi preparo a ripartire. Nelle manovre tipiche del momento (passaggio dei moschettoni ricuperati, corde da sbrogliare) la mia Pentax Spotmatic trova il tempo per volare (e dai che l’è un vizio su ’sti Corni …). Atterra una quarantina di metri sotto, esplodendo. Giù la doppia. Ricupero l’obiettivo intatto e il rotolino delle diapositive. Torno a casa mesto, il portafogli alleggerito (allora il corpo macchina costava 80 mila lire in Svizzera, 105 mila a Milano; e per me 80 mila lire erano un mese di lavoro). La sera del 27 dicembre 1968 la passiamo al Rifugio Medale in compagnia del buon Zaccheo. Fuori fa un freddo boia. Un ultimo bicchiere e poi si va a dormire nella tendina che abbiamo piantato a poca distanza dall’attacco della Cassin. Anche il giorno dopo il freddo è carogna - e il Beppe pagherà caro l’essersi dimenticato di mettere l’antigelo nel radiatore della sua Seicento! In parete, non molto lontano da noi c’è baraonda: Tiziano Nardella e soci stanno finendo la Taveggia. Ma in quanti sono? Da quanto urlano, si direbbero una
1 Nota tecnica: Pilastro Maggiore o Gian Maria, spigolo SE, prima ascensione Giorgio
Tessari, Alfonso Riva, 1965; difficoltà max A1, IV. 2 È la Don Arturo Pozzi - salita nel luglio 1964 da Giorgio Tessari e Antonio Rusconi;
difficoltà d’insieme TD superiore, difficoltà max V, A1, A2.
metà di mille. Anche noi oggi siamo qui per assaggiare una via nuova. Attacco per la Cassin. Alla sua prima sosta prendo a destra e salgo tre tiri gnecchi fin sotto gli strapiombi. Tutto in libera: giusto un paio di chiodi di sicurezza e quelli per le doppie. Per oggi ci basta, la via ci pare possibile. Ritorneremo in primavera, quando il caldo avrà sciolto i ghiaccioli che penzolano sopra le nostre teste. Il 2 marzo del 1969 ritorniamo sulla Cassin alla Medale per fotografare di profilo la “nostra” futura via. Il Beppe assicura la new-entry, Diego Pellacini, io salgo in libera fino al primo diedro. Qui mi unisco alla loro corda e portiamo a termine l’ascensione. La Cassin non sbuca in vetta, ma esce sulla destra seguendo una cengetta, prima della quale ci si slega. Parto io, mi segue Diego, chiude il Beppe. Subito sento un rumore sordo, una botta attutita. Mi giro: siamo in due, il Beppe non c’é. Scendiamo a rompicollo. Dico a Diego di andare da Zaccheo per dare l’allarme mentre io perlustro il ghiaione al piede della Medale. Lo trovo quasi subito. Giuseppe Verderio, classe 1944, da allora riposa nel cimitero di Vimercate.
L’ultima immagine di Giuseppe Verderio
Corna di Medale, via Cassin-Boga, 2 marzo 1969 (foto G. Mauri)
Voglio, devo, fare qualcosa per ricordarlo. Fin da subito ho chiaro dove: quello strapiombo che tante volte avevamo osservato dalla SEV porterà il suo nome. Prima, però, devo rodare Diego alla roccia dei Corni, che lui ancora non conosce. Iniziamo il 13 aprile con la Dell’Oro-Maggi al Corno Centrale. Il 25 aprile portiamo a termine la Direttissima Città di Cantù (terza ascensione; la seconda l’hanno fatta gli stessi primi salitori - Giorgio Brianzi & co. - allo scopo di recuperare il materiale rimasto in parete), uscendo in vetta per lo strapiombo chiodato in espansione dal Giorgio.1 Tra il primo e il secondo tiro, già che ci sono, raddrizzo un po’ la via con una variante mica male. Già col Beppe avevo scoperto che sul versante rivolto verso Valmadrera del Corno Orientale vi è un monotiro che sale in diagonale verso destra, tutto chiodi e strapiombini. La ripercorriamo ancora un paio di volte, poi lo schiodo, lasciando soltanto quello utilizzato per la doppia. Diego pensava che portassi via anche quello! Lo scopo è quello di procurarmi i chiodi che mi serviranno per il mio progetto: una via dedicata alla memoria di Giuseppe Verderio. Qui, sui Corni di Canzo.
* * * Due novembre 1969. Dalla Bocchetta di Luera scendiamo alla base della parete Nord. Girato l’angolo si erge un pilastro. Attacco. I primi tiri di corda non sono proprio il massimo, per via di tutta quell’erba che c’è in parete. Alla fine del terzo tiro supero un bel passaggio su roccia ed eccomi alla sosta. Sorpresa! Nella fessura che qui ha inizio vi sono alcuni chiodi. Sono vecchi, è vero, ma ci sono! Non mi resta che salire e capire dove portano. Dopo una decina di metri ne vedo uno alla mia sinistra, in direzione del “naso”. Ho incrociato, per pochi metri, la Stella Alpina, una via aperta da Giuseppe Crippa e Giuseppe Arosio.2 Guardo verso l’alto: due strisce nere d’acqua scendono parallele. Salirò in mezzo a loro, sul grigio. Il passaggio che segue, fatto completamente in libera e con gli scarponi rigidi - così si usava allora - è rimasto tra i miei ricordi alpinistici. Un pilastrino dove mettere un chiodo di sicurezza e una cengetta inclinata verso il basso è quanto offre il quarto posto di sosta. Preparo il tiro
1 Nota tecnica: Corno Centrale, Parete Fasana, Via Direttissima Città di Cantù; prima
ascensione: Giorgio Brianzi, Angelo Molteni e altri, luglio 1967; difficoltà d’insieme TD, difficoltà max V, A2.
2 Nota tecnica: Corno Orientale, parete Nord, Via Stella Alpina (1963); difficoltà d’insieme TD inferiore, difficoltà max V+, A1.
successivo salendo un po’ di metri su chiodi a espansione (la roccia è compatta, senza buchi né fessure), poi decido di buttare giù le doppie. Passeremo la notte in tenda alla Bocchetta di Luera.
* * * Tre novembre 1969. Io e Diego raggiungiamo l’ultima sosta di ieri. Il nostro cielo ha il colore dello strapiombo, tondo, compatto (ma di quanti metri esce?). Di salirlo in arrampicata non se ne parla nemmeno. O si lascia perdere e si torna a casa, oppure lo si chioda a espansione. E così faccio, dandoci dentro con martello e punteruolo - il trapano a batterie era ancora da inventare. Dopo una quindicina di metri un chiodo esce dal suo buco. Io ci sono appeso, i piedi nel vuoto. Volo. Non provo né panico né angoscia. Vedo soltanto il ghiaione, circa 200 metri più sotto, venirmi incontro velocemente. Un attimo prima dello strappo delle corde (un chiodo ha tenuto!) rivedo la mia vita scorrere in una frazione di secondo. Pendolo nel vuoto. Le corde s’intrecciano. Tolgo di tasca due cordini, faccio due Prusik e risalgo sulle corde fino alla sosta. Il mio volo è stato di (circa) venticinque metri; giorni dopo, una volta rientrato a casa, scoprirò di avere due costole incrinate. A una trentina di metri dalla sosta comincio a spostarmi verso destra, dove intuisco una possibilità d’uscita. Nella parte terminale, dove l’esposizione nel vuoto è massima, provo l’ebbrezza di vedere che alcuni chiodi - su cui ho appena sostato, appeso al tondeggiante soffitto come un salame - fuoriescono dalla roccia per scivolare lungo la corda. Una cosa mi è chiara: indietro non si torna. Devo assolutamente uscire da questo vuoto. Una crepa nella roccia - la prima in quaranta metri - mi permette di piantare un chiodo, ma dal suono capisco che è solido quanto un panetto di burro sotto il sole. Alla fine mi ritrovo coi piedi sull’orlo dello strapiombo, dove un appoggio grande quanto la punta degli scarponi mi sembra una gran cengia. Metto un chiodo, mi ci assicuro e … adesso che faccio? Ricapitolo: sotto, lo strapiombo si è parzialmente schiodato; dove sono io, la sicurezza è al suo minimo storico (il chiodo che ho piantato, di quelli corti tra l’altro, lo devo considerare mezzo dentro oppure mezzo fuori?). Penso: se mentre mi raggiunge al Diego esce un chiodo è sicuro al cento per cento che mi strapperebbe da questa infida posizione. E il rischio che tutto questo possa accadere è molto probabile. Devo decidere in fretta e lo faccio: pian piano, misurando i gesti, mi slego dalle due corde ombelicali che mi uniscono al compagno, quaranta metri più in basso. Le vedo scivolare veloci attraverso i moschettoni. Adesso sono qui, sull’orlo dello strapiombo, solo e
slegato. Una decisione suicida questa? No. Mi son detto: se mi slego, con le due corde Diego può scendere in doppia fino ai piedi della parete, poi risalire per sentiero alla Bocchetta di Luera e da lì cercare, col mio aiuto, la direttrice da cui calare le corde e farmi sicurezza mentre esco dalla via. E così è stato. Sotto un cielo più rosso che blu abbandono questa parete-frigorifero. Ma non può finire così. Sei giorni dopo, io e Diego siamo di nuovo ai Corni, avvolti dalla nebbia. Dopo aver cercato invano un posto dove attaccare le corde per la doppia, d’accordo con lui decido che io solo mi calerò dall’alto, assicurato a spalla, fino alla sosta sul bordo dello strapiombo. Da qui risalirò gli ultimi 35 metri in arrampicata solitaria. Le difficoltà trovate non vanno oltre il quinto grado. Un traversino a sinistra e rivedo l’amico.1 Ha preso a nevischiare. Foto ricordo. Siamo soli. La via dedicata alla memoria di Giuseppe Verderio adesso è davvero finita.
1 Nota tecnica: Corno Orientale, parete Nord; difficoltà d’insieme TD superiore, difficoltà
max V+, A2, A3, A4.
Corno Orientale di Canzo, parete Nord-est
Via Giuseppe Verderio, 2 novembre 1969 (foto A. Rebuzzini)
Corno Orientale di Canzo, parete Nord-est Via Giuseppe Verderio, 2 novembre 1969 (foto D. Pellacini)
Corno Orientale di Canzo, parete Nord-est
Via Giuseppe Verderio, 2 novembre 1969 (foto D. Pellacini)
Corno Orientale di Canzo, parete Nord-est
Via Giuseppe Verderio, 2 novembre 1969 (foto D. Pellacini)
Corno Orientale di Canzo, parete Nord-est Via Giuseppe Verderio, 2 novembre 1969 (foto D. Pellacini)
Corno Orientale di Canzo, parete Nord-est
Via Giuseppe Verderio, 3 novembre 1969 (foto D. Pellacini)
Corno Orientale di Canzo, parete Nord-est
Via Giuseppe Verderio, 3 novembre 1969 (foto D. Pellacini)
Corno Orientale di Canzo, parete Nord-est
Via Giuseppe Verderio, 3 novembre 1969 (foto D. Pellacini)
Corno Orientale di Canzo, parete Nord-est
Via Giuseppe Verderio, 9 novembre 1969 (foto D. Pellacini)
Corno Centrale di Canzo. In rosso: Via direttissima Città di Cantù
e variante Mauri (grafica: Giancarlo Mauri)










































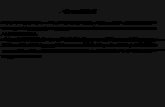




![Introduction: Remembering Aldo Moro [co-authored with Giancarlo Lombardi]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6315661f511772fe451054ce/introduction-remembering-aldo-moro-co-authored-with-giancarlo-lombardi.jpg)











