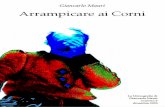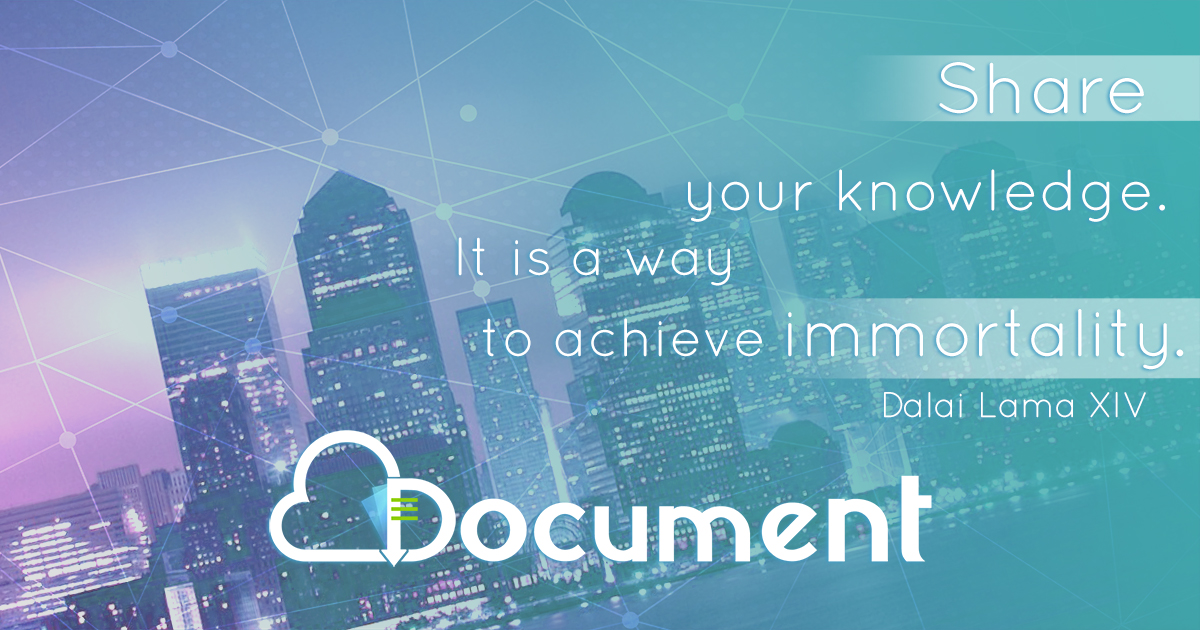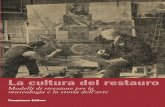Pitture rupestri dell'India Centrale, di Giancarlo Mauri
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of Pitture rupestri dell'India Centrale, di Giancarlo Mauri
© 2013 MONOGRAFIE DI GCM
In copertina: Trikona.
ALTRE PUBBLICAZIONI DELL’AUTORE
1976 : Escursioni nelle Grigne Tamari Editori in Bologna 1980 : Escursioni nelle Grigne. II ediz. Ampliata Tamari Editori in Bologna 1983 : Il Sistema Operativo Unix Dataconsyst, Segrate 1985 : Il Sistema Operativo Unix e la Sicurezza Bancaria - Dataconsyst, Segrate 1988 : Le Grigne. I sentieri e l’Alta Via Tamari Editori, Padova
MONOGRAFIE DI GCM
2003 : La vita è un pellegrinaggio 2004 : I cammini di Santiago 2004 : Scritti di montagna 2004 : Val Codera 2004 : Yoginī (riedizioni : 2007, 2008, 2013) 2005 : Kinner Kailasa parikrama 2005 : Arrampicare ai Corni 2006 : India_2006 (riedizione : 2013) 2007 : India viva (tre ristampe) 2007 : La guerra Italo-Austriaca 1915-1918 2008 : Monte Priaforà e Monte Novegno 2012 : La Valsássina di Leonardo 2012 : S’io fossi stato fermo alla spelunca. Niccolò Stenone 2013 : Jicà 2013 : Scritti sull’India 2013 : India_2000
PITTURE RUPESTRI DELL’INDIA CENTRALE
LA SCOPERTA. La prima menzione della presenza di pitture rupestri sul territorio indiano risale alla fine del XIX secolo, poco dopo la scoperta della grotta di Altamira in Spagna. Dalle pagine del Journal of the Asiatic Society of Bengal, J. Cockburn segnalava come il 5 luglio 1881, durante una partita di caccia, avesse trovato i resti fossili di un Rhinocerus indicus, mentre il 17 marzo 1883, all’interno della grotta Ghormangur, nel distretto di Mirzapur, aveva potuto osservare un dipinto rupestre che a lui sembrava rappresentare la caccia a un simile animale. Inoltre, l’autore aggiungeva di aver potuto vedere altre pitture in ematite rossa nel villaggio di Pergunnah Burhur e nella grotta Harni Narna, vicino a Bidjeygurh. Oggi sappiamo che all’epoca di questi fatti Archibald Carlleyle si era già fatto una vasta conoscenza sulle pitture rupestri di questa regione, ma Carlleyle era morto senza aver divulgato il suo sapere, come lo stesso Cockburn ricordava in una relazione redatta nel 1899. Nel 1901, su Indian Antiquary F. Fawcett pubblicava un rapporto molto ben illustrato sulla Edakal-Cave Wynaad (India sud-occidentale); a suo dire, questo angusto passaggio attraverso la roccia era carico di incisioni, con simboli e immagini stilizzate di uomini. Nel 1907 C. A. Silberrad pubblicava a Calcutta un articolo sui disegni rupestri trovati nell’area di Banda (Mirzapur). Nei quattro anni del suo soggiorno in questo distretto, l’autore ebbe modo di visitare nei pressi della stazione ferroviaria di Manikpur, intorno a Malva e nell’area del fiume Ari molti siti con dipinti rupestri di colore rosso. Aggiunse di aver sentito parlare di altri dipinti nelle vicinanze, ma di non averli potuto esaminare. Lungo la linea ferroviaria Calcutta-Nagpur, poco lontano dalla stazione di Bhupdeopur, sopra le grotte di Singanpur, C. W. Anderson trovò nel 1910 una serie di dipinti rupestri rossi, che presentò al pubblico nel 1918. Il primo vero rapporto sui dipinti rupestri indiani venne fatto da Panchanan Mitra, colui che nel 1927 aveva trovato nei pressi di Ghatsila altre incisioni, che a lui parevano rappresentaro i cinque principi Pandava del Mahabharata. Nel 1932, sul numero 24 del Memoirs of the Archaelogical Survey of India (sotto il titolo “Rock-paintings and other antiquities of the prehistoric and later times”) apparve una rilettura approfondita delle immagini di Mirzapur, Hoshangabad e
Singhanpur, operata da Rai Sahib Manoranjan Ghosh, il curatore del Patna Museum. Ancora in tempi recenti, chi visitava Singhanpur poteva vedere i resti dell’impalcatura di bambù alta sopra il vertiginoso abisso, utilizzata da questo scienziato per fare le sue minuziose riproduzioni in compagnia di Sir Asutosh Mookerjee. Nel 1936 apparve sul periodico IPEK un lavoro di D. H. Gordon sulle pitture rupestri nelle Mahadeo Hills, le colline dedicate al grande dio Shiva; nel 1939 Gordon cominciava la sua cronologia sulle pitture rupestri in questa regione, pubblicata nel 1958 col titolo The prehistoric Background of the Indian culture. Col riassunto di H. Kuhn dei dipinti rupestri fino ad allora ritrovati in India, pubblicato su IPEK nel 1935, la conoscenza di queste opere artistiche irruppe in Europa. Saggi di P. Brown, G. P. Hunter, A. P. Khatri e Alan Houghton Brodrick confluirono in Prehistoric Painting, del 1948. Dal 1962 in poi uscì una serie di 16 pubblicazioni sulle pitture rupestri indiane ad opera di V. S. Wakankar; tra queste, di particolare importanza sono “Painted rock shelters of India” (Firenze 1962); “Peintures rupestres indiennes” (in Objets et Mondes, Parigi 1963); “Painted rock shelters of India” (IPEK 1964-65); “Bhim-Betka Excavations” (Journal of Indian History 1976). Wakankar aveva preso a girovagare per l’India centrale alla ricerca di rocce d’arenaria dalle caratteristiche sporgenze arrotondate, trovandone circa 400 nell’area del Madhya Pradesh. Nel 1954 scoprì l’importantissimo sito di Raisen e nel 1957 Bhimbetka, forse la più grande galleria di dipinti rupestri del mondo. Qui, nella sola sporgenza detta la “roccia zoo” o il giardino degli animali, sono presenti oltre 600 immagini, un numero talmente cospicuo da meritare un’intera monografia. Jagdish Gupta scriverà nel 1965 un grosso libro sui dipinti rupestri dell’India centrale, in devanagari, mentre nel 1972 A. Sundara troverà in prossimità dei megaliti di Mysore delle pitture rupestri che, sebbene con qualche dubbio, a suo avviso raffiguravano uomini-toro. LA GEOGRAFIA. Con l’eccezione della grotta Mahadeo I di Pachmarhi, dove pochissima luce penetra fino ai dipinti (in questo caso si può parlare di pittura in grotta), e per un gruppo dell’Auditorium Rock di Bhimbetka, tutte le altre figure si trovano sotto strapiombi oppure all’interno di semi-grotte, chiamate shelters in inglese o più correttamente abris in francese. Solo in pochi casi si hanno pitture sul soffitto, come a Sita Khardi, Bhimbetka II B-24, Bhimbetka III C-54 e nella galleria superiore di Raisen. Cercandoli sulla carta geografica, apparirà subito chiaro come buona parte di questi luoghi si trovi nelle vicinanze di un corso d’acqua e questo non sempre ha portato loro fortuna. Se a Modi una diga ha sommerso gran parte delle immagini, più fortunate sono state le pitture di Gwalior e Ghormangur, anche loro nelle
vicinanze di due dighe moderne ma in posizione più alta rispetto alle acque. Sita Khardi, a poca distanza da Bhanpura, si trova in un letto fluviale a carattere torrentizio; non molto lontano vi è un secondo sito con resti di pitture sui lati di una cascata perenne. Tikla si trova tra due fiumi; le pitture di Bhopal sono in prevalenza rivolte verso il lago; Bhimbetka II e III confinano con la sorgente Bana Ganga, che si vuole creata da una freccia tirata da Arjuna e dunque fatta oggetto di un pellegrinaggio popolare. Adamgad è vicino al fiume Narmada, un ruscello che scorre vicino alla Pachmarhi’s Bazar Cave, mentre i siti di Nimbu Bhoj, Madha Deo I, II e III posseggono un loro profondo serbatoio. Ancora: Imlikho è in prossimità di una sorgente. Ai piedi di Kabra Pahar e Singanpur si specchiano stagni e fiumicelli. Likhunia e Ahraura si trovano sulla sponda rocciosa del Garai. Verrebbe da pensare che la vicinanza dell’acqua fosse un presupposto necessario. In effettti, tutti i colori utilizzati erano a base di terra macinata e mescolata con acqua, senza l’aggiunta di grassi animali. Per questa ragione molte delle pitture furono dilavate poco dopo la loro applicazione, mentre quelle protette dalle intemperie - le uniche che si sono preservate, perché sotto un riparo - col tempo sono state talmente incrostate dal calcare che oggi per vederle si devono spruzzare con l’acqua - e senza che per questo ne soffrano danno. I COLORI. I colori minerali provengono tutti dagli stessi luoghi della pittura. Ad Adamgad, per esempio, le miniere dei colori si trovano proprio davanti alle pareti dipinte. Le terre vennero macinate e probabilmente rimestate su coppe di foglie, poi applicate alla roccia utilizzando le estremità masticate dei ramoscelli di palma, più raramente con le dita. Studi recenti ci dicono che il bianco è composto da calcare sedimentato, mescolato con il latte emesso da un albero locale. Nei dipinti, l’ossido di ferro rosso si trova in tutte le sue variazioni e gradazioni, dal marrone all’arancio. L’ematite, il pigmento più utilizzato, nei disegni più antichi arriva fino al rosso-blu, in applicazioni più recenti dal rosso corallo all’arancio. Una novità per l’India è il verde petrolio pallido, chiamato hara geru in hindi, che a Bhimbetka e a Modi appartiene allo strato paleolitico inferiore. I PITTORI. Un Bhil di nome Malya raccontò a Wakankar che sulla riva del fiume Chambal, nel luogo dove i suoi antenati in tempi immemorabili avrebbero fondato la località Malasery, vi erano diciassette rocce decorate. Come ci si può aspettare, fin da subito i brahmana negarono che gli autori di questi dipinti potessero essere stati degli umani, affermando - in difesa dei loro interessi privati - che i dipinti erano certamente opera di Rama e Sita, due esseri soprannaturali. Tra i critici “laici”, Stephen Fuchs sentenziò che a suo avviso non vi era alcun nesso tra la pittura rupestre e i discendenti delle tribù che oggi vivono in quei
luoghi, mentre l’indiano Mitra ebbe a scrivere: “Le immagine fanno luce sulla prima invasione arya dell’India”. Per quanto diverse possano essere le opinioni sugli autori delle immagini, almeno su di un punto vi è stata unanimità: è certo che la mitologia indiana odierna è altrettanto viva quanto al principio della sua propagazione. In barba alle opinioni di Fuchs, non è possibile ignorare che i dipinti di Bhimbetka si trovino nel territorio popolato dai Gond, mentre intorno a Pahmarhi vivano sia i Gond che i popoli Korku - questi ultimi considerati tra le più antiche popolazioni Munda. Chi studia con attenzione i dipinti sulle capanne dei Gond oppure le tavole mortuarie dei Korku non ha difficoltà a riconoscervi lo stesso simbolismo e la stessa tipologia delle rappresentazioni rupestri, tradizione che si ritrova persino nei disegni sulle case o per terra che usano fare le donne hindu. Impronte di mani e piedi, insieme a bande a zigzag, si trovano accanto al motivo dell’albero della vita. Vi sono anche swastiche, cerchi concentrici e vortici, stelle o fiori di loto, tridenti, triangoli, pavoni stilizzati, uomini e animali nello stile della clessidra, e talvolta figure che assomigliano a una pelle con la testa stesa per l’asciugatura; quasi tutti gli studiosi ritengono che si debba trattare di una tartaruga (kurma), qui intesa come la seconda “discesa” (avatara) sulla terra di Visnu. Se ciò fosse vero, la datazione di questi dipinti fornirebbe un’età al mito vaisnava. Restando in tema di datazioni, sappiamo che agricoltura, ceramica, ferro, denaro, scrittura, architettura e affilatura della pietra sono arrivati in India dall’antica Persia, dunque non possiamo ignorare i miti, i simboli e le rappresentazioni degli dèi connessi, tenendo presente che anche gli dèi pre-arya erano di origine mesopotamica e (ultimamente) iraniana. Detto questo, resta da chiarire con quale onda l’influenza dell’antico Iran avesse raggiunto i centri dei dipinti rupestri indiani, e in quale misura eventuali usi sacrificali dell’antico Iran possano coincidere con quelli dei primordiali abitanti pre-dravidici. PARTICOLARITÀ E STRUTTURA. I microliti caratteristici delle alture dell’India centrale, sparsi in grandi quantità nei pressi dei siti dipinti, consistono di silex, opale e altre pietre semipreziose. Spesso si trovano pezzi di eliotropo macchiato di rosso e verde e di un’agata grigio-blu. Ed è stata la contemplazione dei rombi concentrici di un’agata spaccata ad aver fornito a Wakankar l’idea che potessero essere stati loro i modelli di certe strutture di dipinti rupestri: se i pittori di quei tempi riconobbero nell’interno delle pietre l’ordine e la struttura delle leggi terrestre, è possibile - a suo avviso - che avessero trasferito quel principio all’interno delle figure, come espressione del compito cosmico degli avatara scesi sulla terra e diventati terrestri. Se questa riflessione di Wakankar fosse veritiera, si potrebbero capire una moltitudine di figure strutturate, quali la serie
caratteristica delle Hospital Hills e di Bhopal. Vecchi dipinti come il toro di Tikla, il bovino sotto l’elefante bianco a Bhimbetka e la forma simile ad uno stendardo che vi sta sopra contengono uno spiccato disegno di favo-chiocciola di grande perfezione, anche se spesso irregolare. In molti casi un tridente spunta dall’estremità della coda, e questo lascia pensare a una similitudine col culto di Mithra. A Bhinyapura, una spiga di grano cresce dalla coda del bovino (vacca, toro, bue?); a Tikla il “cacciatore” mira ad un triangolo nel ventre dell’animale. Nei Veda troviamo sovente dei cenni che sembrano avere la loro corrispondenza nelle pitture rupestri dell’India. Per via di questa enorme importanza, mi sia concesso di riportare il mito di Prithvi (lett.: Terra), la madre di Indra: l’ordine terrestre era mantenuto da Vena, un re necessariamente (per la storia) dispotico. Contrariati dalla sua pedanteria, i sacerdoti l’uccisero con l’erba sacra. Non essendoci più Vena, la Madre Terra fu preda dell’anarchia e smise di produrre nutrimento per gli esseri umani. Ben presto i “saggi” (rishi) rimpiansero la loro azione e per rimediare all’errore compiuto, sfregando dei bastoncini come se dovessero accendere il fuoco del sacrificio, da una coscia del re defunto fecero scaturire un demone nero e nano, dal suo braccio destro il saggio Prithu. Siccome le carestie non cessavano e la Terra continuava a non produrre frutta, pieno d’ira Prithu prese il suo arco e conficcò una freccia nel suolo. “Punta” sul vivo, la Madre Terra assunse la forma di una vacca e tentò di scappare, ma l’agile Prithu riuscì a fermarla. Domata, la Terra promise che avrebbe ripreso a produrre frutti. Ma per far questo (essendo i cereali e la frutta il suo latte materno) le era necessario partorire un vitello. Prithu rimediò: creò il vitello Manu Vaivaswata, poi munse la vacca e donò il “latte” agli umani, che lo consumarono sotto forma di grano e verdura. Solo allora la Terra-vacca prese il nome di Prithvi, perché Prithu, rigenerandola, ne era divenuto il padre. Da questo mito possiamo ricavare una chiave di lettura di alcuni dipinti rupestri: l’arciere che tira sul bovino va interpretato come un simbolo di fertilità e non di caccia cruenta. Altri corpi animali sono riempiti con dei disegni a punti: a Raisen si possono vedere nella parte superiore della galleria, a Bhimbetka sulla roccia zoo. Va ricordato che il gusto per i disegni punteggiati è tuttora vivo tra i contadini indiani: nei pressi di Ujjain ho potuto vedere centinaia di galline e pecore decorate con punti rossi. All’opposto, i disegni interni di altre specie animali - quali i rinoceronti, i tori, le antilopi e le scimmie di Raisen - sono formati da triangoli riempiti di linee diagonali. Da queste differenze si potrebbe dedurre che queste riempiture dei corpi hanno un preciso senso simbolico, che nulla ha a che vedere con il mantello dell’animale ritratto. GLI DÈI IN FORMA ANIMALESCA. Nella galleria superiore di Raisen vi è la rossa pittura di un umano che lancia una pietra ad anello (una macina?) e di un arciere.
Più in basso vi è un toro, sopra il quale è sospesa una figura che porta l’ombrello onorifico e una processione di scimmie (e tutte queste figure sono riempite da segni a forma di “V” sovrapposte). Premesso che l’ombrello onorifico - un attributo tipico di dèi, imperatori, re, alti dignitari e sacerdoti - lo si ritrova spesso sulle tavole mortuarie dei Gond e dei Korku, il fatto che a Raisen appaia sopra un toro dimostra che qui non si tratta di un semplice animale - anche se caricato di potenti simbolismi inerenti la fertilità - ma di un vero e proprio dio-toro; e nei dipinti rupestri, gli dèi-toro - che nell’India preistorica godevano delle massima venerazione - appaiono in stretta relazione con l’uccisione cultuale. Le immagini a suo tempo interpretate come scene di caccia - il rinoceronte di Mirzapur, il salto sopra il toro di Singhanpur e l’uccisione di Dhrampur - ci spiegherebbero invece il passaggio dal semplice salto “minoico” (siccome uccidere il toro è impossibile durante il salto, si dovrà dare a questo gesto un significato allegorico) fino al tocco col bastone (prototipo della “manade” tuttora in voga nella Settimania francese?) e l’uccisione dell’animale. Dove questo è chiaramente rappresentato, l’esecutore è un essere circondato da raggi di sole che uccide il toro con un giavellotto oppure con arco e freccia; accanto alla vittima è presente una scodella, forse per l’ultimo pasto o per raccoglierne il sangue. A Bhimbetka il toro porta sul corpo un disegno simile a quello di Apis di Memfi e al toro del sacrificio di Creta. A Dharampuri la vittima è rappresentata come un umano con testa di toro, a Modi le teste dei tori sacrificati sono disposte in cerchio. Ad Hanumana e Singhanpur l’essere misto-toro assomiglia ad un orante e la forma è ridotta ad un glifo di testa di toro (come l’immagine di Durga-Mahisasuramardini visibile a Gangaikondacholapuram). Altrettanto sorprendente è la rappresentazione di animali senza testa, che forse esprimono l’avvenuta esecuzione cultuale. Altro notevole parallelismo tra le pitture rupestri e i miti dell’India vedica è visibile su di un alto torrione di Bhimbetka (III C-13): poco sotto la vetta, sulla parete è dipinto un toro rosso che soffiando scaccia un piccolissimo (rispetto a lui) essere umano. Una scena che immediatamente porta alla memoria il mito di Indra che eiaculando scaccia Dasyu, così come descritto nel Rgveda. Si ritorna alla dualità delle interpretazioni: l’indiano Wakankar ha sempre riscontrato precise connessioni tra le scene sulle rocce e la mitologia vedica; all’opposto, l’occidentale Gordon, malgrado le numerose coincidenze, continuò a negare che queste pitture rupestri potessero contenere esempi ispirati (o ispiratori?) dalla mitologia hindu. Come spiegarsi, allora, i dipinti che mostrano figure cornute (Shiva-Nandi?), uomini con testa di cavallo (Kinnaura?) o con testa d’elefante (Ganesha?), figure antropomorfe con quattro o più braccia o con aureola punteggiata? Che dire dei
probabili simboli divini quali sono il tridente e l’impronta del piede dell’eroe solare? Non è certo possibile ignorare che ancor oggi nel fondovalle di Raisen, davanti ad un enorme macigno con un preistorico tridente dipinto in rosso, si svolgono in certi periodi dell’anno danze rituali da parte degli indigeni; un’indicazione, questa, del collegamento esistente tra il mondo spirituale dell’attuale popolazione e i vecchi dipinti rupestri. Un altro esempio è rappresentato dall’omino-tartaruga, presente sia in molti dipinti rupestri sia sui muri di tante case indiane, accenno alla seconda incarnazione di Visnu (Kurma-avatara). La difficoltà nell’accettare queste connessioni da parte del mondo occidentale - difficoltà di cui si rese conto anche Wakankar - è in parte data dalla vetustà di queste rappresentazioni: i pesci e le tartarughe trovate a Bhimbetka appartengono allo strato più antico. Da questo dettaglio, Wakankar ne derivò che il concetto originario dell’universo degli dèi hindu doveva risalire al mesolitico. Una rivoluzione, questa, che potrebbe mettere la parola fine alle teorie basate sull’invasione arya, teorie da tempo sotto controllo da parte di molti studiosi. In effetti, riesce difficile capire come un popolo nomade dedito alla pastorizia, d’indole guerresca, e che vivendo in tende o capanne non ha lasciato dietro di sé alcuna traccia di città, abbia potuto introdurre nel Punjab e nella piana gangetica - sebbene in un graduale periodo di tempo - le conoscenze vediche con relativi inni e rituali oblatori. Al contrario, la storiografia continua a dar poco risalto all’importanza dell’apporto di popolazioni greche, ben presenti nell’India dravidica con reami governati da proprie dinastie. A tal proposito, ecco quel che ha lasciato scritto Alain Daniélou in Storia dell’India, Ubaldini, 1984:
I GRECI. “Per circa un millennio, dal VI secolo a.C. al V secolo dell’era cristiana, in India ci furono dei Greci. Giunsero fin lì come esploratori pagati dai Persiani, come soldati dell’esercito di Alessandro; arrivarono in veste di filosofi itineranti, di navigatori commercianti, di artisti, di ambasciatori, di principi. Fondarono regni e città, e l’elenco dei re e delle regine greci che regnarono in India e sulle sue frontiere è tanto lungo quanto quello dei re e delle regine che regnarono sull’Inghilterra dopo la conquista dei Normanni. Ben poche sono le regioni dell’India in cui i Greci non siano penetrati. Visitarono le valli dell’Indo e del Gange, la pianura del Deccan e le rive del Gujarat. Come mercanti essi si diedero al commercio sulle coste del Malabar e di Coromandel; come mercenari prestarono servizio nei palazzi dei re tamil. Fino all’arrivo degli Inglesi, nessun’altra razza europea aveva mai traversato ed esplorato il grande continente indiano in modo così complesso” (George Woodcock: The Greeks in India, pag. 13). L’influenza greca si farà sentire nell’architettura, soprattutto nel Kashmir, fino al Medioevo.
Quando Alessandro condusse il suo esercito in India, nel 326 a.C., scoprì che molti suoi compatrioti si erano già stabiliti sulle fertili montagne che dominano l’Indo. Dopo più di due secoli, alcuni Greci al servizio dei Persiani avevano visitato l’India, vi avevano svolto del commercio, partecipato all’amministrazione. Dopo che Ciro, il fondatore dell’impero persiano, ebbe sottomesso le città greche dell’Asia Minore, il suo impero si estendeva dall’Ellesponto a fin oltre dell’Afghanistan; e vi si circolava facilmente. Migliaia di Greci erano arruolati negli eserciti persiani e nell’amministrazione. Nel 517 a.C., un greco, Scilace, fu incaricato da Dario di esplorare la via marittima che dall’Indo arrivava al Mar Rosso. Egli si imbarcò nei pressi della città di Caspatyros che, secondo le informazioni forniteci da Ecateo di Mileto, suo contemporaneo, doveva trovarsi non lontano dalla moderna Peshawar. Scilace discese l’Indo con una imponente flotta e raggiunse la costa dell’Arabia. Il suo viaggio durò due anni e mezzo. Ne scrisse un resoconto del quale ci è pervenuto un breve frammento negli scritti di uno storico poco noto, un certo Ateneo, che visse parecchi secoli più tardi. La sola menzione pressoché contemporanea di questa spedizione è quella di Erodoto, che nacque una ventina d’anni dopo il ritorno di Scilace. Le fonti sanscrite affermano che nel V secolo a.C. esistevano già importanti colonie greche sul confine nord-occidentale dell’India. Il termine con il quale la letteratura indiana e le iscrizioni chiamano i Greci, a partire dal IV secolo a.C., è Yavana, affine al persiano Yauna, con il significato di Ionio. È tuttavia difficile credere che questo termine non sia stato usato anche prima dell’arrivo di Alessandro. Esso proviene certamente da contatti molto più antichi con il mondo mediterraneo, forse con Creta, essendo impiegato come termine generico per tutti i ‘barbari’ dell’Occidente. “A est di Bharata (l’India) vivono i Kirata e a ovest gli Yavana” (Visnu Purana, II). La parola Yavana è menzionata dal grammatico Pànini (IV secolo a.C.) che ricorda anche la scrittura greca (yavanallipyam). La letteratura buddhista li chiama Yona. Secondo la Legge di Manu, un testo molto antico ma rimaneggiato più volte e la cui versione finale è databile all’inizio dell’era cristiana, i Greci, per le loro virtù guerriere, furono accettati nel sistema castale come ksatriya, cioè come cavalieri-guerrieri, nonostante le loro abitudini impure e le loro trasgressioni ai riti celebrati dal clero.
CRONOLOGIA. Anche il difficile tentativo di ordinare cronologicamente l’imponente materiale dei dipinti rupestri indiani fu sempre segnato da opinioni divergenti. Verso la fine dell’Ottocento, Cockburn e Smith sostennero che il rampone simile a una lancia usato nella scena di caccia al rinoceronte di Mirzapur fosse da paragonare (e datare) con le armi da caccia paleolitiche europee. In IPEK (1953) Kuhn indica le incisioni della Edakal-Cave (India del sud) come neolitiche, lo stesso periodo delle pitture scoperte da Silberrad del distretto Banda e dei petroglifi di Gatsila trovate da Mitra nel 1927.
Una curiosità viene dalle pitture rupestri scoperte nel 1918 da Anderson a Singhanpur, dove in una di queste sembra di poter riconoscere un animale simile al canguro (figura che nella letteratura recente è stato reinterpretato come un’antilope, simbolo importantissimo nella mitologia vedica). Lo stesso è poi accaduto a Raisen, dove due figure sembrano combattere come canguri appoggiati sulla punta della coda. Queste immagini fanno emergere la domanda su come i loro pittori potessero essere a conoscenza di animali presenti solo in Australia. Nel cercare di dare una risposta al quesito non si dovrebbero ignorare le fattezze degli Adivasi dell’India centrale, che ricordano da vicino quelle degli aborigeni dell’Australia, dove la pelle nera e il naso schiacciato sono i segni più evidenti.1 Meno problematica della cronologia assoluta è quella relativa, fatta secondo le osservazioni stratigrafiche dei dipinti. Per le sue ricerche, Gordon prese come spunto le sue esperienze nelle Mahadeo Hills (a Pachmadhi nel 1958), dove analizzando le sovrapposizioni poté stabilire quattro serie principali. Secondo l’autore, la serie più antica è presente in quattro shelters e il suo materiale pittorico consiste di forme geometriche rosso pallido, a volte riempite di colore crema, e di forme umane disarmate. L’epoca successiva è rappresentata da umani con frecce ed archi, con figure in colore rosso e marrone fino al giallo marrone. Dal luogo del loro ritrovamento, Gordon chiama questi dipinti “figure Tamia” e le paragona con quelle di Kabra Pahar. Considerando l’armamento e la pettinatura, Gordon le data intorno al 950 e.c., dunque nell’epoca di Ajanta e Sanchi. Nella seconda serie, uomini (cacciatori e guerrieri armati di freccia ed arco) e animali sono dipinti in giallastro e bianco. Appare una figura a quattro gambe, interpretata come protettore delle mandrie, mentre nelle scene più recenti vi sono scene magiche con maschere animalesche. Queste si ritrovano anche all’inizio della terza serie, in aggiunta a scene di vita quotidiana: donne che allattano i bambini, il grano viene macinato, si raccoglie il miele, provviste vengono stipate sotto una tenda. Si tratta di scene vive come quelle di Adamgad, eseguite in colore rosso o rosa con contorni rossi. Verso la fine di questa serie tutto è dipinto in bianco: dominano guerrieri con lunga spada e pugnale o con ascia e lancia, mentre i cavalli portano una mantellina. Nella quarta serie appaiono musicanti con arpa e tromba; le donne indossano bluse, gonne a campana e stole da gomito; gli uomini una cintura con frange che pendono davanti e dietro. Rammento che la mantellina per i cavalli e la cintura a doppia frangia sono presenti anche nelle miniature del periodo moghul. Durante gli scavi di Wakankar a Bhimbetka (gennaio 1973) sono stati trovati resti del mesolitico (shelter III F23) e costruzioni megalitiche simili a stupà. Sulla base degli scavi di Bhimbetka e Modi, nonché dalle sovrapposizioni nei dipinti
1 Cfr.: India tribale.
rupestri dell’India Centrale, Wakankar arriva alla conclusione che le prime pitture risalgono al tardo paleolitico (meno di 20.000-10.000 anni fa). Un periodo, questo, che verso la sua fine include le pitture di Adamgad (elefanti, bisonti e rinoceronti), i grandi danzatori mascherati di Raisen e alcune immagini di Modi e Bhimbetka. L’epoca mesolitica (10.000-4000 anni fa), ancora senza ceramica, presenta come ritrovamenti secondari dei microliti geometrici. Il materiale pittorico comprende il già menzionato omino-tartaruga (Bimbetka III E-9 o Roccia dell’elefante), le rappresentazioni del pesce (Bhimbetka IV A-22; forse che sia il primo avatara di Visnu?), i rinoceronti (Bhimbetka IV A-10), il sacrificio del toro (Bhimbetka IV A-9) e il felino altro tre metri del quale sono ancora visibili tracce del posteriore con disegni romboidali (Bhimbetka III 24, all’entrata dell’Auditorium Rock). Dell’epoca calcolitica (4000-2500 anni fa) sono le strutture a spina di pesce, le linee a zigzag e i triangoli che ricordano i motivi della ceramica Susa e Khafaja. I tori hanno la coda a tridente e talvolta le corna decorate, il che ricorda il ritorno dal pascolo nelle Alpi. Si trovano decorazioni simili sulla ceramica di Kayata e Nagda (vecchie di circa 3500 anni). La quarta epoca corrisponde ai tempi storici, caratterizzata dalla frequenza di cavalieri, carri da guerra e guerrieri. A Bhimbetka, le immagini di battaglia probabilmente riproducono scene tratte dal Mahabharata. Ovviamente, questo quadro cronologico potrà essere soggetto a modificazioni.
DIARIO DI VIAGGIO Dicembre 1998
INTRODUZIONE. La mia prima volta in India accadde nel 1978. Ero diretto a Kathmandu, ma per un incidente agli unici due aerei della Royal Nepal Airlines (mi dissero che manovrando in pista si erano “pestati” le ali tra di loro) dovetti sostare a Delhi. Fu subito amore, e da allora in India ci sono ritornato ventisei volte. Di questo sub-continente tutto mi affascina, soprattutto la sua popolazione, schiacciata dal peso della sua grande Storia. Col tempo, un tarlo prese a rodermi: leggevo centinaia di libri (ne ho acquistati oltre diecimila, finora), ma il passato dell’India finiva sempre lì, alla Civiltà dell’Indo, che indiana (nel senso stretto del termine) del tutto non era, visto l’apporto del mondo greco. Della preistoria non se ne parlava da nessuna parte - almeno nei testi che trovavo in Italia. Il colpo di fortuna l’ebbi a Londra, durante i miei fine settimana chiuso nel British Museum. Nel settore “libri usati” in vendita, trovai un volume sulla preistoria indiana. Una figura in bianco e nero mostrava un quadrupede dipinto come fosse stato passato ai raggi X. Nel suo ventre vi era un altro animale, molto più piccolo. La didascalia diceva: “Vacca gravida. Pittura rupestre, Raisen, Madhya Pradesh, India. Circa 8000-2500 a.C.”. Il libro costava troppe sterline, quindi lo lasciai ad altri. In compenso, per pochi spiccioli portai a casa la fotocopia della vacca gravida. Il mio nuovo viaggio in India poteva iniziare. Il 14 dicembre 1989 ero a Bombay, ora Mumbay. Come quasi sempre ero solo, bagaglio rigorosamente a mano, la fotocopia in tasca, una Leica a portata di mano e un tot di pellicole vergini. Utilizzando i mezzi locali presi a risalire verso il Nord, con doverose soste per visitare Nasik, Aurangabad, Ellora, Ajanta, Fardapur, Jalgaon e Sanchi, l’ultima
tappa prima di Raisen, dove arrivai alle nove e trenta del mattino. Sceso dal bus, presi a girare con la fotocopia in mano, mostrandola a tutti quanti incontravo per strada. Inutile dire che la stragande maggioranza delle persone da me interpellate non ne sapeva niente, ma non disperai. Alla fine un uomo pensò che forse al “medical store” potevano aiutarmi. Aveva ragione: non poteva essermi d’aiuto, disse il farmacista, però conosceva un signore che era stato compagno di Wakankar nelle sue esplorazioni. Un ragazzo venne subito inviato da lui, chiedendo se era disponibile ad incontrarmi. Ritornò con la risposta: Ramashankar Mishra era felice di conoscermi.
Mezz’ora dopo ero da lui. Gli raccontai quel che cercavo, lui mi mostrò vecchie fotografie e una serie di disegni fatti dal vivo: uomini che danzavano, una donna che faceva il bagno in una elaborata tinozza,1 animali vari e un sorprendente dinosauro circondato da uomini che l’osservavano. Confesso che rimasi di stucco: un dinosauro? Impossibile, dissi, dev’essere una “bufala” scherzosa. Capii d’aver urtato la suscettibilità del mio ospite. Improvvisamente si ricordò che aveva da fare (era titolare di una tipografia che stampava alcuni quotidiani locali) e l’unico aiuto che si sentì di darmi lo sintetizzò in poche parole: a tre chilometri da qui vi è una località chiamata Durgah. Da lì, seguendo una traccia di sentiero, camminando camminando si arriva a Ram
Chajja dove vi sono dei dipinti rupestri. Auguri e arrivederci. Fin troppo per stimolare la mia curiosità. Partii col primo bus. Chiesi e mi indicarono il sentiero. Camminavo su terreno infido: terra da serpenti la chiamo io. In lontananza vi erano delle rocce strane, con strapiombi giallastri modellati dalla glaciazione. Mi arrampicai su una di queste. Sotto lo strapiombo trovai le mie prime pitture rupestri. In equilibrio più che instabile presi a scattare diapositive. Avevo capito il gioco e presi a cercare altri strapiombi tondeggianti. Ne vidi uno, alto, quasi all’apice di un tozzo torrione. Salii la roccia fino a posare i piedi su di una larga cengia chiusa a grotta. Sul soffitto vi era un’apoteosi di cervi, vacche, labirinti e tant’altro. Fotografai il
1 In realtà, dopo aver visto l’originale, sono convinto che sia una persona in barca. La certezza
me l’ha data il disegno che lo sovrasta, dove vi è un’altra figura “in tinozza”, ma circondata da pesciolini appesi ad un filo. Non essendoci il mare qui vicino, Wakankar l’aveva escluso. Credo erroneamente. [fotografia a pag. 76]
tutto. A destra, un delicato passaggio sul vuoto, ma non impossibile per chi in gioventù aveva fatto dell’alpinismo una ragione di vita, mi portò a seguire un’esile cengia, un corridoio che mi permetteva di scoprire altre pitture rupestri. Cautamente (alle mie spalle vi era un salto di circa trenta metri) presi a fotografare. Ma non poteva finire così facilmente: in pochi secondi mi trovai avvolto da un nugolo di api infuriate. Col corpo (ma soprattutto la faccia) sotto l’assalto dello sciame, con calma dovetti ripetere l’aereo passaggio e poi arrampicare fino alla base del torrione, dove finalmente potei sfogarmi ad ammazzare quante più api potevo, loro a riempirmi di punture. Mi vidi spacciato. Presi a correre verso Durgah. Entrai in un cortile e chiesi un aiuto, ma i contadini, vista la quantità di api che mi ero trascinato appresso, si chiusero in casa. Arrivai alla strada e mi incamminai verso Raisen. Un pietoso camionista si fermò, mi aiutò ad uccidere le ultime api che ancora mi erano rimaste sul corpo, poi mi diede un passaggio fino alla casa di un medico. Questi prese una lente e con una pinzetta iniziò a strapparmi i pungiglioni (e i peli della barba, con loro). Poi mi caricò su di una Vespa (sic!) indiana e mi portò nel suo studio, dove mi fece una puntura di chissà cosa nel braccio. Per lui il caso era chiuso. Aveva ragione, visto che molti anni dopo sono qui a scrivere le mie memorie. Il suo studio: una capanna col tetto di latta, pavimento in terra battuta, il tavolo ricoperto da una tela cerata. Seduto per terra, un uomo sputava sangue in un catino. Non avevo di che lamentarmi, tutto sommato. La sera ero di nuovo da Ramashankar: lui mi guardò in modo beffardo, chiedendo se oltre alle api avevo trovato dell’altro. Gli raccontai dei dipinti. Ci rimase “come quel della maschèrpa” e da questo intuii che le porte si erano riaperte: non ero più un mleccha. Prese il telefono e si mise a parlare. Riattaccato, m’informò che era in linea con un giornalista: “tutti insieme, domani andremo sulle tracce di Wakankar e lui scriverà un articolo su questa esperienza”. Il resto della serata la passai in casa del dottore, molto interessato a sapere se era poi vera la storia che le donne occidentali si concedono con facilità. Prima di accompagnarmi al letto che mi era stato messo a disposizione (con un
militare armato di fucile fuori dalla porta!) disse la frase sublime: “Mio padre possiede un cottage circondato da un parco bellissimo. La prossima volta che vieni in India, se porti anche tua moglie andremo in vacanza da lui”. Poche idee ma ben confuse, il dottore. Il giorno dopo, venerdì 22 dicembre 1989, alle 8 e 30 del mattino due jeep arrivarono alla casa di Ramashankar. Scesero sette persone, due autisti e cinque giornalisti: la copertura interstatale era assicurata. Una sosta al tempio di famiglia, poi via in direzione di Pengavam, dove la nostra guida ci portò a vedere i dipinti più significativi. La piacevole gita si concluse sotto un gigantesco albero, dove condividemmo il cibo preparato dalle mogli dei miei compagni di merenda. Con un bus di linea, la sera stessa ero a Bhopal, il mio campo base per la visita di Bhimbetka, sito di cui avevo appreso l’esistenza proprio da uno dei giornalisti. Il 2 dicembre era ricorso il quinto anniversario della nota quanto semi-dimenticata strage. Le 40 tonnellate di isocianato di metile hanno prodotto oltre 15 mila morti, da 300 a 600 mila intossicati, decine di migliaia di persone rimaste cieche. Dagli Usa erano arrivati a frotte gli avvocati, si erano fatti firmare le deleghe di rappresentanza, poi erano rientrati a casa loro. Ovviamente, i soldi pagati dalla Union Carbide erano, guarda caso, più o meno pari al loro onorario. Come sempre, i rassegnati s’accontentano delle briciole. In segno di protesta contro i loro corruttibilissimi governanti, da tempo la città era in sciopero. Questo 23 dicembre ero l’unico pellebianca in circolazione, ma a nessuno dei locali venne in mente di accusarmi di alcunché, anzi, ero il benvenuto. In tarda mattinata, saputo il motivo della mia presenza, l’autista di un bus interstatale autorizzato a partire mi fece sedere al suo fianco. Un’ora dopo fermò il mezzo ad un bivio e mi disse di scendere e seguire l’altra strada, che portava al tempio di Bhima, eretto nei pressi di Bhimbetka. Ovviamente non mi informò di quanti chilometri ero lontano dalla mèta. Salendo, cominciai a visitare ogni roccia che trovavo e dappertutto vedevo disegni, ora rossi, ora bianchi, ora ocra. Sulle rocce vi erano cartellini blu, con numerazioni: B-10, B-9, B-8, B-11, B-12. Intuii che B stava per Bhimbetka. Un roccione isolato portava un rosso tridente in bella vista. Davanti a lui, un masso instabile (mi ricordava una cozza aperta) aveva il soffitto decorato da disegni bianchi su sfondo giallo. Qui trovai anche le prime anime vive: un gruppo di magre vacche che vagava tra le rocce. Più lontano vidi il mandriano; andai da lui e imparai che Arkesan era il suo nome. Parlava solo il dialetto Gond, io pronunciai il nome magico: Bhimbetka. Lui tese il braccio e mi indicò l’orizzonte. Lasciai perdere i sassi laterali e presi di nuovo a salire. Qualche chilometro dopo ero di fronte al cartello blu dell’Archaeological Survey of India, Bhopal Circle. Mentre lo leggevo, un uomo mi si avvicinò. Aveva occhi da buono e mi fidai di lui. Si offrì di accompagnarmi per il solo piacere di essermi utile. Non mi ero
sbagliato nel giudizio. Nato e residente nel vicino villaggio, Krisna Ismarap Parichar con la sicurezza di chi conosce i posti mi portò ai siti più importanti (sono oltre 130 i gruppi con dipinti). Arrampicandomi su di un torrione dirimpettaio potei ammirare da vicino un toro rosso congelato nell’atto di soffiare via un uomo. Una roccia a forma di prua di nave, dai colori cangianti in tutte le tonalità del giallo e del rosso, portava su di una striscia orizzontale un bianco elefante e un ancor più candido stallone, impettito di fronte ad un fiore su sfondo verdino. Altre rocce mostravano cavalli riccamente bardati e cavalieri che volteggiavano le loro armi nell’aria. Un disegno mi riportò col pensiero al mio viaggio tra gli Adivasi dell’Orissa, con file di umani che danzavano abbracciati. Al termine della visita ero felice. Spontaneamente offrii a Krisna una giusta ricompensa. Adesso eravano due “felici”. Il problema del rientro a Bhopal, distante 45-50 chilometri, si risolse in fretta. Dal tempio di Bhima scendeva una beige Ambassador. Mi misi in mezzo alla strada e la fermai. L’autista mi guardò come la servitù dei ricchi usa guardare “gli altri”. I signori, marito e moglie, sedevano dietro. Chiesi loro un passaggio e a dispetto dell’autista non me lo rifiutarono. Strada facendo mi raccontarono che lui, il mio ospite, il giorno dopo avrebbe inaugurato la sua nuova fabbrica di tappi per bottiglie e che oggi era salito al tempio per le dovute cerimonie necessarie a favorire la prosperità dell’azienda. Altro che marketing, uffici tecnici, strategie commerciali, pensai. Qui bastava portare una congrua cifra al sacerdote e questi si metteva ad intercedere presso il divino di sua competenza affinché favorisse gli interessi altrui, che adesso erano pure i suoi, visto che più gli affari prosperavano, più sostanziosa diventava la sua tangente. Il 25 dicembre, dopo 14 ore di scassato bus, mettevo piede in Ahmedabad, base di partenza per la visita di Lothan, un dimenticato sito harappano. Rimasi in città alcuni giorni. In una delle tante librerie da me visitate (ora volevo sapere tutto sui dipinti rupestri, di cui ero profondamente ignorante; del resto, è ben noto come nella vita si può vedere e/o leggere molto ma capire poco) trovai un grande libro rilegato. Era scritto in tedesco, lingua a me incomprensibile, ma molte illustrazioni riprendevano i dipinti da poco visitati. Il libraio, vecchia volpe, sparò un prezzo “occidentale”: con gli stessi soldi un indiano medio ci manteneva l’intera famiglia per alcuni anni. Lo mandai a quel paese, ma solo dopo avergli chiesto carta e penna per prendere nota del titolo: Zentralindische Felsbinder. Lothar Wanke il suo autore, di Graz la casa editrice. Anni dopo, gironzolando tra i librai londinesi trovai una copia di Studies in the Archaelogy of India and Pakistan, editor Jerome Jacobson, e di Prehistoric India to 1000 B.C. di Stuart Piggott. La loro lettura riavvivò il fuoco sopito. Dovevo saperne di più. Mi si accese la lampadina: se l’editore del libro da me sfogliato in
Ahmedabad era austriaco, una telefonata all’Ambasciata forse mi avrebbe aiutato. Trovai una signora cortese perché intelligente. Ascoltò la mia richiesta, prese i dovuti appunti e promise di darmi una risposta appena possibile. Il giorno stesso ne avevo una copia (ormai introvabile, mi disse) offertami, previo pagamento, dall’Università di Vienna. Pochi giorni dopo era nelle mie mani. Carine Paruccini, un’amica di Bolzano appassionata di cose indiane, si offerse di tradurmelo. Con altri testi poi arrivati in casa, questo libro mi è servito per ricostruire la cronologia delle scoperte dei siti con pitture rupestri nell’India centrale. Credo di dovere tanti ringraziamenti a tutte le persone coinvolte.
Ramashankar Mishra, a Pengavam
RAISEN
Le pitture rupestri di Raisen sono state scoperte da Wakankar nel I954. Camminando verso nord in un fondovalle, dopo circa mezz’ora si è di fronte ad un masso più alto di un uomo, decorato con un tridente rosso. Il luogo si chiama Aria Ram Chajja, mentre il gruppo di rocce a destra porta il nome di Hati Tol (Roccia dell’elefante). È qui, sotto questo imponente scenario di rocce, che a periodi stabiliti hanno luogo le festose danze dei Gond. Si sale un po’ verso destra e passando una costruzione di muri a secco si arriva alla galleria inferiore, si aggira un pilastro sporgente e poi salendo tra gli alberi si arriva ad un gruppo di dieci danzatori in maschera. La roccia è dipinta in rosso-marrone e chiazze arancione, con un bianco tridente puntato verso il basso. Le figure portano maschere simili a teste di cavallo con corna o piume e code a strascico. Nelle vicinanze, un secondo dipinto mostra nella parte grigia della roccia un animale sbiadito in porpora senza testa riconoscibile, col corpo
tratteggiato in tutti i sensi. Sopra di lui, nella parte gialla della parete, vi è un’antilope con la strutturazione interna comunemente usata a Raisen; a destra due rossi elefanti con piedi a forma di scodellina; di fronte a loro una pariglia di cavalli in marrone, dietro due ruote che lasciano supporre un carro. Si torna indietro, verso sinistra, per entrare in una galleria alta circa quattro metri e rassogliante ad un duomo. Sotto il soffitto si riconoscono quattro grandi figure a clessidra, e sotto di loro si hanno righe senza fine di processioni di animali: centinaia di antilopi, cervi, rinoceronti e bufali inframmezzati da gruppi collettivi di uomini. Spesso le immagini si sovrappongono a degli schizzi bianchi, più tardi stati coperti dal rosso o non terminati. Nel mezzo della rappresentazione vi è un rinoceronte di 36 cm di larghezza, di colore bianco e rosso: il pittore lo ha dipinto sulla curva della parete, dando forma plastica dell’animale. Sulla sinistra si vedono due piccoli animali che si azzuffano: il loro modo di stare seduti sulle code e di colpirsi reciprocamente con le zampe anteriori ricorda molto i canguri. Due cervi procedono verso sinistra, la massa degli animali verso destra. In questo punto si trova la pittura dei due danzatori color ruggine con teste di animali, che Wakankar giudicò dell’ultimo paleolitico. Entrambi i danzatori hanno una larghezza di circa 90 cm. Sopra ai danzatori vi sono accenni di colore verde chiaro, ma talmente sbiaditi che non si può più riconoscere alcuna figura. Sopra al danzatore di destra si trova uno strato rosso-bianco calcolitico e un’antilope è dipinta sulla parte inferiore del suo corpo. A volte gli animali sono dipinti in modo talmente simmetrico che si potrebbe a volontà intercambiare testa e coda: vien da pensare all’antilope-Giano. Figure simili esistono anche a Tikla e Sita Khardi. Sarebbe altrettanto possibile che si trattasse invece di un animale a tre teste, un motivo che conosciamo dai sigilli dell’Indo come “divinità trinataria”. Un po’ distante dall’Hati Tol, verso sud, si trova la roccia della cosiddetta “vacca incinta”: un’antilope ha un piccolo elefante nel suo interno, come fosse in stato di gravidanza.
BHIMBETKA Bhima, nato dal vergineo concepimento di Kunti da parte del dio del vento Vayu, ha un ruolo importante nel Mahabharata. Bhima-Betke o Bhimbetka è la forma corrotta di Bhimbaithka o “sede di Bhima” e dei suoi fratelli, che non molto lontano da qui sono venerati nel tempio di Bhinyapura, struttura che attira frotte di pellegrini. Nei pressi, in località Bana-Ganga, vi è una sorgente che non è mai secca. Secondo la leggenda questa sorgente deve la sua esistenza alle frecce di Arjuna, il fratello di Bhima, che la fece sgorgare per guarire le ferite di Bishma, il nonno dei Pandava, qui in lotta contro i Kaurava. In quest’area si trovano anche i resti di un tempio distrutto. A Bhimbetka si trovano circa 130 gruppi di pitture, scoperti da Wakankar tra il 1957 e il 1958. Quel che gli scavi hanno portato alla luce permette di stabilire che centomila anni orsono qui esistevano forme di vita umana, alla faccia del “creazionismo” e del reverendo James Ussher.1 Tra le altre cose, qui sono state ritrovate asce, clave e coltelli, variamente databili tra il 10.000 e il 2000 a.e.c. Le pitture, in rosso e nero, talvolta in verde, coprono il periodo dal Mesolitico al Calcolitico. Sulla roccia alta, o “Roccia dello zoo”, vi sono raffigurati numerosi animali, tra cui il bufalo, la tigre, il leopardo, l’orso, il rinoceronte, l’elefante, la volpe, lo sciacallo, le scimmie e il cervo con quattro corna. Non manca la fauna tipicamente indiana, quale il gaur, il nilgai, il sambhar e il chital. Vi si leggono anche scritture del periodo di Ashoka e degli imperatori Gupta. Già dalla strada che porta al tempio di Bhinyapura si può vedere, sebbene sepolto da una fitta vegetazione, questo gruppo di blocchi di arenaria rossa anneritasi nel tempo. Dappertutto sono ben riconoscibili le tracce della terza era glaciale. I siti di Bhimbetka I e II sono più in basso, non lontani dalla strada. NOTA: i dipinti sono ricoperti da una crosta formatasi col tempo, simile ad una cataratta. Per dare risalto ai dipinti è necessario spruzzarvi sopra dell’acqua.
Bhimbetka II B-23 e B-24 è un gruppo di rocce dal giallastro al rosa con pitture prevalentemente biancastre contornate il più delle volte di rosso ruggine oppure rosso e lillà. Sotto una volta sta una grande figura che tiene la spada sopra la testa di una seconda figura, più piccola, con una sciarpa lunga fino al suolo, uno scudo rotondo o un emblema. Verso destra vi è un tridente e una figura con
1 Nel corso del Seicento vennero elaborate varie teorie per stabilire la data di nascita della Terra
sulla base delle informazioni contenute nelle Sacre Scritture. La più nota era quella proposta da James Ussher, arcivescovo di Armagh, nel 1650. Secondo i suoi calcoli, la nascita del pianeta Terra risaliva alle ore 9 del mattino di lunedì 26 ottobre 2004 avanti l’era corrente (a.e.c.), data ritenuta ancor oggi valida da alcuni cristiani integralisti e che compariva nelle note di accompagnamento alla Bibbia di re Giacomo pubblicata in Inghilterra.
al guinzaglio un cane avvolto in numerosi nastri ornamentali. In più dipinti si riconoscono duelli rituali, nei quali la rappresentazione dei relativi visi dei guerrieri è stata decisamente evitata; portano invece gli orecchini, che nel Mahabharata sono il segno dell’invincibilità. I cavalli hanno più cinghie del necessario. Tranne poche eccezioni, i piedi dei cavalieri non sono riprodotti, il cavallo è dipinto di profilo, il cavaliere en face, così che si ha l’impressione che i guerrieri cavalchino “all’amazzone”. Cavalieri e guerrieri a piedi portano la spada e uno scudo intrecciato. Un bovino al guinzaglio, verso il quale si incamminano due arcieri, viene condotto al sacrificio. Gli arcieri sono sovrapposti ad un più antico motivo a favo-chiocciola, conservato in parte. A destra passa un animale simile a una lucertola con macchie rosse e testa da sauro, che viene minacciato da un arciere. Sotto si trova un bianco cavaliere su elefante (56x69 cm): per lui Wakankar fissa una data intorno al 1000-1500 a.e.c. A metà tra le zampe anteriori dell’elefante e un cavaliere che incontra un essere simile ad un uccello vi è un bovino dell’epoca più remota, dalla delicata struttura a favo.
Bhimbetka II B-30 porta una scena mesolitica di inumazione. All’interno di un cerchio di 15-17 cm di diametro il morto è sdraiato su una bara, intorno alla quale si danno da fare tre figure. Un quarto uomo limita il campo davanti a due prefiche. Tutte le figure sono tratteggiate in stile semplice lineare sicuro e molto espressivo.
Bhimbetka II F-1 : una scena calcolitica in rosso, larga 50 cm, nella quale Wakankar vede un cane che spinge una capra selvatica verso uno stregone che porta le piume del pavone.
Bhimbetka II F-5 : la mesolitica “Venere di Bhimbetka” è in rosso scuro e alta 23 cm; alla sua sinistra vi è una scena di copulazione sdraiata. Tutt’intorno vi sono le delicate scalfiture di un pavone, un bovino e un uomo (II F-7). Da qui lo sguardo si sposta verso occidente sul gruppo di arenaria di Bhimbetka III. Al di sopra delle scalfiture, nello strato di fondo si notano i resti del colore verde della fine del paleolitico. Sopra, un uomo è seduto davanti al fuoco; è alto 13 cm e appartiene al periodo mesolitico. Sotto, un gruppo di uomini dipinti in rosso con teste a forma di “ C ” atterra un bisonte (largo 33 cm). Al di sopra di questo disegno la roccia si inarca per formare una mezza cupola, coperta di figure rosso ruggine simili a ragni. Viste dal basso, alcune persone sembrano disposte a testa in giù. Colpiscono alcuni strani ingrossamenti ai gomiti, quasi fossero anelli allargati: forse una protezione dalle corde dell’arco?
Bhimbetka III : qui vi è un centro di culto hindu, con un yoni-lingam di pietra. Al tempo del mio passaggio questo era un luogo di sosta nel pellegrinaggio verso un eremita che si dichiarava servitore di Durga. La roccia principale, che si erge sopra la giungla come un ammasso di torri giganti, è alta circa 30 metri. Il suo roccioso corridoio viene utilizzato come alloggio per la notte.
Bhimbetka III A-19 mostra tre uomini con picconi che marciano contro tre portatori di clave. La sequenza di immagini continua verso destra con una figura seduta, il busto scheggiato, e uno stregone che sventolando procura aria fresca ad una figura sdraiata al suolo. Seguono altre due figure, che con la mano sinistra sembrano raccogliere qualcosa, e una madre che tira il suo bambino per i capelli e lo minaccia con un bastoncino.
Bhimbetka III A-27, chiamata anche “Grotta delle mani”, è una semigrotta simile a una cappella. Accanto a un albero della vita con favi si riconosce Krisna con la ruota del tempo (o un loto) di colore bianco. Ai piedi dell’albero vi è un guardiano con la spada innalzata. Una doppia riga di punti passa attraverso la parete, mentre una moltitudine di mani bianche impresse all’altezza degli occhi di Krishna suggerisce un suggellamento del patto col dio. La grandezza media delle mani bianche è di 25 cm, mentre l’unica impronta rossa è di soli 19 cm. Nel mezzo di queste mani un cavaliere si getta addosso a un grande felino, che a sua volta attacca un animale mezzo bovino e mezzo elefante. Questo dipinto, anche lui bianco, è riempito di tratteggiature a rete e misura 103 cm.
Bhimbetka III A-28 : una mezza grotta senza pitture viene chiamata “Grotta del bambino” e questo perché Wakankar ha qui dissotterrato nello strato mesolitico, in mezzo a strutture megalitiche, parte di un cranio infantile. Un cartello aiuta a comprendere quel che si vede: in cima alla fossa vi è lo strato grigio cenere del primo periodo storico. Segue lo strato nero del calcolitico, databile dal 5000 al 3000 a.e.c. Più sotto vi è lo strato grigio del mesolitico, databile dal 5000 al 15.000 a.e.c., poi lo strato rosso del paleolitico superiore (dal 15.000 al 20.000 a.e.c.) e infine lo strato nero del paleolitico.
Bhimbetka III C-13 viene chiamato “Roccia del toro”. Il motivo principale di questo enorme fungo di pietra è un grande toro rosso (90x110 cm), che dal naso soffia a un uomo (lo scaccia), e dietro a questi vi è un granchio gigante.
Bhimbetka III C-21 (vecchia numerazione C-12) : sul lato posteriore della roccia con lo stregone-medico troviamo il dipinto di un bisonte rosso (41x21 cm, mesolitico), nonché di un orso, di un cervo, di una scimmia e di una antilope. Al di sopra sono dipinti, in rosso più chiaro, un arciere e un cavaliere; il cavallo è in forma di clessidra, con anellini come zoccoli (datato tra il nostro XIV e il XV secolo), nonché due tridenti raddoppiati in cima in sfumature di arancione chiaro.
Bhimbetka III C-21 : uno stregone in rosso (15x22) si china sopra un malato o ferito; è una scena mesolitica, sopra la quale sono poi state incise una moltitudine di scodelline.
Bhimbetka III C-26 mostra la dea Durga con dieci mani, ma soltanto il busto è visibile.
Bhimbetka III C-29 : su questa parete ci sono dèi e dee indiane in rosso corallo chiaro; tra di loro si riconosce Shiva con scodella, spada, scudo e tridente, dunque a quattro braccia, e Ganesha, il dio a testa di elefante (altezza 35 cm). Altre figure sono state rese irriconoscibili dai ritocchi bianchi. L’età di queste pitture è databile verso il 1000 e.c.
Bhimbetka III C-45 è il nome della roccia che mostra la processione del cavaliere regale (cavaliere su di cavallo con mantellina ornamentale, 35x45 cm). Cavalli e uomini del corteo sono in stile clessidra su cui, più tardi, furono eseguiti dei sovradipinti in bianco. Il corteo è accompagnato da tre uccelli e da un grande felino con motivo a punti. Un uomo bastona uno scorpione gigante, il che potrebbe avere un significato astrologico-simbolico.
Bhimbetka III C-54 è una pittura sul soffitto nella “Grotta del cavaliere bianco”.
Bhimbetka III C-55 mostra uno degli affreschi più belli di Bhimbetka: il bisonte bianco.
Bhimbetka III E : uno dei posti più impressionanti è il grande “Padiglione del giardino zoologico”, chiamato anche “Roccia zoo”. Sopra a motivi rossicci, in parte vecchissimi, ci sono più di 600 figure biancastre di animali e alcune figure di pastori. Quasi tutti gli animali portano più o meno marcatamente le strutture calcolitiche tipiche anche di Raisen. In cima vi è un animale con motivo a punti bianchi posto di fronte ad un cavalcatore di elefante. In prevalenza si vedono bovini, ma anche cervi e animali di genere indefinibile. Nella zona centrale si trova un quadrato rosso scuro riempito con linee a zigzag, assomigliante all’omino-tartaruga. Sotto questo quadrato (in rosso scuro) si trovano guerrieri che lottano con spada e scudo (come già visto a Bhimbetka II E-24), un cavaliere regale con scorta a piedi e di fronte a lui un cavaliere accompagnato da un servitore con due ombrelli onorifici. Il suo cavallo porta sotto la pancia un emblema. A seguire, verso destra si vedono tre antilope con la pancia tratteggiata e al di sopra un gruppo di due uomini e due cavalieri che, in contrasto col gruppo di sinistra che è disegnato piatto, qui appare in contorni delicati e sicuri, nello stile di Bhimbetka II B-24. Nemmeno qui furono disegnati i volti: sotto i berretti simili a turbanti, testa e viso sono indicati soltanto con qualche punto (larghezza dell’ultimo gruppo: 1,20 metri).
Bhimbetka III E-15 : sopra un animale disegnato in rossiccio si trova in una piccola sporgenza “la madre di Dio preistorica”, una figura femminile alta 24 cm in rosso scuro. Il corpo è liscio e a forma di bottiglia, la macchia nera sul petto è una pietra nera conficcata nella roccia (una seconda la si vede davanti al ginocchio). La vulva è accennata.
Bhimbetka III E-9 è detta la “Grotta dell’elefante”. Sulla prua della roccia somigliante a una nave c’è un elefante rosso cinabro, che porta nell’interno una figura delimitata da una linea più chiara. Dietro a lui ci sono due impronte rosse di mani, poi un toro della fine del paleolitico largo 145 cm, al di sopra due antilopi. Sul lato sinistro dell’elefante si riconosce, rosso scuro a purpureo, la rappresentazione della tartaruga, seconda reincarnazione di Visnu. Di particolare interesse è l’inclusione della conformazione naturale della pietra nella figura. L’epoca più recente mostra qui un animale bianco con punti dello stesso colore.
Bhimbetka III F-24 : il contrafforte orientale del comignolo di roccia, chiamato Auditorium Rock, è, nel senso più stretto, sede e grotta di Bhima. La zona della maggior parte delle immagini presenta numerosi sovradipinti. In alto traspare ancora il più antico disegno di un bisonte e di un pavone: Wakankar ritiene che il bisonte sia della fine del paleolitico, mentre spiega come mesolitico il contorno disegnato di una mano e come calcolitici i bovini. Il bovino più grande ha degli artigli sulle corna. Sotto tre bovini più piccoli è stato disegnato un triangolo nel grembo, probabilmente come segno di fertilità e rinascita degli animali. Nel centro vi è un cacciatore cornuto con arco e freccia nello stile lineare, color marrone. Quasi invisibile è nella parte sud del duomo di roccia un grande felino lungo tre metri riempito di un sottile motivo a rombi. Da Bhimbetka III si prende dapprima verso sud per un burrone e dopo una escursione di un’ora e mezza verso sud-ovest si arriva al gruppo di massi con sporgenze designato come Bhimbetka IV. Qui si trova, simile a un piccolo lago, una forma concava rotonda con parte interna piana, ma in perpendicolare sulla parete.
Bhimbetka IV A-13 : nel centro di questa sporgenza si svolge un nastro di uomini che portano nelle mani alzate dei bastoni o randelli. All’estremità sinistra una gru porta, tenendolo per il piede, un bambino a una famiglia. La pittura arancione appartiene al primo periodo storico.
Bhimbetka IV A-19 : si tratta di una nicchia interna a cupola, nella quale vi sono alcune grandi figure. La più chiara copre una superficie di quasi un metro quadrato, la testa è trasversale e larga, il collo è alto. Intorno alla sagoma vi è una fila di segni di pesce e scorpione. A parte alcune mal riuscite impronte di mano, qui si vedono due macchie tonde dipinte in arancione chiaro. Quella di destra, più squadrata, è divisa in quattro e in uno di questi quarti si trova un uomo (sembra la pianta di una casa). Nella seconda forma, più tonda, o capanna, si compie forse una scena di copulazione. Tutte queste immagini sono dei tempi storici.
Bhimbetka IV A-22 : tra massi enormi si erge una parete sporgente. Domina per la sua grandezza (1,20 m) e la sua localizzazione in una cavità nella roccia il grande pesce disegnato in violetto spento. Una grossa incrostazione copre la sua parte anteriore, sotto la quale i suoi contorni traspaiono debolmente. Lo strato sotto l’incrostazione porta molte pitture rosse poco chiare, tra di loro anche un cavaliere. Lo strato superiore è pitturato in beige. Se noi sapessimo quanto tempo deve passare per formare una tale incrostazione, si potrebbe qui fissare una cronologia assoluta, non soltanto relativa. Sopra questo pesce sembra che ci sia stato il tentativo di incorporare un pesce più piccolo in una piccola cavità, mentre a sinistra, giù vicino al suolo, sembra che esista un corpo pesciforme, finemente inciso e decorato con motivi a favo e meandro. Sopra alla parte centrale del “pesce gigante” sta un animale cornuto dal cui posteriore esce una quantità di uomini-tartaruga, la “seconda reincarnazione del dio”. Wakankar indica per il pesce e per gli uomini-tartaruga il mesolitico, per la sovrapittura sopra l’incrostazione il periodo storico.
Bhimbetka IV A-9 e IV A-10 : la parte inferiore dell’immagine è dominata da un grande toro rosso scuro dai contorni vigorosi. Dietro al toro, disegnate con lo stesso tratto largo e stessa sfumatura di colore, stanno due figure: quella di destra sembra pungere il toro con un rampone. Sette piccoli uomini disegnati con tratti delicati più scuri danzano intorno all’animale; l’ottavo uomo, che ha la testa circondata da raggi, tiene nella mano destra cinque giavellotti, nella sinistra l’arco o un oggetto simile al truogolo. Sul lato destro dell’immagine vi due busti piatti di uomini, di sfumatura biancastra. L’uomo di destra alza la sua mano (come stesse per benedire) sopra a quello di sinistra, che a sua volta tiene in mano un’antilope. Secondo lo stile, però, l’antilope dovrebbe essere stata dipinta dallo stesso autore del cacciatore con piume e lunga lancia che sta all’estremità destra dell’immagine. Sopra al toro è dipinto un piccolo animale bianco. Secondo Wakankar le figure biancastre e arancioni appartengono al periodo più recente, le figure rosse sono mesolitiche. Se questo è vero se ne può concludere che uccisioni cultuali e sacrifici di animali furono qui eseguiti in continuazione dal mesolitico fino al periodo storico. Sull’altro lato della roccia, vi sono i resti molto incrostati di una pittura verde della fine del paleolitico. Tali resti di colore furono scavati anche a Modi nello strato corrispondente. Al di sopra nel mesolitico furono dipinti alcuni animali in rosso, come due rinoceronti.
Bhimbetka IV E-1 si chiama la “grotta dei danzatori verdi”. La fila delle figure è dipinta in verde petrolio pallido, alta 12 cm, e le teste dei danzatori a forma di U indica che gli uomini sono cornuti. Alla fine della fila di destra vi è una coppia che copula seduta.