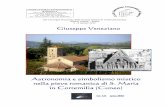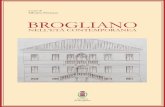Manzanilla 2000 Fuego y regeneración. Los incensarios teotihuacanos y su simbolismo
Le incisioni rupestri di Tresivio (SO) e il simbolismo dell'ascia nell'età del Bronzo in Italia...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Le incisioni rupestri di Tresivio (SO) e il simbolismo dell'ascia nell'età del Bronzo in Italia...
Le incisioni rupestri di Tresivio (SO)e il simbolismo dell’ascia nell’età del Bronzo
in Italia settentrionalePARTE II
ANGELO MARTINOTTI
Istituto Archeologico Valtellinese
3. Il simbolismo dell’ascia nell’età del Rame e del Bronzo in Italia.3.2. L’età del Bronzo: asce di uomini e di dèi.
Dopo la relativa latitanza in coincidenza con l’epoca tardo-eneolitica egli esordi dell’età del Bronzo, la figura d’ascia riappare improvvisamente e pe-rentoriamente a distanza di pochi secoli, a partire dalle fasi finali dell’anticaetà del Bronzo (Bz a2), sempre rivestita dell’ideologia legata alla qualificazio-ne di figure sociali di spicco, erede di una concezione eneolitica rivista alla lu-ce di un immaginario e di un contesto socio-culturale in via di rinnovamentoche stanno assistendo al progressivo emergere di figure di capi ora esplicita-mente connotati come guerrieri(1). esauritosi in un’effimera coda (fase iii a 3)il fenomeno megalitico dell’età del rame, il gusto artistico di quest’epoca (stileiii B), proposto ormai solo su supporto orizzontale, si esprime in ricche com-posizioni costituite da sole figure di armi, organizzate secondo schemi disposi-tivi a raggruppamenti compatti, in allineamento, incolonnamento o ad inca-stro serrato, con orientamento antiparallelo o in contrapposizione, chiaramen-te debitori dei modelli sintattici in auge nello stile di fase campaniforme(2).
in Valcamonica, in corrispondenza di questo periodo si registra una signi-ficativa flessione nell’attività istoriativa, resa ancor più evidente dal confrontocon il fervore del precedente momento eneolitico e soprattutto con il succes-sivo, esplosivo ciclo artistico protostorico della tarda età del Bronzo e dell’etàdel Ferro, che da solo esaurisce l’80% dell’intero patrimonio rupestre camu-no. i complessi riferibili a questa fase artistica non sono numerosi e si concen-trano in pochissimi distretti chiave, dove assumono notevole visibilità. i polipiù importanti coincidono con l’area di Ceto-Foppe di nadro sul versante si-nistro del grande comprensorio rupestre dei dintorni di Capo di Ponte – unazona non vasta che aveva già conosciuto, con il contiguo Dos Cùi, grande vi-
3
(1) Peroni 2004.(2) Marretta 2004, pp. 183-185.
Martinotti 2013_Layout 1 09/10/13 09:55 Pagina 3
vacità istoriativa in età eneolitica e che ora vede continuità di frequentazionesulle rr. 4, 17 e 22-23 – e soprattutto con il colle di Luine, nella bassa Valca-monica, caratterizzato da una eccezionale densità di composizioni(3) (fig. 14).
4
Fig. 14 – a) Ceto (BS), località Foppe di nadro, roccia 23 settore a: composizione diasce e pugnali dell’antica età del Bronzo (rilievo Coop. arch. “Le orme dell’Uomo”;da CaSini, FoSSati 2004); B) Darfo/Boario terme (BS), località Luine, roccia 34 set-tore C: composizione di asce, pugnali, una lancia e “scutiformi” (forse figure di scudi)della Media età del Bronzo (rilievo CCSP; da anati 1982).
(3) Sui soggetti dell’età del Bronzo a Luine: anati 1982, pp. 155-175.
Martinotti 2013_Layout 1 09/10/13 09:55 Pagina 4
il fenomeno artistico non si limita alla sola Valcamonica – che pure ne costi-tuisce l’epicentro – ma emerge anche in isolati, significativi casi alpini cometresivio, la nota “pietra di Castelletto” a Brenzone (Vr), sulla costa orientaledel Lago di garda, e infine il più occidentale complesso valdostano del riparodi La Barme, in Valtournanche (ao)(4).
Scomparse le alabarde e rappresentati in maniera minoritaria i pugnali,nelle composizioni dell’età del Bronzo si impone in maniera generalizzata iltipo iconografico di ascia visto a tresivio.
Sul piano dei contenuti, la selezione iconografica e l’attenzione esclusivaper le figure di manufatti metallici inducono ad associare questo spiccato sim-bolismo oggettuale al diffuso fenomeno, ampiamente documentato a livelloarcheologico in tutta europa a partire dalle fasi iniziali dell’antica età delBronzo, delle deposizioni in prossimità di luoghi naturalmente evocativi –specchi d’acqua, sorgenti, fiumi, alture, passi montani o anfratti – di armi oornamenti bronzei di prestigio, in esemplari isolati oppure accumulati in ri-postigli, a scopo evidentemente rituale, con ogni probabilità di natura religio-sa e votiva(5). ai complessi figurativi rupestri è riconosciuta una funzione so-stitutiva, oppure ausiliaria, delle deposizioni reali: le figurazioni rivestirebberosecondo tale prospettiva un ruolo di “surrogazione virtuale”, ovvero di com-plemento o integrazione simbolico-rituale, nella simulazione, sanzione/cele-brazione o nel perfezionamento di un atto di offerta di oggetti dalla forte ca-rica ideologica(6).
È suggestiva in tal senso la disposizione spaziale assunta dalle superficicon figurazioni dell’età del Bronzo nel polo rupestre camuno di Ceto-Foppedi nadro, organizzata in relazione alla vicinanza con una sorgente d’acqua, at-tiva ancor oggi, che scaturendo ai piedi della r. 30 (un trovante istoriato conuna composizione di fase iii a 1) lambisce le rocce con soggetti enei, in unsignificativo legame con l’elemento acqua che torna in quel ricorrente aspettodella ritualità dell’età del Bronzo rappresentato dalle deposizioni di oggetti inluoghi umidi (Gewässerfunde).
in tale contesto, la figura di ascia, soprattutto nell’iconografia con taglioespanso, assurge a fulcro simbolico assoluto. La particolare sottolineatura sim-bolica che accompagnava questo specifico modello iconografico è ribadita
5
(4) De MariniS 1994, pp. 104-106; SanSoni et al. 1999, pp. 68-72; SanSoni 2006, pp.17-26. Sulla pietra di Castelletto: PaSotti 1971.
(5) La letteratura sul fenomeno delle deposizioni rituali di armi in età protostorica è moltovasta; tra i contributi più significativi, utili per il nostro argomento: torBrügge 1972; La-VrSen 1982; BraDLey 1990; Frontini 2001; DaL ri, teCChiati 2002; CaranCini 2006,con più ampia bibl. di riferimento.
(6) FoSSati 2001; CaSini, FoSSati 2004, p. 335; CaranCini 2006, pp. 27-28.
Martinotti 2013_Layout 1 09/10/13 09:55 Pagina 5
esemplarmente dal pannello centrale della r. 1-sett. a di tresivio, al centro delquale compare, in posizione enfatica, un esemplare d’ascia di dimensionimaggiori, la cui ampia lama circolare è circondata da un anello che ne qualifi-ca la chiara attinenza ad una simbologia solare, a conferma della persistenzadel valore trascendente, forse “uranico” assunto dall’oggetto(7) (fig. 15).
Le valenze simboliche rivestite dall’ascia presso le culture delle genti del-l’età del Bronzo europea permangono in buona misura enigmatiche, in quan-to sfuggono i dettagli delle varie funzioni di volta in volta svolte dall’oggetto,
6
Fig. 15 – tresivio (So), roccia 1 settore a: particolare dell’ascia con lama circolarecontornata da anello (foto e rilievo: Dipartimento Valcamonica e Lombardia – CCSP;da SanSoni et al. 1999).
(7) SanSoni et al. 1999, pp. 46, 78.
Martinotti 2013_Layout 1 09/10/13 09:55 Pagina 6
da quelle più comuni e “pratiche” in ambito quotidiano, più facilmente intui-bili, a quelle particolari, virtualmente proiettate in una sfera astratta ed “idea-le” lato sensu, molto più elusive. non sistematiche osservazioni tecniche com-piute sulle tracce d’uso hanno stabilito come i tipi generici di ascia potesseroadattarsi ad impieghi pratici diversificati, sia in contesti venatori o di battagliacome arma da fendente o da getto, sia in attività artigianali come strumentoda taglio e rifinitura per lavori di carpenteria, anche rimuovendo la lama eusandola a mo’ di scalpello(8). Con la fine dell’antica età del Bronzo e il rapi-do sviluppo di un’artigianato metallurgico sempre più specializzato, anche leasce mostrano decise evoluzioni tipologiche orientate ad una più spiccata spe-cializzazione funzionale.
Di certo non si possono ridurre a meri strumenti da lavoro intere classi diasce di foggia ricercata, a volte riccamente decorate come quelle appartenentialla vasta famiglia con taglio espanso, semicircolare e a flabello, o quelle speci-ficamente concepite per la battaglia come la classe delle haches-spatules concorpo molto stretto e allungato, oppure le scuri ad occhio con sperone poste-riore a capocchia circolare (Nackenscheibenäxte) della piena età del Bronzo eu-ropea(9). Celebre ed emblematico è il caso della spatula-axe tipo rümlang conlama decorata da inserti romboidali in lamina d’elettro, deposta come indica-tore di status nella ricca sepoltura svizzera della t. 1 di thun-loc. renzenbühl(Berna), della fine dell’antica età del Bronzo (Bz a2b; fig. 16)(10).
il tipo iconografico di ascia dell’arte rupestre alpina esalta proprio i carat-teri distintivi (taglio espanso, innesto e corpo della lama molto lungo) propridelle Streitäxte (asce da battaglia) tipiche della cultura di Únětice dell’anticaetà del Bronzo e dei gruppi occidentali della Cultura dei tumuli (Hügelgrä-berkultur) della Media età del Bronzo centro-europea(11).
a partire dal Bronzo antico, in europa l’ascia compare con frequenzanelle sepolture più prestigiose in associazione con l’alabarda e il pugnale a co-stituire “proto-panoplie” di notevole risalto materiale e simbolico in cui emer-ge un iniziale intento di sottolineatura del ruolo guerriero del defunto, con-nesso ideologicamente all’esercizio della leadership. Con la Media età delBronzo, il pugnale e soprattutto l’alabarda saranno rapidamente sostituiti co-
7
(8) roBertS, ottaway 2003, pp. 132, 136-137; KienLin 2006.(9) Sulle haches-spatules: aBeLS 1972, pp. 17-28. Sulle Nackenscheibenäxte, per la romania:
VULPe 1970, pp. 13-25, 66-99 (in partic. i tipi riccamente decorati nelle taff. 19-22); perl’austria: Mayer 1977, pp. 38-44, taff. 7-8. Sulla storia degli studi, l’analisi tipologica e deglistili decorativi e la cronologia del phylum si veda la recente, dettagliata disamina in: DaViD2002, pp. 47-281.
(10) StrahM 1965-66; aBeLS 1972, p. 21 n. 178, taff. 12 e 60 (contesto).(11) De MariniS 1998, p. 176.
Martinotti 2013_Layout 1 09/10/13 09:55 Pagina 7
me elementi di spicco dalla spada e dalla lancia, presto assurti a componenticaratterizzanti di un vero e proprio armamento, attraverso il quale il ruologuerriero del possessore si stagliava simbolicamente in maniera ancor piùchiara(12). La ricorrenza dell’ascia declinerà invece in coincidenza con l’età delBronzo Finale per fare la sua ricomparsa solo nella piena età del Ferro.
in italia settentrionale, le asce di foggia ricercata compaiono regolarmenteanche nei ripostigli del Bronzo antico e Medio costituiti da oggetti di presti-gio (“Lodigiano”, Baragalla, robbio Lomellina e Costa Monticelli nel Bza2b; Cascina ranza, rocca di Badolo, avigliana, Fondo Vecchio ed ello-og-giono nel corso del Bronzo Medio), interpretabili come episodi di tesaurizza-zione o deposizione votiva di beni di valore appartenuti ad una comunità, asegmenti sociali o a personalità di rilievo. i vari oggetti accumulati compren-devano serie di asce di particolare pregio, certo per opportuna ed intenzionaleselezione, significativamente privilegiante le stesse forme a taglio espanso pre-dilette nelle raffigurazioni rupestri. L’associazione ricorrente con monili comecollari aperti con capi a ricciolo (ted. Ösenhalsringbarren; ingl. ingot-torques),ritenuti altresì dotati di una funzione pre-monetale (in qualità di mezzi di ac-cumulazione di ricchezza, di scambio e/o commensurazione del valore), lascia
8
Fig. 16 – Haches-spatules tipo rümlang: a) dalla tomba 1 di thun (Svizzera, Kt. Bern),località renzenbühl (foto: gentile concessione Bernisches historisches Museum); B)dalla palafitta dei Lagazzi di Vhò (Piadena, Cr; da De MariniS 1978); C) tresivio(So), particolare della roccia 1 settore D (foto: Dipartimento Valcamonica e Lom-bardia – CCSP).
Martinotti 2013_Layout 1 09/10/13 09:55 Pagina 8
ipotizzare un analogo impiego anche per certi tipi di asce di ampia diffusione,dal valore intrinseco presumibilmente determinato e convenuto(13) (fig. 17).
Si può desumere in sintesi che l’enfasi simbolica dell’ascia – e quindi lasua traslazione nella dimensione rituale-figurativa – promanasse dalle accezio-ni legate agli utilizzi ideologicamente più rilevanti e pregnanti, tra cui quellimilitare ed economico-rituale erano certo rivestiti di maggior prestigio, il pri-mo in quanto associato – quale espressione di valentia e preminenza fisico-morale, trasferita in campo politico (leadership) – alla qualificazione di indivi-dui socialmente emergenti, ora maggiormente connotata da accenti guerrieri,mentre il secondo (idealmente correlato al primo) materialmente rappresenta-tivo del potere “contrattuale” esibibile dai possessori nei rapporti economici opolitici con altri individui, gruppi e comunità, come pure, ad un livello piùastratto, nelle pratiche di culto rivolte alle divinità(14).
Le considerazioni sulla valenza economica dei ripostigli hanno importan-ti ricadute anche nella sfera votiva, in quanto impongono una riconsiderazio-ne della supposta specularità semantica tra i ripostigli di bronzi e le composi-zioni rupestri quali traslazioni “ideali” dei primi. L’atto di deporre oggetti do-tati di elevato valore, come dedicazione a soggetti sociali o ad entità trascen-denti in richiesta o ringraziamento della concessione di benefici, condivide
9
Fig. 17 – robbio Lomellina (PV), ripostiglio della fine dell’antica età del Bronzo; inprimo piano, ascia a margini rialzati e taglio a flabello tipo Desor-robbio (foto: gen-tile concessione archivio Fotografico dei Musei Civici di Pavia).
(12) De MariniS, SaLzani 2005, pp. 412-415.(13) CaranCini 1996, p. 50; KienLin 2006, pp. 466-469; CaranCini 2006, p. 28, nota
94. Per età precedenti: zaMagni 1996.(14) BraDLey 1990, pp. 36-39 e in part. cap. 2; KienLin 2006.
Martinotti 2013_Layout 1 09/10/13 09:55 Pagina 9
con le forme primitive di scambio e con la pratica del dono tra capi antiquomore un profondo valore “etico” e cerimoniale, risiedente nella volontaria pri-vazione da parte dell’offerente/donatore di un bene materiale prezioso inquanto necessario, raro, esotico, dispendioso in termini di risorse e lavoro, le-gato al prestigio di illustri proprietari, oppure dotato di alto significato sim-bolico o affettivo. È un’atto che genera un’obbligazione nel ricevente, isti-tuendo tra le parti aspettative di corresponsione reciproca e vincoli di naturasociale e politica, secondo la nozione Maussiana dello “spirit of the gift” (15).nelle forme arcaiche di scambio, infatti, le transazioni formali – quali “fattisociali totali”, secondo la definizione di Mauss – coinvolgevano gruppi o i lo-ro rappresentanti (i “capi”) in un sistema di doni e controdoni rigidamentegovernato, per mezzo di convenzioni sociali, dai tre obblighi di donare, accet-tare il dono e ricambiarlo. tali princìpi regolavano non solo le relazioni uma-ne, ma anche il rapporto con la divinità.
essendo la concretezza materiale – nel duplice aspetto del valore econo-mico (o “nozione astratta del valore”) e soprattutto del valore simbolico, ideo-logico, sociale ed etico (“nozione concreta del valore”) – connaturata alla pra-tica del gift exchange, la sostituzione del bene con la sua raffigurazione imma-teriale non può che essere risultato di una reinterpretazione in chiave piùastratta della concezione di dono/offerta e del rapporto tra offerente e benefi-ciario, trasferiti, per dirla con una felice espressione di r. Peroni, «in una sferain cui tutto è immateriale», ossia in una realtà pienamente trascendente in cuiil dono, spogliato della sua componente materiale e “terrena”, si risolve in unatto puramente formale, simbolico e simulato(16). Se quindi per le deposizionireali di oggetti la piena pertinenza ad una ritualità dedicatoria di carattere voti-vo non può essere asserita univocamente, lasciando adito a possibili letture so-cio-politiche(17), appare fortemente fondata la tesi che vedrebbe le forme figu-rative rupestri attingere più propriamente ad una dimensione “religiosa”, costi-tuita da pratiche appunto formali e ritualizzate, concepite in termini astratti.
il significato correlato alla pregnanza simbolica dell’ascia confluirebbe co-sì nell’interpretazione religiosa formulata da Peroni in merito al costume ri-tuale eneo della deposizione di oggetti di bronzo: secondo l’autorevole tesidello studioso, l’offerta votiva a fini cultuali di beni metallici – armi da partedi uomini, ornamenti da parte di donne – sottenderebbe l’avvio di un proces-so di concettualizzazione in senso antropomorfo della divinità, intesa sempre
10
(15) Sull’“antropologia dello scambio”: gernet 1983, pp. 75-112, 165-168; MaUSS 2002.Si veda anche: CaranCini 2006, p. 28.
(16) Peroni 2004, p. 166. Si veda anche: gUiDi 2009, pp. 143-144.(17) CaranCini 1996, p. 49; DaL ri, teCChiati 2002, pp. 478-480; CaranCini 2006,
pp. 27-28.
Martinotti 2013_Layout 1 09/10/13 09:55 Pagina 10
più come entità personificata con caratteristiche, desideri e necessità analoghia quelli dell’uomo(18). Le offerte (reali e virtuali/figurate) svolgerebbero uncompito placatorio e propiziatorio, nei termini del “sacrificio” rituale di benipreziosi, come “dono” e suggello di patto, ovvero accensione/estinzione diuna obbligazione tra uomo e divinità (pro voto, ex voto).
troppo poco si conosce sulla fisionomia preistorica dei pantheon delle po-polazioni europee anteriormente alla decisiva influenza, diretta o mediata,della mitologia classica, se non che – allorquando il concorso di varie fonti la-scia trasparire nebulosi relitti di concezioni affondanti in epoche preistoriche– le figure divine, concepite come impersonali forze “naturali” alla manieraanimistica, appaiono possedere in origine identità spesso non ben definite,cangianti, talvolta teriomorfe o amorfe. Una caratteristica, questa, che si in-travede con difficoltà ancora in età storica nella religione etrusco-italica, so-prattutto in quella concezione cultuale che a. L. Prosdocimi tratteggiava neitermini di una “teologia dell’atto”, e secondo la quale la divinità assumeva dif-ferenti connotati o sfumature funzionali in relazione al contesto rituale in cuiera evocata. Questa nebulosità di fondo della teologia protostorica riemergead esempio in taluni tratti della religiosità etrusca, a cominciare dalle inizialiapprossimazioni nell’assimilazione (in primis iconografica) delle figure divineencorie alle (pseudo-)equivalenti greche in età arcaica, poi trascinatesi in se-guito negli incessanti, talvolta tormentati adattamenti e rielaborazioni nel-l’applicazione dell’immaginario mitologico ellenico alle divinità locali(19).
il processo di antropomorfizzazione, avviato forse già nell’età del Bronzo,avrebbe condotto alla progressiva definizione di un primitivo pantheon poli-teistico, composto da entità divine con identità inizialmente “proteiformi”,alla cui progressiva stabilizzazione – con caratteri e competenze specifici –entro una più canonica “teologia del mito” avrebbe infine contribuito in ma-niera decisiva l’adeguamento al modello del politeismo classico.
Se sia possibile, o lecito, tentare di scorgere un potenziale destinatario di-vino (e quale) dietro ogni offerta di metallo nell’età del Bronzo è questionedelicata e controversa, in primo luogo a ragione del rischio concreto di “forza-re” il documento archeologico, per definizione testimone di per sé “muto”,polisemico e malleabile senza le opportune cautele metodologiche, sovrappo-nendovi interpretazioni dettate da categorie concettuali attualizzanti, estra-nee al contesto culturale e alla mentalità dell’epoca, oppure da personali con-vinzioni. tuttavia, rimuovere a priori un problema in cui rischi di infiltrarsi
11
(18) Peroni 1996, pp. 17-18, 122, 298.(19) Sulla “teologia dell’atto”: ProSDoCiMi 1989, pp. 484-489. Sulla “preistoria” della reli-
gione etrusca: toreLLi 1986, pp.166-167, 174-185. Sull’argomento più di recente anche:gUiDi 2009, p. 144.
Martinotti 2013_Layout 1 09/10/13 09:55 Pagina 11
un po’ più di quel quid di soggettività legata ai personali percorsi di formazio-ne e di indagine, agli interessi, alla sensibilità del ricercatore, o all’adesione al-le mutevoli vagues euristiche e agli schematismi interpretativi dominanti, si-gnifica inaridire inaccettabilmente i termini del discorso, e precludere la pos-sibilità di sviluppo ad ambiti di ricerca potenzialmente fertili. ovviamente, apatto che il tutto avvenga in ossequio alla più scrupolosa trasparenza metodo-logica e ad una sorvegliata impostazione critica, onde non venga meno unabase comune di dibattito e confronto tra specialisti e non si finisca per scade-re nell’arbitrario o nel fantasioso.
tornando alla questione, dall’incrocio delle considerazioni sulle offerte dispade in fiumi dell’italia settentrionale, proposte in uno studio generale di P.Frontini, con i dati relativi al fenomeno delle deposizioni in acqua (Gewässer-funde) in trentino, pubblicati in una approfondita indagine da L. Dal ri e U.tecchiati, emerge una tendenziale distinzione geografica nelle tipologie di of-ferte, con una netta preferenzialità per la dedicazione di asce in area alpina,cui si contrappone una predilezione per le spade nei contesti umidi di pianu-ra20. Una specifica, geograficamente trasversale differenziazione coinvolge an-che il rapporto tra le classi di oggetti e gli ambienti di deposizione. in assenzadi più precisi dati quantitativi in merito, mancando una rassegna completa diquesto genere di rinvenimenti su scala regionale, anche a livello qualitativo siriscontra in area alpina una relazione preferenziale tra le asce e i contesti d’altaquota (Höhenfunde, Paβfunde), con casi emblematici anche in Valtellina(ascia-martello in pietra d’età eneolitica, del tipo cosiddetto “a ferro da stiro”,da Montespluga-sito SP3: 1875 m s.l.m.; ascia in bronzo ad alette terminalitipo aldeno della prima età del Ferro da tovo S. agata-loc. Passo del Morti-rolo: 1890 m s.l.m.) e in Valcamonica (ascia in bronzo a m. r. tipo grenchendi BM 3 dal ripostiglio del lago d’arno in Valsaviore: 1860 m s.l.m.)(21).
La relazione tra manufatto e cornice ambientale nei contesti d’altura nonsembra essere casuale, nonostante il rischio di approssimazioni insito in que-sta categoria di testimonianze a fronte della frequente aleatorietà dei rinveni-menti e della conseguente incertezza nella localizzazione del contesto(22). inmerito a questo aspetto non può essere trascurato un interessante ma vessatospunto interpretativo desunto da remote notizie folkloristiche e da generichecategorie etnografiche. Da tempo infatti è acquisito nell’ambito degli studi et-
12
(20) Frontini 2001; DaL ri, teCChiati 2002, pp. 472-473.(21) Sull’ascia-martello in pietra da Montespluga: FeDeLe 1999, pp. 31-32, fig. 16; sul-
l’ascia in bronzo da tovo S. agata-Passo del Mortirolo: Poggiani KeLLer 1999, p. 48, fig. 4;sul ripostiglio del lago d’arno: De MariniS 1972; SanSoni 2006, pp. 10-12, 15. Sugli Höhen-funde trentini anche: teCChiati 2007, pp. 55-56.
(22) teCChiati 2007, p. 45.
Martinotti 2013_Layout 1 09/10/13 09:56 Pagina 12
nografici e di storia delle religioni il legame simbolico, nella religiosità d’etàstorica di matrice indoeuropea, tra l’ascia – e le armi da getto in generale – edil fulmine, traslato in senso mitologico come attributo di dèi maschili, guer-rieri ed uranici, manifestantisi su cime e luoghi aperti d’alta montagna, secon-do una tradizione avvertibile come tarda eco ancora in età medievale e mo-derna nei racconti popolari e pseudo-eruditi sulle pietre cerauniae (o “pietredella folgore”), alcuni riferentisi proprio ad asce litiche preistoriche(23).
Sono qualificati dall’attributo dell’ascia (spesso bipenne) il dio slavo Pe-run, il lituano Perkūnas, il germanico týr/tîwaz, il norreno thor e il romano-orientale Iuppiter Dolichenus, interpretatio tardoantica del dio hurrita e hittitadella tempesta teshub/tarhun (fig. 18), tutti dèi guerrieri ed uranici, in genereabitatori di alte vette(24). non è forse improprio collocare in un orizzonte cro-nologicamente così alto, nella piena età del Bronzo, l’affermarsi – nel quadro
13
Fig. 18 – a) Stele hittita del dio teshub, da gaziantep (turchia; foto: avi Dolgin, daFlickr – licenza Creative Commons By-nC-Sa 2.0); B) statua di Iuppiter Dolichenus,da Carnuntum (Petronell-Carnuntum, austria; foto: Matthias Kabel, da wikimedia –licenza Creative Commons By-Sa 3.0).
(23) Mano 1996. La tradizione origina da un passo di Plinio il Vecchio, Naturalis HistoriaXXXVii, 51. Cattaneo CaSSano 1996, p. 252; Peroni 1996, p. 298; DaL ri, teCChiati2002, nota 117.
(24) DUranD 1972, pp. 159-163; SanSoni 2006, pp. 73-80.
Martinotti 2013_Layout 1 09/10/13 09:56 Pagina 13
di un avviato processo di definizione ed antropomorfizzazione di figureastratte del pantheon protostorico – del ruolo dell’ascia quale simbolo di divi-nità maschili di ascendenza celeste, conservatosi ancora in età storica cometarda ma avvertibile eco presso molte mitologie locali dell’area centro-euro-pea, balcanica e nordica.
a conclusione di questa trattazione sul possibile significato religioso del-l’ascia nell’età del Bronzo, e a mo’ di contrappunto critico a quanto argo-mentato finora (e in ossequio alla moda interpretativa attualmente dominantenel panorama delle ricerche), è opportuno percorrere un possibile indirizzointerpretativo alternativo, afferente più alla sfera del “politico” che a quella del“sacro”(25). Secondo un’ottica esegetica maggiormente sensibile al campo so-ciologico, infatti, tanto nella deposizione rituale di oggetti in età enea quantonel simbolismo dell’ascia potrebbe cogliersi non tanto la proiezione del desti-natario trascendente dell’atto rituale, reale o figurato, quanto piuttosto delpiù contingente offerente, rappresentato in maniera allusiva da un oggetto-in-segna qualificante. L’angolazione preferenziale da cui perscrutare tale valore èofferta indubbiamente dalla documentazione funeraria, capillare ed ininter-rotta, ma soprattutto sede elettiva per forme, seppur mediate, selettive edideologicamente deformate, di autorappresentazione sociale.
Come anticipato, nelle sepolture dell’età del Bronzo europea, la presenzadell’ascia come prestigioso indicatore di ruolo e di status ricorre episodica-mente ma diffusamente, tendendo a diradarsi in coincidenza con le fasi finali(età del Bronzo recente e Finale; Bz D-ha B2 nella cronologia centro-euro-pea), dapprima affiancata ed infine sostituita dal coagularsi, nella composizio-ne dei corredi di rango, di panoplie guerriere sempre più strutturate in cuipresto assume ruolo centrale la spada. È l’avvio di un processo, coordinatosisu scala pan-europea, in cui lo sviluppo e la capillare interconnessione trans-regionale (c.d. koiné) della produzione metallurgica – connessi allo strutturar-si di un artigianato sempre più specializzato e alla crescente domanda/offertada parte di distretti evoluti dal punto i vista dell’organizzazione socio-econo-mica (come le terramare padane) – si intrecciano in un meccanismo di reci-proca propulsione con l’emergere di una élite dominante, con funzione politi-camente dirigente, ideologicamente connotata come guerriera(26).
in italia settentrionale, in particolare nel progredito bacino padano, laspada inizia ad essere documentata con frequenza a partire dal BM 2-3, di-mostrandosi copiosamente rappresentata fin dall’inizio nel regime delle offer-te in acqua, in prossimità di fiumi (nogara-loc. Pila del Brancón, Vr; fiume
14
(25) DaL ri, teCChiati 2002, pp. 478-480.(26) Peroni 2004; gUiLaine, zaMMit 2005, pp. 196 ss.; De MariniS, SaLzani 2005, pp.
412-415. ringrazio la dott.ssa Katalin Jankovits per le utili indicazioni sull’argomento.
Martinotti 2013_Layout 1 09/10/13 09:56 Pagina 14
Sile-area di S. antonino, PD; fiume Po-area di Caorso, Pr; basso corso delChiese), e meno diffusamente come indicatore di status, come accade nellenecropoli dell’area veneta (nogara-loc. olmo, Vr; Povegliano-loc. gambalo-ni, Vr; roncoferraro-loc. Corte delle Due Madonne, Mn) e della facies occi-dentale di Scamozzina-Monza-alba (BM 3-Br 1)(27). a queste evidenze fa dasbalorditivo contrasto la totale assenza, nell’arte rupestre alpina del periodo,di figure di spada, arma di cui – considerata l’indubbia rilevanza ideologicadimostrata nel record archeologico – ci si attenderebbe in effetti una esplicitae marcata ricaduta simbolica anche nella dimensione figurativa(28).
acquisita la sporadica ma significativa presenza archeologica di spade inarea alpina (Valtellina compresa(29)) a partire dalla piena Media età del Bron-zo, l’esclusione dall’immaginario rupestre eneo può giustificarsi alla luce di al-meno tre spiegazioni ragionevoli, correlate a diverse potenziali cause di invisi-bilità documentaria forse in parte concomitanti:
1 – una ragione di natura cronologica, dipendente da una parziale sfasatu-ra tra il momento di auge delle composizioni opliche rupestri, ossia l’arco tem-porale Ba D/e-BM 2/3, coincidente con l’apice dell’importanza del simboli-smo dell’ascia, e quello dell’affermazione della (valenza simbolica della) spadanell’immaginario sociale e nella pratica votiva in area centro-alpina, non ante-riore al BM 2/3-Br, epoca in cui la fortuna dei soggetti dello stile iii B iniziaad estinguersi a favore di un repertorio tematico orientato verso la figuraumana (resa nello stilema del c.d. “orante schematico”: stile iii C);
2 – una irrilevanza, incompatibilità o non pertinenza concettuale del sim-bolismo della spada con le finalità dell’atto istoriativo, per le quali risulta in-vece coerente, anzi centrale, il simbolismo di asce e pugnali;
3 – una istanza di carattere sociale, ventilata nello studio di Dal ri e tec-chiati, che determinerebbe una seppur parziale distinzione di “attori sociali”,o meglio un’opposizione tra individuo e collettività, alla base dell’espressionevotivo-simbolica, che farebbe meccanicamente corrispondere le deposizioni dispade alle offerte di esponenti di una élite guerriera e le deposizioni di asce al-la manifestazione di una dedicazione collettiva(30).
15
(27) De MariniS, SaLzani 1997; Frontini 2001.(28) Fa eccezione il caso, cronologicamente controverso, della “pietra delle griselle” (torri
del Benaco, loc. Brancolino-Vr), ipoteticamente riconducibile alla tarda età del Bronzo: gag-gia 2004, pp. 163-164.
(29) Spada tipo rixheim del Bronzo recente dal Colle di Fuentes presso Colico: PoggianiKeLLer 1989, p. 51, fig. 45.
(30) DaL ri, teCChiati 2002, p. 478: «Che l’offerta di asce si configuri come dono dellacollettività nel suo insieme, mentre l’offerta di spade sia propriamente l’offerta fatta in primoluogo dall’élite (la nascente aristocrazia gentilizia), è ipotizzabile, ma non verificabile».
Martinotti 2013_Layout 1 09/10/13 09:56 Pagina 15
Se ormai è indubbiamente documentato, nel corso della media età delBronzo, l’affermarsi di un modello emergente di élite guerriera connotata dal-la spada, restano tuttavia incomprensibili le ragioni di una ipotetica(auto?)esclusione o di un celamento, in area alpina, di questi “portatori dispada” (e della relativa insegna) da un contesto rappresentativo presumibil-mente prestigioso ed elitario quale doveva essere l’arte rupestre, a tutto van-taggio della collettività (subalterna?). a questo punto, rimanendo sul terrenosociologico, si potrebbe postulare una locale resistenza culturale all’afferma-zione della nuova élite – ripiegando così sulla vieta immagine dello spaziomontano perennemente arretrato o in ritardo – ovvero, meglio, una intenzio-nale astensione di quest’ultima dalle forme di comunicazione tradizionali, intemporaneo declino, per affidare la propria visibilità ad altri canali e contesti(e occasioni sociali) ritenuti maggiormente efficaci nel veicolare i nuovi con-tenuti ideologici, come le deposizioni rituali in luoghi umidi a scopo religioso(votivo) e/o politico (appropriativo/delimitatorio), oppure a fenomeni di na-tura più effimera nella loro materialità e a noi non documentati, e marcandocosì la rottura/distanza dalla tradizione. a quest’ultima opzione, argomenta-bile solo in via ipotetica, si potrebbe far risalire la già rimarcata flessione, inValcamonica e Monte Bego (dove è piuttosto un’interruzione), nel flusso dimanifestazioni rupestri in coincidenza con il Bronzo Medio e recente.
riprendendo e sviluppando l’idea di differenze di soggetti alla base delledifformità nel comportamento, nella selezione ed esposizione di categorie og-gettuali tra pratiche cultuali figurative e materiali, una lettura potrebbe configu-rare tra l’offerente/committente umano ed il destinatario divino dell’offerta –reale o virtuale – una variabile graduazione di visibilità: più sbilanciata verso ilprimo, nel caso di dediche di spade ed ornamenti, nel tentativo di porre enfasisull’assimilazione dell’atto votivo alla pratica del “dono tra capi”; progressiva-mente slittante dal primo al secondo, tra Bronzo Medio e Bronzo recente, nelcaso delle deposizioni di asce in area alpina, nell’ambito di un culto ormai for-malmente codificato, evocatore delle supreme divinità montane della folgore(31).
tentando di coniugare quest’ultimo spunto con osservazioni interessantiinsite nella spiegazione 1 (mutamento diacronico di pratiche e simbolismi so-ciali e rituali) e 3 (ascesa di un modello sociale con al vertice élites guerriere),un ipotetico quadro comprensivo verrebbe così sinteticamente a delinearsi:
asce = offerta di esponenti d’una élite locale (Ba-BM) > simbolo di divinità uranica (BM-Br)VS
spade = offerta di esponenti di una nuova élite guerriera (BM 2/3)
16
(31) Peroni 1996, p. 122; DaL ri, teCChiati 2002, p. 473.
Martinotti 2013_Layout 1 09/10/13 09:56 Pagina 16
Le manifestazioni rupestri di stile iii B si qualificherebbero come esito diun’espressione simbolica “tradizionale”, caratterizzata sul piano sia locale, tra-mite una forma espressiva – l’arte rupestre – peculiare dell’ambiente culturalealpino, sia sociale, in quanto afferente ad una élite erede dell’ideologia di po-tere eneolitica autorappresentantesi attraverso insegne “tradizionali”, nel corsodell’età del Bronzo Medio in via di rapido rinnovamento (o superamento) allaluce di una nuova ideologia elitaria di matrice militare, quella dei “portatoridi spada”, in ascesa. Se si sia trattato di una discontinuità, di una sostituzionedelle élites tradizionali con nuove componenti sociali (allogene?(32)) accompa-gnata dal conseguente portato di conflittualità, d’integrazione tra gruppi etratti culturali differenti e di rinegoziazione dell’identità sociale, oppure siastato piuttosto un graduale “passaggio di consegne”, consumatosi sul pianodell’evoluzione socio-culturale interna o di una dinamica acculturativa (an-ch’esse non esenti da traumatici fenomeni di conflitto e di dialettica tra rin-novamento e tradizione) suscitate dalla trama sempre più fitta di relazionicon realtà socialmente ed economicamente propulsive, è un problema che almomento né la documentazione figurativa né l’apporto delle sporadiche eframmentarie testimonianze archeologiche possono contribuire a chiarire.
Con la tarda età del Bronzo, il simbolismo uranico dell’ascia parrebbe es-sersi alfine pienamente trasferito dalla sfera politico-religiosa, quale segno delpotere sociale proiettato in campo rituale, alla sola sfera religiosa, tradizional-mente conservativa, cristallizzandosi e perpetuandosi in qualità di astratto at-tributo divino.
Con l’età del Bronzo recente e Finale (1350-950 c.ca a.C.) il simbolismodelle armi, dominante nelle fasi artistiche precedenti, si eclissa rapidamente –con timide sopravvivenze, a livello di concettualità di fondo e di modelli sin-tattici, nelle poche composizioni di palette e di lance realizzate à polissoir (33) –per lasciar spazio ad un inedito linguaggio di respiro narrativo e descrittivo,incentrato sul soggetto umano colto nelle azioni e situazioni che l’immagina-rio protostorico camuno esaltava come maggiormente significative, rappre-sentative di valori ed ideali collettivi.
17
(32) Secondo il modello dell’infiltrazione di bande guerriere giovanili, a scopo di razzia e disostituzione alle élites locali, proposto per le dinamiche della Media e tarda età del Bronzo inPiemonte e Liguria: gaMBari 2004, pp. 84-85; DeL LUCCheSe, gaMBari 2006, pp. 188-189.
(33) Sulle lance dell’età del Bronzo: De MariniS 1994. Sulle più antiche composizioni dipalette, da ultimo: Martinotti 2009, con bibl. prec.
Martinotti 2013_Layout 1 09/10/13 09:56 Pagina 17
riferimenti bibliograficiaBeLS B.-U. 1972 – Die Randleistenbeile im Baden-Württemberg, dem elsaß, der
Franche-Comté und der Schweiz, “Prähistorische Bronzefunde” iX, 4, München.anati e. 1982 – luine collina sacra, “archivi” vol. 8, Capo di Ponte.BraDLey r. 1990 – the Passage of arms. an archaeological analysis of prehistoric hoards
and votive deposits, Cambridge.CaranCini g. L. 1996 – la metallurgia dell’antica età del Bronzo, in CoCChi geniCK
D. (a cura di), l’antica età del Bronzo in Italia, atti del Congresso nazionale(Viareggio, 9-12 gennaio 1995), Firenze, pp. 33-56.
CaranCini g. L. 2006 – la produzione metallurgica e le sue molteplici implicazioni inrelazione ai contesti di carattere votivo e sacrale di età protostorica, in iD. (a cura di),Miscellanea protostorica 2006, “Quaderni di Protostoria” 3, Perugia, pp. 18-69.
CaSini S., FoSSati a. e. 2004 – le figure di armi dell’età del Rame sulla roccia 23 di Foppedi Nadro, in iiD. (a cura di), le pietre degli dèi. Statue-stele dell’età del Rame ineuropa: lo stato della ricerca, atti del Congresso internazionale (Brescia, 16-18settembre 2004), “notizie archeologiche Bergomensi” 12, Bergamo, pp. 313-337.
Cattaneo CaSSano a. 1996 – Ritrovamenti di asce in pietra levigata in siti dell’età delFerro e di età storica, in VentUrino gaMBari 1996, pp. 251-253.
DaL ri L., teCChiati U. 2002 – I gewässerfunde nella preistoria e protostoria dell’areaalpina centromeridionale, in zeMMer PLanCK L. (a cura di), Kult der Vorzeit in denalpen. Opfergäben – Opferplätze – Opferbrauchtum / Culti nella preistoria delle alpi.le offerte – i santuari – i riti, 2 voll., Bolzano, parte ii, pp. 457-491.
DaViD w. 2002 – Studien zu Ornamentik und Datierung der bronzezeitlichenDepotfundgruppe Hajdúsámson-apa-Ighiel-Zajta, “Muzeul national al Unirii albaiulia – Bibliotheca Musei apulensis” XViii, teil 1, alba iulia.
De MariniS r. C. 1972 – Materiali dell’età del Bronzo dalla Valcamonica e dal Sebino(Brescia), in “Bollettino del Centro Camuno di Studi Preistorici” Viii, pp. 159-197.
De MariniS r. C. 1978 – lagazzi di Vhò (Cremona), in “Preistoria alpina” 14,pp. 271-273.
De MariniS r. C. 1994 – Problèmes de chronologie de l’art rupestre du Valcamonica,in “notizie archeologiche Bergomensi” 2, pp. 99-120.
De MariniS r. C. 1998 – la metallurgia dell’antica e Media età del Bronzo in Piemonte,in MerCanDo L., VentUrino gaMBari M. (a cura di), archeologia in Piemonte1. la preistoria, torino, pp. 157-186.
De MariniS r. C., SaLzani L. 1997 – le necropoli del Bronzo Medio e Recente nellalombardia orientale e nel Veneto occidentale, in BernaBò Brea M., CarDareLLi a.,CreMaSChi M. (a cura di), le terramare. la più antica civiltà padana, Catalogodella Mostra, Venezia, pp. 703-719.
De MariniS r. C., SaLzani L. 2005 – tipologia e cronologia dei materiali, in SaLzaniL. (a cura di), la necropoli dell’età del Bronzo all’Olmo di Nogara, “Memorie delMuseo Civico di Storia naturale di Verona – 2a serie, Sezione Scienze dell’Uomo”8, Verona, pp. 391-448.
18
Martinotti 2013_Layout 1 09/10/13 09:56 Pagina 18
DeL LUCCheSe a., gaMBari F. M. 2006 – l’area alpina sud-occidentale e il mondo ligure,in VitaLi D. (a cura di), Celtes et Gaulois, l’archéologie face à l’Histoire 2: laPréhistoire des Celtes, actes de la table ronde de Bologne-Monterenzio (28-29maggio 2005), “Bibracte” 12/2, glux-en-glenne, pp. 179-196.
DUranD g. 1972 – le strutture antropologiche dell’immaginario, Bari.FeDeLe F. 1999 – le ricerche del Pian dei Cavalli nel contesto del popolamento preistorico
della Valchiavenna, in Poggiani KeLLer r. (a cura di), atti del II Convegnoarcheologico Provinciale, “Quaderni del Parco delle incisioni rupestri di grosio” 3,Sondrio, pp. 17-34.
FoSSati a. 2001 – le armi nell’arte rupestre dell’età del Bronzo: depositi votivi disostituzione e rituali iniziatici nelle alpi, in FoSSati, Frontini 2001, pp. 105-112.
FoSSati a., Frontini P. (a cura di) 2001 – archeologia e arte rupestre. l’europa – le alpi– la Valcamonica, atti del 2° Convegno internazionale di archeologia rupestre(Darfo/Boario terme, 2-5 ottobre 1997), Milano.
Frontini P. 2001 – aspetti rituali delle deposizioni di armi durante l’età del Bronzo inItalia settentrionale: alcuni spunti, in FoSSati, Frontini 2001, pp. 113-120.
gaggia F. 2004 – le incisioni rupestri del Monte Baldo, in “Bollettino del CentroCamuno di Studi Preistorici” 34, pp. 159-168.
gaMBari F. M. 2004 – le vie tra il grande fiume e il mare. le prime fasi dell’età delBronzo nelle valli Curone e Grue, in VentUrino gaMBari M. (a cura di), allaconquista dell’appennino. le prime comunità delle valli Curone, Grue e Ossona,torino, pp. 79-88.
gernet L. 1983 – antropologia della Grecia antica, Milano.gUiDi a. 2009 – aspetti della religione tra la fine dell’età del Bronzo e la I età del Ferro,
in Drago troCCoLi L. (a cura di), Il lazio dai Colli albani ai Monti lepini trapreistoria ed età moderna, roma 2009, pp. 143-151.
gUiLaine J., zaMMit J. 2005 – the Origins of War. Violence in Prehistory, oxford.KienLin t. L. 2006 – Waffe – Werkzeug – Barren: zur Deutung frühbronzezeitlicher
Randleistenbeile in Depotfunden des nordalpinen Raums, in wotzKa h.-P. (a curadi), Grundlegungen. Beiträge zur europäischen und afrikanischen archäologie fürManfred K. H. eggert, tübingen, pp. 461-476.
LaVrSen J. 1982 – Weapons in Water. a european sacrifical rite in Italy, in “analectaromana instituti Danici” Xi, pp. 7-25.
Mano L. 1996 – la cote dei fulmini. Sopravvivenza di un mito, in VentUrinogaMBari (a cura di) 1996, pp. 15-22.
Marretta a. 2004 – l’arte rupestre della Valcamonica e della Valtellina. Stato dellaricerca, in “Bollettino del Centro Camuno di Studi Preistorici” 34, pp. 175-208.
Martinotti a. 2009 – instrumentum rituale. Simbologia ed ideologia della “paletta”nell’Italia protostorica tra archeologia ed arte rupestre, in anati e. (a cura di), Makinghistory of prehistory: the role of rock art / Produrre storia dalla preistoria: il ruolodell’arte rupestre, Pre-atti del XXiii Valcamonica Symposium (Capo di Ponte,28 ottobre-2 novembre 2009), Capo di Ponte, pp. 243-254.
MaUSS M. 2002 – Saggio sul dono. Forma e motivo dello scambio nelle società arcaiche, torino.
19
Martinotti 2013_Layout 1 09/10/13 09:56 Pagina 19
Mayer e. F. 1977 – Die Äxte und Beile in Österreich, “Prähistorische Bronzefunde”iX, 9, München.
PaSotti M. 1971 – la pietra di Castelletto, in “Bollettino del Centro Camuno di StudiPreistorici” 6, pp. 67-76.
Peroni r. 1996 – l’Italia alle soglie della storia, roma-Bari.Peroni r. 2004 – Culti, comunità tribali e gentilizie, caste guerriere e figure di eroi e
principi nel secondo millennio in Italia tra europa centrale ed egeo, in MarzatiCoF., gLeirSCher P. (a cura di), Guerrieri, principi ed eroi fra il Danubio e il Po dallaPreistoria all’alto Medioevo, Catalogo della Mostra, trento, pp. 161-173.
Poggiani KeLLer r. 1989 – Valtellina e Valchiavenna nella preistoria e protostoria.Ritrovamenti e siti dal Mesolitico all’età del Ferro, in eaD. (a cura di), Valtellina emondo alpino nella Preistoria, Catalogo della Mostra, Modena, pp. 24-68.
Poggiani KeLLer r. 1999 – Ricerche e scavi in Valtellina, in eaD. (a cura di), atti delII Convegno archeologico Provinciale, “Quaderni del Parco delle incisioni rupestridi grosio” 3, Sondrio, pp. 41-62.
ProSDoCiMi a. L. 1989 – la religione degli Italici, in PUgLieSe CarrateLLi g. (a curadi), Italia omnium terrarum parens. le civiltà degli enotri, Choni, ausoni, Sanniti,lucani, Brettii, Sicani, Siculi, elimi, Milano, pp. 475-546.
roBertS B., ottaway B. S. 2003 – the use and significance of socketed axes during thelate Bronze age, in “european Journal of archaeology” 6, 2, pp. 119-140.
SanSoni U. 2006 – la sacralità della montagna: la Valsaviore, le alpi, i Monti degli Dèi,Capo di Ponte-Boario terme.
SanSoni U., gaVaLDo S., gaStaLDi C. 1999 – Simboli sulla roccia. l’arte rupestre dellaValtellina centrale dalle armi del Bronzo ai segni cristiani, “archivi” vol. 12, Capodi Ponte.
StrahM Ch. 1965-1966 – Renzenbühl und Ringoldwil. Die Fundgeschichte zweierfrühbronzezitlicher Komplexe, in “Jahrbuch des Bernischen historischen Museums”45-46, pp. 321-371.
teCChiati U. 2007 – Manifestazioni di culto nella preistoria e nella protostoria del corsoalpino dell’adige. Proposte interpretative e spunti metodologici, in Il Baldonell’antichità, atti del primo incontro di studi e ricerche archeologiche (CaprinoVeronese, 20 maggio 2006), “Quaderni culturali caprinesi” 2, pp. 42-63.
torBrügge w. 1972 – Vor- und frühgeschichtliche Fluβfunde. Zur Ordnung undBestimmung einer Denkmälergruppe, in “Bericht der römisch-germanischenKommission des Deutschen archäologischen instituts” 51-52, pp. 1-145.
toreLLi M. 1986 – la religione, in PUgLieSe CarrateLLi g. (a cura di), Rasenna.Storia e civiltà degli etruschi, Milano, pp. 157-237.
VentUrino gaMBari M. (a cura di) 1996 – le vie della pietra verde. l’industria liticalevigata nella preistoria dell’Italia settentrionale, Catalogo della Mostra, torino.
VULPe a. 1970 – Die Äxte und Beile in Rumänien I, “Prähistorische Bronzefunde” iX,2, München.
zaMagni B. 1996 – l’ascia come simbolo. Prestigio, distinzione sociale, accumulo diricchezza, in VentUrino gaMBari (a cura di) 1996, pp. 144-145.
20
Martinotti 2013_Layout 1 09/10/13 09:56 Pagina 20