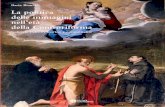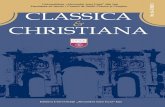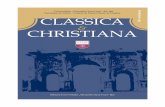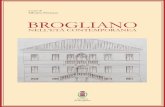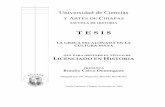La politica delle immagini nell'età della Controriforma. Gabriele Paleotti teorico e committente.
LE DONNE DELLA MEDICINA NELL'ETà CLASSICA GRECA E ROMANA. Medicae, obstetrices, iatromeae in the...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of LE DONNE DELLA MEDICINA NELL'ETà CLASSICA GRECA E ROMANA. Medicae, obstetrices, iatromeae in the...
LE DONNE DELLA MEDICINA NELL'ETà CLASSICA GRECA E ROMANA.
di Massimiliano Visalberghi Wieselberger
ABSTRACT:
A small essay, depicting the role of the doctor feminine in Greek and roman times, by analizing fonts, archaeological evidencies as well as epigraphy.
Un breve saggio che illustra il ruolo della donna medico ai tempi greci e romani, attraverso l'analisi di fonti, evidenzearcheologiche e epigrafiche.
-GRECIA-
Sebbene nella concezione della mentalità greca, la donna fosse inferiore all'uomo, e per questo segregata a compiti che la esulavano dalla "politikè", ovvero dall'essere una attiva cittadina, vi sono figure che possono vantare di aver ribaltato questa presa di posizione, contribuendo con il loro ruolo edimpegno, alla formazione di uno spiraglio di cambiamento nell'ottica del tempo.Donne che si fecero un nome nella storia, come nel loro campo. Uno di questi campi è la medicina.
In realtà, sebbene occasionalmente, gia' in epoca precedente,alcune figure vengono menzionate, come detentrici ed esperte delle arti curative:
-Agamede, figlia del re degli Epei, che presta aiuto e soccorre
i feriti sul campo di battaglia nella pianura di Troia"conosceva tutti i rimedi quanti l'ampia terra dona"(Iliade, XI, 740-741)
-Elena, regina di Sparta, famosa per La guerra di Troia, è detta guaritrice e conoscitrice delle arti mediche. Si narrava che avesse studiato con la famosa Polidamna ("domatrice di molti mali"), in Egitto, terra che Omero presenta come la patria della medicina, dai tempi del fondatore dell'arte, Pèone, medico degli Dei. Ricordata per il " nepento", una droga con "il potere di eliminare ogni angoscia e ira e di cancellare ogni ricordo doloroso" i cui ingredienti la maestra egizia trasmise ad Elena (Odissea, IV, 227-232)
Ma è solo a partire da una rinomata figura, che rappresenta la lotta al diritto dell'espressione individuale femminile, che la donna potrà finalmente esprimere la professionalità medica.Stiamo parlando di..
-Agnodike
Nata ad Atene, nel IV° sec a.C. dove era proibito alle donne o agli schiavi studiare medicina, secondo quanto racconta Igino, Agnodice decise di travestirsi da uomo per poter divenire allieva di Erofilo, scegliendo come campi d'azione per la sua futura professione l'ostetricia e la ginecologia. Tuttavia, il successo che ebbe in città, dovuto proprio al fatto di essere una donna tra le donne, le suscitò la gelosiadi molti colleghi uomini, che la citarono davanti all'Areopago, cioè al tribunale più antico di Atene. Qui fu accusata di approfittarsi delle sue pazienti e di corromperle sessualmente. La donna allora rivelò all'assemblea il suo sesso. Venne allora accusata di aver violato la legge vigenteche non le permetteva di accedere alla professione medica. A suo favore intervenne allora la folla delle donne aristocratiche della città, le stesse che lei aveva curato.
Esse ottennero che la legge fosse abolita.
fonti:Igino, fab. 274H. King, Agnodike and he profession of medicine, "Procedings Cambridge Philol. Society", n.s. XXXII, 1986
Storia o leggenda dalle sfumature allegoriche, sta di fatto che dopo di lei, altre figure vengono riportate dalle fonti:
-Artemisia II, regina di Caria, (... – 350 a.C.) conoscitricedi erbe medicinali, (Plinio, Nat. Hist., XXXVI), citata da Ippocrate. Da cui il nome dell'assenzio, Artemisia appunto.
- Mousa di Bisanzio, figlia di Agatocle, "iatrine" (donna medico) ricordata in una stele funeraria, II°-I° sec a.C. ritrovata aBisanzio.E' raffigurata (fig. 1) con velo mentre tiene in mano un libro, accompagnata da una giovane e con coppia di cani adoranti ai suoi piedi. (Firatli N. Robert, 1964, pp. 96-97)
Fig. 1: Mousa, di Bisanzio, figlia di Agatocle, donna medico, II° -I° a.C.
-Antiochis di Tlos, (fig.2)
(in greco Ἀντιoχίς) – (medico greco, Tlos, Licia, odierna Turchia, I sec. a.C.).Figlia del medico Diodoto di Tlos, in Licia, nella provincia di Antalya (odierna Turchia), professò medicina nella sua città natale, dove era tenuta in grande considerazione, tanto che alla sua morte le venne eretta una statua che, alla base, reca
attualmente la seguente iscrizione:
Ἀντιοχὶς Διοδότοu Τλωὶς μαρτυρηθεῖσα ὑπὸ τῆς Τλωέων βουλῆς καὶ τοῦ δήμου ἐπὶ τῇ περὶ τὴν ἰατρικὴν τέχνην ἐνπειρίᾳ ἔστησεν τὸν ἀνδριάντα ἑαυτῆς
“Antiochis, figlia di Diodoto di Tlos, ha ricevuto un riconoscimento speciale da parte del Consiglio ed il popolo di Tlos per la sua esperienza nell’arte della guarigione, questastatua di lei appose” ( Pleket, Epigraphica Vol. II , no.12.)
La statua riporta più di quanto appaia. Infatti è datata allaprima metà del I sec. a.C. Inoltre il citato padre Diodoto diTlos corrisponde certamente al Diodoto conosciuto tramite la "De Materia Medica" di Dioscoride del I sec. d.C. (Diosc. De Materia Medica, VIII), che lo ritiene un’autorità in campo medico..
Il famoso medico empirista Eraclide di Taras/Taranto del I° sec. a.C., aveva scritto in onore di Antiochis un libro sull'emorragia dal naso. (epistassi).La menziona in una sua lettera ( Gossen, s.v. ‘Heraclides of Tarentum’,RE vol. 8, 493–496, no. 54)
Antiochis viene ricordata come una illustre figura di medico, specializzata in reumatologia, artriti e nelle malattie dellamilza. (citata nelle fonti da Galeno, 12.691 e 13.250, 13.34;Plinio il Vecchio, Sorano di Efeso.)
fig.2: dedica ad Antiochis, figlia di Diodotos di Tlos, I° a.C.
-Epitaffio di Pantheia, curatrice (II sec. d.C.) (fig. 3)
“Pantheia, tuo marito ti dice addio. Da quando te ne sei andata, non cesso di soffrire della tua morte crudele. Hera, dea del matrimonio, non ha mai visto sposa pari a te, bellezza, saggezza, castita’ pari alle tue. Mi hai dato figlia mia immagine. Ti sei presa cura dei figli e del marito. Hai retto il timone della vita nella nostra casa, e hai levato alta la nostra fama in campo medico: anche se eri una donna, le tue abilita’ in medicina non erano inferiori alle mie. In riconoscimento di questo, il tuo sposo Glicone ti ha eretto questa tomba. Ho seppellito qui anche il corpo di mio padre, l’ immortale Filadelfo, e anch’io giacero’ qui quando saro’ morto. Come solo con te ho diviso il mio letto, cosi’ possa coprirmi la stessa terra che copre anche te”. ( Pleket, Epigraphica Vol. II , no.20)
fig. 3: Pantheia, medico donna. dedica del marito medico Glicone, II° d.C.
-Elefantide di Lemno, o Laide chirurga e ginecologa (citata da Galeno, Plinio il Vecchio, Plinio, Naturalis historia, XXVIII, 23, 81. Sorano di Efeso)
-Plinio il Vecchio rammenta Salpe di Lemno, esperta "ocularia" (oftalmologa).
-E' sempre Plinio, che ricorda anche Olimpia di Tebe, rinomata ginecologa.
-ROMA-
Nel mondo romano, non abbiamo notizie dirette di donne-medico, almeno fino al periodo tardo repubblicano.Periodo in cui, dato il contatto derivante dall'assoggettazione dei territori greci, le arti classiche penetrarono e fiorirono.Tramite artigiani, letterati, artisti, e professionisti.Tra di essi anche la figura del medico (medicus) e del chirurgo (chirurgus, dal greco cheiro- mano-urghè- opera).E' ben probabile, che agli inizi, molte di tali figure furonoschiavi, e successivamente liberti.Idem appare, per la controparte femminile, considerando l'alto numero di queste categorie tra le iscrizioni ritrovate, e inerenti al I a.C.-I° d.C. (fig. 4-9)
Ruoli:
La donna risulta avere diverse mansioni nel campo delle cure mediche, con specializzazioni differenti, sebbene a volte, presenti in un'unica figura.Il ruolo piu' conosciuto, e citato dalle fonti è sicuramente quello di
1) "obstetrix" ovvero, l'ostetrica, simile al ruolo moderno ("Sine obstetricis operā", Plaut. Cistellaria. 1, 2, 22; id. Captivi. 3, 4, 96: "mittere ad obstetricem", Ter. Andria. 3, 1, 5; Hor. Epodes. 17, 51; Vulg. Exod. 1, 15: "obstetricum nobilitas", Plin. 28, 6, 18, § 67; Paul. Sent. 2, 24, 8 sq.)E' da notare che il ruolo della donna non fu solamente relegato al mestiere di "obstetrix" (Gourevitch 1984: 220-223; Andrè 1987: 125-130; D'Amato 1993: 37-39.); ma anche di ginecologa.
Strumenti divaricatori vaginali ed anali e pestelli. Dal Museo di Napoli
2) "ocularia" che rappresenta l'omonima categoria maschile.(Scrib. Comp. 37.) In questo ruolo, si possono annoverare tutte le conoscenze di unguenti, colliri e pomate, giunte sino a noi, come adesempio, le sostanze ritrovate nella cosiddetta"tomba dell'oculista", appartenente ad una donna, rinvenuta nel 1847 a Fontenay-le-Compte in Francia, e datata al II° a.C. (fig. 10) Conteneva pigmenti e preparazioni secche per tali medicamenti.(Fillon, 1847, pp. 618-621; 1849; Boyer, 1990, pp.215-249; 2002, pp.135-142; G. Erba, 2014,
Slanosiietum. p. 26)
Fig. 10: repertorio di filtri ed alambicchi dalla cosiddetta "tomba dell'oculista donna" gallo-romana da Saint-Médard-des-Prés (Vendée), II° a.C., museo di Fontenay-le-Comte (Vendée)
Inoltre, vi è anche il termine
3) "iatromea", (Gourevitch 1984: 224; Andrè 1987: 125; d'Amato 1993: 37.) citata da Plinio, (Plin. 29, 1, 2, § 4) e presente in un'iscrizione (Inscr. Orell. 4232.): come esperta di pozioni ed unguenti, che, al pari del ruolo dell'ocularia,parrebbero suffragate dal trattato di Dioscoride, medico greco del I° d.C nella cui opera in 5 libri, "De materia medica", viene descritta la preparazione, persino mediante un processo di distillazone, di tali farmaci.
Un rilievo gallo-romano, da Grand (Vosges), II° d.C.. ora al museo d' Epinal (France), sembra raffigurare proprio una
donna dedita a tale professione (fig. 11).
fig. 11: "meditrina" ovvero iatromea, farmacista gallo-romana. . ritrovata a Grand (Vosges), II° d.C. museo d'Epinal (Francia),
O forse il significato del nome si riferiva ad un ruolo di subaltenità od intermedio, rispetto alla
4) "medica" (Gourevitch 1984: 223-226; Andrè 1987: 130-132; D'Amato 1993: 39-41.) avvicinabile a quello del greco "iatrine" e riferito al medico donna: è indubbio che il loro sapere le avesse portate ad essere considerate allo stesso livello dei colleghi maschili, come vedremo. Sebbene, raramente, questa professione portava ad un reddito superiore alla norma.Da ricordare inoltre che il medicus era valutato il vero esperto; mentre il chirurgo era considerato subalterno ad esso, solo capace di eseguire gli interventi operatori.
Strumenti chirurgici sono stati ritrovati in tre tombe femminili: 2 in Germania ed una in Spagna (Kunzl, 1995b, ein archaeologisches problem, pp. 309-319)Inoltre un corredo di strumenti appartenente ad una donna proviene da Pompei (R. Berg, Donne medico a Pompei? in: Donna e lavoro nella documentazione epigrafica : atti del 1. Seminario sulla condizione femminile nella documentazione epigrafica : Bologna, 21 novembre 2002 a cura di Alfredo Buonopane e Francesca Cenerini.)
Tale ritrovamento ci illustra la medesima situazione dei colleghi maschili: ovvero l'ambulatorio ("Medicatrina" o taberna medicorum ), come un ambiente spartano con cassepanche, cassette per gli atrezzi, sedie, uno scriptoriume un lettino.
Queste donne, sembra avessero le seguenti strade per formarsi: avvicinarsi ad un medico esperto come apprendiste, fosse egli un servo, o il padrone; se non in alcuni casi, il marito stesso. Come le fonti riportano.
-Un'attestazione del I° caso è data dall'iscrizione denominata ‘Restituta’, (IG XVI 1751), in cui una donna di nome "Restituta" appone una dedica al suo maestro e padrone, Claudio Alcimo, medico di Cesare (non vi è certezza di quale Cesare si tratti). L'iscrizione è comunque databile dal I° d.C.(Irving, 2011)
E' comunque assodata la presenza della "medica" , ovvero il medico donna. Marziale, maliziosamente, ci dà un indizio della loro esistenza riportando:
"Et fieri quod non facit ipse sinitprotinus accedunt medici medicaeque recedunt.."
"E permette che venga fatto ciò' che egli non riesce a fare più. Vengono subito i medici e vanno via i medici "donne" […] (Marziale, XI, 71 )
Iscrizioni e fonti appaiono suffragare il poeta latino.Si ritiene utile riportare alcune figure di donne conosciute per le proprie conoscenze nel campo medico:
-Naevia Clara, (fig. 12) medica philologa Roma. Cippo con
iscrizione. (da Masci la collezione, tav iX, fig. 4)
Fig. 12: Naevia Clara, medica philologa Roma. Cippo con iscrizione. (da Masci la collezione, tav iX, fig. 4)
-Julia Pieris da un'iscrizione su stele, a Treviri. 'Julia Pieris, ostetrica, riposa qui. Non fece mai del male a nessuno' (fig. 13).
Fig. 13: stele di Julia Pieris a Treviri. 'Julia Pieris, ostetrica, riposa qui. Non fece mai del male a nessuno'.
-Nel trattato “De compositione medicamentorum” Scribonio sosteneva che alcune esponenti della famiglia imperiale fossero esperte nei farmaci tanto quanto Galeno. Ovvero: Messalina, la terza moglie di Claudio; Livia, moglie di Augusto; Ottavia, la sorella di quest'ultimo; e Giulia, la figlia.
Se gia' Messalina non brillava comunque per principi morali, e di certo non Giulia, per la sua ostentata ribellione all'integrità del padre, vi sono pero' figure ancora piu' oscure, che misero la loro conoscenza al servizio non della cura, bensi' della morte..
-Lucusta, nota anche come Locusta (Gallia, ... – Roma, 9 gennaio 69 d.C.), fu una delle prime avvelenatrici seriali della storia.
Nata in un luogo imprecisato della Gallia, si trasferì adolescente a Roma. Possedeva un emporio sul colle Palatino, dove vendeva veleni ed elisir di ogni tipo; Profonda conoscitrice della farmacologia; e per questo molto popolare come avvelenatrice. Era molto richiesta soprattutto dalle classi ricche per sbarazzarsi di parenti o amanti, ma talvolta usò le sue conoscenze anche per diletto personale.
Venne chiamata da Agrippina Minore per uccidere l'Imperatore Claudio, forse avvelenato con un piatto di funghi.( Cassio Dione, libro LX, XXXIV; Tacito, libro LX, XXXIV) Nel 55 fu condannata a morte per questo omicidio, ma Nerone, venutone a conoscenza, mandò un tribuno del pretorio per salvarla dall'esecuzione. In cambio di ciò, le fu ordinato di avvelenare Britannico. Riuscita nel suo obiettivo, ebbe da Nerone il perdono e perfino possedimenti terrieri.(Svetonio, libro VI, XXXIII) Durante la rivolta contro Nerone, fornì del veleno all'imperatore, affinchè lo usasse per suicidarsi.( Svetonio, libro VI, XLVII)
Sette mesi dopo il suicidio di Nerone, Lucusta fu condannata a morte dall'imperatore Galba, condotta in catene per tutta Roma e giustiziata durante le Agonalia dedicate a Giano.( Cassio Dione, libro LXIV, III) Non si sa di preciso con quale metodo venne giustiziata: la leggenda vuole che venne violentata da una giraffa e poi fatta a pezzi da vari animaliferoci.. Una delle prime citazioni di Locusta nella letteratura apparenelle Satire di Giovenale, dove si parla di una donna che "alle sue parenti inesperte insegna, meglio di Locusta, come seppellire le spoglie grigie dei mariti tra le chiacchiere della
gente"(Giovenale, libro I, LXXI).
Ma vi sono anche figure che hanno contribuito profondamente alla formazione del pensiero moderno sulla cura:
-Cleopatra, vero nome, Metrodora, (Parker, 1997, pp. 131-150) ginecologa e dermatologa, scrisse nel II° d.C. un trattato "de Geneticis" Tale manuale venne usato almeno fino al VI° d.C. E successivamente ripreso.
-Aspasia, ginecologa, chirurga e ostetrica, scrisse un trattato, nel II° d.C. a lungo (o volutamente) ritenuto opera di un omonimo maschile, Aspasio. (P. Manuli, Parigi, 1980, pp. 393 Fisiologia e patologia del femminile negli scritti ippocratici dell'antica ginecologia greca, in : Hippocratica,atti del colloquio, Parigi, 4-9 settembre 1978).
Alcune "medicae" oltre alla famigerata Lucusta, provengono dai territori gallici, ma con piu' limpide e riconosciute capacità:
-Nimes Flavia Hedone, donna medico, vissuta nel I° d.C. da un'iscrizione (Cil. XII, 3343)
- Sextilia, dalla città odierna di Bourbonne-les-Bains, nel territorio dei Galli Lingoni, citata in una dedica a Borvo e Damona, riporta l'effige "med(ica)", rimarcata dalle caratteristiche delle due divinità, legate alla sfera terapeutica e medica.
-Metilia Donata (fig. 14)
Medico di Lugdunum (odierna Lione), citata in un'iscrizione sul suo monumento funerario, a Lione, come donna medico,
che dono' alla città un edificio pubblico.
CIL XIII 2019 Metilia Donata Medio[m(atrica)] \ de sua pecunia dedit \ l(oco) d(ato) d(ecreto) d(ecurionum).
Fonti:
J. Rougè, una iscription de medecine au Musèe de Lyon, in "Centre Jean Paulerne, Memoires III, Medecines et medecine de l'Antiquitè" St. Etienne 1982, pp. 165-170D. Gourevitch, Le mal d'etre femme. La femme et la medecine dans la rome antique, Paris, 1984, p. 225J. Andre', etre medecin à Rome, Paris, 1987, p. 132Cristofori, non arma virumque, le occupazioni nell'epigrafia del Piceno, Bologna 2000, pp. 229-234 C. D'Amato, la medicina, Roma, 1993, pp. 39-41
Fig. 14: iscrizione dell'atto di donazione di edificio pubblico di Metilia Donata, Lione, Musee del Civization
-Aemilia Hilaria
medico gallo-romana.(in latino: Aemilia Hilaria; 300 – 363)Si dedicò completamente alla professione di medico, allora considerata appropriata solo agli uomini.Si occupò come madre surrogata del nipote poeta Decimo Magno Ausonio, che ha parlato di lei nella sua opera Parentalia. Per avere completa libertà rinunciò ad un eventuale coniuge e venne soprannominata virginitas devota (vergine consacrata).
fonti: Ausonio, Parent. VIII, 5-6A.Pellertier, la femme dans la societè gallo-romaine, Paris 1984, pp 68-69D. Gourevitch, Le mal d'etre femme. La femme et la medecine dans la rome antique, Paris, 1984, pp. 121, 226J. Andre', etre medecin à Rome, Paris, 1987, p. 131C. de Filippis Cappai, Medici e medicina in Roma antica, Torino 1993, p. 210G. Cloke, This Female Man of God: Women and Spiritual Power in the Patristic Age, 350-450 AD ed. Routledge 2003, pp 160
Da Metz, infine abbiamo una stele funeraria, con un rilievo che rappresenta una donna con in mano una cassettina degli atrezzi medici, confermata dalla'iscrizione "medica" sulla parte superore della stele. (fig. 15)
fig. 15: Stele gallo-romana d'una donna medico – II° sec d.C.- Museo di Metz
Conclusioni:
Jatromeae, oculariae, Ostetrices, Mediacae. Questi i titoli delle specialiste che lasciarono un segno nella storia della medicina, e nella storia dell'uomo.Un tempo, che ancora oggi vive nell'arte medica.
Fig. 4: lista delle donne medico (da: Alonso, 2011)
Fig. 5: lista delle donne medico (da: Alonso, 2011)
Fig. 6: lista delle donne ostetriche (da: Alonso, 2011)
Fig. 7: lista delle donne ostetriche (da: Alonso, 2011)
Fig. 8: lista delle donne ostetriche (da: Alonso, 2011)
Fig. 9: lista delle donne ostetriche (da: Alonso, 2011)
lista delle iscrizioni di medicae e obstetrices: (da Alonso, 2011)
Medicae 1. Naevia Clara (Roma) V. Nutton, Roman medicine, ANRW II 37. 1, 1993, 61; AE 2001, 263. C(aius) Naevius C(aii) l(ibertus) Phi[lippus] / medicus chirurg(us) / Naevia C(aii) l(iberta) Clara / medica philolog(a) / in fro(nte) ped(es) XI s(emis) / in agr(o) ped(es) XVI
2. Iulia Pye (Roma) CIL VI, 9614; H. Gummerus, op. cit., 36, n. 111; J. Korpela, op. cit., 178, n. 135. Iulia / Pye / medica
3. Melitine (Roma) CIL VI, 6851; H. Gummerus, op. cit., 23, n. 29; H. Thynlander, Inscriptions latines de San Michele d'Axel Munthe, Opuscula Romana, 4, 1962, 144, n. 42; J. Korpela, op. cit., 163, n. 42; M. Pavese, La colezione epigrafica di Villa San Michele, en B. E. Thomasson (ed.), A Survey of greek and latin inscriptions on stone in swedish collections, Jonsered, 1997, 58-59, n. 64. Roma Melitine / medica Appulei
4. Secunda (Roma) CIL VI, 8711; ILS, 7803; H. Gummerus, op. cit., 26, n. 42; J. Korpela, op. cit., 179, n. 140. Secunda / Livillaes / medica // Ti(berius) Claudius /
Caesaris l(ibertus) / Celer aeditu(u)s / a Vesta
5. Terentia Prima (Roma) CIL VI, 9616; H. Gummerus, op. cit., 36, n. 113; J. Korpela, op. cit., 190, n. 203. D(iis) M(anibus) / Terentiae / Niceni Terentiae / Primaes medicas li/bertae fecerunt / Mussius Antiochus / et Mussia Dionysia / fil(ii) m(atri) b(ene) m(erenti)
6. Minucia Asste (Roma) CIL VI, 9615 (p. 3470) = 33812; CIL XIII, *299; H. Gummerus, op. cit., 36, n. 112; J. Korpela, op. cit., 163, n.43. Minucia / (mulieris) l(iberta) Asste / medica
7. Venuleia Sosis (Roma) CIL VI, 9617; H. Gummerus, op. cit., 36, n. 114; J. Korpela, op. cit., 163, n. 46. Mª Ángeles ALONSO ALONSO Venuleia / (mulieris) l(iberta) Sosis / medica
8. Primilla (Roma) CIL VI, 7581 (p. 3852); ILS, 7804; H. Gummerus, op. cit., 24, n. 32; J. Korpela, op. cit., 200, n. 256. Deae sanctae meae / Primillae medicae / L(ucii) Vibi(i) Metilonis f(iliae) / vixit annis XXXXIIII / ex eis cum L(ucio) Cocceio / Apthoro XXX sine / querella fecit / Apthorus coniug(i) / optimae castae / et sibi
9. Anonyma (Roma) CIL VI, 8926; H. Gummerus, op. cit., 28, n. 59; J. Korpela, op. cit., 185, n. 176; R. Flemming, op. cit., 385, n. 4.
[Diis] Manibus / [Crescen]ti a frumento / [minist]ratorum Aug(usti) / [- - -] Caesaris medica / [ex familia c]astrensi coniugi / [optimo f]ecit et sibi posterisque suis
10. Iulia Sophia (Anacapri, Campania) AE 1972, 83. Iulia Sophia / Isidori Ti(berii) Caesaris / Augusti l(iberti) l(iberta) medic(a) / vixit annos XXII
11. Scantia Redempta (Capua, Campania) CIL X, 3980 (p. 976); ILCV, 615; ILS, 7805; H. Gummerus, op. cit., 61, n. 218; L. Chioffi, art. cit., 164, fig. 1; idem, Epigrafi di Capua dentro e fuori il museo provinciale Campano, Capua, 2008, n. 7. Scantiae Redemptae in/comparabilissimae feminae que/ius de vitae documenta non sufficit / mediocritas hominum at cumulum laudis / pervenire fuit namque iuvenis ista / omni genere laudis condigna primo deificae / sanctitatis pudicitiae vallata honestate morum / aetas in parentibus procliva castitate inlustris / [in]nata pi[t]enacitatis magistra (v)er(e)cundiae antistis disclipin[ae] / [in] medicina fuit et innocentiae singularis / [t]alisfuit ut esset exemplum matrimoni fuit t[alis] / ut contemneret iuventutem nam maritus am[isit ?] / co(n)iugem familiarem salutis et vitae suae nut[ric(em)] / haec vixit annis XXII mensibus X / Fl(avius) Tarentinus et Scantia Redempta / parentes filiae dulcissimae/ sibique fecerunt
12. Anonyma (Casale di Sabone, Latium) AE 1974, 192. [D(iis)] M(anibus) / [- - -]nae dulcis/[simae v]ixit annis XX[-
- - / - - -]zon con/iugi medic(ae) / [b(ene)] m(erenti) f(ecit)
13. Iulia Sabina (Auximum, Picenum) MEDICAE Y OBSTETRICES EN LA EPIGRAFÍA LATINA 291 CIL IX, 5861; H. Gummerus, op. cit., 57, n. 203. Deis Manib(us) / Iuliae Q(uinti) l(ibertae) / Sabinae / medicae / Q(uintus) Iulius Atimetus / coniugi / bene merenti 14. Octavia Artimisia (Pisaurum, Umbria) CIL XI, 6394; G. Cresci Marrone, G. Mennella, Pisaurum I. Le iscrizioni della colonia, Pisa, 1984, 330-331, n. 109. - - - - - - / [- - -] + + + + + viva fecit / Tutilia Cn(aei) Tutili(i) leib(erta) / Menotia hoc moniment(um) / fecit Octavia[e] Auli l(ibertae) / Artimisiae medicae
15. Sentia Elis (Verona, Venetia) CIL V, 3461; H. Gummerus, op. cit., 73, n. 273. C(aius) Cornelius / Meliboeus / sibi et / Sentiai / Elidi medicai / contuber(nali) / Sentiai Aste
16. Flavia Hedones (Nemausus, Gallia Narbonensis) CIL XII, 3343; H. Gummerus, op. cit., 88, n. 343; B. Rémy, Les inscriptions de médecins en Gaule, Gallia, 42, 1984, 126,n. 5. Flaviae / Hedones / medicae / ex testa/[mento]
17. Metilia Donata (Lugudunum, Gallia Lugdunensis) CIL XIII, 2019; J. Rougé, art. cit., 165-168, con foto; B. Rémy, art. cit., 138-139, n. 18, fig. 15. Metilia Donata medic[a] / de sua pecunia dedi[t] / l(oco) d(ato) d(ecreto) d(ecurionum)
18. Anonyma (Divodurum, Belgica) CIL XIII, 4334; H. Gummerus, op. cit., 91, n. 358; B. Rémy, art. cit., 145, n. 24, fig. 19. [- - -]SA[- - -]/ini f(ilia) medica
19. Iulia Saturnina (Emerita Augusta, Lusitania) CIL II, 497; EE VIII, 363, n. 16; ILS, 7802; H. Gummerus, op. cit., 84, n. 323; L. García Iglesias, Epigrafía romana deAugusta Emerita (tesis mecanografiada), Madrid, 1973, n. 293; B. Rémy, Les inscriptions de médecins dans les provinces romaines de la Péninsule Ibérique, Revue des Études Anciennes, 93, 3-4, 1991, 328-330, n. 3, lám. II, fig. 4. D(iis) M(anibus) s(acrum) / Iuliae Saturni[nae] / a[nn(orum)] XXXXV / uxori [inco]mpara/bili m[edica]e optimae / mulie[ri san]ctissimae / Cassius Philippus / maritus ob meritis / h(ic) s(ita) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)
20. Iulia [- - -] (Gades, Baetica) 11, 196. HEp Mª Ángeles ALONSO ALONSO Iulia +[- - -] / medika a[n(norum) - - -] / k(ara) s(uis). H(ic) s(ita) e(st), s(it) t(ibi) [t(erra) l(evis)]
21. Asyllia Polla (Carthago, Africa proconsularis) CIL VIII, 24679; H. Gummerus, op. cit., 82, n. 316; E. Pettenó, Acque termali e medici dell’Africa romana, en M. Khanoussi, P. Ruggeri, C. Vismara (coords.), L’Africa romana: atti dell’XI Convegno di Studio, Cartagine, 15-18 dicembre 1994, Ozieri, 1994, 397,n. 25, con foto. Asyllia L(ucii) f(ilia) Polla / medica h(ic) s(ita)e(st) / vixs(it) a(nnos) LXV / Euscius l(ibertus) d(e) s(uo) f(ecit)
22. Sextilia (Bourbonne-les-Bains, Germania Superior) CIL XIII 5919; H. Gummerus, op. cit., 93, n. 365; B. Rémy, Les inscriptions des médecins découvertes sur le territoire des
provinces de Germanie, Revue des Études Anciennes, 98, 1-2, 1996, 157-158, n. 19, fig. 10; Y. Le Bohec, Inscriptions de la cité des Lingons. Inscriptions sur Pierre, Paris, 2003, 135, n. 206. Boruoni / et Damo/nae / [Se]xtilia / [S]exti fil(ia) / med(ica) / - - - - - -
23. Sarmanna (Gondorf, Germania Superior) AE 1937, 17; R. J. Rowland Jr., Some new Medici in the Roman Empire, Epigraphica, 39, 1977, 176, n. 410; B. Rémy, art. cit., 150-151, n. 13. Hic iacet Sarman/na medica vixit / pl(us) m(inus) an(nis) LXX Pientius / Pientinus fili(i) et / Honorata norus / titolum posuerunt / in pace
Obstetrices
24. Helena (Roma) AE 1991, 126. Helena / Lucretiae / opstetrix
25. Teidia [- - -] (Roma) CIL VI, 37810; J. Korpela, op. cit., 163, n. 45. Sex(tus) Teidiu[s Sex(ti) l(ibertus)] / Ante[ros] / Teidia Sex(ti) [l(iberta)- - -] / opstetri[x]
26. Prima (Roma) CIL VI, 8948; J. Korpela, op. cit., 178, n. 137. Prima Liviae opstetrix Asterope Maximi (servus) / Epicharis Maximi (servus) mater
27. Sempronia Peloris (Roma) MEDICAE Y OBSTETRICES EN LA EPIGRAFÍA LATINA 293 CIL VI, 6832; J. Korpela, op. cit., 160, n. 29. Sempronia Peloris / Atratinae opstetrix / [- - -]ris v(ixit)
a(nnos) [- - -] / - - - - - -
28. Grattia Hilara (Roma) CIL VI, 9721; 9721 a; J. Korpela, op. cit., 178, n. 133. a) C(aius) Grattius / Hilarae / opstetricis l(ibertus) / Plocamus / a monte / Esquilino b) Grattia / (mulieris) l(iberta) / Hilara
29. Iulia [- - -]sia (Roma) CIL VI, 8949; J. Korpela, op. cit., 178, n. 136. [Iul]iae / [diva]e Aug(ustae) l(ibertae) / [- - -]siae / [obs]tetrici
30. Sallustia Athenais (Roma) CIL VI, 8192; J. Korpela, op. cit., 178, n. 138. Q(uintus) Sallustius / Diogae l(ibertus) / Dioges // Sallustia / Artemidori l(iberta) / Athen[ai]s / opstetrix
31. Sallustia Imerita (Roma) CIL VI, 8207; J. Korpela, op. cit., 178, n. 139. Sallustia Q(uinti) l(iberta) Imerita opstetrix / Q(uintus) Sallustius Q(uinti) l(ibertus) Artimidorus / p(atronus ?)
32. Antonia Thallusa (Roma) CIL VI, 8947; ILS, 1840; J. Korpela, op. cit., 179, n. 142. Antoniae Aug(ustae) l(ibertae) / Thallusae / opstetric(i)
33. Hygia (Roma) CIL VI, 4458; J. Korpela, op. cit., 178, n. 134. Hygia / Marcellae l(iberta) / obstetrix
34. Secunda (Roma) CIL VI, 6325; J. Korpela, op. cit., 179, n. 141. Secunda / opstetrix / Statiliae maioris
35. Hygia (Roma) CIL VI, 6647; J. Korpela, op. cit., 190, n. 202. Hygiae / Flaviae Sabinae / opstetr(ici) vixit ann(os) XXX / Marius Orthrus et / Apollonius contubernali / carissimae
36. Poblicia Aphe (Roma) CIL VI, 9723; J. Korpela, op. cit., 163, n. 44. Poblicia (mulieris) l(iberta) Aphe / opstetrix ossa tibi / bene quiescant / vixit annos XXI
37. Taxis (Roma) AE 1926, 52; AE 1991, 127. Mª Ángeles ALONSO ALONSO Taxis Ionidis Iulia[e Aug(ustae)] / opstetrix v(ixit) a(nnis)XXX[- - -] / Hesper et Epitync[hanus] vicari(i) de suo [fec(erunt)]
38. Iulia Veneria (Roma) CIL VI, 9722; J. Korpela, op. cit., 182, n. 162. D(iis) M(anibus) / Iuliae Vene/riae ops(t)etri/ci b(ene) m(erenti) / fecit / Iulius He/- - - - - -
39. [Volusia] Torquata (Roma) CIL VI, 9725 = 27558; J. Korpela, op. cit., 182, n. 163; M. Buonocore, Schiavi e liberti del Volusi Saturnini. Le iscrizioni del colombario sulla via Appia antica, Roma, 1984, 133, n. 102. [D(iis) M(anibus) s(acrum) / [Volusia]e D[m]oeni / [Volusiae To]rquataes ops(t)etrici / [Cl]audia Nome / [de s]e bene merenti
40. Claudia Trophime (Roma) CIL VI, 9720; J. Korpela, op. cit., 185, n. 175. Claudiae Trophim(e) / obs(t)etrici / T(itus) Cassius Trophimus f(ilius) / matri pientissimae et / Ti(berius) Cassius Trophimianus / aviae et posterisque suis / fecerunt / vix(it)ann(os) LXXV m(enses) V
41. Valeria Syra ? (Roma) CIL VI, 9724; J. Korpela, op. cit., 206, n. 285. [- - -]antiv [- - -V]aleriae Syre/[- - -] qu(a)e vixit annis XXXI
/ [- - -q]uo fecit annos VIIII et / [- - - de]posita pri(die)idus novem(bres) / [- - -]a filia obs(t)etricis
42. Secunda (Surrentum, Campania) AE 2005, 328. Secunda / Aug(ustae) l(iberta) opste/trix vix(it) ann(is) / XXIV
43. Maria Peregrina (Capua, Campania) CIL X, 3972; L. Chioffi, art. cit., 163. Mariae (mulieris) et Suavitti l(ibertae) / [P]eregrinae opstetrici
44. Coelia Hagne (Puteoli, Campania) CIL X, 1933; S. L. Tuck, Latin Inscriptions in the Kelsey Museum. The Dennison and the Criscio collections, Michigan, 2005, 80-81, n. 113. D(iis) M(anibus) / Coeliae Hagne / obs(t)etrici / M(arcus) Ulpius Zosimus / coniugi sanctissim(ae)
45. Scribonia Attice (Ostia, Latium) G. Calza, op. cit., 248-249 y 367; H. Thylander, Inscriptionsdu port d’Ostie, Lund, 1952, 162, A222, con foto; A. Helttula, Le iscrizioni sepolcrali latine nell'Isola sacra, Helsinki, 2007, n. 133. MEDICAE Y OBSTETRICES EN LA EPIGRAFÍA LATINA 295 H(uic) m(onumento) d(olus) m(alus) a(besto) / D(iis) M(anibus) / Scribonia Attice / fecit sibi et M(arco) Ulpio Amerimno / coniugi et Scriboniae Calli/tyche matri et Diocli et suis / et libertis libertabusque poste/risque eorum praeter Panara/tum et Prosdocia(m) h(oc) m(onumentum) h(eredem) e(xterum) n(on) s(equetur)
46. Hygia (Narnia, Umbria) CIL XI, 4128. Hygiae / Autroniae Fortunat(ae) / opstetrici / fecit Fidus / filius
47. Volusia (Tarquinii, Etruria) CIL XI, 3391; M. L. Caldelli, art. cit., 306-308, n. 50, tab.XVI, fig. 1; J. Kaimio, op. cit., n. 164. [V]olu[si]a [- - -]/ opstetrix / vixit annos [- - -]
48. Cleopatra (Forum Iulii, Gallia Narbonensis) AE 1979, 396; J. Gascou, M. Janon, Inscriptions Latines de Narbonnaise. Fréjus, Paris, 1985, 66-67, n. 30. - - - - - - /Niger P[- - -] / et Cleopa[trae - - -] / suae opst[etrici] / f(ecit)
49. Iulia Pieris (Augusta Treverorum, Belgica) CIL XIII, 3706. Iulia Pier/is obstetrix / hic iacet / nulli gra/vis
50. Irene (Thubursicu Numidarum, Africa proconsularis) CIL VIII, 4896; S. Gsell, op. cit., 135, n. 1377. Diis M(anibus) sac(rum) / Irene ops(t)e/trix Fausti / D(- - -) S(- - -) S(- - -) medici / v(ixit) a(nnis) XXXIII
51. Licinia Victoria (Utica, Africa proconsularis) AE 1903, 107; R. Cagnat, A. Merlin, Inscriptions Latines d’Afrique: Tripolitaine, Tunisie, Maroc, Paris, 1923, 125, n. 427. O(ssa) v(obis) b(ene) q(uiescant) // D(iis) M(anibus) s(acrum) / L(ucius) Valerius / Valerianus / pius vixit / annisLXII / m(enses) V dies VII // Licinia Victoria / ops(t)etrix / pia vixit / annis IL / m(enses) VI d(ies) XIIII // t(erra) v(obis) l(evis) s(it)
52. Caelia Bonosa Mazica (Mustis, Africa proconsularis) CIL VII, 15593; Z. Benzina Ben Abdallah, Catalogue des inscriptions latines païennes du Musée du Bardo, Roma, 1986, 150, n. 385. D(iis) M(anibus) s(acrum) / Caelia Bono/sa Mazica / obstetrix ma/rita castissi/ma et pudicis/[sima] vixit / [ann]is XXXXII / m(ensibus) III h(ic) s(ita) e(st) // D(iis) M(anibus) s(acrum) / Mª Ángeles ALONSO ALONSO P(ublius) Flavi/us P(ublii) f(ilius) / Corn(elia tribu) / Felix / p(ius) v(ixit) a(nnis) / LXXV / m(ensibus) VI h(ic) s(itus) e(st)
53. Aurelia Macula (Mactaris, Africa proconsularis) AE 1980, 936. D(iis) M(anibus) s(acrum) / Aurelia Ma/[c]ula p(ia) vixit / annis LVI / obs(t)etrix
54. Caelia Victoria (Thagaste, Numidia) CIL VIII, 5155; S. Gsell, op. cit., 84, n. 887; AE 1914, 240.D(iis) M(anibus) s(acrum) / Noviae / Dativae / boni o/minis /feminae / piae qui / v(ixit) a(nnis) XXXV / h(ic) s(ita) // D(iis) M(anibus) s(acrum) / Caeliae / Victori/ae obste/trici ra/rissimae / piae quae / vixit an/nis XXVI / h(ic) s(ita) //[C]ae[l]i[u]s Nori/[cus] coniugi et / [so]ror[i] caris/[si]mis
55. Aelia Sotere (Salona, Dalmatia) CIL III, 8820; A. y J. Šašel, Inscriptiones Latinae quae in Iugoslavia inter annos MCMXL et MCMLX repertae et editae sunt, Ljubljana, 1963, 60, n. 125. D(iis) M(anibus) / Aeliae Sotere ob/stetrici def(unctae) an(norum) XXXV / Ael(ius) Antonianus / Themistocles / libertae b(ene) m(erenti)
Fonti storiche:
-Decimo Magno Ausonio, Parentalia
- Bibbia Vulgata, Esodo
-Cassio Dione Cocceiano, Storia romana.
- Dioscoride, de materia medica, in: K. Sprengal, ed., Dioscorides. De Materia Medica,(Lipsiae: Knobloch, 1829), viii. -Dioscorides, De Materia Medica, pref. 5; J. Scarborough and V. Nutton, ‘The Preface of Dis-corides’ Materia Medica: Introduction, Translation, and Commentary’, Transactions and Studies of the College of Physicians of Philadelphia4 (1982): 187–227.
-Eraclide di Taranto, lettere in: Gossen, s.v. ‘Heraclides ofTarentum’,RE vol. 8, 493–496, no. 54
-Galeno in: Galeni opera omnia, Karl Gottlob Kühn (a cura di), 20 voll., Leipzig, Car. Cnoblochii, 1821-1833.
-Decimo Giunio Giovenale, Satire.
-Igino Astronomo, Fabulae
-Ippocrate, Corpus Hippocraticum
-Marco Valerio Marziale, Epigrammi
-Omero, Iliade
-Omero, Odissea
-Paulo di Tarso, lettere
-Tito Maccio Plauto, Cistellaria,; Captivi
-Plinio, Naturalis historia
-Scribonio, De compositione medicamentorum
-Sorano d'Efeso, Gynaecia
-Publio Cornelio Tacito, Annales.
-Publio Terenzio Afro, Andria
-Gaio Svetonio Tranquillo, Vite dei Cesari.
Fonti bibliografiche:
-M. Alic, (1999), Proffitt, Pamela, ed., "Agnodice", NotableWomen Scientists (Gale Group)
-Mª Ángeles ALONSO ALONSO, Medicae y obstetrices en la epigrafía latina del Imperio romano. Apuntes en torno a unanálisis comparativo / 267 in: Classica et Christiana 6/2 2011, UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” IA I FACULTATEA DE ISTORIE CENTRUL DE STUDII CLASICE
-J. Andre', etre medecin à Rome, Paris, 1987, p. 132
-A. Buonopane, Medicae nell'occidente romano: un'indagine preliminare, in Donna e lavoro nella documentazione epigrafica, Faenza 2003
-R. Berg, Donne medico a Pompei? in: Donna e lavoro nella documentazione epigrafica : atti del 1. Seminario sulla condizione femminile nella documentazione epigrafica : Bologna, 21 novembre 2002 a cura di Alfredo Buonopane e Francesca Cenerini.)
-Boyer 1990,: R. BOYER (dir.), « Découvertede la tombe d’un oculiste à Lyon (fin du IIe siècle après J.-C.), instruments et coffret avec collyres », Gallia, 47, 1990,p. 215-249.
-Boyer 2002: R. BOYER , « Collyres trouvésdans une tombe gallo-romaine à Lyon »,dans L’œil dans l’Antiquité 2002, p. 135-142
-C. de Filippis Cappai, Medici e medicina in Roma antica, Torino 1993, p. 210
-G. Cloke, This Female Man of God: Women and Spiritual Power in the Patristic Age, 350-450 AD ed. Routledge 2003, pp 160
-Cristofori, non arma virumque, le occupazioni nell'epigrafiadel Piceno, Bologna 2000, pp. 229-234
-C. D'Amato, la medicina, Roma, 1993, pp. 39-41
-G. Erba, Slanosiietum. Che guarisce, - Fillon 1847: B. FILLON, « Lettreà M. Letronne sur un tombeauantique découvert à Saint-Médard desPrés,
Fontenay le Comte (Vendée),12 novembre 1847 »,Revue archéologique ou recueil de documents et de mémoires relatifs à l’étude des monuments, à la numis-matique et à la Philologie de l’Antiquité et du Moyen Âge publiés par les principaux archéologues français et étrangerset accom- pagnés de planches gravées d’après les monu-ments originaux , Paris, IVe année, 1, du15 mars au 15 octobre 1847, p. 618-621, avec plan légendé de la tombe, p. 621.-Fillon 1849 : B. FILLON,Description de la villa et du tombeau d’une emme artiste gallo-romaine découverts à St-Médard des Prés (Vendée), Fontenay, 1849, lithographiéespar F. Ritter et O. de Rochebrun
-D. Gourevitch, Le mal d'etre femme. La femme et la medecine dans la rome antique, Paris, 1984, p. 225
-J. Irving, Restituta: The Training of the Female Physician, AM-PHORAE Conference at Macquarie University, Sydney, 30 September 2011
-H. King, Agnodike and her profession of medicine, "Procedings Cambridge Philol. Society", n.s. XXXII, 1986
- E. Künzl, Ein archäologisches Problem : Gräber römischer Chirurginnen. In : P.J. van der Eijk, H.F.J. Horstmanshoff, P.H. Schrijvers, Ancient medicine in its socio-cultural context, vol. I, 1995, 309-319.
-P. Manuli, Parigi, 1980, pp. 393 Fisiologia e patologia del femminile negli scritti ippocratici dell'antica ginecologia greca, in : Hippocratica, atti del colloquio, Parigi, 4-9 settembre 1978;
- R. Merkelbach, and J. Stauber.Die Südküste Kleinasiens, Syrien und Palaestina,(Leipzig: Walter deGruyter, 2002), 181
-J. Barràgan Nieto, El espacio de la mujer en la medicina romana, in Espacos e Paisagens, Antiguidade Clássica e Heranças Contemporâneas, VII Congresso da Associacao Portuguesa de Estudos Classicos, Evora, 10-12 Abril 2008
H.N. Parker, Women physicians in Greece, Rome, and the Byzantine Empire, in: Women Phisicians and healers: climbing a long hill. ed Lilian R. Furst. University Press ofKentucky, 1997 p. 131-150
-A.Pellertier, la femme dans la societè gallo-romaine, Paris 1984, pp 68-69
-Corrado Petrocelli, Il ruolo della donna nella storia della medicina, 20/09/2013 in Cultura, Settembre 2013.
-J. Rougè, una iscription de medecine au Musèe de Lyon, in "Centre Jean Paulerne, Memoires III, Medecines et medecine de l'Antiquitè" St. Etienne 1982, pp. 165-170