Peculiarità lessicali nel Dialogus miraculorum di Cesario di Heisterbach - Studi Medievali 55.1,...
Transcript of Peculiarità lessicali nel Dialogus miraculorum di Cesario di Heisterbach - Studi Medievali 55.1,...
STVDI MEDIEVALI
S E R I E T E R Z A
Anno LV - Fasc. I
2 0 1 4
FONDAZIONE
CENTRO ITALIANO DI STUDI SULL’ALTO MEDIOEVOSPOLETO
FONDAZIONE
CENTRO ITALIANO DI STUDISULL’ALTO MEDIOEVO
SPOLETO
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 3 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Cyan
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 3 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Magenta
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 3 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Yellow
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 3 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Black
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 3 lato A data 04/15/2014 colore A
ll
PR
EP
S
CMYKP
RE
PS
CMYK
SOMMARIO DEL FASCICOLO
ANTONIO PADOA SCHIOPPA, Giustizia civile e notariatonel primo Duecento comunale: il caso di Savona,1203-1206 ........................................................ pag. 1
RICERCHE
WIM FRANÇOIS, Augustine’s Heritage in Late MedievalBiblical Scholarship (1200-1500) ............................ » 25
VALENTINA LUNARDINI, Peculiarità lessicali nel Dialogusmiraculorum di Cesario di Heisterbach ................. » 75
BENOÎT DEBIÈVE, La plenitudo potestatis dans le Bre-viloquium de principatu tyrannico (1339-1341) deGuillaume d’Ockham ......................................... » 101
NOTE
ALBRECHT CLASSEN, The Mirror Image in Neidhart’sPoetry: Destabilization of the Social Structure byMeans of Sexual Competition .............................. » 165
FRANCESCA DELL’ACQUA, L’auctoritas dello pseudo-Dionigi e Sugerio di Saint-Denis .......................... » 189
THOMAS HAYE, Antonius de Bonanno und Jakob vonAragón (Bf. von Valencia 1369-1396). Ein Beitragzur Wirkungsgeschichte der Poetria nova Galfredsvon Vinsauf ..................................................... » 215
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 5 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Cyan
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 5 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Magenta
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 5 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Yellow
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 5 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Black
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 5 lato A data 04/15/2014 colore A
ll
PR
EP
S
CMYKP
RE
PS
CMYK
SOMMARIO DEL FASCICOLOVI
DISCUSSIONI
ELISABETTA BARTOLI - PATRIZIA STOPPACCI, Corrispon-denze edite ed inedite ......................................... pag. 229
LETTURE E CONGETTURE
BERNHARD SCHIRG, In bivio. Zur Lebenswegentscheidungals Motiv frühhumanistischer Selbstdarstellung bei Gerivon Arezzo und Francesco Petrarca ....................... » 299
RECENSIONI ...................................................... » 341
J. C. FRAKES (ed.), Contextualizing the Muslim Other in Medieval Christian Discour-se (A. Bertolacci), p. 341; E. GAMILLSCHEG, Manuscripta Graeca. Studien zur Ge-schichte des griechischen Buches in Mittelalter und Renaissance (D. Frioli), p. 344; J.HAINES (ed.), The Calligraphy of Medieval Music (L. Albiero), p. 351; M. LAUWERS
(ed.), La Dîme, l’Église et la Société Féodale (P. Tomei), p. 356; M. NARDELLO, Icarismi, forma dell’esistenza cristiana. Identità e discernimento (G. Cremascoli), p.359; P. VAN GEEST, The Incomprehensibility of God. Augustine as a Negative Theolo-gian (G. Alliney), p. 361; U. NAGENGAST, Gothorum florentissima gens. Gotenge-schichte als Heilsgeschichte bei Isidor von Sevilla (G. Fiesoli), p. 364; S. BAXTER, TheEarls of Mercia. Lordship and Power in Late Anglo-Saxon England (R. Canosa), p.366; M. ANSANI, Caritatis negocia e fabbriche di falsi. Strategie, imposture, disputedocumentarie a Pavia fra XI e XII secolo (G. Vendittelli), p. 371; I. CHABOT, Rico-struzione di una famiglia. I Ciurianni di Firenze tra XII e XV secolo. Con l’edizionecritica del « Libro propio » di Lapo di Valore Ciurianni e successori (1326-1429) (S. To-gnetti), p. 380; K. BUSBY and R. DALRYMPLE (eds.), Arthurian Literature XXII,XXIII (S. Gwara), p. 383; M. BERISSO (cur.), Poesia comica del Medioevo italiano(A. Bisanti), p. 386; M. SEIDEL, Padre e figlio. Nicola e Giovanni Pisano (A. Pero-ni), p. 391; M. BOURIN, J. DRENDEL et F. MENANT (éds), Les disettes dans la con-joncture de 1300 en Méditerranée occidentale (G. P. G. Scharf), p. 406; R. CARDINI -F. SZNURA (cur.), Coluccio Salutati. Cancelliere della Repubblica Fiorentina/Chancellorof the Florentine Republic. Carteggio Pubblico/Public Correspondence 1375-1406. Indiceonomastico e toponomastico/Onomastic and Toponomastic Index. Riproduzioni degli ori-ginali/Reproductions of originals in CD (D. De Rosa), p. 411; N. MARCELLI, Eros,politica e religione nel Quattrocento fiorentino. Cinque studi tra poesia e novellistica (A.Bisanti), p. 417; C. P. WEINBERG and E. A. MATTER (eds.), Education, Civic Vir-tue, and Colonialism in Fifteenth-Century Italy: The « Ogdoas » of Alberto Alfieri (A.Degl’Innocenti), p. 425.
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 6 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Cyan
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 6 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Magenta
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 6 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Yellow
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 6 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Black
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 6 lato A data 04/15/2014 colore A
ll
PR
EP
S
CMYKP
RE
PS
CMYK
SOMMARIO DEL FASCICOLO VII
NOTIZIE DEI LIBRI RICEVUTI ............................. pag. 429Notizie firmate ................................................... » 429Abbiamo inoltre ricevuto .......................................... » 454I libri della Fondazione CISAM ................................ » 484I libri della SISMEL - Edizioni del Galluzzo ................. » 489
A cura di: G. Alliney, D. Bianconi, A. Bisanti, F. Canaccini, M. Cerno, D.Checchi, A. Classen, N. Labère, A. Poli, G. Rodríguez, A. Rovelli, B.Visentin.
Si parla di: F. Accrocca, P. Allegretti, A. Andreose, E. Avgoloupi, E. Ayroulet,C. Azzara, N. Baldini, A. Barbero, M. Bartoli, A. Bartolomei Romagnoli, A.Bartolomei Romagnoli - G. Picasso, M. Bassetti - A. Czortek - E. Menestò,M. Battaglia, L. Battaglia Ricci, M. Benedetti, F. Bernard - K. Demoen, L. A.Berto, F. Bocchi, M. Bollati, C. Brandoli, A. Brilli, M. Brinzei - N. Wicki, M.T. Brolis - A. Zonca, C. Brucker - P. Demarolle, S. Brufani, M. Büchsel - R.Müller, M. Burlamacchi, J. Burton - L. Lockyer, M. Cacciari, F. Cardini, A.Casadei, G. Casagrande, L. Castaldi, Circolazione di uomini e scambi culturali tra cit-tà (secoli XII-XIV), R. Cobianchi, C. Corradini - P. Golinelli - G. Z. Zanichel-li, R. Cross, M. Cursi, F. D’Aiuto - P. Vian, J. Dalarun, W. D’Avanzo, A. De-gl’Innocenti - P. Gatti, T. De Robertis - R. Miriello, E. Di Stefano, A. Dres-sen, O. Dubreucq, T. Ferreri, A. Fidora - A. Niederberger - M. Scattola, F.Fiorentino, I. Foletti, P. Freedman, C. Friedl, J. V. García Marsilla, C. Gaullier-Bougassas, L. Gérard-Marchant, M. Giansante, A. V. González, P. Grillo, A.Grisafi, B. Guenée - J.-M. Moeglin, P. Guglielmotti, C. E. Honess - M.Treherne, P. Howard, La ricerca del benessere individuale e sociale, D. Levante, C.H. Lohr, F. López, J. M. Luxford, C. Machabey-Besanceney, A. Maiarelli, N.Mancassola, P. Maranesi, P. Maranesi - F. Accrocca, P. Mari, A. Mastromatteo,E. A. Matter - G. Zarri, J. F. Meirinhos, E. Menestò, S. Mitchell - P. VanNuffelen, S. Morrison, S. Muzzi, M. R. Narvález, J. Nechutová, M. Oldoni, P.Orsini, R. Paciocco, M. Pade, D. Pagliara, R. Parmeggiani, D. Pezzini, B. Pier-re - A. Vauchez, C. M. Radding, A. Rapetti, D. Rico Camps, G. Roussineau,F. Santi, A. Scattigno, G. P. G. Scharf, F. Sedda, C. Segre, E. Somigli, E. Ste-vanin - Z. Zanardi, P. Stotz, N. Tangari, L. Temperini, A. Thomas, L. Toma-sin, A. Tombolini, L. Travaini, H. Uulders, S. Verderber, J. C. M. Vigueur, L.Viscido, C. Wickham, S. Wood.
SOMMARIO DEL FASCICOLOVI
DISCUSSIONI
ELISABETTA BARTOLI - PATRIZIA STOPPACCI, Corrispon-denze edite ed inedite ......................................... pag. 229
LETTURE E CONGETTURE
BERNHARD SCHIRG, In bivio. Zur Lebenswegentscheidungals Motiv frühhumanistischer Selbstdarstellung bei Gerivon Arezzo und Francesco Petrarca ....................... » 299
RECENSIONI ...................................................... » 341
J. C. FRAKES (ed.), Contextualizing the Muslim Other in Medieval Christian Discour-se (A. Bertolacci), p. 341; E. GAMILLSCHEG, Manuscripta Graeca. Studien zur Ge-schichte des griechischen Buches in Mittelalter und Renaissance (D. Frioli), p. 344; J.HAINES (ed.), The Calligraphy of Medieval Music (L. Albiero), p. 351; M. LAUWERS
(ed.), La Dîme, l’Église et la Société Féodale (P. Tomei), p. 356; M. NARDELLO, Icarismi, forma dell’esistenza cristiana. Identità e discernimento (G. Cremascoli), p.359; P. VAN GEEST, The Incomprehensibility of God. Augustine as a Negative Theolo-gian (G. Alliney), p. 361; U. NAGENGAST, Gothorum florentissima gens. Gotenge-schichte als Heilsgeschichte bei Isidor von Sevilla (G. Fiesoli), p. 364; S. BAXTER, TheEarls of Mercia. Lordship and Power in Late Anglo-Saxon England (R. Canosa), p.366; M. ANSANI, Caritatis negocia e fabbriche di falsi. Strategie, imposture, disputedocumentarie a Pavia fra XI e XII secolo (G. Vendittelli), p. 371; I. CHABOT, Rico-struzione di una famiglia. I Ciurianni di Firenze tra XII e XV secolo. Con l’edizionecritica del « Libro propio » di Lapo di Valore Ciurianni e successori (1326-1429) (S. To-gnetti), p. 380; K. BUSBY and R. DALRYMPLE (eds.), Arthurian Literature XXII,XXIII (S. Gwara), p. 383; M. BERISSO (cur.), Poesia comica del Medioevo italiano(A. Bisanti), p. 386; M. SEIDEL, Padre e figlio. Nicola e Giovanni Pisano (A. Pero-ni), p. 391; M. BOURIN, J. DRENDEL et F. MENANT (éds), Les disettes dans la con-joncture de 1300 en Méditerranée occidentale (G. P. G. Scharf), p. 406; R. CARDINI -F. SZNURA (cur.), Coluccio Salutati. Cancelliere della Repubblica Fiorentina/Chancellorof the Florentine Republic. Carteggio Pubblico/Public Correspondence 1375-1406. Indiceonomastico e toponomastico/Onomastic and Toponomastic Index. Riproduzioni degli ori-ginali/Reproductions of originals in CD (D. De Rosa), p. 411; N. MARCELLI, Eros,politica e religione nel Quattrocento fiorentino. Cinque studi tra poesia e novellistica (A.Bisanti), p. 417; C. P. WEINBERG and E. A. MATTER (eds.), Education, Civic Vir-tue, and Colonialism in Fifteenth-Century Italy: The « Ogdoas » of Alberto Alfieri (A.Degl’Innocenti), p. 425.
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 7 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Cyan
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 7 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Magenta
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 7 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Yellow
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 7 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Black
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 7 lato A data 04/15/2014 colore A
ll
PR
EP
S
CMYKP
RE
PS
CMYK
Peculiarità lessicali nel Dialogus miraculorumdi Cesario di Heisterbach
Cesario di Heisterbach (1180 c.a., m. post 1240) si aggregò,tra i 19 e i 20 anni, alla comunità monastica dell’omonima ab-bazia cistercense, ove, monachus et magister noviciorum, insegnòteologia e diventò priore 1. Scrittore prolifico, compose ser-moni e omelie 2, opere di carattere agiografico, come la Vita,passio et miracula beati Engelberti Coloniensis archiepiscopi (aa. 1226-1237) 3, la Vita sanctae Elysabeth Lantgraviae (a. 1236-1237) 4, laContinuatio catalogi archiepiscoporum Coloniensium (1238), crono-tassi dei vescovi di Colonia per gli anni 1167-1238 5, probabil-mente sua città natale, e un commento alla sequenza Ave, prae-clara maris stella 6. In questo parziale elenco di opere occorreinserire i Libri octo miraculorum (sive Volumen diversarum visio-num), composti tra il 1225 e il 1227, di cui rimangono solo i
1. Per la biografia di Cesario cfr. Compendium auctorum latinorum medii aevi
(C.A.L.M.A.), II. 5, a cura di M. LAPIDGE - C. LEONARDI - F. SANTI, Firenze, 2008,
voce Caesarius Heisterbacensis prior, pp. 540-541 (F. VERMIGLI) e Lexicon des Mittelalters,
II, München, 1983, colonne 1363-1366 (F. WAGNER).
2. Fasciculus moralitatis venerabilis fratris Caesarii Heisterbacensis monachi Sacri Ordinis
Cisterciensium, curante J. A. COPPENSTEIN, Coloniae, 1615.
3. Die Wundergeschichten des Caesarius von Heisterbach, herausgegeben von A. HIL-
KA, Berlin, 1933-1937, III, 234-328.
4. Ibid., 344-381. Inoltre cfr. Die Schriften des Caesarius von Heisterbach über die
hl. Elisabeth von Thüringen, herausgegeben von A. HUYSKENS, in Annalen des histori-
schen Vereins für den Niederrhein, 86 (1908), pp. 1-59 [17-59].
5. M.G.H. SS XXIV 345-7.
6. Exposiciuncula super sequenciam « Ave, preclara maris stella », édité par R. B. C.
HUYGENS, in Cîteaux, XX (1969), pp. 108-169 [119-127].
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 83 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Cyan
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 83 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Magenta
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 83 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Yellow
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 83 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Black
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 83 lato A data 04/15/2014 colore A
ll
PR
EP
S
CMYKP
RE
PS
CMYK
VALENTINA LUNARDINI76
primi tre 7. All’ambito della letteratura visionaria e miracolisti-ca è da ricondurre anche il Dialogus miraculorum sive De miracu-lis et visionibus sui temporis, risalente al 1219-1223 8. Il presentestudio verte sull’analisi linguistica di alcuni lemmi presenti inquest’opera, pubblicata nel 1851 da Joseph Strange 9 e poi tra-dotta, al completo o antologicamente, da diversi studiosi tra iquali Alexander Kaufmann 10, Ernst Müller-Holm 11, Otto Hel-linghaus 12, Henry von Hessen Scott 13, André Barbeau 14, Jaapvan Moolenbroek 15 e, nel 2009, da Horst Schneider 16. Ci siriferisce al testo di quest’ultima edizione nel presente saggio.
Il Dialogus miraculorum mette in scena, sotto forma di dialo-go tra il novicius interrogans e il monachus respondens, 746 exemplasuddivisi in 12 distinctiones o temi. Tema costante di questi rac-conti paradigmatici è la salvezza dell’anima, conseguita in segui-to a determinati comportamenti. Le vicende dei racconti, pre-sentate dall’autore come veramente accaduti, traggono spuntosoprattutto da alcune opere di Gregorio Magno, cioè i Dialogi,la Regula pastoralis, i Moralia in Iob e dalle Vitae patrum. Vengo-no presentati gli ideali di comportamento, descritti anche nellarovina spirituale conseguente alle infedeltà e alle trasgressioni,
7. Libri octo miraculorum (sive Volumen diversarum visionum), herausgegeben von A.
MEISTER, in Die Fragmente der Libri miraculorum des Caesarius von Heisterbach, Roma,
1901. Inoltre cfr. HILKA, Die Wundergeschichten cit. (nota 3), 15-128.
8. C.A.L.M.A. cit. (nota 1), p. 540.
9. Caesarii Heisterbacensis monachi ordinis Cisterciensis Dialogus miraculorum, herau-
sgegeben von J. STRANGE, Köln, 1851.
10. Wunderbare und denkwürdige Geschichten aus den Werken des Cäsarius von Hei-
sterbach, übers. A. KAUFMANN, in Annalen des historischen Vereins für den Niederrhein, 47
(1888), pp. 19-228.
11. Caesarius von Heisterbach deutsch, herausgegeben von E. MÜLLER-HOLM, Berlin,
1910.
12. Hundert Auserlesene, wunderbare und merkwürdige Geschichten des Zisterziensers
Cäsarius von Heisterbach († 1240), übersetzt von O. HELLINGHAUS, Aachen, 1925.
13. The Dialogue on Miracles: Caesarius of Heisterbach (1120-1235), übers. H. VON
HESSEN SCOTT, London, 1929.
14. CESAIRE DE HEISTERBACH, Le dialogue des miracles. Livre 1: De la conversion, tra-
duit du latin, présenté et annoté par A. BARBEAU, Oka, 1992.
15. Mirakels historisch. De exempels van Caesarius van Heisterbach over Nederland en
Nederlanders, übersetzt von J. VAN MOOLENBROEK, Hilversum, 1999.
16. CAESARIUS VON HEISTERBACH, Dialogus miraculorum/Dialog über die Wunder, I.-
V., eingeleitet von H. SCHNEIDER, übersetzt und kommentiert von N. NÖSGES und
H. SCHNEIDER, Turnhout, 2009, d’ora in poi DIAL.
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 84 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Cyan
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 84 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Magenta
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 84 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Yellow
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 84 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Black
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 84 lato A data 04/15/2014 colore A
ll
PR
EP
S
CMYKP
RE
PS
CMYK
PECULIARITÀ LESSICALI NEL DIALOGUS MIRACULORUM 77
tipici della vita cristiana e della condizione monastica, soprat-tutto negli inevitabili conflitti con il Maligno. Si tratta, cioè, diracconti edificanti, ben noti nella letteratura ascetica e moltousati nelle omelie.
***
Nella trattazione di quest’opera, una delle più significative del-la spiritualità monastica dell’età di mezzo, ricorrono lemmi di pe-culiare struttura e significato, che documentano la storia della cul-tura e della mentalità dell’epoca e che necessitano di una qualchespiegazione, perché scarsamente o per nulla documentati nei di-zionari dell’antichità classica e nei lessici mediolatini ed espressi informe della latinità medievale che presentano peculiarità semanti-che e morfologiche. Si tratta, in genere, di lemmi che possono es-sere ricondotti, spesso in contesti di prodigio, a vari temi, quali idemoni, la tentazione a compiere il male, la famiglia e il quotidia-no, il lavoro agricolo, il diritto e il mondo ecclesiastico.
Nella mente di Cesario e nella sua esperienza monasticaquesti ambiti fanno riferimento a una società in cui l’accani-mento del Male deve essere vinto dall’azione divina. Nel corsodella narrazione dei fatti sovrannaturali e di origine divina rac-contati nella sua opera, si ha l’impressione che il Male e i sim-boli della sua tentazione, evocati dai diversi vocaboli, siano co-stantemente presenti in tutti gli aspetti della vita. Ciò risulta findal primo dei vocaboli su cui mi accingo a condurre l’analisiper delinearne la vicenda nella lessicografia medievale.
APODIARE
Inizio con il lemma usato nell’exemplum in cui, ad agire, èil demonio nella forma della coda di un vitello, simbolo deibeni materiali che si sostituiscono allo spirito, come si narra nelracconto biblico del vitello d’oro costruito da Aronne, diviniz-zazione della ricchezza, del piacere sensuale e del potere 17.
17. Exodus 32, 1-10. L’edizione di riferimento è Biblia Sacra iuxta Vulgatam versio-
nem, edited by R. WEBER - R. GRYSON, Stuttgart, 1994.
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 85 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Cyan
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 85 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Magenta
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 85 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Yellow
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 85 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Black
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 85 lato A data 04/15/2014 colore A
ll
PR
EP
S
CMYKP
RE
PS
CMYK
VALENTINA LUNARDINI78
Si legge, infatti, in Cesario la vicenda di un novizio dell’ab-bazia di Himmerod, presso Eifel, distolto dal canto dei Salmiper colpa della coda di un vitello, che gli si accostava sempre dipiù:
Alio tempore transformans se daemon in caudam vituli, et super formam cadens, cui
idem novicius se apodiabat, motu levissimo trahebat se ad novicium 18.
Cesario si sofferma allora nel descrivere la fascinazione delMale indicandone i risultati, cioè l’impropria celebrazione litur-gica. Ciò avviene perché il demonio se apodiabat al novizio, dalui raggiunto alle scapole dopo essersi soffermato sopra lo stalloligneo del coro. Non esistono attestazioni del lemma apodiare(app-) nella tradizione classica. Scarsa è la documentazione nellalessicografia mediolatina. Il lemma è, infatti, ignoto a Papias e aOsberno, e si trova solo nelle Derivationes di Uguccione da Pi-sa 19, dal quale, come di consueto, attinge il Balbi 20. Qualchealtro dato viene offerto dal Du Cange, nel glossario da lui re-datto nel 1678 e nel quale, attraverso brevi spiegazioni o vere eproprie dissertazioni, si dà vita ad uno degli strumenti essenzialiper l’interpretazione dei testi mediolatini 21. Il lemma apodiareindica l’azione del sostenere, dell’appoggiarsi a qualcosa o aqualcuno, come accadde a danno dello sprovveduto noviziodell’abbazia di Himmerod, al quale si accostò, appoggiandosi, ildemonio, sotto forma di coda di vitello, con il risultato che il
18. DIAL. 5, 5, p. 968-969, l. 19-22.
19. UGUCCIONE DA PISA, Derivationes, a cura di E. CECCHINI - G. ARBIZZONI - S.
LANCIOTTI - G. NONNI - M. G. SASSI - A. TONTINI, Firenze, 2004, I, p. 915, P 42, 4:
« et inde podio -as, et componitur appodio –as, suppodio –as, omnia pro inniti, et
secundum hoc sunt neutra et absoluta ».
20. JOANNIS BALBI Catholicon, Mainz, 1460 (rist. anast. Westmead, 1971): « appo-
dio ».
21. DU CANGE, Glossarium mediae et infimae Latinitatis, I-X, Niort, 1883-1887 (rist.
anast. Bologna, 1981-1982), I, p. 315: « Apodiare [Inniti, Fulcire, sustinere - Inquisi-
tio pro canonisatione S. Yvonis MS.: D. Yvo quando somno nimio gravabatur. tunc
positis brachiis supra pectus, et involutus ad modum crucis, sedendo et se Apodiando
de pectore super libros, et inclinato capite dormiebat. Litterae Philip. III ann. 1280.
apud Marten. tom. 1. Anecd. col. 1160: Concessimus (...) quod possint facere pila-
rios lapideos vel ligneos in quibus possent (...) tectum domorum suarum et aedificio-
rum firmare, Apodiare et apponere, etc.] ».
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 86 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Cyan
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 86 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Magenta
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 86 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Yellow
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 86 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Black
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 86 lato A data 04/15/2014 colore A
ll
PR
EP
S
CMYKP
RE
PS
CMYK
PECULIARITÀ LESSICALI NEL DIALOGUS MIRACULORUM 79
monaco « mox in psalmodia fallebatur » 22. Per completezza distudi sul lemma, si possono citare il Glossarium del Diefenba-ch 23 e il Mittelateinische Wörterbuch 24.
BOTI
Il lemma boti, nel senso di stivale, appare nel racconto di unprodigio in cui è protagonista un cavaliere dives et honestus 25, dinome Winemaro, originario di Aldindorp. Questo cavalieregiaceva a letto paralizzato, ma, dopo aver indossato le scarpe diGualtiero di Birbech, uomo di grande fede, riprese le forze e sialzò in piedi completamente risanato. Questo è il passo:
Mox per eundem nuncium boti viri Dei satis veteres mittuntur, quos infirmus cum
fide ac devotione suscipiens, statim ut manus praemortus imposuit, beneficium ex eis
sensit 26.
Nel testo fornito il lemma che indica le scarpe del defuntoGualtiero è boti, che vediamo registrato nel Mittelateinische Wör-terbuch con il senso di stivale 27. Questa calzatura, utilizzata per-lopiù dai monaci, è registrata anche da Osberno, alla glossa:« bota, genus calceamenti » 28. Anche il Diefenbach riporta la
22. DIAL. 5, 5, p. 968, l. 23.
23. L. DIEFENBACH, Glossarium Latino-Germanicum mediae et infimae aetatis, Fran-
kfurt am Main, 1857 (rist. anast. Darmstadt, 1997): p. 42, C « Appo-, apo- (4, 75,
76), appe- (17) -diare (cf. sustentare) ».
24. Mittellateinisches Wörterbuch bis zum ausgehenden 13. Jahrhundert in Gemein-
schaft mit den Akademien der Wissenschaften zu Göttingen, Heidelberg, Leipzig,
Mainz, Wien und der Schweizerischen Geisteswissenschaftlichen Gesellschaft, herau-
sgegeben von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und der Deutschen
Akademie der Wissenschaften zu Berlin, München, 1967-2003: I, 753, l. 40: « apo-
dio sim. v. appodio; 802, l. 43 appodio, -avi, -atum, -are [...]; 803, l. 1-5 intrans. i. q.
inniti - sich anlehnen, stützen: CAES. HEIST. Mirac. I 5,5 p. 282, l. 13 cui (formae) idem
novicius <se> (add. ed., vix recte) apodiabat ».
25. DIAL. 7, 38, p. 1438, ll. 57-58.
26. Ibid., pp. 1438-1439, ll. 4-7.
27. Mittellateinisches Wörterbuch cit. (nota 24), I, 1546, ll. 42-45 « bota, -ae f. vel
botus, -i m. (francog. vet. bote) script.: bott-: l. 55-59-62 sqq. bocc-: l. 59 form. acc. pl.
-ones: l. 55 metr. bô-: l. 48. caliga (subtalaris) – (halbhoher) Stiefel, Knöchelschuh ».
28. OSBERNO, Derivazioni, a cura di P. BUSDRAGHI - M. CHIABÒ - A. DESSÌ FUL-
GHERI - P. GATTI - R. MAZZACANE - L. ROBERTI, Spoleto, 1996, I, p. 158, c 183:
« Crepida, genus calciamenti quod et bota dicitur ».
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 87 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Cyan
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 87 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Magenta
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 87 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Yellow
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 87 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Black
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 87 lato A data 04/15/2014 colore A
ll
PR
EP
S
CMYKP
RE
PS
CMYK
VALENTINA LUNARDINI80
forma: « bota koder im schuch » 29. Per il rimando al tedesco dioggi si veda Boot.
BRAXARE – BRAXATRIX
Cum incendium illud maximum quod erat sub Adolpho archiepiscopo, magnam partem
civitatis Coloniensis consumpsisset, mulier quaedam quae ecclesiae sanctorum Apostolorum
pro sua mercede braxare consueverat, domum ligneam prope positam habebat 30.
Fra i lemmi che documentano la vita e i costumi dell’epoca, siregistra il verbo braxare, riferito, nella scarsa documentazione di cuisi può disporre, alla produzione di birra, a cui spesso si attendevanei pressi dei monasteri. Sappiamo che la produzione, il consumoe il commercio della birra erano piuttosto diffusi in questa epoca.L’attività di produzione si articolava in una serie complessa di fasie si concentrava in particolari zone per lo sfruttamento dei corsid’acqua. Le abbazie riservavano spazi per le attività artigianali, trale quali la lavorazione dei cereali. Il passo sopracitato narra di unfatto prodigioso accaduto a Colonia, nell’epoca della signoria delpresule Astolfo, che governò la città tra il 1193 e il 1214 31. Unadonna che attendeva alla produzione della birra presso la chiesa deiSanti Apostoli, vide miracolosamente salvata la sua casa in predaalle fiamme. Il lavoro di questa donna è indicato dal verbo braxare.Il lemma non è registrato nei lessici mediolatini ma è documenta-to nel Mittellateinisches Wörterbuch alla voce bracio 32. Il Du Cangeaccoglie il lemma con un rimando a Cesario 33, che, in un altropunto, usa il verbo in senso metaforico, per riprendere la condottariprovevole di un sacerdote non esemplare nell’amministrare il sa-cramento della penitenza 34.
29. DIEFENBACH, Glossarium cit. (nota 23), p. 79, C.
30. DIAL. 8, 62, pp. 1652-1653, ll. 1-8.
31. Ibidem, nota 1494.
32. Mittellateinisches Wörterbuch cit. (nota 24), 1559, l. 1 « bracio -avi, -are. (cf.
francog. vet. bracier): proprie i. q. cervisiam facere – (zu) Bier brauen 2 translate i. q. confi-
cere - zustande bringen, ‘zusammenbrauen’: CAES. HEIST. mirac. I 3. 41 p. 162, 4 quanta
mala mali sacerdotes [...] braxent in confessionibus ».
33. DU CANGE, Glossarium cit. (nota 21), p. 739: « Braxare, Braxator, Braxatoria,
etc. Vide Brace; I, 728: Braxare, apud Caesarium Eysterbach. lib. 8. cap. 62. et lib.
10 cap. 31 ».
34. Cfr. infra nota 42 e contesto, e supra nota 32.
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 88 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Cyan
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 88 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Magenta
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 88 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Yellow
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 88 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Black
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 88 lato A data 04/15/2014 colore A
ll
PR
EP
S
CMYKP
RE
PS
CMYK
PECULIARITÀ LESSICALI NEL DIALOGUS MIRACULORUM 81
Nell’ambito semantico sin qui registrato, si trova il lemmabraxatrix, che compare nell’intitolazione del capitolo ove si nar-ra il prodigio della casa preservata dalle fiamme dell’incendio 35.Anche il lemma braxatrix, non attestato nei lessici mediolatini,viene accolto dal Du Cange con il rimando a Cesario 36. La va-riante braciatrix (-axa, -acsa-, -icis) è attestata nel MittelateinischesWörterbuch 37. Nel Vocabularius ex quo, lessico composto in lin-gua latina e segnato dalla presenza di elementi linguistici di areagermanica, vediamo documentata, accanto al verbo braxare, laforma maschile del lemma, cioè braxator 38.
Un altro prodigio, sempre a proposito dell’attività del braxa-re, è narrato da Cesario a proposito della preparazione e delcommercio della birra, praticati da una donna di Duisburg, nel-l’episcopato di Colonia:
In Episcopatu Coloniensi opido imperiali quod Duseburg dicitur, vidua quaedam cer-
visiam braxare ac vendere solebat 39.
La donna, secondo il racconto di Cesario, salva la propriacasa, anche qui da un incendio, ponendo le botti, che contene-vano la birra, davanti alla porta della propria abitazione, reci-tando, al contempo, fervide preghiere e ricordando anche l’ir-reprensibile onestà della sua vita e del suo lavoro:
Nam omnia sua vasa quibus cervisiam emptoribus mensurare solebat, ad ostium do-
mus contra flammas ponens, in multa cordis sui simplicitate, sic oravit dicens: “Do-
35. DIAL. 8, 62, p. 1652: « De braxatrice ecclesiae sanctorum Apostolorum,
cuius domus inter flammas miraculose servata est ».
36. DU CANGE, Glossarium cit. (nota 21), p. 739: « Braxare, Braxator, Braxatoria,
etc. Vide Brace; I, p. 728 Braxatrix, apud Caesarium Eysterbach lib. 8 cap. 62. Ex
quibus observare est in Scotia et Germania Braciatoriam artem mulierum proprie fuis-
se: une Brasseressede miel, in Chronico Flandriae cap. 72. Ita etiam Britton in Legib.
Anglic. pag. 76-77. quasi mulierum duntaxat brassandi, seu cerevisiam conficiendi ars
fuerit ».
37. Mittellateinisches Wörterbuch cit. (nota 24), p. 1558, ll. 14-16: « braciatrix (-axa-,
-acsa-), -icis f. quae cervisiam facit - (Bier-)Brauerin: CAES. HEIST. mirac. I 8, 62 p. 135,
3 apostoli braxatricis [...] domum [...] servare curaverunt ».
38. Vocabularius ex quo, Überlieferungsgeschichtliche Ausgabe gemeinsam mit K.
GRUBMÜLLER, herausgegeben von B. SCHNELL - H.-J. STAHL - E. AUER - R. PAWIS,
Tübingen, 1988-1989, II, p. 357: « Braxare bruwen, Braxator ein bruwer ».
39. DIAL. 10, 31, p. 1960-1961, ll. 10-12.
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 89 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Cyan
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 89 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Magenta
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 89 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Yellow
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 89 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Black
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 89 lato A data 04/15/2014 colore A
ll
PR
EP
S
CMYKP
RE
PS
CMYK
VALENTINA LUNARDINI82
mine Deus iustus et misericors, si unquam aliquem hominum his mensuris decepi,
volo ut domus haec comburatur. Si autem feci quod rectum est in oculis tuis, precor
iustitiam tuam, ut in hac hora misericorditer respicias necessitatem meam, et mihi
meaeque supellectili parcere digneris” 40.
Per completare il quadro delle testimonianze circa il verbobraxare, bisogna ricordare anche le attestazioni del lemma nelDiefenbach 41.
Lo stessa lemma, ora analizzato in riferimento alla prepara-zione della birra, è attestato, con un significato diverso, ancheper stigmatizzare la condotta riprovevole di alcuni sacerdotinell’amministrare il sacramento della confessione. Ecco il passoin questione:
Quanta mala mali sacerdotes Deum non timentes braxent in confessionibus, plurimis
exemplis tibi possem ostendere, sed parcendum est ordini, parcendum sexui, parcen-
dum religioni 42.
Si tratta di un dialogo in cui un pio monaco vuole metterein guardia un novizio dal peccato della lussuria, di cui potrebbemacchiarsi persino il sacerdote nell’ascolto delle confessioni. Ilsignificato letterale di braxare, sopra analizzato 43, diventa qui fi-gurato e indica il compiere, di nascosto, qualcosa di illecito.Questo significato figurato e peggiorativo non viene registratonei lessici e nei glossari mediolatini, ma è riportato esclusiva-mente nel Mittellateinisches Wörterbuch, che alla voce bracio regi-stra sia il significato di preparare la birra, sia, in senso generale,l’idea del fare, del realizzare, ma, anche qui, senza indicazionedi derive morali 44.
40. Ibidem, ll. 15-22.
41. DIEFENBACH, Glossarium cit. (nota 23), p. 81, « AB Braxare, -ire, baxare (1) (cf.
praxare) hd. nd. bruwen, borwen (23). hd. bruen, brwen (5b), bruhen (5, 21), bre-
wen (4, 66), breuen (134), prewen (1), brauchen (67); bier bruwen sim., sieden (76),
machen (6) ».
42. DIAL. 3, 41, pp. 640-641, ll. 18-21.
43. Cfr. supra nota 30, 39 e 40.
44. Mittellateinisches Wörterbuch cit. (nota 24), p. 1559, ll. 27-30: « bracio [...] tran-
slate i. q. conficere – zustande bringen, ‘zusammenbrauen’: CAES. HEIST. mirac. I 3, 41 p.
162, 4 quanta mala mali sacerdotes [...] braxent in confessionibus. HUGO TRIMB.
Laur. 208 o pia Braxedis, cunctis succurrito fedis, ut bona sic braxent, vitiis ne frena
relaxent ».
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 90 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Cyan
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 90 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Magenta
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 90 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Yellow
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 90 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Black
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 90 lato A data 04/15/2014 colore A
ll
PR
EP
S
CMYKP
RE
PS
CMYK
PECULIARITÀ LESSICALI NEL DIALOGUS MIRACULORUM 83
BRIA
Il lemma bria è attestato in un sol punto del Dialogus di Ce-sario. Questo è il passo:
Unde dicta est superbia, quasi supra briam, id est, mensuram, se extollens 45.
Il termine è noto sia nei lessici del latino classico sia inquelli mediolatini, dove si incrociano i significati di vaso da vi-no o di altre bevande, e di misura adottata nel fruirne. Soprat-tutto nell’epoca successiva all’età classica avviene questo sposta-mento di significato, e vediamo applicata a bria la spiegazionemensura, come attestato nell’Elementarium di Papias 46, in Osber-no 47, nel Balbi 48 e nel Closener 49. Uguccione affianca allaspiegazione di bria, un rimando, per la derivatio nominis, a bracos,traslitterazione di bracúv: « Item a bracos hec bria -e, quedamcensura; ubi enim nimietas est, mensura non est » 50. A questolemma è ricondotto anche ebrius, in quanto extra mensurambibens 51.
CARENA
Il diavolo si presenta, nel racconto di Cesario, anche nellefattezze di un cavaliere di nome Enrico, proveniente da Bonn,che chiede ospitalità presso il convento, nel periodo precedentela Pasqua. Il cavaliere chiede a Gherardo, abate del monastero,una pietra su cui dormire e fare penitenza. Il passo presentaquesta intitolazione:
45. DIAL. 4, 3, pp. 676-677, ll. 13-14.
46. PAPIAS, Elementarium doctrinae rudimentum, Venetiis, 1496 (rist. anast. Torino,
1966), B 43b: « Bria idest mensura ».
47. OSBERNO, Derivazioni cit. (nota 28), p. 88, B XXI 1: « Bria .i. quedam men-
sura teste Ysidoro ».
48. BALBI, Catholicon cit. (nota 20): « bria idest mensura a bracos quod est breve
ubi enim nimietas est mensura non est et bria dicitur quedam in terra ubi sunt boni
casei ».
49. Die Vokabulare von Fritsche Closener und Jacob Twinger von Königshofen, herau-
sgegeben von K. KIRCHERT zusammen mit D. KLEIN, Tübingen, 1995, I, Br 26, p.
186: « Bria. Versus: Est mensura brios, sobrius inde venit ».
50. UGUCCIONE, Derivationes cit. (nota 19), p. 146, B 117, 16.
51. Ibidem: « et componitur ebrius -a -um, idest extra mensuram bibens ».
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 91 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Cyan
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 91 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Magenta
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 91 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Yellow
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 91 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Black
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 91 lato A data 04/15/2014 colore A
ll
PR
EP
S
CMYKP
RE
PS
CMYK
VALENTINA LUNARDINI84
De Henrico milite apud nos carenam faciente, et de lapide, in quo dormiebat tempo-
re orationis 52.
La penitenza, un’esperienza ritenuta necessaria nel cristiane-simo, viene indicata con il lemma carena, in riferimento allepratiche penitenziali del tempo della quaresima:
Miles quidam Bonnensis, Henricus nomine, tempore quodam quadragesimali care-
nam fecit apud nos 53.
In realtà il cavaliere non aveva seri intenti di penitenza, co-me si evince dal racconto di Cesario. Quanto al nostro lemma,esso è attestato nel Du Cange, ove si legge: « Carena, carrinaquadragesimale jejunium seu publica poenitentia ». Tra i riman-di noto: « Joan. de Janua: Carrena et publica poenitentia etquadragena idem sunt » 54. Nel Diefenbach il lemma è ritenutovulgare ytalorum 55, mentre nel Mittellateinisches Wörterbuch si ipo-tizza una derivazione « a theod. vet. chara ‘paenitentia’ » 56.
CARRATA
All’ambito agricolo si ascrivono dei lemmi utilizzati per de-signare il sistema di misurazione del grano e del vino. Perquanto attiene al lessico relativo a questo settore dell’attivitàsvolta nella vita dei campi, Cesario menziona la vicenda di unsoldato, di cui non viene riportato il nome, molto solerte aversare la decima, costituita dai frutti della terra, tra i quali l’u-va vendemmiata nei campi. Dal racconto di Cesario sappiamoche il raccolto era ogni anno abbondante, a tal punto che
circa decem carratas annuatim facere solebat 57.
52. DIAL. 4, 37, pp. 762-763, ll. 11-12.
53. Ibidem ll. 13-14.
54. DU CANGE, Glossarium cit. (nota 21), p. 167.
55. Diefenbach, Glossarium cit. (nota 23), p. 101, « A Carena (est vulgare ytalorum
a carentia ciborum &c. 65. cf. quadragena) ».
56. Mittellateinisches Wörterbuch cit. (nota 24), 281, l. 5: « carena sim. v. 2. carina;
III 284, l. 41-43: carina (ka-, ke-, -rr-, -ran-, -ren-,), -ae f. (fort. pendet a theod. vet.
chara ‘paenitentia’) paenitentia ieiunii (quadraginta dierum) ».
57. DIAL. 10, 13, pp. 1922-1923, ll. 7-8.
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 92 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Cyan
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 92 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Magenta
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 92 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Yellow
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 92 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Black
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 92 lato A data 04/15/2014 colore A
ll
PR
EP
S
CMYKP
RE
PS
CMYK
PECULIARITÀ LESSICALI NEL DIALOGUS MIRACULORUM 85
Il vocabolo carrata viene tradotto, nella citata edizione deiFontes christiani, con Fuder, così spiegato: « Das Fuder (plaustrum,carra), ist eine Rechneinheit für Verpakkungen flüssiger und fe-ster Waren bzw. das Maß für die Tragfähigkeit oder Zugkraftvon Tieren oder Karren; vgl. WITTHÖFT, Fuder. Ein Fuder(großes Faß) enthielt in der Gegend zwischen Rhein und Maas800 bis 900 Liter; vgl. NOLDEN, Besitzungen des Aachener Marien-stifts 47 » 58. Dunque carrata indicava un carro della capienza di800/900 litri, utilizzato, come risulta dal racconto di Cesario,durante le operazioni di vendemmia per trasportare l’uva rac-colta e destinata alla pigiatura. Questo vocabolo è assente neilessici mediolatini e, in genere, scarsamente documentato. NelClosener viene così riportato: « Carrata Fuder. Versus: Est car-rata vini, sed plaustrum dicito ligni » 59. Anche il Diefenbachregistra la medesima accezione: « Carrata [...] eyn fuoderwyns » 60, mentre il Du Cange 61 e il Mittellateinisches Wörterbuchregistrano le forme del lemma che alternano la t con la d 62.
CHORITAE / SANGUINITAE
Tra i termini che indicano l’insieme di persone unite da le-gami di consanguineità o da alleanze, ricordiamo il lemma cho-ritae e sanguinitae. Entrambi vengono utilizzati da Cesario nelpasso del Dialogus qui riportato:
Noverat enim paucos esse clericorum, qui canonice intrassent, ita ut non essent san-
guinitae, id est, a cognatis introducti, vel choritae, id est, per potentiam magnorum
intrusi, sive symoniaci, pecunia scilicet vel obsequiis intromissi 63.
In questo passo Cesario si riferisce, dunque, alla vicenda dichierici diventati tali perché introdotti negli ordini da consan-
58. Ibidem nota 1810.
59. Die Vokabulare von Fritsche Closener cit. (nota 49), I, Ca 325, p. 242: « Carrata
Fùder. Versus: Est carrata vini, sed plaustrum dicito ligni ».
60. DIEFENBACH, Glossarium cit. (nota 23), p. 103, B.
61. DU CANGE, Glossarium cit. (nota 21), pp. 183-184: « Carrada, Carrata, Onus
Carri, quantum Carro vehi potest ».
62. Mittellateinisches Wörterbuch cit. (nota 24), 309, l. 3: « *carrata v. *carrada; III,
307, l. 9: *carrada (-ta), -ae f. vel rarius *carradum; III, 307, l. 17: onus carri, vehes –
Wagenladung, Fuder ».
63. DIAL. 6, 5, pp. 1172-1173, ll. 15-19.
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 93 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Cyan
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 93 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Magenta
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 93 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Yellow
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 93 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Black
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 93 lato A data 04/15/2014 colore A
ll
PR
EP
S
CMYKP
RE
PS
CMYK
VALENTINA LUNARDINI86
guinei. Il lemma sanguinitae indica, in tale contesto e in sensospregiativo, i consanguinei introdotti a cognatis. L’unica attesta-zione di questo vocabolo è presente nel Du Cange, che riportail passo di Cesario sopracitato, aggiungendo ubi pro choritae, le-gendum puto curitae, a curia, vel Chortitae, a corti, seu aula, vel pa-latio 64. Il vocabolo choritae, non attestato nei lessici mediolatini,viene dunque registrato esclusivamente dal Du Cange, che sup-pone un errore da emendarsi con coritae o chortitae, ipotizzandola derivazione da curia o cohors 65. Un’altra ipotesi, al riguardo, èfornita in nota alla citata edizione dei Fontes christiani del passodi Cesario, ove si indica un possibile nesso di choritae con il vo-cabolo che nella Vulgata indica i figli di Core, addetti alle portedel tempio 66.
CLENODIA
Il Maligno può assumere anche sembianze umane e diven-tare mite e familiare, mimetizzandosi in un uomo ben vestito eapparentemente innocuo. Ciò si legge nel racconto di Cesario,riferito a una giovane originaria di Nivelles, che viene adulatadal diavolo, invidioso delle virtù della ragazza. La donna, chenon conosce l’uomo ben vestito, non cede alla seduzione e al-l’adulazione, e neppure alla tesi in cui si elogia la vita matrimo-niale e si denigra la sterilità conseguente alla verginità. Il signo-re ben vestito offre doni. Ecco il passo:
Invidens diabolus tantae virtuti, in specie viri admodum pulchri satisque decenter ve-
stiti apparens virgini, coepit illam verbis amatoriis sollicitare, clenodia offerre, laudare
coniugii fecunditatem, virginitatis vituperare sterilitatem. Cui virgo, nesciens quis es-
64. Du Cange, Glossarium cit. (nota 21), p. 315: « Choritae [Clerici per potentiam
magnorum intrusi. Fortassis mendum est, ut dicitur in] Sanguinitae ».
65. Ibid., VII, p. 302: « Sanguinitae, Consanguinei, agnati, cognati, sanguine con-
juncti. Caesarius Heisterbach. lib. 6. cap. 5: Noverat enim paucos esse Clericos, qui Ca-
nonice intrassent, ita ut non essent Sanguinitae, id est, a cognatis introducti; vel Choritae, id
est, per potentiam magnorum intrusi: sive Simoniaci, pecunia scilicet vel obsequiis intromissi.
Ubi pro Choritae, legendum puto curitae, a curia, vel Chortitae, a corti, seu aula, vel
palatio ».
66. DIAL. 6, 5, pp. 1172-1173, nota 953. Cfr. Biblia sacra, ed. cit. (nota 17), Ex
6, 24: « Filii quoque Core Asir et Helcana et Abiasab: hae sunt cognationes
Coritarum ».
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 94 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Cyan
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 94 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Magenta
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 94 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Yellow
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 94 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Black
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 94 lato A data 04/15/2014 colore A
ll
PR
EP
S
CMYKP
RE
PS
CMYK
PECULIARITÀ LESSICALI NEL DIALOGUS MIRACULORUM 87
set, respondit: “Virum ducere non propono, Christi amore nuptias carnales postpono
et contemno” 67.
Il diavolo descritto in questo passo da Cesario appartiene allacultura popolare e non è un personaggio terrificante né un geniodel male, ma un uomo affascinante, vinto, però, da una donnanon più astuta di lui ma tenace nel rifiutare le offerte amorose enel prediligere l’amore di Cristo. I doni che il diavolo offre allavergine sono espressi dal lemma clenodia, plurale del sostantivoneutro denodium. Il vocabolo di conio squisitamente tedesco, co-me attesta l’odierno Kleinod, viene accostato dal Du Cange al lem-ma greco keimälion: « clenodium, clenodia keimälion res quaevis pre-tiosa » 68. Il Mittellateinisches Wörterbuch registra la glossa: « cleno-dium [...] res pretiosa », con il rimando « theod. vet. kleinôt » 69.Rimandi all’ambito germanico sono presenti nel Diefenbach, ovesi legge: « Clenodium [...] gesmeid, geschmeide, ein iubel, iu-wael » 70. Il keimälion del Du Cange sta alla base del lemma cimelio,della nostra lingua.
CRUSELINUM
Il cavaliere Rudingero, trenta giorni dopo esser morto, ap-pare in sogno alla figlia, con in mano un vaso. Ecco il passo:
Portabat enim vas parvum et fictile quod vulgo “cruselinum” vocatur in manu sua,
in quali 71 in tabernis potare solebat 72.
Il vaso che porta il cavaliere è una piccola brocca in cui erasolito bere quando in vita frequentava le osterie. I lessici me-diolatini non registrano questo lemma che indica un piccolorecipiente contenente liquidi e che viene invece riportato dalDu Cange 73 e dal Mittellateinisches Wörterbuch, ove si legge la
67. DIAL. 3, 6, pp. 516-517, ll. 9-15.
68. DU CANGE, Glossarium cit. (nota 21), p. 366.
69. Mittellateinisches Wörterbuch cit. (nota 24), p. 709, ll. 4-6.
70. DIEFENBACH, Glossarium cit. (nota 23), p. 126, C.
71. Questa è anche la lezione riferita nel passo citato dal DU CANGE, alla v. cruse-
linum, cfr. infra nota 73.
72. DIAL. 12, 41, pp. 2278-2279, ll. 23-25.
73. DU CANGE, Glossarium cit. (nota 21), p. 631: « Cruselinum, Vas potorium par-
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 95 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Cyan
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 95 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Magenta
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 95 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Yellow
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 95 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Black
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 95 lato A data 04/15/2014 colore A
ll
PR
EP
S
CMYKP
RE
PS
CMYK
VALENTINA LUNARDINI88
variante cruseolus 74. La forma corrispondente del tedesco odier-no è Krügelchen, diminutivo di Krügel/Krog 75. Azzardo un’ipo-tesi. Il lemma del nostro passo non sarà crugelium, cioè la formalatinizzata di questo diminutivo?
CURMEIDIA / IUS CURMEIDIAE
Tra i vincoli imposti alla proprietà dei beni, esisteva anche, aitempi di Cesario, l’obbligo di rinunciare a un patrimonio, in de-terminate situazioni. Per questo, una vedova, dopo la morte delmarito, si vide costretta a lasciare parte dei suoi averi a un mona-stero di Colonia. Cesario narra che un converso, eccessivamentezelante, riteneva doveroso richiedere alla vedova del defunto ilmiglior capo di bestiame o la miglior veste, a motivo di determi-nati vincoli esistenti col monastero, evocati con questo testo:
Nam uxor eius, eo quod esset “de familia” nostra, iure “curmeidiae” illum obtulit 76.
Il diritto di riscuotere, da parte del monastero, tali beni, de-finiti mortuarium, è, dunque, espresso con la formula iure curmei-diae. Lo ius curmeidiae indicava i beni mobili e immobili sogget-ti a manomorta, cioè, nel nostro caso, destinati a passare allaproprietà ecclesiastica e inalienabili. Il lemma curmeidia non èattestato nei lessici mediolatini ma nella forma curmedia nellaraccolta del Du Cange 77 e nella forma curmeda nel Mittellateini-
vulum fictile, cujusmodi sunt, quae Creusels vocamus. Caesarius lib. 12. cap. 41: Por-
tabat enim vas parvum et fictile, quod vulgo Cruselinum dicitur, in manu sua, in
quali in tabernis potare solebat ».
74. Mittellateinisches Wörterbuch cit. (nota 24), p. 2047, ll. 2-6: « *cruseolus (-sio-),
-i m. vel *crisolus, -i m. (francog. vet. Croisuel [...] de genere quodam vasorum alch. i. q.
catinus – Schmelztiegel ».
75. Dizionario delle lingue italiana e tedesca, realizzato dal Centro Lessicografico Sanso-
ni, sotto la direzione di V. MACCHI, Firenze, 1972, p. 799: « Krügel n. (-s,-) <austr>
(Krug) boccale m. – Krügelchen (dim. di Krug) n. (-s,-) brocchetta f ».
76. DIAL. 4, 62, pp. 832-833, ll. 3-4.
77. DU CANGE, Glossarium cit. (nota 21), p. 672: « Curmedia, servitutis species in
Germania, quae ejusmodi erat, ut obeunte aliquo obnoxiae conditionis, dominus jus
haberet rem, quam vellet, in illius bonis, verbi gratia equum, vestem, annulum, etc.
seligere , sibique asserere [...] Caesarius lib. Miracul. cap. 62: Cui cum Conversus re-
sponderet: Talis homo eum (pullum equinum) nobis legavit; ait Praepositus, utrum
ex devotione, vel ex aliquo jure legavit eum? Respondit Conversus: Ex decessu il-
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 96 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Cyan
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 96 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Magenta
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 96 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Yellow
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 96 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Black
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 96 lato A data 04/15/2014 colore A
ll
PR
EP
S
CMYKP
RE
PS
CMYK
PECULIARITÀ LESSICALI NEL DIALOGUS MIRACULORUM 89
sches Wörterbuch 78. Il lemma trova un corrispettivo nella formadel tedesco Kurmut, registrato nel Deutsches Wörterbuch dei fra-telli Grimm 79: il lemma tedesco ha, quindi, come tramite,questo passo di Cesario. La vicenda narrata nel Dialogus ha, pe-rò, un lieto fine per merito del parere del preposto del mona-stero, Reynaldus, che – uomo generoso e illuminato – non ri-tenne giusto esigere lo ius curmeidiae dalla vedova, che era statasposa di un uomo bonus et amicus noster fidelis 80.
EXFESTUCARE
Fra i lemmi desunti dall’ambito del diritto, oltre al curmei-dia, di cui sopra 81, è da ascrivere exfestucavit, attinente all’istitu-to dell’affrancamento dalla schiavitù. La crescita agricola e losviluppo economico dei secoli IX e X comportarono una mag-gior richiesta di manodopera, con la conseguenza di dover af-francare individui dalla condizione di schiavitù. L’idea è espres-sa con il lemma exfestucare. Il vocabolo indica, in senso stretto,l’affrancamento dal padrone e in forma traslata il rompere ilvincolo con qualcuno a cui si era legati. Questo è il passo diCesario che riferisce la vicenda di un giovane nobile, spinto daun contadino a rinnegare il Signore:
Tandem miser iuvenis a villico persuasus, Creatorem suum ore negavit, manu exfe-
stucavit, diabolo hominium faciens 82.
Il verbo exfestucare non è presente nei dizionari di latinoclassico, che registrano esclusivamente la forma semplice festuco-as -are, con l’accezione dello spianare e battere una superficie
lius emersit, nam uxor ejus, eo quod esset de familia nostra, jure Curmediae illum
obtulit ».
78. Mittellateinisches Wörterbuch cit. (nota 24), p. 2138, ll. 27-28: « *curmeda (ku-,
kor-, cor-, -rem-, -rim-, -ribe-, -meid-, -meyd-, -etha, -dia), -ae f. (theod. vet. kuri,
mieta); 32: ius capitale, census capitalis – Sterbfall, Besthaupt; 37-39: CAES. HEIST. mirac.
I 4, 62 p. 231, 9 iure -eidiae (-diae, -eidae var. l.) ».
79. Deutsches Wörterbuch von J. und W. GRIMM, Leipzig, 1873, colonna 2813:
« Kurmede, f. Kurmut n. u. a., ein rhein.-westf. rechtsausdruck ».
80. DIAL. 4, 62, pp. 832-833, l. 6.
81. Cfr. nota 76.
82. DIAL. 2, 12, pp. 410-411, ll. 3-5.
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 97 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Cyan
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 97 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Magenta
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 97 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Yellow
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 97 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Black
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 97 lato A data 04/15/2014 colore A
ll
PR
EP
S
CMYKP
RE
PS
CMYK
VALENTINA LUNARDINI90
per mezzo di una festuca, cioè di una verga. La festuca era ancheutilizzata nel rito di liberazione di uno schiavo, sul cui capo es-sa veniva posta per indicare, con un tocco, che gli veniva resti-tuita la libertà 83. Il preverbio perfettivizzante ex, nel compostoexfestuco come è riportato da Cesario, mantiene il significatooriginario del sostantivo festuca, evocando il rito di affranca-mento, di cui si è detto. I lessici mediolatini non tramandano ilverbo exfestucare, ad eccezione del Balbi, ove, con una lieve va-riante, viene così riportato: « Festuca [...] inde effestucare ver-bum iuris idest abrenuncia » 84. Ex(-eff)festucare è dunque un vo-cabolo del diritto, che indica la fine di una condizione di servi-tù o, comunque, di sudditanza, dalla quale – come risulta dalpasso di Cesario – era possibile liberarsi anche con un atto for-male di ripudio, dichiarando fermamente di non voler più ri-conoscere qualcuno o qualcosa a cui si apparteneva, sino all’ab-bandono della propria fede, con atto di apostasia o affidandosial demonio. Per completezza d’informazione ricordo che ancheil Du Cange 85, il Diefenbach 86 e il Mittellateinisches Wörterbu-ch 87 registrano la voce exfestucare.
FURRATA (CAPPA)
Il demonio si presenta sotto le spoglie di un pellegrino chechiede aiuto a un cavaliere di nome Gherardo, il quale lo acco-
83. PLAUTI Comoediae, recensuit et emendavit F. LEO, Berolini, 1958, II, Miles glo-
riosus, IV, 1, 15: « Quid ea? ingenuan an festuca facta e serva liberast? »
84. Cfr. JOANNIS BALBI Catholicon cit. (nota 20). Il lemma abrenuncia rimanda alla for-
mula del rito dell’ordo baptismi, al momento della abrenunciatio e della professio fidei, attra-
verso l’abrenuntio pronunciato dal battezzando richiesto di « abrenuntiare Satanae, operi-
bus eius et pompis eius » (cfr. Ordo baptismi in Rituale romanum pro diocesi bus Italiae).
85. DU CANGE, Glossarium cit. (nota 21), pp. 453-454: « Festuca [...] Exfestucare,
Idem quod Festucam tradere, abjicere, rem abdicare Caesarius lib. 2 Miracul. cap. 12 ».
86. DIEFENBACH, Glossarium cit. (nota 23), p. 216, B: « Exfestucare [...] hechin vel
swingen (8 & c.). v’ziehen (8). entkleiden ».
87. Mittellateinisches Wörterbuch cit. (nota 24), p. 1576, l. 36: « *exfestucatio,
*exfestuco v. *effestucatio, *effestuco; III, 1115-1117, l. 71-72: *effestuco (exf-), -
avi, -atum, -are (ex et festuca, cf. *abfestucare); l. 18-20 spectat ad homines (ad
Deum: l. 28) i. q. abdicare, contradicere – sich lossagen (von), Fehde bieten; l. 27-
29 CAES. HEIST. mirac. I 2, 12 p. 80, 1 miser iuvenis [...] creatorem suum ore nega-
vit, manu -vit diabolo hominium faciens ».
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 98 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Cyan
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 98 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Magenta
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 98 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Yellow
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 98 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Black
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 98 lato A data 04/15/2014 colore A
ll
PR
EP
S
CMYKP
RE
PS
CMYK
PECULIARITÀ LESSICALI NEL DIALOGUS MIRACULORUM 91
glie e gli dona il proprio mantello, esprimendo in tal senso ungrande gesto di carità 88. Questo è il passo:
Die quadam Deo permittente omnium bonorum inimicus diabolus ante ostium militis
pulsans, sub forma et habitu peregrini, in nomine Sancti Thomae hospitium petivit. Quo
sub omni festinatione intromisso, cum esset frigus, et ille se algere simularet, Gerardus
cappam suam furratam bonam satis, qua se tegeret iens cubitum, transmisit 89.
La cappa furrata è il mantello, fatto di pelliccia, che consenteal falso pellegrino di ripararsi dal freddo. Il lemma furratus nonè registrato in nessun lessico mediolatino ma è presente nel DuCange, che rimanda a foderatus, indicando la pelliccia che rico-priva il mantello 90. Il verbo furrare nel senso di foderare, da cuideriva furratus, è registrato soltanto nel Diefenbach 91.
GRUTILLANDO
Le cicogne dell’abbazia di Cîteaux vengono benedette dalpriore prima della loro partenza verso paesi caldi. Questi volati-li paiono rispondere, gracchiando, alla benedizione del priore,grato per il lavoro da loro compiuto nel liberare il monastero ei dintorni dai danni recati dai vermi. Questo è il passo di Cesa-rio che narra l’episodio:
Die quadam cum acies suas ordinassent ad peregrinandum, ne hospitalitatis concessae
immemores esse viderentur, conventum qui eadem hora in agro laborabat petentes,
eumque crebrius grutillando circumvolantes, omnes in admirationem verterunt, igno-
rantibus quid peterent 92.
Il lemma grutillare è onomatopeico nell’indicare il verso emessodalle gru che, nel nostro passo, esprimono la loro riconoscenza alpriore per essere state ospitate al riparo dalle intemperie all’interno
88. Per il topos agiografico è da citare il notissimo racconto del gesto compiuto
da s. Martino, come si legge in SULPICIO SEVERO, Vita di Martino, 3, 1-6, a cura di F.
RUGGIERO, Bologna, 2003 (Biblioteca Patristica, 40), pp. 82-87.
89. DIAL. 8, 59, pp. 1642-1643, ll. 20-25.
90. DU CANGE, Glossarium cit. (nota 21), p. 637: « Furratus, Forratus, Pellitus, ex
Gall. Fourré [...] Vide Foderatus ».
91. DIEFENBACH, Glossarium cit. (nota 23), p. 253, C: « *Fur- (23), fu-rare fùtern
(6). vudern (8). voderen (23) ».
92. DIAL. 10, 58, pp. 2008-2009, ll. 8-12.
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 99 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Cyan
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 99 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Magenta
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 99 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Yellow
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 99 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Black
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 99 lato A data 04/15/2014 colore A
ll
PR
EP
S
CMYKP
RE
PS
CMYK
VALENTINA LUNARDINI92
del monastero. Questo lemma non è presente nei dizionari del la-tino classico, né in quelli del latino medievale. Avremmo, quindi,un hapax attestato in quest’opera di Cesario.
MALDRUM
All’ambito del sistema di misurazioni agricole del mondogermanico è da ricollegare il lemma maldrum, utilizzato da Ce-sario al singolare e al plurale (maldra) per indicare una misura-zione del grano. Ecco i passi che si leggono nel Dialogus:
Portarius vero centum libras suas recipiens, non ex eis vineas vel agros, sed totidem
maldra siliginis apud Confluentiam comparavit, quibus satis sufficienter usque ad
messem pauperes sustentavit 93.
Cum post confirmationem Ottonis in regno tanta esset abundantia annonae, ut in Epi-
scopatu Coloniensi maldrum quinque vel sex denariis multo tempore venderetur, contigit
in quadam eiusdem Dioecesis villa, cuius nomen excidit, miraculum dignum memoria 94.
Questo vocabolo, come carrata, non è registrato nel lessicimediolatini, ma esclusivamente nel Closener 95 e nei repertorisuccessivi del Diefenbach 96 e del Du Cange, ove si nota l’alter-nanza tra le lettere t /d 97. Il corrispettivo del tedesco odierno èMalter, che indica tuttora una misura di grano, come registranoi dizionari della lingua tedesca 98.
MUMMART
Un altro lemma di cui non abbiamo documentazione al difuori dell’opera di Cesario, è mummart, registrato in questa frase:
93. DIAL. 4, 66, pp. 840-841, ll. 13-16.
94. Ibid., pp. 1930-1931, ll. 23-27.
95. Die Vokabulare von Fritsche Closener cit. (nota 49), Ma 68, p. 858: « Maltrum
Malter oder vierteil ».
96. DIEFENBACH, Glossarium cit. (nota 23), p. 344, C: « *Mal-drum, -trum (74, 93)
[...] hd. malter, malder [...] viertail (74) ».
97. DU CANGE, Glossarium cit. (nota 21), pp. 201-202: « Maltra, Maltrum, Mal-
drus, Maldrum [...] Maldrum et Maldrus apud Caesarium lib. 4. cap. 6. lib. 10. cap.
17. et 47 ».
98. Dizionario delle lingue italiana e tedesca cit. (nota 75), p. 875: « Malter m./n. (-s,
-) 1. <Stor> (Getreidemaß) antica misura per cereali (100-700 l circa) ».
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 100 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Cyan
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 100 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Magenta
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 100 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Yellow
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 100 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Black
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 100 lato A data 04/15/2014 colore A
ll
PR
EP
S
CMYKP
RE
PS
CMYK
PECULIARITÀ LESSICALI NEL DIALOGUS MIRACULORUM 93
Mummart momordit me 99.
Nel brano da cui si cita, è narrata la vicenda di una donnanobile e devota, alla quale un lupo, che si aggirava nei dintornidel villaggio, rapisce la figlioletta. La bimba riesce a salvarsi dal-le grinfie del lupo, ma reca il segno del morso che l’animale halasciato sul collo. Il lemma mummart è l’espressione popolarecon la quale si indica il lupo 100. Non ne trovo la documenta-zione né in lessici mediolatini né in dizionari moderni.
MUSSUS
Cesario narra anche la vicenda di un uomo che, per alleg-gerire il carico di legna portato sulle spalle da alcuni affaticatiindividui, decide di acquistarne una parte. Questo è il passo:
Tantae igitur pietatis exstitit vir beatus, ut saepe in porticu ecclesiae sedens, cum
pauperes musso, quem de nemore collegerant, oneratos praeterire cernere, emeret ipse,
non quod eo in aliquot indigeret, sed ut paupers a labore liberaret 101.
Il lemma mussus è attestato unicamente nel glossario del DuCange, che così riporta: « Mussus vel mussum. Caesarius lib. 6Mirac. Cap. 5: cum pauperes musso, quem de nemore college-rant, oneratos preterire cerneret ». Ecco la spiegazione che vienedata: « Fascis lignorum vel herbarum, aut muscus, herba seu lanu-go arborum et locorum palustrium, inquit editor, Gallis, Mous-se » 102. Il Du Cange conosce, dunque, mussus e muscus, e attribui-sce al secondo dei due lemmi il significato corrispondente all’italia-no muschio e al francese mousse, a cui vien fatto riferimento. Neltedesco della nostra versione, il vocabolo di Cesario viene resocon Moos, il termine che indica il muschio 103.
PARTICULA
Alla celebrazione della Messa è da ricollegare il lemma par-ticula, utilizzato da Cesario nel racconto di un prodigio avvenu-
99. DIAL. 7, 45, pp. 1456-1457, l. 29 e pp. 1458-1459, l. 1.
100. Ibidem, nota 1295: « Volkstümlicher Ausdruck für den Wolf ».
101. DIAL. 6, 5, pp. 1168-1169, ll. 16-20.
102. DU CANGE, Glossarium cit. (nota 21), p. 559.
103. Dizionario delle lingue italiana e tedesco cit. (nota 75), p. 924.
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 101 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Cyan
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 101 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Magenta
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 101 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Yellow
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 101 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Black
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 101 lato A data 04/15/2014 colore A
ll
PR
EP
S
CMYKP
RE
PS
CMYK
VALENTINA LUNARDINI94
to nei confronti di una donna del Brabante, che poté riceverel’Eucarestia dalle mani stesse del Salvatore. Il lemma, diminuti-vo del sostantivo pars, indica il frammento dell’ostia consacrata.Questo è il passo di Cesario:
Nostis domine quot hic reposueritis particulas? Sic enim hostias vocare solent 104.
L’accezione liturgica che ha il vocabolo nella prassi eucari-stica, non è registrata in nessun lessico o glossario di latino me-dievale. Essa è, però, viva anche nell’uso corrente della linguaitaliana, come documentano i dizionari moderni.
RUMBULA
Nella città di Veldenz, in diocesi di Treviri, una nobildon-na s’indigna davanti a una statua della Vergine molto veneratadalla gente del posto ma raffigurata in modo rozzo. La Vergine,umiliata, condanna la nobildonna alla miseria sino alla fine deisuoi giorni. Queste sono le parole di disprezzo pronunciate neiconfronti della statua di legno:
Ut quid hic stat vetus haec rumbula 105?
Il lemma rumbula nella spiegazione riferita dal Du Cange,sta ad indicare una donna anziana e malfamata 106. Non esistonoaltre documentazioni del lemma nei repertori, nei dizionarimoderni, nei lessici e nei glossari mediolatini. Il corrispettivodel tedesco odierno è Rumpel/Gerümpel, termine adottato nellaversione in tedesco del nostro passo 107.
104. DIAL. 9, 35, pp. 1818-1819, ll. 13-14.
105. DIAL. 7, 44, pp. 1454-1455, ll. 13-14.
106. DU CANGE, Glossarium cit. (nota 21), p. 235-236: « Rumbula. Caesarius Hei-
sterbacensis lib. 7. cap. 45: Ipsam iconam (Deiparae) respiciens [...] indignans ait, Ut quid
hic stat vetus haec Rumbula? Et mox: Quia Domina illa vocavit me veterem Rumbulam.
Qua voce designari putant vetulam, putidam aut infamem formina [...] vel Rumbu-
lam intelligit Mulierem, quia rhombum tractat ».
107. Dizionario delle lingue italiana e tedesco cit. (nota 75), p. 1135 (Gerümpel), p. 503
(Rumpel).
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 102 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Cyan
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 102 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Magenta
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 102 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Yellow
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 102 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Black
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 102 lato A data 04/15/2014 colore A
ll
PR
EP
S
CMYKP
RE
PS
CMYK
PECULIARITÀ LESSICALI NEL DIALOGUS MIRACULORUM 95
RUTTA
Cesario riporta la vicenda di un servo dell’arcidiacono di
Lüttich, che decide di diventare un predone. Questo è il passo:
Eodem tempore servus quidam, aliquando cursor Ottonis Archidiaconis Leodiensis,
officium suum deserens, multitudini praedonum, quae rutta vulgo dicitur, se associa-
vit 108.
Lo stesso lemma, con il significato di banda di uomini dedi-ti al malaffare, è attestato anche in questo passo:
et quia ad parentes redire erubuit, praedonibus, quorum multitudo “rutta” vocatur,
se coniunxit 109.
Il lemma ruta/rutta è attestato nel Du Cange 110. Sempre ilDu Cange rimanda alla voce rumpere, allegando anche la docu-mentazione relativa ai derivati del lemma, del quale non c’ètraccia nei lessici e nei glossari mediolatini. Per il Fortleben del
vocabolo nel tedesco di oggi è da citare il lemma Rotte 111.
SACERDOTATUS
All’ambito dei temi trattati riguardo alla condotta dei mini-
stri del culto, in particolare nell’amministrazione del sacramentodella penitenza, è da ascrivere il verbo sacerdotari, registrato daCesario nel Dialogus, ove si legge il racconto del monaco chenarra al novizio la vicenda di un sacerdote che impartiva la
medesima pena penitenziale, senza distinzione, sia al fedele cheviveva in esemplare continenza, sia al peccatore incontinente. Ilcommento allo strano comportamento suona così:
Certe male sacerdotati sumus 112.
108. DIAL. 11, 53, pp. 2154-2155, ll. 18-20.
109. DIAL. 2, 2, pp. 350-351, ll. 13-14.
110. DU CANGE, Glossarium cit. (nota 21), p. 245: « Ruta, Praedonum cohors. Vide
Rumpere [...] Rutta, Cohors praedonum vel militum: Rutuarii, Milites vel predones.
Vide Rumpere ».
111. Dizionario delle lingue italiana e tedesco cit. (nota 75), p. 1129.
112. DIAL. 3, 40, pp. 638-639, ll. 10.
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 103 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Cyan
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 103 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Magenta
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 103 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Yellow
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 103 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Black
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 103 lato A data 04/15/2014 colore A
ll
PR
EP
S
CMYKP
RE
PS
CMYK
VALENTINA LUNARDINI96
Il verbo attivo sacerdotare, non presente nei lessici mediolati-ni, indica l’essere promossi al ministero sacerdotale, e in questosenso viene registrato nel glossario del Du Cange 113. Il verbopassivo sacerdotari, che pure indica la condizione di chi, nellaChiesa, riceve il sacramento dell’ordine, è attestato esclusiva-mente nel Diefenbach, ove si legge: « Sacerdotari briester wer-den (75) » 114.
SCULTETUS
All’ambito del lessico attinente al governo della città è daricondurre il lemma scultetus, vocabolo presente in questi quat-tro passi del Dialogus di Cesario:
Narravit mihi anno praeterito scultetus proximae villae, quae Wintere dicitur, rem
satis terribilem 115.
Qui [...] mox ut egressus est, occurrit ei quidam scultetus suus primo 116.
Amicus noster scultetus de Kolmere 117.
Item de sculteto de Leggenich qui in eundem montem missus est 118.
Il lemma scultetus, non registrato nei glossari mediolatini,indica una magistratura di alto grado nella vita cittadina, comerisulta dalle attestazioni del Du Cange 119 e del Diefenbach 120.Anche il Closener registra la forma scultetus, con l’indicazionedel tedesco odierno Schultheiß, che indica il sindaco della cit-
113. DU CANGE, Glossarium cit. (nota 21), p. 255: « Sacerdotare ad Sacerdotium
promoveri. Chron. Corn. Zantfliet ad ann. 1364. apud Marten. Tom. 5. Ampl. Col-
lect. Col. 284: Qui (Engelbertus) cum infra tempus praescriptum nollet Sacerdotare, sed
aspiraret ad Comitatum Clevensem, [...] renuntiavit electioni de se factae Coloniae ».
114. DIEFENBACH, Glossarium cit. (nota 23), p. 506, B.
115. DIAL. 4, 22, pp. 726-727, ll. 15-16.
116. DIAL. 6, 26, pp. 1242-1243, ll. 25-27.
117. DIAL. 12, 7, pp. 2198-2199, l. 1.
118. Ibidem, ll. 11-12.
119. DU CANGE, Glossarium cit. (nota 21), p. 376: « Scultetus, vox ejusdem originis
ac Sculdais, Praetor, Praefectus, Ballivus, Judex oppidi ».
120. DIEFENBACH, Glossarium cit. (nota 23), p. 521, C: « Scultetus (aus altsächs.
schuldhêt?) [...] scholtheyß (7) ».
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 104 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Cyan
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 104 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Magenta
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 104 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Yellow
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 104 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Black
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 104 lato A data 04/15/2014 colore A
ll
PR
EP
S
CMYKP
RE
PS
CMYK
PECULIARITÀ LESSICALI NEL DIALOGUS MIRACULORUM 97
tà 121. Nell’italiano abbiamo il termine sculdascio, con cui si de-signa l’ufficiale regio di grado inferiore sottoposto al gastaldo 122.
STERLINGUS
Protagonista di un altro racconto di Cesario è un soldato dinome Mengoz, colpevole di non aver assolto un voto emessodurante una malattia. Incontrato un altro soldato di nome Gul-dolfo, intraprende, con lui, un pellegrinaggio, durante il quale,in una sosta, viene rimproverato dal vescovo per la promessanon mantenuta. Preso da spavento, viene raggiunto dal demo-nio che tenta di dissuaderlo dai buoni propositi e, in più, locolpisce e lo getta a terra. Assistendo al fatto, Guldolfo esortaMengoz a sciogliere il voto. Questi dice di non aver denaro, eallora il compagno interviene, cioè, per usare le parole diCesario,
dedit ei solidum sterlingorum, et ille solvit votum neglectum 123.
Il lemma sterlingus è registrato esclusivamente negli Exquo 124 e nei dizionari mediolatini di epoca successiva, quali ilDu Cange 125 e il Diefenbach 126. La documentazione ivi citata
121. Die Vokabulare von Fritsche Closener cit. (nota 49), Sc 140, p. 1321: « Scultetus
Schultheisse Scultetus Shultheiße Wa] fehlt B1 So1 ».
122. La forma ‘sculdhais’ è attestata nell’Edictum Rothari, come si legge in Le leggi
dei Longobardi, storia, memoria e diritto di un popolo germanico, a cura di C. AZZARA e S.
GASPARRI, Città di Castello, 2005 (Collana Alto Medioevo, 4), pp. 20-22, in partic.
p. 15: « De grabworfin. Si quis sepulturam hominis mortui ruperit et corpus expolia-
verit aut foris iactaverit, nongentos soledos sit culpavelis parentibus sepulti. Et si pa-
rentis proximi non fuerint, tunc gastaldius regis aut sculdhais requirat culpa ipsa et ad
curte regis exegat ». Cfr. anche i numeri 35, 18 e 221.
123. DIAL. 5, 42, pp. 1098-1099, ll. 6-7.
124. Vocabularius ex quo cit. (nota 38), p. 2586: « Sterlingus ein engelsche eyn en-
ghelsch pening ».
125. DU CANGE, Glossarium cit. (nota 21), pp. 319-320: « Esterlingus, Sterlingus,
voces Anglis, et inde caeteris nationibus familiares in re monetaria. Trifariam vero
accipitur Esterlingus, seu Sterlingus: primo pro monetario pondere, deinde pro quali-
tate monetae, tertio denique pro quapiam monetae specie ».
126. DIEFENBACH, Glossarium cit. (nota 23), p. 551, C: « Sterlingus, -lingeus, -elin-
gus, ester- (11), estri- (19) -lingus (moneta, engl. sterling) ».
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 105 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Cyan
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 105 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Magenta
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 105 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Yellow
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 105 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Black
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 105 lato A data 04/15/2014 colore A
ll
PR
EP
S
CMYKP
RE
PS
CMYK
VALENTINA LUNARDINI98
attesta che il solidus sterlingorum indica un tipo di moneta, moltodiffusa e variamente valutata, il cui approdo è l’attuale lemmainglese sterling.
STREPA
Il demonio assume le sembianze di un giovinetto che, ge-nuflesso, tiene la staffa di un soldato e si pone al suo servizio.Nel racconto si precisa che questi
numquam equum suum ascendit, numquam descendit, quin ille praeparatus esset, et
genu flexo strepam teneret 127.
Il lemma strepa indica la staffa, cioè uno dei finimenti chepende ai lati della sella ove il cavaliere può appoggiare il piede.Questo lemma, non attestato nei lessici mediolatini di area ita-lica, è da ricollegarsi all’ambito germanico, come documentatonel Summarium Heinrici, opera di area germanica che si pone ametà strada tra l’enciclopedia e il lessico, e che risale ai secoliXI-XII 128. Aggiungo che il lemma, non registrato nella lessico-grafia mediolatina, è attestato nella documentazione offerta dalDu Cange 129. Spiegando il lemma, il Du Cange, dà, come si-nonimo stapes, registrando, per quest’ultimo lemma, la variantestapha 130.
127. DIAL. 5, 36, pp. 1078-1079, ll. 1-2.
128. Summarium Heinrici Band I. Textkritische Ausgabe der ersten Fassung Buch I-
X, herausgegeben von R. HILDEBRANDT, Berlin-New York, 1974; Summarium Heinri-
ci Band II. Textkritische Ausgabe der zweiten Fassung Buch I-VI sowie des Buches
XI in Kurz und Langfassung, herausgegeben von R. HILDEBRANDT, Berlin-New
York, 1982; Summarium Heinrici Band III. Wortschatz. Register der deutschen Glos-
sen und ihrer lateinischen Bezugswörter auf der Grundlage der Gesamtüberlieferung.
Bearbeitet und herausgegeben von R. HILDEBRANDT und K. RIDDER, Berlin-New
York, 1995: I, p. 355, X, VIIII, « Strepa (vel sternipes) stegereif ».
129. DU CANGE, Glossarium cit. (nota 21), p. 612: « Strepa, Stapes, quo quis in
equum tollitur, cui insistunt pedes equitantium. Anglis Stritrop, est Strepa [Stirrup.]:
Straep, corrigia. Acta Hadriani PP. IV: Decretum est [...] quod idem Rex pro Apostolo-
rum Petri et Pauli reverentia praedicto PP. Hadriano exhiberet stratoris officium, et ejus Stre-
pam teneret ad conscendendum equum [...] Caesarium lib. 5. cap. 36. lib. 7. cap. 33 ».
130. DU CANGE, Glossarium cit. (nota 21), p. 583: « Stapes, Stapedium, Stapha aliis,
qua quis in equum tollitur ». Per ‘staffa/strepa’ cfr. C. BATTISTI - G. B. ALESSIO, Di-
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 106 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Cyan
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 106 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Magenta
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 106 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Yellow
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 106 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Black
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 106 lato A data 04/15/2014 colore A
ll
PR
EP
S
CMYKP
RE
PS
CMYK
PECULIARITÀ LESSICALI NEL DIALOGUS MIRACULORUM 99
TUNNA
Il vitium gulae colpisce alcuni monaci cistercensi, che si ac-cingono a preparare carni e vini prelibati, gustandone golosa-mente, non però in cucina, ma dopo averli collocati in unagrossa botte, temendo che l’abate li rimproverasse. Il passo vie-ne così riportato da Cesario:
Abbas quidam nigri ordinis, vir bonus et disciplinatus, monachos habebat satis mira-
biles et dissolutos. Die quadam quidam ex eis praepaverant sibi diversi generis carnes
et vina delicata. Quibus cum uti non auderent in aliqua officina timore Abbatis, con-
gregati sunt in vas vinarium maximum et vacuum, quod vulgo dicitur tunna, illuc
deferentes praeparata 131.
Il lemma utilizzato da Cesario per indicare il grande reci-piente che contiene i cibi prelibati che i monaci furtivamentesottraggono agli occhi dell’abate, è tunna. Questo vocabolo èattestato nel Corpus glossariorum latinorum che riporta: « tunna(tinia cod.) bidin saxonice gloss. Werth. (cf. Gallée 355: v. sup-pl. cf. tunna chufa A II D, III 262,3 II) » 132. L’accezione di va-so, recipiente o coppa viene riportata anche nel Diefenbach,ove si legge: « Tonna [...] chuofa » 133. Il lemma viene inoltreregistrato dal Du Cange con il significato di recipiente checontiene acqua, vino ed altre bevande 134. La forma corrispon-dente del tedesco odierno è Tonne.
VALENTINA LUNARDINI
zionario Etimologico Italiano, I-V, Firenze, 1975, V, pp. 3612-3613: « staffa [...] Long.
Staffa, idem. Molto diffuso nei dialetti. Data l’origine germanica della staffa, non sor-
prende che anche il fr. abbia un prestito analogo, étrier, dal francone streup correggia,
latinizzato nell’XI sec. come strepa ».
131. DIAL. 3, 49, pp. 654-655, ll. 5-11.
132. Corpus Glossariorum Latinorum, edited by G. GOETZ, I-VII, Lipsiae et Berolini,
1888-1923 (rist. anast. Amsterdam, 1965): VII, p. 374.
133. DIEFENBACH, Glossarium cit. (nota 23), p. 587, B: « To-, tu- (22b, 125, 127,
Sum., Gf.) -nna, -na (22b, Gf.), -nsa (22b) hd. faß. offer- (Gf.), leit- (Sum.) -vaz;
chuofa ».
134. DU CANGE, Glossarium cit. (nota 21), p. 209: « Tunna, Tonna, Vas aquae, vi-
ni, cerevisiae, et alterius liquoris capax, Gallis, Germ. Belg. Tonne. Gloss. Anglo-Sax.
Aelfrici: Cupa, tunne ».
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 107 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Cyan
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 107 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Magenta
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 107 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Yellow
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 107 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Black
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 107 lato A data 04/15/2014 colore A
ll
PR
EP
S
CMYKP
RE
PS
CMYK
VALENTINA LUNARDINI100
ABSTRACT: This essay examines the figure of Caesar of Heisterbach, the
author of several hagiographies, sermons, and texts pertaining to visionary and
miracle literature, such as the Dialogus miraculorum sive De miraculis et visionibus
sui temporis. The author analyses the lemmas in the latter, of particular
significance in the Latin lexical patrimony and requiring explication because of
their semantic and morphological peculiarities. These words can be traced to
various contexts, such as the ecclesiastical world, family and daily life, evil, the
law, and agricultural work. Each gloss includes documentation present in
lexicons and Medieval Latin glossaries and catalogues in an effort to reconstruct
the history of the word. In addition, the author provides evidence relating to
these lemmas from modern glossaries, finding – where possible – results in
contemporary languages, with particular reference to Germanic-speaking
areas. The twenty-six lemmas studied are: apodiare, boti, braxare/braxatrix, bria,
carena, choritae/sanguinite, clenodia, cruselinum, curmeidia/ius curmeidiae,
exfestucare, furrata (cappa), grutillando, maldrum, mummart, mussus, particula,
rumbula, rutta, sacerdotatus, scultetus, sterlingus, strepa, tunna.
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 108 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Cyan
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 108 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Magenta
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 108 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Yellow
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 108 lato A data 04/15/2014 colore P
rocess Black
Studi M
edievali Fasc I_G
iugno 2014.job segnatura nr. 108 lato A data 04/15/2014 colore A
ll
PR
EP
S
CMYKP
RE
PS
CMYK




































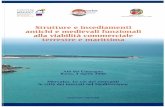









![Storia dell'Arco 4 - [Brovelli] - Dispensa didattica Corso OPS Storico parte quarta - Archi Basso medievali](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63203c0bc5de3ed8a70da29e/storia-dellarco-4-brovelli-dispensa-didattica-corso-ops-storico-parte-quarta.jpg)




