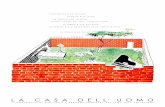I ponti medievali sulla Cecina, dal Paratino alla foce, nelle testimonianze di Giovanni Targioni...
Transcript of I ponti medievali sulla Cecina, dal Paratino alla foce, nelle testimonianze di Giovanni Targioni...
La collanaÈ destinata alla pubblicazione di studi, editi ed inediti, tappe di itinerari di ricerca, Percorsi, appunto. Offre agli specialisti la possibilità di avere a disposizione, raccolti in un volume, saggi spesso di non facile reperimento e, al lettore ‘comune’, l’opportunità di entrare dentro il ‘laboratorio’ dello storico.
Il libroxxxxxxxxxx
Il curatorexxxxxxx
Volumi pubblicati 1. Marco Tangheroni, Medioevo Tirrenico. Sardegna, Toscana e Pisa2. Franca Leverotti, Popolazione, famiglie, insediamento. Le sei Miglia lucchesi nel XIV e XV secolo3. Silio P.P. Scalfati, Corsica Monastica. Studi di storia e di diplomatica4. Silio P.P. Scalfati, La Forma e il Contenuto. Studi di scienza del documento5. Paola Ventrone, Gli araldi della commedia. Teatro a Firenze nel Rinascimento6. Silio P.P. Scalfati, Diplomatica Corsa7. Lucia Gai - Giancarlo Savino, L’Opera di S. Jacopo in Pistoia e il suo primo statuto in volgare
(1313)8. Bruno Dini, Saggi su una economia-mondo. Firenze e l’Italia fra Mediterraneo ed Europa (secc.
XII-XIV)9. Riccardo Fubini, Quattrocento fiorentino. Politica, diplomazia, cultura10. Emilio Cristiani, Scritti scelti, a cura di Silio P.P. Scalfati e Marco Tangheroni11. Emilio Gabba - Umbero Laffi, Sociedad y politica en la Roma republicana (siglos III-I a.C.)12. Graziella Berti - Catia Renzi Rizzo - Marco Tangheroni, Il mare, la terra il ferro13. Maria Luisa Ceccarelli Lemut, Medioevo Pisano. Chiesa, Famiglie, Territorio14. Franco Cardini - Maria Luisa Ceccarelli Lemut (a cura di), Quel mar che la terra inghirlanda. In
ricordo di Marco Tangheroni15. Maria Luisa Ceccarelli Lemut - Massimo Dringoli (a cura di), Castelli e fortificazioni della
Repubblica Pisana16. Antonio Musarra, La guerra di San Saba17. Rosanna Pescaglini Monti, Toscana medievale. Pievi, signori, castelli, monasteri (secoli X-XIV)
Stud
i di S
toria
deg
li In
sedi
amen
tiin
ono
re d
i Gab
riella
Gar
zella
Collana PERCORSI
Studi di Storia degli Insediamenti
in onore diGabriella Garzella
a cura diENRICA SALVATORI
ISBN 978-88-6315-386-6
9 7 8 8 8 6 3 1 5 3 8 6 6
ENR
ICA
SA
LVA
TOR
IPacini
Editore
PaciniE d i t o r e
Ricerca
PaciniE d i t o r e
Ricerca
a cura diEnrica Salvatori
Studi di Storia degli Insediamenti
in onore diGabriella Garzella
© Copyright 2014 Pacini Editore SpA
ISBN: 978-88-6315-713-0
Realizzazione editoriale
Via A. Gherardesca56121 Ospedaletto (Pisa)[email protected]
Fotolito e StampaIndustrie Grafiche Pacini
Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, comma 4, della legge 22 aprile 1941 n. 633 ovvero dall’accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMER-CIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000. Le riproduzioni per uso differente da quello personale sopracitato potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dagli aventi diritto.
I PONTI MEDIEVALI SULLA CECINA, DAL PARATINO ALLA FOCE, NELLE TESTIMONIANZE DI GIOVANNI TARGIONI TOZZETTI,
ROMUALDO CILLI, EMANUELE REPETTI
Laura GaLoPPini
La glauca luna lista l’orizzonteE scopre i campi nella notte occulti
E il fiume errante. In suono di singultiL’onda si rompe al solitario ponte.
Giovanni Pascoli, Il Ponte, in Myricae
Oltrepassare il fiume Cecina, fin dai tempi remoti, era una tappa fondamentale nel percorso viario costiero dell’Aurelia, per arrivare sia alla deviazione della più interna Emilia Scauri, nel cammino verso Pisa (direzione nord), sia alla strada che, sul lato destro del fiume, portava a Volterra (direzione ovest)1. Il corso del fiume in prossimità di una foce utilizzata come scalo portuale nei traffici locali, secondo fonti tardo medievali (portus Cecinae)2, lascia supporre l’esistenza di diversi ponti costruiti in varie epoche, come attestano talora ritrovamenti casuali, ol-tre ad alcuni guadi attraversabili a seconda delle stagioni3. Di particolare rilevanza sono le testimonianze lasciateci da Giovanni Targioni Tozzetti (1751), Romualdo Cilli (1752-53) ed Emanuele Repetti (1833), i quali, nei loro scritti, hanno fornito preziose indicazioni dei ‘ponti sulla Cecina’ collocati nell’ultimo tratto affrontato dal fiume prima di sfociare in ma-
1 Questo contributo recupera una tematica centrale per la storia del terri-torio alla foce della Cecina collocandosi nel filone dei contributi dedicati alla Maremma Pisana da Maria Luisa Ceccarelli Lemut e da Gabriella Garzella. Il lavoro sintetizza due miei studi, ai quali rinvio per ulteriori approfondimenti e bibliografia, dedicati alla Storia di un territorio alla foce del Cecina: dall’alto Medioevo all’Ottocento, in La villa romana dei Cecina a San Vincenzino (Livorno). Materiali dello scavo e aggiornamenti sulle ricerche, a cura di F. Donati, Pisa 2012, pp. 99-140, e a Romualdo Cilli e Giovanni Targioni Tozzetti: ‘la pianta della villa di Albino’ sulla collinetta di San Vincenzino a Cecina (Livorno), in «Bollettino della Accademia degli Euteleti della città di San Miniato», 79 (2012), pp. 305-343. G. GarzeLLa, Pisa com’era. Topografia e insediamento dall’impianto tardoantico alla città murata del secolo XII, Napoli 1990, pp. 3-7; M.L. CeCCareLLi LeMut, Viabilità medievale di origine romana nel territorio pisano, ora in ead., Medioevo Pisano. Chiesa, Famiglie, Territorio, Pisa 2005, pp. 369-432, per la viabilità costiera ma-remmana pp. 372-375; J. a. quirós CastiLLo, Archeologia delle strade nel medioe-vo, in L’ospedale di Tea e l’archeologia delle strade della Valle del Serchio, a cura di J. A. Quirós Castillo, Firenze 2000, pp. 15-70.
2 Vada e San Vincenzo erano i luoghi destinati al caricamento dei grani, cfr. GaLoPPini, Storia di un territorio, cit., p. 119.
3 L. PaLerMo, Il territorio di Riparbella in età etrusca e romana: appunti per una carta archeologica, in Riparbella terra della maremma pisana dalle origini ai nostri giorni, a cura di G. Biagioli, Forlì 2004, pp. 41-133.
218 LAURA GALOPPINI
re4. Scopo di questo contributo è mettere a confronto e analizzare queste affermazioni per individuare i ponti medievali che sorgevano in quel tratto del fiume dove oggi vediamo ben quattro ponti, tutti costruiti nel corso del Novecento. Questi, seguendo il percorso verso il mare (ovvero est-ovest), sono: il ponte della variante Aurelia nella zona del Paratino (SS1), quello che dall’attuale «via Aurelia nord» (via S. Pietro in Palazzi) si collega con corso Matteotti (l’arteria che attraversa l’abitato di Cecina), il ponte della ferrovia (il quale passa sopra l’attuale via Circonvallazione) e, infine, quello in prossimità della foce a Marina di Cecina (via Volterra).
Ementi et recipienti pro ipso ponte: 1204
Fin dai primi del Duecento abbiamo l’attestazione di un ponte ri-cordato in un atto noto al Repetti (1833), che scriveva: «È altresì vero che di un ponte sulla Cecina presso il Fitto fanno menzione le carte pisane del medio evo; ma questo era un pontone, o navalestro, siccome lo dichiara un istrumento del 29 settembre 1204, relativo a un tal di Bibbona Pontonario, che vendè alcune terre a Enrico Navalestro del ponte della Cecina (Arch. Dipl. fior. Carte del monastero di S. Lorenzo
4 G. tarGioni tozzetti, Relazioni d’alcuni viaggi fatti in diverse parti della To-scana, per osservare le produzioni naturali e gli antichi monumenti di essa, voll. 6, Firenze 1751-1754; per il Cilli, cfr. in tarGioni tozzetti, Relazioni d’alcuni viaggi, cit., vol. 6, pp. 350-352; e. rePetti, Dizionario geografico fisico storico della Tosca-na, voll. 6, Firenze 1833-1846.
Fig. 1. I moderni ponti sulla Cecina: n. 1, ponte della variante Aurelia nella zona del Paratino (SS1); n. 2, ponte di collegamento con la “via Aurelia nord” (via S. Pietro in Palazzi) e corso Matteotti; n. 3, ponte della ferrovia; n. 4, ponte di Marina di Cecina.
219I PONTI MEDIEVALI SULLA CECINA
alle Rivolte)»5. Abbiamo ritrovato il documento: un atto di vendita sti-lato in platea de Biboni prope ecclesiam Sancti Andree da due fratelli di Bibbona a nome anche dello zio Bernardino, che vendevano al ponte di Cecina, rappresentato da Enrico pontonario (Henrigo pontonario pontis de Cecina, ementi et recipienti pro ipso ponte), la terza parte di due terre presso la Cecina al Paratino (positarum ad Cecinam ad Paratinum), con-finanti in tre punti con la terra comitum, cioè dei Gherardeschi, e, nel terzo caso, anche con terra dell’arcivescovo di Pisa6. Quindi, a parte una svista nel riconoscimento dei contraenti, veniamo a sapere – dettaglio di fondamentale importanza – che il ponte fisicamente rappresentato dal pontonario Enrico risultava come personalità giuridica di per sé.
Ancora, risale al 1217 un livello perpetuo concesso da Nerbotto di S. Miniato di Querceto all’opera del ponte di Cecina, rappresentata dal pontonario Moricone del fu Viviano (Moricone filio quondam Vivianis, pontonario opere pontis de Cecina, presenti et recipienti pro [opera] suprascripti pontis), per un pezzo di terra, con tutte le pertinenze, si-tuato nel piano del Paratino, vicino al ponte (unum integrum petium terre cum omni sua pertinentia, quod est positum in plano de Paretino prope pontem suprascriptum), confinante su un lato con la terra del medesimo ponte (terra suprascripti pontis)7. L’atto fu stilato presso la casa del ponte, ad esso vicina e probabilmente presso la pieve del Pa-ratino (actum iuxta domum suprascripti pontis que est iuxta pontem et in confinibus plebis de Paretino): quindi il ponte continuava ad avere una personalità giuridica, ed era affiancato da una costruzione a uso del pontonario.
Dalla lettura di questi due documenti appare che, a monte dell’attua-le zona della Ladronaia8, vi era un ponte che possiamo qualificare come il ‘ponte del Paratino’: questo passaggio era collocato su un importante asse viario che, poco più a sud, portava all’ospedale di Linaglia, dipendente da quello di Stagno9. Non a caso nel 1251, nell’atto rogato a Pisa in una casa dell’ospedale di San Leonardo di Stagno, Ugo rettore concesse in livello perpetuo un appezzamento presso la Cecina e presso la pieve di Paratino; il destinatario del livello era questa volta un privato che agiva per sé e per i suoi eredi, e abitava presso il ponte sulla Cecina, zona Paratino10.
5 rePetti, Dizionario geografico, cit., vol. 1, p. 639. 6 Archivio di Stato di Pisa (=ASP), Diplomatico, S. Lorenzo alla Rivolta, 1204
settembre 29 (stile pisano data l’indizione VII, quindi 1203), corta.7 ASP, Diplomatico, S. Lorenzo alla Rivolta, 1218 giugno 26, corta, stile pisano.8 Collinetta – dove si ricorda uno dei più antichi insediamenti della zona –
situata sullla riva sinistra del fiume a monte dell’attuale paese di Cecina (ovest) e delimitata oggi dalla SS1 nella direttrice verso Casalgiustri, cfr. GaLoPPini, Storia di un territorio, cit., pp. 112-117.
9 i. ChioCCa, Indagine storico-archeologica sull’Ospedale di Linaglia (Guardis-tallo, Pisa), tesi di laurea, rel. prof. M. Milanese, a.a. 2006-2007, pp. 41-52.
10 ASP, Diplomatico, S. Lorenzo alla Rivolta,1251 febbraio 27, corta.
220 LAURA GALOPPINI
Romualdo Cilli: «gli avanzi del ponte che io ho fatti scavare»
Giovanni Targioni Tozzetti nel terzo volume della sua opera, descri-veva, per la prima volta e secondo una metodologia di tipo scientifico, le terre del Feudo di Bibbona, Riparbella, Guardistallo, Casale e Cecina, cioè il vasto territorio che costituiva il «Marchesato di Cecina in quanto posto nella fine della Valle del Cecina, e formato per lo più da una vasta tenuta chiamata la Fattoria di Cecina, posseduta già dalla Famiglia Rea-le de’ Medici» (1751)11. In quegli anni, lungo la fascia costiera posta fra la riva destra (verso Vada) e quella sinistra del Cecina (fino a Bibbona), si era già manifestata l’opera pionieristica finanziata dal conte fiorentino Carlo Ginori, il quale aveva acquistato le terre, e con esse il titolo di Mar-chese. Grazie agli ingenti capitali e seguendo le più avanzate teorie eco-nomico-illuministiche di quegli anni, il Ginori aveva realizzato un’opera dettata da motivazioni pratiche e rivolta, in primo luogo, alla bonifica di terreni che si presentavano paludosi, infestati dalla malaria e spopolati. Ai maggiori esperti del tempo erano stati affidati i suoi progetti, e, fra questi, il Targioni Tozzetti fu incaricato di studiare l’intero territorio per individuare le possibili risorse naturali utili a innescare diversificati processi economici volti allo sviluppo della zona. Fu allora recuperata la memoria storica del ponte trecentesco edificato dal Comune di Pisa. Lo stesso Targioni Tozzetti ricorda, guadando il fiume privo di un ponte, di aver osservato quelli che a lui sembravano «fondamenti d’una pila», mentre i locali erano di opinione contraria. Esplorando ancora un tratto del fiume, presso l’antico palazzo mediceo del Fitto, osservava «una mu-raglia» che riteneva il «primo sostegno ad un ponte mediocre e piano di legno» di cui parlavano gli Statuti pisani (1287):
Mi fu supposto, che nel letto del fiume dove io lo guadai, si vedano i fondamenti d’una pila di ponte, ma da alcuni pratici del paese fui assicurato che ciò non è vero. Osservai però rasente al dirupo della col-linetta, sulla quale è il palazzo [Fitto], una muraglia, la quale sembra aver servito da principio, e da primo sostegno ad un ponte mediocre e piano di legno. La Repubblica pisana ebbe per lo meno voglia di fab-bricare questo utilissimo ponte, poiché negli Statuti del 1284 [1287] L. 4 si legge: la rubrica 12 De ponte Cecinae; e vi si dice Cecinae pontem fieri & aptare faciemus. Il granduca Cosimo I ve lo fece12; ma poi non so come rovinò e forse ne è avanzo la muraglia accennata13.
Il Targioni Tozzetti si riferisce alla rubrica degli Statuti pisani (XII.
11 GaLoPPini, Romualdo Cilli e Giovanni Targioni Tozzetti, cit., pp. 309-314.12 Si tratta della Vita Di Cosimo I De’ Medici, Granduca Di Toscana, descritta
da Aldo Mannucci, Bologna 1586, p. 170, dove si ricorda come Cosimo I «fece in diversi fiumi & torrenti della Toscana, per commodo de’ viandanti, fabricare più & più ponti, come in Arno, Ambra, Mugnone, Tevere, Chiana, Ombrone, Bisenzo, Cercina [Cecina], Elsa, Era, Arbia, Orcia, Cascina, Pescia & più altri».
13 tarGioni tozzetti, Relazioni d’alcuni viaggi fatti, cit., vol. 3, p. 248.
221I PONTI MEDIEVALI SULLA CECINA
De ponte Cecine) nella quale si stabiliva di costruire un ponte idoneo al passaggio degli uomini e del bestiame (ita quod homines et bestie inde libere transire possint), probabilmente con riferimento anche all’attiva pratica della transumanza verso le terre maremmane14.
Dopo la pubblicazione del volume e la notizia della ricerca dell’an-tico ponte sulla Cecina, il Targioni Tozzetti ricevette almeno due lettere di Romualdo Cilli, quel fedele «soprintendente alle fabbriche ed acque» del marchese Carlo Ginori che svolse un ruolo centrale nella costruzione della villa e della colonia della Cecina abitando per circa un decennio su queste terre. Le chiare segnalazioni del Cilli, basate sui primi scavi lun-go il letto del fiume, furono raccolte e pubblicate dal Targioni Tozzetti nell’ultimo volume della prima edizione della sua opera, fra le Giunte e correzioni (1754). Dalla prima lettera del Cilli inviatagli da Cecina (20 aprile 1752) riportava questi brani:
«Nella lettura del tomo terzo de’ suoi Viaggi, avendo osservato a c. 248 che la Repubblica Pisana ordinò farsi il Ponte al fiume Cecina, mi do l’onore di dirle, che questo Ponte ritrovasi distante dalla foce del fiume circa un sesto di miglio, come dimostrano gli avanzi de’ Pilastri, che ho fatti scavare per rinvenire la grandezza e misure del medesimo. Questo Ponte sì vicino al mare, è assolutamente opera de’ Pisani, per-ché il Ponte che serviva alla Via Emilia, doveva trovarsi circa alquanto ov’è il Forno di Cecina, perché ivi mirano alcuni lunghi pezzi di strada lastricata, che si ritrovano nei boschi, tanto a destra che a sinistra del Fiume, e si suppone sieno stati tralasciati per fare capo al Fitto, ov’è il miglior guado del fiume, ed ove il Granduca Cosimo I edificò il ponte di legname sopra pilastri di muro, de’ quali ancora vi esistono gli avanzi etc.»15.
Il Cilli dunque riteneva di aver individuato i resti dell’antico ponte trecentesco «distante dalla foce del fiume circa un sesto di miglio»: consi-derato che il miglio toscano di allora misurava 1.653,6 metri (pari a 2.833 braccia)16, le rovine si dovevano trovare a circa 275,6 metri dalla foce, co-munque molto vicino alla bocca del fiume, anche tenendo presenti le pos-
14 ASP, Statuti, reg.1, c. 100v; Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo, a cura di F. Bonaini, Firenze 1854-1870, vol. I, p. 487; per il 1287, cfr. M. ronzani, Una nuova datazione per gli statuti di Ugolino e Nino ‘podestà, capitani e rettori del Comune e del Popolo di Pisa’, in «Bollettino Storico Pisano», LX (1991), pp. 267-282.
15 tarGioni tozzetti, Relazioni d’alcuni viaggi, cit., vol. 6, 351-352.16 a. Martini, Manuale di metrologia, Torino 1883, p. 206.
Fig. 2. ASP, Statuti, reg.1, c. 100v, particolare. Rubrica XII. De ponte Cecine.
222 LAURA GALOPPINI
sibili varia-zioni della linea costiera. Forse, con-siderato il tratto favore-vole all’attra-ver samento del fiume in p r o s s i m i t à del mare, se ne ipotizza la collocazione presso quel «guado alle vacche» in-dicato nella carta dell’in-gegner Ferdi-nando Piaz-zini (1821). Con una se-conda lettera
al Targioni Tozzetti (da Cecina, 20 marzo 1753), il Cilli tornava sull’ar-gomento aggiungendo come il ponte fosse stato costruito «per comodo della Terra di Vada» e, più in generale, per utilizzare le spiagge (e la foce) per lo sbarco e imbarco delle merci locali e nella navigazione costiera:
«Gli avanzi del ponte, che io ho fatti scavare vicino al mare un terzo di miglio, gli credo del ponte fabbricato dalla Repubblica pisana nel 1281 [sic!], per comodo della Terra di Vada, e per avere la facilità di scorrere la spiaggia del mare. Questo ponte, secondo denota un pilastro rima-sto rovesciato, è stato fatto cadere alla corrente del fiume, allorché accrescendosi la corrosione della destra sponda, l’estremità del ponte restò senza appoggio. I pilastri di questo ponte avevano la superficie di pietre riquadre, et il ponte era diviso in 5 archi».17
Sembra quindi che il ponte di cui ci parlano gli Statuti pisani e ter-minato nel 1340, rispetto a quello del Paratino attestato nel Duecento, fosse stato spostato verso il mare per una maggiore utilità anche dello scalo offerto dalla bocca della Cecina. La sua costruzione è da collo-care nel più ampio contesto politico ed economico dei decenni di fine Duecento e dei primi del Trecento, ossia dopo la battaglia della Meloria (1284), quando i Pisani ormai intravedevano chiaramente la fine del loro predominio commerciale nel Mediterraneo, tanto più dopo la loro espul-
17 tarGioni tozzetti, Relazioni d’alcuni viaggi, cit., vol. 6, 352-353.
Fig. 3. La riva sinistra della Cecina nella Pianta dell’ing. Ferdinando Piazzini (1821), dove è indicato solo il “guado alle vacche in pros-simità della foce”: forse qui si trovava il trecentesco ponte pisano. ASP, Camera Comunitativa, filza n. 112, ins. 29.
223I PONTI MEDIEVALI SULLA CECINA
sione dalla Sardegna conquistata dai Catalano-aragonesi (1334-1336), e guardavano con rinnovato interesse alle risorse presenti nel territorio.
De ponte Cecine: 1287-1340
Il ponte di legno e di mattoni fu realizzato solo all’epoca del conte Fazio di Donoratico della Gherardesca18. Nel 1338 vennero iniziati o per lo meno decisi i lavori, che durarono due anni. Erano già stati program-mati, o quanto meno definiti da un perizia preliminare, prima del 20 luglio 1338: infatti quel giorno gli Anziani deliberarono il pagamento, da addebitarsi sulla cassa delle gabelle comunali, di salarium et merce-dem per quattro cittadini e cinque tecnici (magistris), tutti con cavalli, mandati dal Comune in una missione di quattro giorni allo scopo di organizzare i lavori al nuovo ponte che doveva essere costruito e siste-mato sopra il fiume Cecina. Il 27 novembre una provvisione di esperti nominati dagli Anziani aveva definito le modalità dei lavori al ponte; in questa delibera, o in una degli stessi Anziani in data imprecisata, era stata anche definita la lista dei Comuni chiamati a contribuirvi19.
I lavori erano sicuramente già in corso nel successivo anno 1339, a giudicare da varie lettere degli Anziani riguardanti uno dei quattro cittadini protagonisti della citata trasferta organizzativa preliminare: Bonagiunta Ciabatta o Ciabatto, pontonaio od operaio del Pontevecchio di Pisa (attuale Ponte di Mezzo) e di quello nuovo della Spina e degli altri ponti del comune pisano, e non soltanto dei ponti già esistenti. Infatti già il 13 maggio egli risulta responsabile del ponte da farsi sopra il fiume Cecina (pontis fiendi super flumine Cecine); due giorni dopo lo stesso ope-raio appare sempre come responsabile della costruzione del ponte (circa ipsius pontis executionem), con la definizione più esplicita di incaricato di far fare il ponte sulla Cecina (deputati super faciendo fieri pontem super Ciecina); il 24 dello stesso mese di maggio è qualificato come capomastro ovvero sovrintendente ai lavori del ponte (capomagistri pontis de Ciecina); infine il 18 luglio il medesimo pontonaio è definito di nuovo capomastro (pontonarius vel capomagister) del ponte sulla Cecina attualmente in corso di costruzione (pontis de Cecina qui presentialiter construitur et fit).
Il suo non era certo un compito facile, come risulta dalle citate lette-
18 L. tanFani, Della Chiesa di S. Maria del Pontenovo detta della Spina e di al-cuni uffici della Repubblica pisana, Pisa 1871, pp. 34-35.
19 Per la cronologia dei lavori al ponte e annessi cfr. ASP, Comune, Divisione A: provvisioni 1338 luglio 20 (reg. 104 c. 23r con cc. 21v per giorno e mese e c. 1r per l’anno), 1338 novembre 27 (cit. con data nella lettera 1339 maggio 13 e verosimilmente anche, senza data, nella lettera 1339 maggio 15, entrambe infra) e in data imprecisata (cit. nella lettera 1339 maggio 15, infra); lettere 1339 mag-gio 13, 15 e 24 e luglio 18 (reg. 205 cc. 1v, 2v, 7v e 17r); provvisioni 1340 aprile 8 e 23 (reg. 105 cc. 61r-63v con 64v, e cc. 67v con 68r); ratifica in consiglio 1340 aprile 28 di provvisione aprile 21 (reg. 53 cc. 37r-39r); lettera 1340 settembre 21 (reg. 205 c. 84v).
224 LAURA GALOPPINI
re degli Anziani che lo riguardavano, tutte indirizzate a Nicola de Castro-durante, ufficiale del comune pisano in Gherardescha (13 e 15 maggio) o in Marittima (24 maggio), o al suo successore in Gherardescha, Angelo de Bilbiena (18 luglio). Il 13 maggio il Ciabatta ricevette un richiamo dagli Anziani in seguito a lamentele del Comune di Bibbona perché, violando la provvisione del 27 novembre dell’anno prima, lo costringeva a tra-sportare ogni giorno a proprie spese dieci carri di pietre per rinforzare le fondamenta. Invece il 15 maggio risulta che era stato lui a denunciare per lettera agli Anziani la disobbedienza di imprecisati Comuni, e ad essere ripreso fu ora l’ufficiale della Gherardesca, perché lo appoggiasse. Anche il 24 maggio l’ufficiale della Maremma venne nuovamente solleci-tato dagli Anziani ad appoggiarne l’opera costringendo tutti gli abitanti delle terre di Bibbona, Bolgheri e Rosignano a trasportare coi loro carri il legname necessario al ponte della Cecina, dai boschi dove si trovava fino al ponte stesso, per una ricompensa adeguata della fatica e secondo un determinato prezzo: come già dalla lettera del 13 maggio risulta chia-ro che i comuni della zona non si rifiutavano in assoluto di collaborare al nuovo ponte, ad esempio con servizi di trasporto di legname e pietre, ma solo di collaborarvi gratuitamente, e soprattutto risulta che avevano avuto partita vinta. Infine il 18 luglio Bonagiunta Ciabatta figura come responsabile non più soltanto della costruzione del nuovo ponte, ma anche della costruzione e del completamento della palizzata che da poco si stava facendo nel porto di Vada per la sicurezza di quest’ultimo: l’uffi-ciale della Gherardesca venne quindi invitato a costringere al trasporto di qualsiasi materiale necessario e opportuno per entrambe le opere gli abitanti non solo dei tre comuni già citati, Rosignano, Bolgheri e Bib-bona, ma ora anche di quello di Vada. E quest’ultimo non fu coinvolto soltanto nei servizi di trasporto per la nuova palizzata del proprio porto, come sarebbe stato logico aspettarsi: infatti, secondo una dichiarazione resa l’anno dopo da Bonagiunta Ciabatta, ormai ex pontonario, era an-che stato molto gravato nella costruzione del ponte sulla Cecina20.
I lavori al ponte non si arrestarono nemmeno durante l’inverno 1339-1340. Lo prova la conclusiva delibera di pagamento dell’8 aprile 1340, fra l’altro a favore di un materassaio per il prezzo del noleggio degli otto letti in cui aveva dormito la manodopera che aveva lavorato al ponte per due mesi, gennaio e febbraio appena passati, quindi all’inizio del 1340.
Entro l’8 aprile 1340, però, il ponte era terminato, e il giorno stesso si poté procedere alla delibera di pagamento definitiva e dettagliatissi-ma, addebitata ora sulla cassa non più delle gabelle, ma dei ponti del Comune21. Ne beneficiarono anzitutto due fornitori di legno e tavole per lo più di rovere, di mattoni e di calcina (lignamen, matones et calcina), materiali tutti che erano stati usati per il ponte fatto e costruito da poco sul fiume Cecina; un altro fornitore da saldare era quello di chiodi (agu-
20 ASP, Comune, Divisione A, 53 c. 39r (delibera 21 aprile 1340, inserita in ratifica del 28 aprile).
21 ASP, Comune, Divisione A, 105, cc. 61r-63v..
225I PONTI MEDIEVALI SULLA CECINA
torum), materiale che però era stato trasportato fino al ponte da un’altra persona, anch’essa quindi da pagare (pro portatura agutorum in sex sar-cinis apud dictum pontem). Tra i fornitori si trova infine un cartario, per il prezzo delle carte e dei quaderni o registri usati nella costruzione del ponte sulla Cecina, ovviamente per tenerne i conti. Nella maggior parte dei casi, però, si trattava di remunerare la manodopera specializzata (magistro), con o senza garzone o aiutante (famulo), pagata quotidiana-mente (pro giornatis o pro diebus) per aver lavorato al ponte, in genere per 26 giorni, forse in squadre che si alternavano di mese in mese; l’uni-ca manodopera di cui sia indicata la specializzazione sono le due coppie di operai addetti al taglio del legname con la sega doppia (serratoribus cum serra dupla), pagati a giornata per aver lavorato con quell’attrezzo a segare il legname necessario al ponte (rispettivamente pro giornatis 18½ e 7 quibus serviverunt cum eorum o dicta serra ad serrandum lignamina suprascripti pontis o pro dicto ponte)22. La conclusione dei lavori, rivela-ta dalla delibera di pagamento di 11 lire e 7 soldi a favore dell’operaio dell’opera di una chiesa e in questo caso comprensiva di materiale e ma-nodopera specializzata, saranno state le due lapidi marmoree, certo una per capo del ponte, in cui è scritto, più probabilmente inciso, il tempo di costruzione del ponte stesso e sono dipinti gli stemmi del Comune e del Conte (sunt picta arma communis et domini comitis). Così ci rivela il bel documento che, di seguito, riportiamo integralmente.
Providerunt domini Anthiani Pisani
c. 61r Sexto ydus aprilis23
Providerunt domini Anthiani Pisani populi, partitu inde facto inter eos ad denarios (!) albos et giallos secundum formam Brevis Pisani populi,
quodIohannes olim Landi Ciaffuli, pontonarius pontium veteris et novi de Spina Pisane civitatis et aliorum pontium, de pecunia dictorum pontium que apud eum est et erit occasione dicti officii, det et solvat et dare et solvere possit et debeat infrascriptis personis infrascriptas pecunie quantitates eis a pontonario dictorum pontium debitas infra-scriptis de causis, que debita contratta (!) fuerunt ante tempus officii et electionis dicti Iohannis, videlicet:Gerardo de Roccha et Corsino de Vignalilibras mille sexcentas nonagintaocto et soldos duodecim denariorum Pisanorum, pro pretio lignorum centumoctuagintasex de rovero, cros-
22 Sui vocaboli «serra» e «serrare», cfr. S. BattaGLia, Grande dizionario della lingua italiana (= GDLI), Torino 1964-, s. v. ove si ricorda il termine già in uso nella Carta Pisana di Filadelfia; in proposito, cfr. a. Mastruzzo, Il conto navale nel pano-rama grafico della Pisa altomedievale, in Pisa e il Mediterraneo. Uomini, merci, idee dagli Etruschi ai Medici, a cura di M. Tangheroni, Catalogo della Mostra, Milano 2003, pp.190-195.
23 ASP, Comune, Divisione A, 105, cc. 61r-64v.
226 LAURA GALOPPINI
sorum palmo uno et quarto per faciem et longorum gubitis mille oc-tingentis octuagintaseptem et palmo uno gubiti, ad rationem soldorum decem et octo pro quolibet gubito; et in alia parte libras quingentas quinquagintaduas denariorum Pi-sanorum pro pretio lignorum octuagintaocto, crossorum per faciem palmo uno et osso et longorum gubitis septingentistrigintasex, ad rationem soldorum quindecim pro quolibet gubito; et in alia parte libras quadringentas sex et soldos sedecim denariorum Pisanorum pro pretio lignorum centumtrigintaduorum de rovero //61v crossorum per faciem palmo uno et longorum gubitis mille decem et septem, ad rationem soldorum octo pro quolibet gubito; et in alia parte libras ducentas trigintaduas et soldos decem denario-rum Pisanorum pro pretio tabularum trecentarum septuagintaduarum de rovero, ad rationem soldorum duodecim et denariorum sex pro qualibet; et in alia parte libras septingentas quinquagintaduas et soldos decem denariorum Pisanorum pro pretio pesorum duorum milium centum quinquaginta calcine, ad rationem soldorum septem pro quolibet peso;et in alia parte libras quadringentas denariorum Pisanorum pro pretio milliariorum octuaginta mactonum, ad rationem librarum quinque pro quolibet miliari (!); que omnia – lignamen, matones et calcina – operata fuerunt ad con-strutionem et pro construtione pontis noviter facti et constructi supra flumen Cecine.
EtGuidoni Tiniosi libras octuagintaquinque et soldos sex denariorum Pisanorum pro pretio centenariorum decemseptem et libbrarum sex agutorum plurium rationum, ad rationem librarum quinque denario-rum pro quolibet centonario, pro constructione dicti pontis.
EtMaçino de Curtibus, operaio opere Sancti Iohannis Batiste, libras undecim et soldos septem denariorum Pisanorum pro pretio duarum lapidum de marmore in quibus scriptum est tempus quo dictus pons fuit construptus (!) et sunt picta arma communis et domini comitis.
EtIusto Nerii de Sancto Marcho libras novem et soldum unum denario-rum Pisanorum pro portatura agutorum in sex sarcinis apud dictum pontem pro ipso ponte.
// c. 62r EtHenrico magistro de Pontesercli libras vigintisex denariorum Pisano-rum, pro se et pro famulo suo, pro giornatis vigintisex quibus ipsi labo-raverunt ad dictum pontem, ad rationem soldorum viginti denariorum Pisanorum per diem.
EtNuto Cilori, magistro de cappella sancte Marie Maddalene, pro se et pro eius famulo, libras vigintitres et soldos octo denariorum Pisano-rum pro giornatis vigintisex quibus laboraverunt ad dictum pontem, ad rationem soldorum decemocto denariorum Pisanorum per diem.
EtFrancescho Blagii, magistro de cappella sancti Laurentii, pro se et pro eius famulo, libras vigintitres et soldos octo denariorum Pisanorum pro diebus vigintisex quibus laboraverunt ad dictum pontem, ad ratio-nem soldorum decem octo denariorum Pisanorum per diem.
Et
227I PONTI MEDIEVALI SULLA CECINA
Simoni Sagantino, magistro de cappella sancte Marie Maddalene, li-bras sedecim et soldos decemocto denariorum Pisanorum pro diebus vigintisex quibus laboravi[t] ad suprascriptum pontem, ad rationem soldorum tredecim per diem.
EtPaulino Bencivennis, magistro de cappella sancte Trinitatis, libras sedecim et soldos decemocto denariorum Pisanorum pro giornatis vigintisex quibus laboravit ad suprascriptum pontem, ad rationem soldorum tredecim per diem.
EtGioni Benossi de sancto Lorenso (!) libras undecim et soldos quatuor-decim denariorum Pisanorum pro diebus vigintisex quibus laboravit ad dictum pontem, ad rationem soldorum novem denariorum Pisano-rum per diem.
//62v EtIohanni Nieri, magistro de Pontesercli, libras sedecim denariorum Pi-sanorum pro giornatis trigintaduabus quibus laboravit ad suprascrip-tum pontem, ad rationem soldorum decem denariorum Pisanorum per diem.
EtIohanni Benossi de sancto Laurensio libras septem et soldos sedecim denariorum Pisanorum pro giornatis vigintisex quibus laboravit ad suprascriptum pontem, ad rationem soldorum sex per diem.
EtDomenicho Moncini de sancto Egidio libras septem et soldos sedecim denariorum Pisanorum pro giornatis vigintisex quibus laboravit ad construtionem (!) suprascripti pontis, ad rationem soldorum sex per diem.
EtMarino Homodei de sancta Maria Maddalena libras septem et soldos sedecim denariorum Pisanorum pro giornatis vigintisex quibus la-boravit ad construtionem (!) dicti pontis, ad rationem soldorum sex denariorum Pisanorum per diem.
EtNuto Cillieri magistro de sancta Maria Maddalena, pro Lapo et Prime-rano Perini de Castronovo Vulterarum, serratorum cum serra dupla, libras quatuordecim, soldos tredecim et denarios quatuor denariorum Pisanorum pro giornatis decemocto et dimidia quibus serviverunt cum eorum serra ad serrandum lignamina suprascripti pontis pro dicto ponte, ad rationem soldorum sedecim per diem.
// 63r EtContro Perini de Castronuovo (!), Bettoni Iohannis de Vada, serratori-bus com serra dupla, libras quatuor et soldos decemocto denariorum Pisanorum pro giornatis septem quibus serviverunt cum dicta serra ad serrandum lignamina pro dicto ponte, ad rationem soldorum quatuor-decim per diem.
EtBetto Vannis de Vico pro Michelino dicto Barbaricina libras octo et soldos sedecim denariorum Pisanorum pro giornatis vigintinovem et media quibus stetit et servivit ad construtionem (!) suprascripti pontis, ad rationem soldorum sex per diem.
EtBetto suprascripto pro Bettuccio Guiduccii de Luca libras unam et sol-dos decem denariorum Pisanorum pro giornatis sex quibus servivit et
228 LAURA GALOPPINI
stetit ad construtionem (!) suprascripti pontis, ad rationem soldorum quinque per diem.
EtBetto suprascripto pro Domenicho Cavavite de Castronovo Vulterra-rum libram unam et soldos sex denariorum Pisanorum pro giornatis sex et media quibus servivit et stetit ad construtionem (!) dicti pontis, ad rationem solidorum quatuor per diem.
EtBetto suprascripto pro Vanne Puccii de sancto Pietro (!) libras duas et soldos decem denariorum Pisanorum pro giornatis decem quibus stetit et servivit ad construtionem (!) suprascripti pontis, ad rationem soldorum quinque per diem.
// 63v EtPuccetto matrassario de sancto Ysidero (!) libras quinque denariorum Pisanorum pro pretio nauli octo lettorum (!) in quibus dormiverunt magistri qui laboraverunt ad dictum pontem pro duobus mensibus, videlicet ianuarii et februarii proxime preteritorum, ad rationem sol-dorum quinquaginta per mensem.
EtBacciameo Chiassi libras sex et soldos decem denariorum Pisanorum pro pretio mende certorum corredorum platte ipsius Bacciamei que fuerunt operata in constructione ipsius pontis.
EtHenrichino vinario libras sex denariorum Pisanorum pro pretio mende certorum corredorum platte ipsius Henrigini que fuerunt operata dicta occasione.…………………………………………..
c. 64v ……………………………………….Et
Martino cartario libram unam et soldos undecim denariorum Pisa-norum pro pretio cartarum et librorum operatarum et operatorum in constructione dicti pontis de Cecina.
Pro conservatione dicti pontis: Villabuona
Nel quadro generale della sistemazione delle infrastrutture che do-vevano accompagnare e completare il nuovo ponte sulla Cecina, termi-nato entro l’8 aprile 1340, è da collocare il tentativo di fondazione di un villaggio nominato auguralmente Villabuona24. Risale al 23 dello stesso mese una delibera di pagamento, da addebitarsi sulla cassa dei ponti co-munali (de pecunia dictorum pontium), di un salarium et mercedem per quattro individui più un notaio e un magistro, tutti a cavallo, mandati
24 G. rossi saBatini, Pisa al tempo dei Donoratico (1316-1347). Studio sulla crisi costituzionale del Comune, Firenze 1938, pp. 69-70; G. GarzeLLa, Villabuo-na. Un progetto trecentesco di ‘terra nuova’ presso il ponte sulla Cecina, in Cecina. Studio di geografia urbana, a cura di L. Marchetti, Lucca 2003, pp. 217-226; Ga-LoPPini, Storia di un territorio, cit., pp. 129-130.
229I PONTI MEDIEVALI SULLA CECINA
dal comune in Maremma presso la Cecina sia per il ponte ivi appena fatto sia per una villa e una pedata, che invece dovevano ancora venir co-struite; fra i quattro provisoribus missis a comuni et pro comuni Pisano in Marittimam apud Cecinam occasione pontis ibi noviter facti et ville et pedate ibi fiendarum si trova Bonagiunta Ciabatta, l’artefice del ponte25.
Secondo gli ordinamenti del 21 aprile la fossa o canale di derivazio-ne doveva essere scavata dai Comuni ricordati prima nel promontorio o lingua di terra che si trovava nel fiume vicino al ponte e prolungata in linea retta fino a questo, seguendo le istruzioni date dall’operaio (supra-scripta comunia, in puncta quadam terre que est in flumine Cecine secus pontem, faciant et facere debeant unam fossam usque ad dictum pontem recta linea, per illum modum de quo dictus operarius voluerit et declara-bit). Quanto poi alla rampa d’accesso al ponte (pedata) si prevedeva che la sua costruzione inevitabilmente avrebbe occupato e devastato terre o raccolti cerealicoli: i danni sarebbero stati stimati dal pontonaio in carica e dall’operaio futuro, e in base a quella stima risarciti ai rispettivi proprietari dal Comune di Pisa. Per quanto invece riguarda Villabuona, la cui costruzione era associata alla pedata nell’ordine di pagamento del 23 aprile e alla pedata e alla fossa negli ordinamenti di due giorni prima, non è stranamente ricordata il 21 settembre fra le competenze del nuovo operaio, limitate appunto a pedata e fossa, e fino ad oggi non si conosco-no documenti sull’inizio effettivo dei lavori: da ciò la comune opinione che Villabuona non fu mai edificata.
Il documento che ci rivela una serie di dati interessanti è la provvi-sione del 21 aprile 1340 (poi ratificata il 28), col progetto per la costru-zione di questo insediamento, al piede del ponte appena costruito, cioè dal lato di San Vincenzo (in pede dicti pontis Cecine noviter ibi constructi, videlicet ex latere Sancti Vincentii)26. Attraverso dettagliate disposizioni si stabiliva che ora, per cominciare (nunc in principio), si costruissero sedi-ci case (domus), di cui 11 dal lato inferiore verso il mare (ex latere inferio-ri versus mare) e 5 dal lato superiore verso la Gherardesca, dal poggetto presso la Cecina in giù verso S. Vincenzo (ex latere … superiori versus Gherardescam, a podiolo quod est secus Cecinam infra versus Sanctum Vincentium), ciascuna su un lotto edificabile (solum sive casalinum)27
25 ASP, Comune, Divisione A, 105, c. 68r con c. 67v (per la data).26 ASP, Comune, Divisione A, 53, cc. 37r-39r; una traduzione in G. Garzella,
Villabuona, cit.; trascrizione in Galoppini, Storia di un territorio, cit., pp. 129-130.27 I casalini appaiono non degli appezzamenti ma solo la parte edificata su tali
Fig. 4. ASP, Comune, Divisione A, reg. 53, c. 37v, particolare. L’augurale nome di Villa-buona per la villa di nuova fondazione.
230 LAURA GALOPPINI
largo tre pertiche e mezzo (circa m. 10,19) e lungo sei (circa m. 17, 46)28, o anche più lungo sul lato mare ad arbitrio di chi edificava. Inoltre i proprietari degli undici casalini situati lato mare avrebbero avuto tutta la terra che si trovava dopo, per la larghezza corrispondente al proprio casalino, secondo una linea retta tracciata fino al mare.
Per accelerare e facilitare l’impianto e il popolamento della nuova villa, i singoli lotti con obbligo di costruzione della casa vennero spartiti tra varie persone che ne avevano fatto liberamente richiesta e i Comuni limitrofi. Il primo degli undici casalini situati verso il lato mare, cioè quello presso il palazzetto del ponte (iuxta palassectum dicti pontis), sa-rebbe stato del pontonaio del Ponte Vecchio e del Ponte Nuovo della Spi-na di Pisa e degli altri ponti del Comune, ad uso di quei ponti; il secondo, vicino al primo, di Bertuccio di Cenne da Casale; il terzo, situato vicino al secondo, di ser Iacopo notaio del fu ser Ugolino di Montescudaio; il quarto, vicino al terzo, di ser Bindo di Rustichello notaio di San Lorenzo alla Rivolta; confinanti gli uni agli altri vi sarebbero stati poi quelli dei Comuni di Casale (il quinto), di Donoratico (il sesto), di Rosignano (il settimo), di Bibbona (l’ottavo), di Bolgheri (il nono), di Castagneto e di Segalari (il decimo), di Guardistallo (l’undicesimo). Gli altri cinque ca-salini, dal lato più alto verso la Gherardesca, sarebbero stati, nell’ordine: il primo, presso il poggetto vicino al fiume dal lato di San Vincenzo, del Comune di Vada; gli altri dei Comuni di Montescudaio (il secondo), di Riparbella (il terzo), del Terriccio e di Castellina (il quarto), di Collemez-zano, di Bellora e di Mele (il quinto).
Nei decenni successivi anche il trecentesco ponte pisano andò in rovina. Il collegamento fra le due rive del fiume tornò a essere difficol-toso e guadare il Cecina era un’impresa rischiosa. In seguito il Grandu-ca Ferdinando I fece edificare, sulla riva sinistra e poco lontano dalla foce, il Castello (chiamato poi del Fitto) – un «gran Palazzo, quale è in difesa per bataglia da mano, per resistere a Turchi che dessino in terra in quelle parti» – e accanto fu costruito un nuovo ponte di legno tra il 1590 e il 1594. Il Targioni Tozzetti dovette osservarne i resti. Perciò scriveva che vi era, «rasente al dirupo della collinetta, sulla quale è il palazzo [Fitto], una muraglia, la quale sembra aver servito da principio, e da primo sostegno ad un ponte mediocre e piano di legno». In seguito anche il ponte cinquecentesco andò in rovina e rimase presso il Fitto un sistema di traghettamento con una barca, denominato appunto il passo della barca. Occorre arrivare all’Ottocento, quando l’ingegnere fiorentino Alessandro Manetti realizzò, fra il 1821 e il 1822, un grande ponte di legno, lungo ben 127 metri, a 15 luci. Dopo il 1858, deterioratosi quello
porzioni di terra, concretamente la base delle domus. Il termine casalino, indica “piccola casa rustica”, non tanto nel significato in cattivo stato (così in GDLI, s. v.), ma come diminutivo di casale, ossia di un agglomerato rurale non recintato.
28 Calcolando la pertica pisana, misura lineare, in m. 2,91; cfr. M. Luzzati, Note di metrologia pisana, in «Bollettino Storico Pisano», XXXI-XXXII (1962-63), pp. 191-220, p. 220 (la pertica quadrata corrisponde a mq. 8,51).
231I PONTI MEDIEVALI SULLA CECINA
di legno, ne fu realizzato uno in muratura su disegno di Evangelista Lombard. Lo scopo era consolidare un passaggio sul fiume lungo una strada che vedeva il crescente aumento dei trasporti di uomini, carri e animali attraverso il ponte proprio mentre il borgo del Fitto di Cecina, con uno sviluppo straordinario, diveniva il Comune di Cecina. Di fatto la moderna Villabuona29.
29 GaLoPPini, Storia di un territorio, cit., pp. 131-134, con la relativa bibliografia.* I documenti conservati presso l’Archivio di Stato di Pisa sono stati riprodotti
dietro concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (prot. 11/4/13), se ne fa divieto di duplicazione con qualsiasi mezzo.
Fig. 5. La riva destra della Cecina nella Carta topografica dell’ing. Roberto Bombici (1825), dove è indicato il ponte di legno, presso il Fitto, costruito su progetto di A. Manetti (1821). ASP, Camera Comunitativa, filza n. 112, ins. 29.