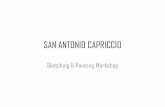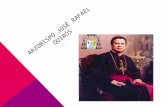A ROMAN SARCOPHAG REMPLOYED AS BURIAL OF ST. ROMUALD FOUNDER OF THE CAMALDOLESE / Il sarcofago...
Transcript of A ROMAN SARCOPHAG REMPLOYED AS BURIAL OF ST. ROMUALD FOUNDER OF THE CAMALDOLESE / Il sarcofago...
GIULIA BARATTA
IL SARCOFAGO ROMANO DESTINATO A SAN ROMUALDONELL’ABBAZIA DI SAN SALVATORE A VALDICASTRO (AN):
UN CASO DI RIUTILIZZO1
Nell’abbazia di San Salvatore in località Val di Castro (Fig. 1), nellafrazione Poggio San Romualdo del comune di Fabriano, a circa una ven-tina di chilometri dalla città, tra le montagne dell’Appennino marchi-giano, si conserva un sarcofago romano corredato da iscrizione, per ilquale è stata avanzata l’ipotesi di una origine tuficana2.
Il sarcofago costituisce un elemento importante strettamente vinco-lato alla storia dell’abbazia3.
1 Questo lavoro si inserisce nell’ambito del progetto FFI2011-25113 e del Grup deRecerca Consolidat LITTERA (2009SGR1254 e 2014SGR63) ed è stato in parte realizzatocon i fondi ex 60%.
2 A. PAGNANI, La badia di Valdicastro. 1. Cenni descrittivi, in «Rivista camaldolese» 2(1927), p. 302; R. SASSI, I ricordi romani di Fabriano. Conferenza (Appendice: Le epigrafi romanedel territorio di Fabriano), Fabriano 1938, p. 68, n. LXIII.
3 Dell’originaria chiesa romanica, che prevedeva due corpi di fabbrica perpendico-lari tra loro e destinati rispettivamente a chiesa, con orientamento est-ovest, ed a mona-stero, con asse principale orientato nord-sud, rimane oggi solo la cripta peraltrofortemente ritoccata e con l’abside più piccola di quanto non fosse in origine. L’attualecostruzione di impianto sostanzialmente romanico con evidenti componenti gotiche, ca-ratterizzato da una pianta a croce commessa con navata unica conclusa dal transetto a treabsidi, è, come ricorda l’iscrizione dell’arco trionfale, opera del maestro Tebaldo e risaleal 1262. I lavori di ampliamento della chiesa e dell’annesso monastero iniziati in questoanno e terminati verso la metà del XIV secolo, hanno trasformato il complesso in una ab-bazia fortezza. Numerosi sono stati sino ad oggi i rimaneggiamenti della struttura dovuti
«Picus» XXXIV (2014), pp. 43-64 – ISSN 0394-3968
Questa fu istituita da Romualdo4, nativo di Ravenna e figlio di Sergioduca degli Onesti, il santo fondatore della congregazione dei Camaldolesi,
GIULIA BARATTA44
vuti alle alterne vicende storiche che hanno riguardato l’abbazia ed ai danni subiti daltempo e dai terremoti. L’aspetto odierno della chiesa, di dimensioni minori rispetto al-l’impianto del XIII secolo, è costituito dalla parte superstite al sisma che ha colpito Val-dicastro alla metà del XVIII secolo, e che ha comportato la perdita di almeno due campatedella navata e della facciata ricostruita nel 1799. Altri restauri che hanno riguardato tuttoil complesso sono stati eseguiti dai conti Serafini, proprietari dell’abbazia a partire dal1877, ed ancora di recente per il suo recupero e la trasformazione in azienda agricola. Alsuo interno si conserva un interessante repertorio di affreschi del XII e XIV secolo tra cuiil più antico ciclo, purtroppo solo parzialmente conservato, raffigurante la vita di SanRomualdo, di un anonimo artista della prima metà del Trecento, un gigantesco San Cri-stoforo forse opera del Maestro di Esanatoglia cui sono sicuramente attribuibili altre duepitture raffiguranti rispettivamente La Madonna e San Cristoforo che regge il Bambinoe san Romualdo in trono databili, verosimilmente, agli anni ’80/’90 del XIV secolo (peri cicli pittorici della chiesa di San Salvatore vedi A. DELPRIORI, Appunti sul Quattrocentofabrianese: gli affreschi di Valdicastro, in A. DE MARCHI, Intorno a Gentile da Fabriano: nuovistudi sulla pittura tardogotica, Livorno 2008, pp. 99-114). Per una breve sintesi sulle vicendestoriche dell’abbazia di Valdicastro vedi O. MARCOALDI, Valdicastro. Cenni storici e topogra-fici, Fabriano 1877 (ringrazio la biblioteca provinciale di Campobasso per avermi fattoavere copia del raro volume); PAGNANI, La badia di Valdicastro, cit., pp. 300-305; G. CA-STAGNARI (a cura di), Abbazie e castelli della comunità montana Alta Valle dell’Esino, Arcevia1990, pp. 233-242; A. CHERUBINI, Territorio ed abbazie nelle Marche, in E. SIMI VARANELLI(a cura di), Le abbazie nelle Marche. Storia e Arte. Atti del convegno internazionale (Macerata,3-5 aprile 1990), Roma 1992, (= ‘Pubblicazione della Facoltà di Lettere e Filosofia’ 66), pp.249-362 part. p. 255 e pp. 304-305. R. GRÉGOIRE, Appunti di storia monastica nelle Marche,ibid., pp. 109-125, in part. p. 112 e p. 118.
4 Alcuni accenni alle vicende di Romualdo si trovano già nella Vita di Pietro Or-seolo, redatta da un monaco catalano nell’XI secolo, e nella Vita quinque fratrum di Brunodi Querfurt del 1009. Il primo “biografo” del santo è però Pier Damiani che scrive laVita Sancti Romualdi verso il 1042 (si veda l’edizione G. TABACCO, Petri Damiani Vita BeatiRomualdi, Roma 1957 [= “Fonti per la storia d’Italia” 94]) che viene ripreso nelle successivebiografie. Tra le prime merita ricordare AGOSTINUS FORTUNIUS, Translatio corporis sanctiss.Patris Romualdi sacrae Eremi Ordinisque Camaldulensis institutoris, Florentiae 1562 (l’operaè edita nello stesso anno anche a Firenze per i tipi di Francesco Rampazzetto); unaversione in volgare dell’opera di A. Fortunio dal titolo Translazione del corpo di S. Romualdofondatore del sacro heremo et Ordine di Camaldoli, Firenze 1563 presso Lorenzo Torrentino;AGOSTINO FORTUNIUS, Vita del Padre San Romualdo abate fondatore del sacro eremo e Ordinedi Camaldoli, e riformatore della vita Eremitica, Firenze 1586; IUAN DE CASTAÑIZA, Historiade S. Romualdo, padre y fundador de la orden Camaldulense, que es una idea y forma perfectade la vida solitaria, Madrid 1597 e la sua traduzione in italiano ad opera di TIMOTHEO DA
un ordine di monaci benedettini, nel primo decennio dell’XI secolo5. Ro-mualdo morì il 19 giugno di un anno compreso tra il 1023 e il 10276, se-condo una delle tradizioni all’età di 120 anni7, in una cella che si fece
Il sarcofago romano destinato a San Romualdo 45
BAGNO,Historia della vita di San Romualdo. Padre e fondatore dell’ordine Camaldolese ch`è unaidea, e forma perfetta della vita solitaria, Napoli 1685; F.M. MACHIARELLI, Delle notizie storichedella vita di San Romoaldo e degli altri suoi beati discepoli, Napoli 1716 ed una bella edizioneillustrata Vita et acta sanctissimi patris et patriarchae Romualdi fundatoris Camaldulensium la-tino idiomate ab Petro Damiani eiusdem discipulo composita, Viennae Austriae 1723.Sull’ordine, sulla sua regola, sulle principali vicende del santo fondatore in particolaresulla sua esperienza ascetica ed eremitica e sulla sua conversione vedi A. PAGNANI, Vita diS. Romualdo abbate fondatore dei Camaldolesi, Fabriano 1967; R. BOSSI (a cura di), Gli ordinireligiosi. Storia e spiritualità. Antoniniani, Camaldolesi, Vallombrosiani, Serviti, Barnabiti,Fatebenefratelli, Camilliani, Scolopi, Mechitaristi, III vol., Fiesole 1997, pp. 43-60.; AA.VV.,Ottone III e Romualdo di Ravenna. Impero, monasteri e santi asceti. Atti del XXIV Convegno delCentro Studi Avellaniti, Fonte Avellana 2002, Negarine di San Pietro in Cariano 2003 edin particolare i lavori di U. LONGO, La conversione di Romualdo come manifesto programmaticodella riforma eremitica, pp. 215-236 e R. FORNACIARI, Romualdo di Ravenna, i suoi discepoliBenedetto di Benevento e Giovanni e il monachesimo missionario dell’età ottoniana, pp. 237-266nello stesso volume. Nell’ambito della storia locale si veda anche F. MONTANI (NINTOMA),Lettere su le origini di Fabriano (edizione a cura di Romualdo Sassi), Fabriano 1922, pp. 233-239. Per una raccolta di bibliografia sul tema vedi R. BARTOLETTI (coord.), San Romualdo.Culto - bibliografia, Fabriano 2004 (= ‘Documenti e Studi’ 3), pp. 91-109.
5 A Valdicastro, ove già esisteva una piccola chiesa ed un convento femminile, Ro-mualdo ha fatto realizzare, verso il 1005, un primo eremo con delle celle per sé e per al-cuni monaci. La data di fondazione del monastero vero e proprio è di qualche annoposteriore e va collocata tra il 1009 e il 1010. A tale proposito vedi CASTAGNARI (a curadi), Abbazie e castelli, cit., p. 233.
6 PETRUS DAMIANUS, Vita sancti Romualdi, caput LIV. Vedi di recente C. FALCHINI(ed.), Privilegio d’amore. Fonti camaldolesi. Testi normativi, testimonianze documentarie e letterarie,Magnano 2007, pp. 9-10: «Il terminus ad quem, infatti, è dato dal documento dell’agosto1027 con cui il vescovo di Arezzo Teodaldo dona agli eremiti di Camaldoli la chiesa delSanto Salvatore, e nel quale si fa memoria di Romualdo, che dunque era già morto. Ilterminus a quo della morte, poi, è dato dal fatto che nel medesimo documento Teodaldodice di aver egli stesso in precedenza consacrato tale chiesa su preghiera di Romualdo. ETeodaldo era diventato vescovo nel 1023».
7 Per quanto riguarda l’età del santo al momento del decesso esistono diverse teorie.Le due più accreditate accettano rispettivamente una cronologia lunga ed una corta.Secondo la prima Romualdo avrebbe effettivamente raggiunto i 120 anni e sarebbepertanto nato a Ravenna tra il 903 e il 907 mentre secondo l’altra l’anno di nascitaandrebbe collocato intorno al 950 e Romualdo avrebbe pertanto vissuto poco meno diottanta anni. Sull’argomento vedi C. ROGGI, A quale età morì san Romualdo, in «Bene(1948), pp. 331-338; A. POLVERARI, Il problema della longevità di Romualdo, in Fonte Avellana
realizzare a circa due chilometri dall’abbazia, ove, per commemorarne lamemoria, nel 1732 l’abate Roberto Palladini fece costruire una chiesetta,l’attuale eremo di San Biagiolo.
Senza dubbio il sarcofago è stato utilizzato come tomba del santo,ma non si sa quando esattamente il reperto romano sia stato portato nel-l’abbazia di Valdicastro e destinato al nuovo uso nella chiesa di San Sal-vatore. Tuttavia le vicende che seguono la morte di San Romualdo, redattecon dovizia di particolari dai suoi biografi, consentono di avanzare alcuneipotesi in merito. Il primo a narrare le vicende del santo è stato Pier Da-miani cui si deve la descrizione8 di come, a cinque anni dalla morte, dun-que, al più tardi nel 10329, il corpo, sino ad allora verosimilmentecollocato in una sepoltura terragna nella chiesa10, venisse riesumato “data
Il sarcofago romano destinato a San Romualdo 47
nel suo millenario I. Le origni. Atti del V Convegno del Centro di studi avellaniti (Fonte Avellana,26-27-28 agosto 1981), Fonte Avellana 1982, pp. 245-251.
8 PETRUS DAMIANUS, Vita Sancti Romualdi, caput LXXII, De corpore Romualdi sanopost quinquennium invento: Post quinquennium vero a sancti viri obitu, data monachisab apostolica sede licentia, ut supra venerabile corpus eius altare construerent, Azo qui-dam frater silvam petiit, quatenus modicam capsam faceret, quae sancti confessoris ossaet pulverem tantummodo capere potuisset. Nocte igitur insecuta, dormienti cuidam fratrivenerabilis quidam senex apparuit, quem protinus interrogans, ait: Ubi est huius monas-terii prior? Quod cum ille se scire negaret, illico senex addidit: Pro fabricanda, inquit,capsa ire in silvam studuit, sed beati viri corpus in tam exiguum vasculum non intrabit.Postera igitur die prior, composita capsa, revertitur, et mox a fratre, qui visionem viderat,quae illum causa ad silvam invitasset, inquiritur. Quod cum ille velut labore defessus di-cere noluisset, illico frater, et sui causam itineris retulit, et quod ipse viderat, exponendoper ordinem non celavit. Defosso igitur tumulo, ita propemodum totum sancti viri corpussanum illibatumque reperiunt, velut tunc fuerat, cum sepulturae illud primitus tradide-runt, excepto quod tenuis quaedam mucoris lanugo in quibusdam eius membris excre-visse videbatur. Reiecta igitur modica capsa quae facta fuerat, illico vas aptum admensuram beati corporis praeparant, et in eo sanctarum reliquiarum patrocinia reconden-tes, desuper altare solemniter consecrant. Obiit autem vir beatissimus Romualdus decimotertio Kalendarum Iuliarum, regnante Domino nostro Iesu Christo, qui cum Patre et Spi-ritu sancto vivit et gloriatur per infinita saecula saeculorum. Amen.
9 In questo anno San Romualdo viene canonizzato da papa Giovanni XIX mentreviene dichiarato santo nel 1595, da papa Clemente VIII. Il Martirologio Romano necelebra la memoria il 19 giugno, giorno della sua morte. In alcune località al santo puòessere dedicato anche il 7 febbraio, giorno della traslazione delle sue ossa da Iesi a Fa-briano nel 1481.
10 Sulla prima sepoltura vedi A. FORTUNIO, Historiarum Camaldulensium pars poste-
monachis ab apostolica sede licentia, ut supra venerabile corpus eius altareconstruerent”. Poiché le spoglie di Romualdo furono trovate incorrotte la“modica capsa” che i monaci avevano previsto per contenerne le ossa ri-sultò di fatto insufficiente e si rese pertanto necessaria la realizzazione diuna più grande cassa, “vas”, al di sopra della quale fu consacrato l’altare.Secondo Agostino Fortunio, nella sua Translatio corporis sanctiss. Patris Ro-mualdi sacrae Eremi Ordinisque Camaldulensis institutoris, redatta nel 1561 ededita a Firenze, aput Iuntas, nel 1562, si trattava di una cassa di legno in-serita in un monumento di pietra oggetto di devozione e culto: “Compo-sitis enim sacrosanctis effossis Reliquijs in nova excisa capsa iuxta nitaevisionis seriem. Ipsaque in novo lapideo Monumento intrusa in ipsometMonasterio Vallis Castri (quod sui integerrimi corporis Reliquijs inter cae-tera, que varijs in locis erexerat magis honorare placuit) Altarique de licen-tia sedis Apostolicae posito, atque sacrato, omnes protinus, utriusquesexus Agri Fabriani, circumvicinorumque, locorum persone ad eas ibi ve-nerandas maximo devotionis, ac pietatis studio quotidie confluere caepe-runt”11. L’inserimento della cassa lignea12 all’interno di un contenitorelapideo, che peraltro sembra fungere da base dell’altare o da sostegno dellasua mensa, come indica l’uso del termine “monimentum”, è ulterior-mente ribadita dallo stesso A. Fortunio quando descrive, con dovizia didettagli, la non proprio ortodossa seconda riesumazione del corpo delsanto avvenuta in una notte del 1466 ad opera di alcuni monaci a seguitodi rumori che da tempo mettevano in dubbio la presenza delle sue spoglienel monastero di Valdicastro13: “An vero perperam fama inveteravisset,
GIULIA BARATTA48
rior, Venetijs 1579, I, p. 44, cap. 21 e PAGNANI, Vita di San Romualdo, cit., p. 355. Suquesto notaio, divenuto monaco camaldolese, nato a Fiesole nella prima metà del XVIsecolo la cui opera Historiarum Camaldulensium «costituisce il costante punto diriferimento per le successive storie dell’Ordine camaldolese, compresi gli Annales camal-dulenses, che riconoscono i libri Historiarum camaldulensium come «primus parens», vediE. DEL GALLO, Agostino, in Dizionario biografico degli Italiani 49 (1997), p. XXX s.v.Fortunio e la bibliografia citata.
11 FORTUNIUS, Translatio corporis, cit., pp. 20-21.12 Vedi R. BARTOLETTI (coord.), San Romualdo. Vita, iconografia, Fabriano 1984, p.
191 per il rinvenimento di resti lignei all’interno del sarcofago forse pertinenti a questae/o alla successiva cassa.
13 L’abbazia di Valdicastro in particolare tra il XIV e il XV secolo vive momenti mol-
eas in notissimo Monumento iacere, factum est anno MCCCLXVI. Utquidam ipsius Coenobij omnium audacissimus Monachus, qui huiusrei vere certior redderetur, Noctu ad monumentum ipsum, in quo San-ctis Reliquiae servabatur clam impudenter accessertit. Qui Cuneis Sepul-chri primum vasto superiori lapide, Mox vero tegmine lignae capsaealiquantulum per vim elevatis, patefacta mediocriter arca, intrispexit sa-crisanctum longaevum Corpus totum integrum, in nullaque parte ma-culatum iacere. Tametsi quodam tenuis lanuginis mucore non nihilaspersum videtur”14 (Fig. 2). Preso atto che il corpo incorrotto15 trovatonel sepolcro corrispondeva effettivamente a quello di San Romualdo,per decisone unanime dei monaci viene nuovamente tumulato nellostesso “monimentum”. Nella parte superiore di questo viene realizzata
Il sarcofago romano destinato a San Romualdo 49
to difficili. Nel 1427 papa Martino V ne decreta l’unione con il monastero di San Biagioa Fabriano (Annales Camaldulenses VI, p. 317-318) e successivamente l’abbazia vienetrasformata in commenda. Nel 1452 e nel 1475 il commendatario di Valdicastro proponepiù volte lo spostamento del corpo di San Romualdo alla città di Fabriano. Con unabolla datata 15 ottobre 1652 papa Innocenzo X sopprime tra numerose chiese anchequella di San Salvatore in Valdicastro. Per una breve sintesi su queste vicende vediMARCOALDI, Valdicastro, cit., p. 16-17.
14 FORTUNIUS, Translatio corporis, cit., pp. 21-21.15 Non tutte le fonti concordano sul fatto che anche al momento di questa riesuma-
zione il corpo del santo fosse incorrotto. A tale proposito PAGNANI, Vita di San Romualdo,cit., p. 357 ed in part. nota 4 e R. BARTOLETTI (coord.), San Romualdo. Ricognizione sepolcro,Fabriano 20032 ( = ‘Documenti e Studi’), p. 48.
Fig. 2 – Vita et actasanctissimi patriset patriarchae Romualdi(ed. Vienna 1723),caput II, p. 2.
un’apertura in corrispondenza del volto del santo per consentire ai de-voti di vederlo: “Deinde cum luce clarius iam iam omnibus constitissetsacrosanctas Reliquias ibi revera requiescere, factum est Monachorumomnium assensu, ut monimentum ipsum iterum diligenti studio clau-sum obsignatumque fuerit. Relicta superius partia quae dedita operafacta fuit fenestrella, per quam beatissimi Patris facies quicunque adve-nienti cum opus esset ostendi posset, quae quidem fenestrella hucusqueab omnibus cernitur”. Il riposo di Romualdo in questa sepoltura ter-mina nell’anno 1480 quando il suo corpo viene trafugato da due monacidel convento di Classe. Dopo il fortunoso recupero delle sue spoglie,oramai ridotte alle sole ossa, avvenuto a Iesi, inizia una lunga e compli-cata vicenda di contese delle reliquie del santo tra questa città, Fabrianoe il convento di Valdicastro che termina con la loro definitiva traslazione,non senza colpi di scena ed avvenimenti miracolosi16, nell’anno 1481nell’allora chiesa di San Biagio, oggi San Biagio e Romualdo, a Fabriano,ove ancora sono conservate.
Il sarcofago
Il sarcofago (Fig. 3) è stato preso in considerazione sino ad ora solodal punto di vista del suo corredo epigrafico17 e non è stato recepito nelsuo insieme18 ad eccezione della sintetica nota di A. Pagnani19 «Il sarcofagoè pagano, proveniente dalle rovine di Tufico o altra città distrutta20. Èlungo m. 2,30, largo m 0,70, alto m. 0,53. Nei fianchi porta scolpiti consemplicità e finezza scudi incrociati. Nel davanti vi sono striature rettilinee
GIULIA BARATTA50
16 Tutte queste vicende sono narrate da A. Fortunio e riprese dai successivi biografi:FORTUNIUS, Translatio corporis, cit., p. 21 ss.
17 Vedi infra.18 Sui sarcofagi delle Marche non esiste un lavoro di insieme ad eccezione di quanto
concerne i pezzi tardi. Per gli esemplari di tipo ravennate vedi la sintesi di G.M. GABRIELLI,I sarcofagi di tipo ravennate nelle Marche, in «Felix Ravenna» III ser., 31 (1960), pp. 97-116e per quelli tardi paleocristiani ed altomedievali, G.M. GABRIELLI, I sarcofagi paleocristianied altomedievali delle Marche, Ravenna, 1961.
19 PAGNANI, La badia di Valdicastro, cit. p. 302.20 A. Pagnani nel volume Vita di San Romualdo, cit., p. 357 pensa ad una eventuale
provenienza da Cupra.
verticali, e nel mezzo un quadrato libero per la iscrizione, che dice così…».Successivamente anche R. Sassi pubblica una succinta descrizione21: «Sar-cofago in pietra nell’altar maggiore della chiesa di S. Romualdo a Valdi-castro. Incerto se pagano o cristiano; può essere l’ultima delle epigrafituficane come la prima delle iscrizioni medievali di Albacina. Sfuggita agliantichi raccoglitori, perché coperta da una croce». A queste poche parolefa seguito un breve accenno da parte di R. Bartoletti che non apporta so-stanziali novità22.
Il pezzo, in marmo proconnesio (lung. 235; larg. 68; h. 56 cm) si trovaattualmente collocato davanti all’altare moderno nella chiesa di San Sal-vatore a Val di Castro ed è pertanto facilmente accessibile e ben visibile.Si tratta di un sarcofago rettangolare a cassa strigilato o baccellato, dellavariante piuttosto rara con strigili, o baccellature, verticali. Il sarcofago èlavorato su tre lati tutti delimitati superiormente da una cornice lisciasporgente ed inferiormente da una semplice fascia liscia.
Il sarcofago romano destinato a San Romualdo 51
21 SASSI, I ricordi romani di Fabriano, cit., p. 68, n. LXIII; R. SASSI, Iscrizioni medievalidel territorio Fabrianese, in «Studia Picena» 7 (1931), pp. XXXX, I.
22 BARTOLETTI, San Romualdo. Ricognizione, cit., p. 38.
Fig. 3 – Abbazia di Valdicastro. Sarcofago (foto G. Baratta).
La fronte si caratterizza per la presenza di due pannelli rispettiva-mente con 19 strigili, per quanto riguarda quello di sinistra, e 20 per quelche concerne il destro, inquadrati da una cornice lievemente incavata e ru-dentati nel terzo inferiore23. Sia nella parte superiore che in quella infe-riore corre un astragalo a fusarole e perline (Fig. 4). Al centro, tra ipannelli, si trova una tabula ansata che accoglie il, o forse, i testi epigrafici.A delimitare la fronte del sarcofago, ad entrambe le estremità, è collocatauna colonnina tortile poggiante su alta base attica e coronata da un capi-tello corinzio24.
GIULIA BARATTA52
23 In generale sui sarcofagi strigilati, sull’origine di questa decorazione e sulle diversevarianti anche con la tabula ansata centrale vedi G. KOCH - H. SICHTERMANN, RömischeSarkophage, München 1982 (= ‘Handbuch der Archäologie’), pp. 73-76 e pp. 241-245; piùnello specifico per gli strigili verticali p. 242 e G. KOCH, Sarkophage der römischen Kaiserzeit,Darmstadt 1993, in particolare p. 90.
24 Per le colonne angolari e la presenza della tabula ansata vedi P. KRANZ, Jahres-zeiten-Sarkophage. Entwicklung und Ikonographie des Motivs der vier Jahreszeiten auf kaiserzei-tlichen Sarkophagen und Sarkophagdeckeln, Berlin 1984 (= ‘ASR’ 5, 4), p. 258, n. 400,Musei Vaticani, Galleria lapidaria – ultimo decennio II secolo d.C. – prima metà III se-colo d.C.
Fig. 4 – Sarcofago, dettaglio: pannello strigilato destro (foto G. Baratta).
I due lati brevi della cassa sono decorati da un motivo di scudi in-crociati25 dietro i quali sono collocate altrettante lance le cui punte sonorivolte verso l’alto. Sul lato destro (Fig. 5) la decorazione scultorea è ul-timata e gli scudi risultano decorati da motivi curvilinei che si dipartonoda un fiore centrale. In alto, quasi in prossimità dell’incrocio degli scudi,ed in basso, tra la decorazione curvilinea di quello posto in secondopiano, è presente rispettivamente un foro. Il lato sinistro (Fig. 6), invece,è un non finito: gli scudi, le lance ed il fiore centrale sono solo grosso-lanamente abbozzati e manca del tutto la decorazione sulla superficiedegli scudi.
Il lato posteriore non presenta elementi decorativi e risulta solo gros-solanamente lavorato con evidenti tracce di gradina.
L’interno del sarcofago (lung. 2,20; h. 0,50; larg. 0,60), che si è potutovedere in occasione della sua apertura nel 1982 (Fig. 7)26, è lavorato a gra-dina, ha i lati brevi stondati e presenta all’estremità destra un gradino pog-giatesta di 60 x 30 x 4 cm.
Il coperchio (lung. 214; larg. 54; h. 22 cm), del tipo a due falde conacroteri (Satteldachdeckel) (Fig. 7), tre dei quali attualmente risultanomancanti, in marmo proconnesio27, non è pertinente alla cassa e di di-mensioni non compatibili in particolare per quanto riguarda la minorelunghezza. Sembra trattarsi comunque di un pezzo antico che ha subitonel corso del tempo dei rimaneggiamenti come indicano chiaramente unincasso che si trova a circa metà della sua lunghezza (32 x 29,5 cm) e la fi-nestra (Fig. 8) protetta da una grata di 28 x 26,5 cm, fatta con quattrofasce di ferro battuto, e da uno sportello di cui rimangono solo le cernieree l’allogiamento per il chiavistello, realizzata, come indicano le fonti, per
Il sarcofago romano destinato a San Romualdo 53
25 Per alcuni confronti vedi i sarcofagi in G. KOCH, Die Mitologischen Sarkophage. Me-leager, Berlin 1975, (= ‘ASR’ 12, 6), p. 134, n. 152 variamente datato tra il 290 e i primianni del IV secolo d.C. (Cava dei Tirreni, Abazia della Trinità); p. 132, n. 147, intornoalla metà del III secolo d.C. (Wolston House, rinvenuto a Roma); p. 133, n. 150 tardo IIIsecolo. D. BIELEFELD, Die Stadtrömischen Eroten-Sarkopahge. Weinlese und Ernteszenen, Berlin1997 (= ‘ASR’ 5, 2, 2), p. 112, n. 66, sarcofago di Ostia conservato nei magazzini, datatoal secondo quarto del II secolo d.C.
26 BARTOLETTI, San Romualdo. Vita, cit., p. 183.27 Secondo Bartoletti si tratta di “pietra delle cave locali”, BARTOLETTI, San Romualdo,
Vita, cit., p. 183.
Il sarcofago romano destinato a San Romualdo 55
Fig. 6 – Sarcofago, lato breve sinistro (foto G. Baratta).
GIULIA BARATTA56
Fig. 7 - Interno del sarcofago con cassa lignea(da BARTOLETTI, San Romualdo, Vita, cit., p. 193).
consentire la visione e il culto delle spoglie di San Romualdo dopo la rie-sumazione del 1466.
Il sarcofago di produzione urbana può essere attribuito per le sue ca-ratteristiche stilistiche alla seconda metà del II secolo d.C. e difficilmenteoltre la sua fine28.
L’epigrafia
Al centro della fronte la tabula ansata29 con cornice modanata ed ele-menti vegetali negli angoli esterni (Fig. 9) contiene un testo epigrafico30:
Il sarcofago romano destinato a San Romualdo 57
28 Ringrazio il Prof. Ugo Brandenburg che ha confermato questa datazione, per lasua gentile disponibilità. Per un altro sarcofago con strigili verticali di questa cronologiavedi KOCH - SICHTERMANN, Römische Sarkophage, cit., p. 180, fig. 209.
29 Sulla tabula ansata come supporto epigrafico vedi M. MAYER I OLIVÉ, Tabulae an-satae votivas en santuarios. Algunas reflexiones a propósito de las halladas en el posible mitreo deCan Modolell en Cabrera de Mar Barcelona, in G. BARATTA - S.M. MARENGO (eds.), Instru-menta inscripta III. Manufatti iscritti e vita dei santuari in età romana, Macerata 2012, pp.223-245.
30 SASSI, I ricordi romani di Fabriano, cit., p. 68, n. LXIII; PAGNANI, La badia di Valdi-
Fig. 8 – Dettaglio del coperchio (foto G. Baratta).
Aureliae Ve=ronicenimatri karis=sime que vi=
5 xit annis LIValerius Ni=comacus filiusposuit.
Rispettivamente sull’ansa sinistra e su quella destra della tabula, al-l’altezza della riga 4,: B(ene) e M(erenti) preferibile a B(onae) M(emoriae) peril formulario utilizzato nell’iscrizione.
Tabula ansata 55 x 58 cm; campo epigrafico 42 x 36 cm. Lettere: r. 14,2 cm; r. 2 4,5 cm; r. 3 4,5 cm; r. 4 4,5 cm; r. 5 4,4 cm; r. 6 4,5 cm; r. 74,3 cm e 3,3 cm per la I nana; r. 8 3,6 - 3,3 cm.
r. 3-4 PAGNANI; BARTOLETTI: carissime; SASSI, PETRACCIA-TRAMUNTO eTRAMUNTO: rarissime; r. 5 PAGNANI; SASSI; BARTOLETTI; PETRACCIA-TRA-MUNTO e TRAMUNTO: L; r. 5-6 BARTOLETTI (che non trascrive con la sud-divisione in righe) L Valerius.
L’iscrizione si distribuisce su nove righe con un’impaginazione abba-stanza curata. Di recente, prima del 198131, è stata rubricata in manieragrossolana senza che il testo sia stato del tutto rispettato: manca, infatti,il colore nel numerale I che segue il numerale L alla riga 5, evidentementenon visto da chi ha eseguito il lavoro. Si notano anche vistose tracce a ma-tita con proposte di integrazione, ad esempio quae per que alla riga 4. Larubricatura, inoltre, alla riga 3, induce ad una erronea lettura dell’aggettivokarissime poiché la lettera iniziale è stata trasformata, con l’ausilio del co-lore, da K in R.
GIULIA BARATTA58
castro, cit., p. 302; BARTOLETTI, San Romualdo. Ricognizione, cit., p. 38; PETRACCIA -TRAMUNTO, Il contributo dell’epigrafia, cit., p. 272; TRAMUNTO, Silloge epigrafica tuficana,cit., p. 219, n. 66.
31 BARTOLETTI, San Romualdo. Ricognizione, cit., p. 38 fa riferimento alla “iscrizioneritinta in rosso”, segno che la rubricatura era già presente nel 1981, anno della prima edi-zione del volume.
Il testo non pone particolari problemi. Si tratta, infatti, di un’iscri-zione funeraria dedicata a Valeria Veronice32, mater karissima, dal figlio Va-lerius Nicomacus. La difficoltà maggiore risiede nel combinare le nove righedi testo con la formula B(ene) M(erenti) presente sulle anse (Figg. 10-11). In-fatti, da un punto di vista della paleografia e delle dimensioni delle lettere,tutte sembrerebbero tra loro compatibili. A ben guardare, però, il campoepigrafico appare ribassato rispetto alla superficie delle anse e con segni
59
Fig. 9 – Tabula ansata con iscrizioni (foto G. Baratta).
Il sarcofago romano destinato a San Romualdo
32 Allo stato attuale i due personaggi non risultano attestati altrove. Solo a Romaun’iscrizione funeraria (C.I.L. VI 3444) ricorda una donna con un’onomastica moltosimile: D(is) M(anibus) / Aurelia Vero/nice M(arco) Ulpio / Longino evoc(ato) / Augg(ustorum)nn(ostrorum) ho/mini optimo / et bene mere/nti fecit / coniugi. Difficile però che possa trattarsidella stessa persona non solo per la cronologia ma anche perchè il marito dell’una sichiamaMarcus Ulpius Longinus ed il figlio dell’altra Valerius Nicomacus.
GIULIA BARATTA60
Fig. 10 – Tabula ansata, dettaglio dell’ansa sinistra (foto G. Baratta).
Fig. 11 – Tabula ansata, dettaglio dell’ansa destra (foto G. Baratta).
di rimaneggiamento dello specchio il che potrebbe indurre a ritenereche sul sarcofago siano presenti due diverse iscrizioni, una prima, di cuirimangono solo le lettere B edM nelle anse, ed una seconda, quella oggirubricata, che forse può aver fatto suo il testo superstite della precedente.L’ipotesi di un palinsesto di testi epigrafici comporta però il problemadi combinare le eventuali due iscrizioni con l’orizzonte cronologico delsarcofago che difficilmente può essere datato molto oltre la fine del II se-colo d.C. A questo periodo ben si accordano sia le caratteristiche paleo-grafiche del testo rubricato, se si prescinde dai “danni” e dalle illusioniottiche arrecati dal pesante intervento di colorazione, sia quelle dellelettere presenti nelle anse. Se, dunque, come sembra, si tratta effettiva-mente di due iscrizioni, e non di una sola, si dovrebbe ammettere unaloro successione cronologica in un breve arco di tempo compreso tra lafine del II e la prima metà del III secolo d.C. ed escludere, pertanto, leprecedenti datazioni proposte per il testo epigrafico e di conseguenzaanche per il sarcofago33.
Conclusioni
R. Sassi, e in maniera più dubitativa anche A. Pagnani, ripresi da R.Bartoletti, sostengono che il sarcofago provenga da Tuficum. In realtà, perle sue caratteristiche il pezzo è riconducibile ad una bottega urbana e, allostato attuale, non è possibile stabilire se, ed eventualmente quando, siastato portato nel municipio tuficano.
Da un punto di vista teorico tutte le ipotesi sono possibili. Infattisulla base dei dati a disposizione nulla vieta di ritenere che il pezzo siastato portato a Tuficum già in epoca antica. In questo caso si tratterebbedella testimonianza di una sepoltura di un certo livello proprio nel mo-mento di massimo splendore del municipio che però non può essere at-tribuita a nessuno dei membri dell’elite tuficana noti dalle numeroseattestazioni epigrafiche34.
Il sarcofago romano destinato a San Romualdo 61
33 Per le precedenti datazioni del testo epigrafico e del sarcofago vedi supra nota 28.34 Sulla società di Tuficum vedi M. MAYER I OLIVÉ, Municipes et incolae Tuficani
utriusque sexus. Algunas consideraciones sobre la sociedad de una ciudad de la regio VI: Tufi-cum, in M.F PETRACCIA (a cura di), Tuficum, cit., pp. 21-46; per una edizione completa
È comunque anche possibile che il sarcofago non sia mai stato por-tato a Tuficum e che pertanto il palinsesto di iscrizioni presenti nella tabulaansata sia riconducibile ad un uso ed un riuso avvenuto nell’Urbe. In ul-tima analisi non si può scartare neanche l’ipotesi che il pezzo provenga daun sito anche lontano da Tuficum o che addirittura sia da porre in rela-zione ad una sepoltura legata ad una eventuale villa rustica sita sul luogo,o nelle vicinanze35, del monastero fondato da San Romualdo.
Il coperchio, posto a chiudere la cassa litica, e non pertinente a que-sto, documenta l’esistenza di un secondo sarcofago per il quale valgono lestesse considerazioni ed ipotesi già avanzate per la cassa.
Comunque sia il sarcofago ed il coperchio, provenienti da Roma, daTuficum o da un sito nei suoi dintorni, vengono riutilizzati a Valdicastroper la sepoltura di San Romualdo successiva alla riesumazione del suocorpo a cinque anni dalla morte, nell’anno 1032 circa. Infatti, standoalle fonti, il “monimentum”, in cui il santo viene deposto la prima voltaè lo stesso in cui viene ricollocato dopo la riesumazione del 1466. Sial’uso del termine “monimentum” che la dettagliata descrizione dellafonte primaria, costituita dalle opere di A. Fortunio, che fanno chiara-mente riferimento alla realizzazione di un altare, il monumentum altaris,sulla sepoltura di San Romualdo, la cui costante collocazione nellachiesa di San Salvatore, dove di certo si trova già nel 175236, o per un
GIULIA BARATTA62
delle iscrizioni tuficane, seppure con alcune imprecisioni, vedi nello stesso volume ilcontributo di TRAMUNTO, Silloge epigrafica, cit., pp. 155-224.
35 Si tratta solo di un’ipotesi basata sul fatto che l’area in cui sorge l’abbazia è unpianoro ben adatto allo sfruttamento agricolo per la presenza di boschi ed acqua. O.Marcoaldi vi segnala la presenza di una “fornace o fabbrica di materiali laterizi” e visospetta anche la presenza di “fucine”, MARCOALDI, Valdicastro, cit., p. 3 e p. 26, note3 e 4. Non si può escludere che il toponimo Valdicastro tragga origine da castrum intesonon tanto nel senso di castello fortificato, come supposto da Marcoaldi (p. 6), quantoforse anche di villa rustica possibilmente fortificata in epoca tardoantica.
36 Lo conferma un passo del diario di due monaci camaldolesi, Giambenedetto Mit-tarelli e Anselmo Costadoni, che nel 1752 effettuano un viaggio, che li porta anche aValdicastro dove, nella chiesa, vedono il sarcofago. Per il codice cartaceo n. 643 che con-tiene il manoscritto, una volta facente parte della collezione della biblioteca del monasterodi S. Michele di Murano, ed ora alla biblioteca del monastero di Camaldoli, rimandoalla pubblicazione del facsimile con trascrizione ed edizione critica a cura di Mons. Giu-
certo periodo nella cripta37 resta incerta, invitano a ritenere che la mensafosse poggiata sul coperchio del sarcofago ed incassata, per garantirne lastabilità, nell’alloggiamento ricavato al centro della copertura. Solo apartire dal 1466 si deve ritenere che l’altare si trovasse davanti, e menoprobabilmente dietro, al sarcofago visto che sul coperchio litico si realizzala “fenestrella”, ancora oggi ben visibile e protetta da una grata di ferro,per poter vedere i resti del santo; la mensa, pertanto, non può più essereposata sulla cassa litica poiché impedirebbe la vista delle spoglie di Ro-mualdo. La “fenestrella” oltre che dalla grata era anche protetta da un“robusto sportello di ferro” che si poteva chiudere con un chiavistello.Questa seconda protezione ben descritta da A. Pagnani38, che ancoral’ha vista, è stata tolta in occasione della messa in opera della nuovapiana dell’altare realizzato per le feste centenarie della morte di San Ro-mualdo nel 1927. La sua rimozione nel 1982, per consentire la ricogni-zione del sepolcro39, e il fatto che non sia più stata ricollocata al suoposto rendono oggi la cassa ed il coperchio ben visibili dietro all’altaremoderno.
Il sarcofago romano destinato a San Romualdo 63
seppe Maria Croce che ringrazio per avermi gentilmente trasmesso gli interessanti passirelativi alla visita a Valdicastro.
37 Si tratta naturalmente di un’ipotesi, avanzata a suo tempo anche da A. Pagnani,che potrebbe essere suffragata, come scrive il monaco camaldolese, dal fatto che negli in-ventari conservati nell’archivio della chiesa di San Biagio e Romualdo, almeno a partiredal 1639, la cripta viene definita “Sepolcro di S. Romualdo”. Sempre secondo quantoscrive Pagnani il sarcofago potrebbe essere stato portato nella chiesa superiore in occasionedei lavori che portarono anche alla realizzazione della nuova facciata nel 1799; PAGNANI,La badia di Valdicastro, cit., p. 303 e PAGNANI, Vita di San Romualdo, cit., p. 357 ove si ipo-tizza che il sarcofago possa essere stato portato nella cripta in occasione dei restauri dellachiesa nel 1262, ipotesi ripresa in BARTOLETTI, San Romualdo. Ricognizione, cit., p. 45.Anche l’autore delle belle tavole dell’edizione viennese del 1723 della vita del santo di PierDamiani (Vita et acta sanctissimi patris et patriarchae Romualdi, cit.) immagina la sepolturadel santo nella cripta.
38 PAGNANI, La badia di Valdicastro, cit., p. 302 e PAGNANI, Vita di San Romualdo, cit.,p. 358.
39 In occasione di questa all’interno del sarcofago sono stati rinvenuti una cassettadi legno (49 x 29 x 23 cm) con catenella di ferro e almeno 34 resti ossei oltre a delle tavoledi legno, BARTOLETTI, San Romualdo. Vita, cit., pp. 183-193 e supra nota 12.
Il sarcofago, nel quale sino al 1480 ha riposato San Romualdo, è dun-que uno dei tanti interessanti casi del riutilizzo di materiale archeologico40
e dell’uso di spolia, ma soprattutto è testimone di una pagina importantedella storia del cristianesimo.
RIASSUNTO
Il contributo verte su un sarcofago romano riutilizzato come sepoltura di San Romualdo nel-l’abbazia di Valdicastro. L’autopsia del pezzo ha rivelato l’esistenza di altre lettere pertinentialla già nota iscrizione funeraria che lo correda e ha consentito di cambiare la datazione sinoraproposta.
Regio V, Tuficum, Valdicastro, San Romualdo, sarcofago, epigrafia.
RESUMEN
Exte trabajo versa sobre un sarcofago romano reutilizado como sepultura de San Romualdoen la abadía de Valdicastro. La autopsia de la pieza ha permitido ver otras letras presentes en laya conocida inscripción funeraria romana que lleva el sarcofago y ha consentido cambiar la dataciónhasta ahora propuesta.
Regio V, Tuficum, Valdicastro, San Romualdo, sarcofago, epigrafía.
GIULIA BARATTA64
40 Nella cripta sono presenti altri pezzi antichi in particolare una colonna ed un ba-samento riutilizzato come altare, che saranno oggetto di un prossimo studio.