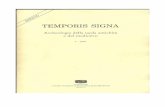Un emporio genovese alla foce del Danubio (Chilia, 1360-1361)
P. GUERRINI, Le iscrizioni del Tetramorfo di Foce (Amelia - Tr). Addenda alle IMAI, II, Umbria –...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of P. GUERRINI, Le iscrizioni del Tetramorfo di Foce (Amelia - Tr). Addenda alle IMAI, II, Umbria –...
pag.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
RICERCHE
E. Destefanis, ...quandam curtem Bremedo...: prime considerazioni sugli antefatti del monastero di S. Pietro di Breme (PV) ........................................................
V. Chiaraluce, Il teatro romano e la cinta muraria altomedievale di Todi. Una rilettura alla luce delle nuove acquisizioni ....................................................................
G. Faustini, La chiesa di San Silvestro presso Fornole: un caso di recupero dell’altura nel medioevo ...............................................................................................
D. Nuzzo - M.R. Depalo - S. Airò, Archeologia urbana nella “Cittadella nicolaia-na” di Bari. Nuovi dati dal riesame delle indagini degli anni Ottanta nell’area del pretorio bizantino .......................................................................................
M. Voltaggio, Hagia Polis Hierosolyma. Birth and Development of Jerusalem Christian Topography ...................................................................................
IL DUCATO DI SPOLETO
C. Angelelli - S. Buonaguro - S. Zampolini Faustini, Archeologia urbana a Spoleto. Lo scavo di Palazzo Pianciani ....................................................
NOTE E DISCUSSIONI
A. Adrian,Le chancel de Saint-Pierre-aux-Nonnains à Metz: étude et restauration ....
M.L. Casati, Frammenti altomedievali dalla chiesa di San Fedele nelle collezioni civi-che di Como ..............................................................................................
D. Anedda, La collezione Carrand al Museo del Bargello: le placchette eburnee della Sala Islamica .............................................................................................
D. Stiaffini, Le recenti scoperte archeologiche di Pisa e i riflessi sullo studio diacronico dei manufatti vitrei in uso durante il medioevo ................................................
INDICE
1
15
51
79
107
125
147
155
173
187
P. Guerrini,Le iscrizioni del Tetramorfo di Foce (Amelia - TR). Addenda alle IMAI, II, Umbria – Terni ...................................................................................
M. Zegretti, Su due chiese poco note dell’estremo suburbio orientale di Roma: San Gennaro, Santi Nicandro, Eleuterio e Andrea .............................................
RECENSIONI
Dal cantiere dei Ss. Quattro Coronati a Roma. Note di storia e restauro per Giovanni Carbonara, a cura di Lia Barelli e Raffaele Pugliese, Roma, 2012 (L. Ermini Pani), p. 219; Paesaggi, comunità, villaggi medievali. Atti del Convegno internazionale di studio (Bologna, 14-16 gennaio 2010), a cura di P. Galetti, Spoleto, 2012 (L. Ermini Pani), p. 224; Ivan Rainini, Antiqua spolia. Reimpieghi di epoca romana nell’architettura sacra medievale del Maceratese, Macerata, 2011 (P. Pensabene), p. 227.
RASSEGNA ................................................................................................
A cura di G.M. Annoscia (ceramica), O. Bucarelli (epigrafia), P. Guerrini (metalli), M.C. Som-ma, F. R. Stasolla.La rassegna di Archeologia e Moneta è a cura di E. A. Arslan
ABSTRACT ...............................................................................................
pag.
»
»
»
197
209
231
283
indiceVI
Le iscrizioni del Tetramorfo di Foce (Amelia - TR). Addenda alle IMAI, II, Umbria - Terni
Nella frazione di Foce, a pochi chilometri da Amelia (Fig.1), presso la chiesa di S. Gregorio si conser-vano tre lastre caratterizzate da bassorilievi che rappresentano i simboli degli Evangelisti con le relative iscrizioni. La quarta lastra dovrebbe essere quella esposta nel Museo Archeologico di Amelia ed attribuita, nel relativo catalogo, alla chiesa di S. Silvestro a Fornole1. Nel volume delle IMAI della provincia di Terni si è dunque seguita tale assegnazione2.
La notizia dell’esistenza di questo gruppo parziale del Tetramorfo a Foce consente ora di rettificare la provenienza della lastra dell’evangelista Marco nel Museo Comunale di Amelia e di integrare con queste nuove schede il corpus epigrafico della provincia di Terni. La lastra con il leone alato mostra infatti evidenti affinità con queste di Foce sia a livello stilistico, sia dimensionale, ma soprattutto per quanto riguarda contenuto e tipologia della scrittura adottata nei relativi cartigli.
Il castello di Foce, per la strategica posizione di avamposto sui colli amerini, si trovò coinvolto e con-teso nelle lotte per il predominio territoriale tra Amelia, Narni e Todi. Dal XII secolo si hanno notizie documentarie del Castrum Focis posto a controllo dell’antica viabilità che si distaccava dalla Flaminia all’altezza del ponte di Augusto, presso Narni, per dirigersi verso Amelia, e poi verso Nord fino a rag-giungere Todi3. Il castello, assoggettato da Amelia, passò sotto il dominio di Narni quando quella città, nel 1245, fu occupata da Federico II4 e le venne restituito solo nel 1256, grazie all’intervento di papa Alessandro IV5. E’ possibile che il sito potesse essere occupato sin dai secoli dell’altomedioevo6.
Al momento non si hanno notizie, né tracce materiali o documentarie che riguardino il castello e/o la chiesa di S. Gregorio che possano intervenire a chiarire l’origine di entrambi. La stessa intitolazione, forse al Gregorio martire spoletino la cui passio risale alla fine V- inizi VI secolo, mentre la diffusione è attestata dal martirologio di Adone dell’8597, non concorre a meglio definire la cronologia dell’edificio.
1. M. Bernardi, Reperti lapidei medievali, in M. Matteini Chiari - S. Stopponi, Museo Comunale di Amelia. Raccolta archeologica. Iscrizioni, sculture, elementi architettonici e d’arredo, Perugia, 1996, p. 224, n. 269. Devo alla gentile segnalazione del dott. Emilio Lucci, che ringrazio sentitamente, la notizia delle lastre di Foce.
2. P. Guerrini, Inscriptiones Medii Aevi Italiae (saec. VI-XII), II, Umbria, Terni, Spoleto, 2010, (Collana del Centro Italiano di Studi sull’Alto medioevo), pp. 85-87, n. 21.
3. T. Cesari, Istoria della miracolosa immagine di Nostra Signora delle Grazie che si venera nella chiesa de’ RR. monaci cisterciensi presso il castello di Foce, Roma, 1858, pp. 1-3; E. Lucci, La topografia di Amelia medievale, in Amelia e i suoi statuti medievali, a cura di E. Menestò,Spoleto, 2004, (Quaderni del Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici in Umbria, 43), p. 141. Per le vicende del castello di Foce nel basso medioevo si rimanda a R. Manni, Amelia nel basso medioevo, in Amelia e i suoi statuti medievali, a cura di E. Menestò, Spoleto, 2004, (Quaderni del Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici in Umbria, 43), p. 5, nota 4, pp. 16, 26.
4. J. L. A. Huillard-Bréholles, Historia diplomatica Friderici Secundi, pars VI, Parisiis, 1880, p. 288; G. Cansacchi, Amelia nelle lotte contro i due Federichi, in Rivista del Collegio Araldico, XXXV (1940), pp. 122-130.
5. E. Menestò, Un esempio di storiografia e cultura letteraria tra Medioevo e Umanesimo, in Le cronache di Todi (secoli XIII-XVI), Firenze, 1979 (Quaderni del Centro per il Collegamento degli Studi Medievali e Umanistici dell’Università di Perugia, 4), p. 451.
6. S rimanda al contributo di Cinzia Perissinotto per la ricostruzione del limes longobardo-bizantino nell’Umbria meridionale: C. Perissinotto, Contributo alla definizione del sistema di difesa del corridoio Bizantino nel territorio dell’Umbria meridionale, in Il corridoio Bizantino e la via Amerina in Umbria nell’alto medioevo, a cura di E. Menestò, Spoleto, 1999, (Uomini e mondi medievali), pp. 219-258.
7. BHL 3677. Si rimanda a G. Guerrini, Santi di Spoleto, in La basilica di San Gregorio Maggiore a Spoleto. Guida storico-artistica, a cura di S. Boesch Gajano - L. Ermini Pani - B. Toscano, Milano, 2002, pp. 70-78. Le reliquie del martire spoletino Gregorio sarebbero state prelevate nel 970 da alcuni uomini del seguito di Deoderico di Metz (A. Sereni, Note di archeologia e topografia altomedievale dell’I-talia centrale in margine al viaggio del vescovo Deoderico di Metz, in Dalla Tuscia Romana al territorio valvense. Problemi di topografia medievale
paola guerrini198
Il gruppo scultoreo del Tetramorfo doveva essere originariamente in connessione con la chiesa di S. Gregorio eretta, sulla sommità dell’altura, che ospita l’insediamento all’interno del circuito difensivo, im-mediatamente in prossimità di una porta urbica (Fig. 2).
La facciata dell’edificio di culto è stata recentemente intonacata ed è caratterizzata da un grande portale a tutto sesto con doppia ghiera, rispettivamente quella esterna in calcare bianco e quella interna in pietra rosata, riconducibile per caratteristiche architettoniche nell’ambito dell’XI secolo8 (Fig. 3). Il grande finestrone posto sopra il portale è con ogni evidenza realizzato in frattura e potrebbe sostituire una precedente apertura: finestra o rosone9. L’abside, in bozze lapidee di forma e pezzatura piuttosto regolari legate con malta, presenta una piccola monofora terminante con una ghiera a tutto sesto in cotto (Fig. 4). L’abside è coronata da una cornice ad archetti pensili che la Gigliozzi sottolinea caratterizzare gran parte degli edifici umbri di pieno XI secolo nelle absidi o lungo i fianchi10. Anche la tecnica muraria della struttura, in cui si riscontra la tendenza a ordinare i conci in file tendenzialmente parallele, ben si accorda con una datazione dell’edificio al pieno secolo XI11.
Entro il medesimo orizzonte cronologico, o al XII secolo, sarebbero da inquadrare, su base stilistica, i capitelli reimpiegati all’esterno della chiesa, davanti alla facciata (Fig. 5), capitelli che mostrano una sintassi prossima, pur se semplificata, avendo un unico ordine di foglie più alte e stilizzate, a quella dei capitelli presenti ai lati del portale principale della cattedrale di S. Maria a Civita Castellana, datati alla fine del XII secolo12.
alla luce delle recenti ricerche archeologiche. Giornate in onore di Jean Coste (Roma 10-11 febbraio 1998), a cura di L. Ermini Pani, Roma, 2001, (Miscellanea della Società Romana di Storia Patria, XLIII), pp. 249-250).
8. P. Durante, La chiesa di S. Martino a Taizzano, in Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Architettura. Dipartimento di storia dell’Archi-tettura, restauro e conservazione dei beni architettonici, n.s., 40 (2002), pp. 69-74, in part. p. 72.
9. F. Gangemi, Santa Maria di Ponte. Studio su una pieve in Valnerina, Spoleto, 2006 (Biblioteca del Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici in Umbria, 22), p. 115.
10. M.T. Gigliozzi, Architettura romanica in Umbria. Edifici di culto tra la fine del X e gli inizi del XIII secolo, Roma, 2000, p. 25.11. Gigliozzi 2000 (nota 10), p. 26.12. E. Parlato - S. Romano, Roma e il Lazio. Il Romanico, Milano, 2001, p. 223, fig. 207.
Fig. 1 – Localizzazione di Foce (stralcio della C.T. R. 1: 200.000).
le iscrizioni del tetramorfo di foce (amelia - tr) 199
Fig. 2 – Foce. La chiesa di S. Gregorio e la porta urbica.
Fig. 3 – Foce. S. Gregorio. Il portale.
paola guerrini200
Fig. 4 – Foce. S. Gregorio. L’abside.
Fig. 5 – Foce. S. Gregorio. Colonne e capitelli riutilizzati.
le iscrizioni del tetramorfo di foce (amelia - tr) 201
Al medesimo XII secolo potrebbero essere assegnate su base stilistico-iconografica le stesse lastre con i simboli degli Evangelisti (Figg. 6-8). Queste, non in collocazione originaria, sono poste ai lati del portale, assicurate con grappe, rispettivamente a sinistra l’aquila e a destra il toro alato, mentre quella con l’Angelo è poggiata su una sorta di basamento realizzato con elementi lapidei di spoglio, di fronte al portale dell’edificio di culto. A destra e sinistra di questo sono presenti due colonne a fusto liscio poste su elaborate basi e sormontate dai capitelli compositi di fattura medievale cui si è già accennato. Si tratta di elementi di spoglio provenienti dalla stessa chiesa di S. Gregorio.
Fig. 6 – Foce. S. Gregorio. Lastra dell’evangelista Luca.
Fig. 7 – Foce. S. Gregorio. Lastra dell’evangelista Giovanni.
paola guerrini202
Le lastre, di forma rettangolare, sono lavorate a bassorilievo; esse risultano molto abrase in superficie e le iscrizioni appaiono di difficile lettura, pur potendovisi identificare la presenza dei celebri versi del Carmen Paschale di Coelius Sedulius13, versi che caratterizzano, pur con lievi divergenze dalla forma cano-nica, anche la quarta lastra dell’evangelista Marco già edita14 (Fig. 9).
Sul piano stilistico non si hanno al momento confronti puntuali, anche se per quanto riguarda il toro alato, per organizzazione e resa del motivo, con uno stile rigidamente disegnativo, disposizione frontale della testa e forma degli occhi, forte è l'assonanza con la lastra dell’evangelista Luca di Narni15.
In relazione all’aquila, l’ “arcaicità” che la connota, lascia intravedere una sorta di vicinanza stilistica con l’altare a blocco di S. Maria del Priorato a Roma contenente le reliquie del martire spoletino S. Savino. Confronti si possono istituire sia con il simbolo equivalente presente nel Tetramorfo rappresentato su un lato dell’altare sia, per la resa del piumaggio in uno stile disegnativo e rigido, con le piume rese come squa-me e, per la stessa forma degli occhi, con i pavoni presenti sulla fronte16. Tali elementi che accomunano le due opere suggeriscono di assimilare le sculture di Foce ad esemplari di X secolo. Per l’Angelo, richiami si possono istituire con l’equivalente Evangelista di S. Maria Maggiore a Tuscania17 (XII secolo?) e, anche se meno vicino geograficamente, con quello del Duomo di Modena18, attribuito a Wiligelmo o alla sua scuola (inizi XII secolo). Elementi in comune sono la resa rigidamente frontale dell’Angelo, la forma delle ali e lo stesso modo di rendere il piumaggio: a Foce si ha però una realizzazione totalmente a bassorilievo, mentre sia a Tuscania sia a Modena si passa da un altorilievo al tutto tondo impiegato per il capo.
Il tema del Tetramorfo caratterizza molte facciate romaniche, soprattutto umbre, e gli sporadici casi presenti nell’alto Lazio sono perlopiù ricondotti a maestranze di quest’area geografica.
13. Coelius Sedulius, Carmen Paschale, ed. J. Huemer, Sedulii opera omnia, Vienne, 1885 (Corpus Scriptorum ecclesiasticorum latinorum, X).
14. Guerrini 2010 (nota 2), pp. 85-87, n. 21. 15. Guerrini 2010 (nota 2), pp. 184-186, n. 51. 16. M. Cecchelli, La diocesi di Roma. Tomo IV, La I Regione Ecclesiastica, Spoleto, 1976 (Corpus della scultura altomedievale VII),
pp. 80-83; A. Peroni - S. Riccioni,The reliquary altar of S. Maria del Priorato in Rome, in Early Medieval Rome and the christian west,Essays in Honour of Donald A. Bullough, a cura di J. M. H. Smith, Lieden - Boston - Köln, 2000, pp. 135-150.
17. J. Raspi Serra, Tuscania. S. Maria Maggiore, Milano, 1971, pp.100,126. 18. Lanfranco e Wiligelmo. Il Duomo di Modena, Catalogo della Mostra, Modena, 1984, pp. 385 e; 436.
Fig. 8 – Foce. S. Gregorio. Lastra dell’evangelista Matteo.
le iscrizioni del tetramorfo di foce (amelia - tr) 203
In particolare risultano essere quasi esclusivamente umbri i casi delle raffigurazioni dei quattro Evan-gelisti corredati dai versi di Coelius Sedulius19, autore della prima metà del V secolo, che nel suo Carmen Paschale traspone in composizione poetica il Vangelo e presenta in quattro versi l’identificazione tra gli Evangelisti e i relativi simboli20:
«Hoc Matthaeus agens hominem generaliter impletMarcus ut alta fremit vox per deserta leonisJura sacerdotii Lucas tenet ore juvenciMore volans aquilae verbo petit astra Johannes».
Questi hanno avuto una grande diffusione, nella tradizione manoscritta, in particolare negli evange-liari, che avrebbero fornito, per questo specifico caso, un repertorio di formulari.
I versi di Sedulius, in epigrafia, sembrano fare la loro prima apparizione nella rappresentazione del Tetramorfo su una lastra del Battistero di Callisto al Museo Cristiano di Cividale in Friuli, che il pa-triarca Sigvald (768-786) offre a S. Giovanni Battista. Ciascun Evangelista, rappresentato dal suo simbolo, tiene un cartiglio sul quale è inscritto il verso che gli corrisponde21. Si ritrova pertanto in epigrafia dalla seconda metà dell’VIII secolo al XIII secolo, con una diffusione sul territorio europeo che riguarda anche la Francia22.
19. I versi del Carmen Paschale di Sedulio ricorrono nei Tetramorfi presenti nelle facciate di S. Ponziano a Spoleto, nel S. Rufino di Assisi, nel S. Pietro a Tuscania, nella Pieve di S. Maria di Ponte e nel Tetramorfo di cui fa parte il toro presente a Narni. In alter-nativa si possono trovare nei libri aperti, associati ai simboli degli Evangelisti, l’incipit del relativo Vangelo (duomo di Cremona e di Modena) o il semplice nome dell’Evangelista (duomo di Civita Castellana) o ancora il cartiglio vuoto (S. Maria Maggiore a Tuscania, S. Giovanni degli Zoccoli a Viterbo).
20. Sedulii opera omnia, ed. J. Huemer, Vienne, 1885 (Corpus Scriptorum ecclesiasticorum latinorum,X), lib. I, pp. 41-42, vv. 355-358.21. Si rimanda a R. Favreau,Épigraphie et miniatures. Les vers de Sedulius et les évangélistes, in R. Favreau,Études d’épigraphie médiévale,
Recueil d’articles de Robert Favreau rassamblés à l’occasion de son depart à la retraite, 1, Texte, Limoges, 1995, pp. 515-530; R. Favreau, Épigraphie médiévale, Turnhout, 1997, p. 150 e da ultimo a G. Cuscito, Epigrafia medievale in Friuli e in Istria (secc. VI-XIII). Per un corpus delle epigrafi medievali dell’alto adriatico, Trieste, 2006, pp. 36-39.
22. Corpus des Inscriptions de la France Médiévale, 12, Aude, Hérault, Paris, 1988, n. 23, pp. 34-36.
Fig. 9 – Amelia, Museo Archeologico Comunale. Lastra dell’evangelista Marco.
paola guerrini204
Le lastre di Foce lasciano aperto l’interrogativo sulla loro originaria collocazione. Nell’organizzazio-ne della facciata, il Tetramorfo figura infatti impostato sul grande rosone centrale nel S. Eutizio a Preci, nella pieve di S. Maria di Ponte, nel S. Felice di Narco, a Spoleto nel S. Ponziano, nel duomo e a S. Pietro, ad Assisi nel S. Rufino, nella collegiata di S. Maria Assunta a Lugnano in Teverina, per poi passare nel Viterbese, dove compare nella facciata di S. Pietro a Tuscania e nel S. Giovanni degli Zoccoli a Viterbo23. Tutto questo gruppo di esemplari mostra notevoli affinità stilistiche ed iconografiche, così come, più in generale, le rispettive facciate, caratterizzate dal rosone centrale e dal Tetramorfo. Esse rispondono ad una tipologia iconografica ed architettonica che risulta diffusa in maniera capillare dalla seconda metà- fine del XII alla prima metà del XIII secolo, in un’area che valica i confini umbri per estendersi ai territori limitrofi24.
Pur rispondendo al medesimo tema iconografico, allo stato attuale delle conoscenze sulla chiesa di S. Gregorio non è possibile attribuire con certezza tali lastre ad una facciata complessa e strutturata orga-nicamente intorno al tema del rosone centrale, anche se la lacuna rappresentata dalla finestra in facciata potrebbe occuparne lo spazio.
In questa tipologia organizzativa della facciata i quattro Evangelisti occupano lo spazio di risulta ai quattro angoli del quadrato in cui è incluso il cerchio del rosone, e presentano pertanto un lato ad arco di cerchio; sono inoltre perlopiù ad alto e altissimo rilievo, se non a tutto tondo.
Rispetto alla tipologia appena descritta, le lastre di Foce si distinguono sul piano stilistico e morfo-logico dal resto degli esempi citati, tra loro piuttosto omogenei. La cronologia presunta su base stilistica
23. Si rimanda a Gangemi 2006 (nota 9), pp. 135-145, con bibliografia.24. Gangemi 2006 (nota 9), p. 181.
Fig. 10 – Epigrafe dell’evangelista Luca. Particolare. Fig. 11 – Epigrafe dell’evangelista Matteo. Particolare.
le iscrizioni del tetramorfo di foce (amelia - tr) 205
(XII secolo) e la forma rettangolare delle lastre lasciano ipotizzare un’impostazione della facciata di que-sto edificio di culto non ancora rispondente all’organizzazione, che diverrà canonica, del rosone centrale corredato ai quattro angoli dagli Evangelisti.
E’ opportuno richiamare a confronto le lastre con Evangelisti, di analoga forma, presenti nella fac-ciata di S. Maria Maggiore a Tuscania25, per le quali sono state chiamate in causa maestranze umbre. Esse sono reimpiegate disposte a croce intorno al rosone e dunque non occupano lo spazio di risulta dalla forma obbligata. Pur non vicine a quelle di Foce sul piano stilistico e per essere quelle di Tuscania ad altissimo rilievo, una certa assonanza, oltre che per la forma rettangolare del supporto, si può osservare nell’Angelo, in entrambi i casi reso rigidamente frontale. Analogamente frontale è l’Angelo di San Mat-teo del Duomo di Modena, attribuito alla scuola di Wiligelmo se non allo stesso maestro26. Purtroppo sia per la chiesa di Tuscania sia per il duomo di Modena non si conosce l’originaria collocazione delle lastre e di conseguenza l’originaria organizzazione della facciata27.
Un altro possibile confronto si può istituire con la cattedrale di Civita Castellana, dove i rilievi con i simboli degli Evangelisti, realizzati su supporti quadrangolari, sono inseriti nei quattro pilastri di sostegno del portico. Anche per queste sculture è stata proposta un’attribuzione a maestranze umbre e una destinazione, nel progetto originario della facciata, a fiancheggiarne il rosone e solo in seguito inserite nei pilastri del portico risalente alla prima metà del XIII secolo28.
Di fatto, dei casi presentati che mostrano supporti di forma rettangolare, non risulta nota la posizio-ne originaria. Rispetto al gruppo umbro “canonico”, le lastre di Foce esibiscono una sintassi scultorea meno complessa, che forse è da attribuire ad un’officina locale o subregionale, i cui caratteri peculiari si rintracciano anche nella lastra di S. Luca conservata a Narni29, ovvero ad una fase precedente rispetto agli esempi umbri citati, ascrivibili alla fine XII - inizi XIII secolo.
In conclusione, alla luce di quanto attualmente conosciuto è evidente che non si può meglio defi-nire l’originario posizionamento di queste lastre e dunque, se erano in facciata, l’organizzazione della stessa. Allo stesso tempo le caratteristiche stilistico-iconografiche, quella arcaicità e schematicità del tratto, più disegnativo che plastico-scultoreo, possono attribuirsi ad un effettiva recenziorità o piuttosto alle modeste capacità di una bottega locale.
I pochi elementi costruttivi apprezzabili della chiesa di S. Gregorio - portale, muratura e archetti pensili dell’abside - rimandano al pieno XI - XII secolo, datazione cui sarebbero da riferire anche i ca-pitelli presenti all’esterno della chiesa. Per quanto riguarda le iscrizioni, la tipologia di scrittura adottata é una maiuscola romanica con inclusioni di lettere onciali e minuscole, realizzata con solco triangolare molto aperto a causa probabilmente anche dell’erosione superficiale.
Si può notare la A con ampio tratto orizzontale posto all’incrocio dei lati obliqui e la traversa spez-zata, la G a ricciolo, la O a mandorla, la N talvolta retroversa; la M e la E di tipo onciale sono evidenti nella lastra dell’aquila (rispettivamente alla r.1 e alla r.2). Tutti questi elementi possono convergere per una datazione del gruppo del Tetramorfo di Foce, non meglio circoscrivibile, nell’ambito del XII se-colo.
La realizzazione della decorazione scultorea di S. Gregorio avrebbe dunque fatto seguito all’ultima-zione dell’edificio romanico.
25. Raspi Serra 1971 (nota 17), pp. 100,126.26. Lanfranco e Wiligelmo (nota 18), pp. 385 e 436. Circa l’originale posizione delle lastre con Tetramorfo vale ricordare la tesi di
Arturo Carlo Quintavalle che le attribuisce ad un pulpito (A.C. Quintavalle, Da Wiligelmo a Niccolò: pulpiti scomposti, problemi di filo-logia e di funzioni, in Forme e storia. Scritti di arte medievale e moderna per Francesco Gandolfo, a cura di W. Angelelli – F. Pomarici, Rende (CS), 2011, pp. 181-196), anche se non sembra possibile allo stato attuale applicare tale proposta al nostro caso.
27. Il progetto della facciata di S. Maria Maggiore a Tuscania doveva probabilmente prevedere nella parte alta una composizione di lastre con storie tratte dal Vecchio e Nuovo Testamento (Raspi Serra 1971 (nota 17), pp.100,126). Per i rilievi con i simboli degli Evangelisti riutilizzati nella facciata del duomo di Modena sopra il rosone è stata ipotizzata da Frankl e da De Francovich un’origina-ria collocazione in facciata tra il portale e il loggiato nella parte poi occupata dal protiro; per Quintavalle sarebbero invece pertinenti ad un ambone, data la loro frequenza in queste strutture (E. Castelnuovo, Sc. 5 - Wiligelmo - I simboli degli evangelisti, in Lanfranco e Wiligelmo 1984 (nota 18), p. 436.
28. Parlato - Romano 2001 (nota 12), pp. 224-225.29. Guerrini 2010 (nota 2), pp. 85-87, n. 21.
paola guerrini206
1. Foce (Amelia) - Chiesa di S. Gregorio. Epigrafe didascalica-esegetica (sec. XII). Figg. 6 e 10.
La lastra relativa all’evangelista Luca, con la rappresentazione del toro alato, è collocata in facciata sulla destra del portale d’ingresso e misura cm 43 di altezza e cm 69 di larghezza. Il testo presenta una scrittura continua sulle due pagine che si sviluppa su sette righe di scrittura.
Per la porosità e lo stato di degrado della superficie la lettura si rivela piuttosto difficoltosa. Il libro aperto che coincide con lo specchio epigrafico misura cm 19,5 in altezza e 8 in larghezza. La scrittura adottata è una maiuscola romanica atipica con elementi di onciale e minuscole. Si nota la presenza della N retroversa in r. 5, E onciale in r. 6. In r. 2 segno abbreviativo a linea ondulata sulla prima U.
[Iu] sa- cerdo- ti (m) Lu- ca te-
5 net ore iu- [v]e ci.
2. Foce (Amelia) - Chiesa di S. Gregorio. Epigrafe didascalica-esegetica (sec. XI/XII). Figg. 7 e 11
La lastra relativa all’evangelista Giovanni, con la rappresentazione dell’aquila, si conserva in facciata sulla sinistra del portale. Misura cm 42 di altezza ma, avendo una forma leggermente trapezoidale, misura
Fig. 12 – Epigrafe dell’evangelista Giovanni. Particolare.
le iscrizioni del tetramorfo di foce (amelia - tr) 207
in larghezza cm 55,5 in basso e cm 52 in alto. Lo specchio epigrafico costituito dal libro aperto misura cm. 21 di altezza e 8,5 di larghezza. Il testo si sviluppa su 8 righe con una scrittura continua.
Presenza di lettere onciali (M r. 1) e minuscole (U/V in r. 3), trattino obliquo che taglia il corpo della L in r. 2 ad indicare un’abbreviazione per contrazione. In r. 5 possibile errore del lapicida con l’inseri-mento della P. L’errore può forse imputarsi alla presenza del nome di Ioannes a fine testo che può aver indotto all’inserimento di APS (apostolus). Ciò comporterebbe una certa capacità di lettura e compren-sione del testo da parte dell’esecutore materiale della lastra e/o dell’epigrafe.
More v- ola(n)s aq(ui)- le verb- o petit
5 a{p}s- t[r] - oa[nn]e- s.
3. Foce (Amelia) - Chiesa di S. Gregorio. Epigrafe didascalica-esegetica (sec. XI/XII). Figg. 8 e 12
La lastra con l’Angelo, simbolo dell’evangelista Matteo, è attualmente collocata di fronte alla porta d’ingresso della chiesa. L’Angelo è realizzato a mezzo busto in posizione praticamente frontale. Tra le mani tiene il libro aperto. La lastra misura cm 47,5 di altezza ma, avendo una forma trapezoidale, misura in larghezza cm 65 in basso e cm 61,5 in alto. Lo specchio epigrafico non è ben evidente se sia costituito da una pagina unica o da due pagine come nelle altre lastre dove la costola centrale è percepibile. Esso misura cm 19,5 di altezza e 11 di larghezza. Il testo si sviluppa su 8 righe con una scrittura continua. In r. 6 è presente una N retroversa. La lastra, assai corrosa in superficie, é di difficile lettura.
[Hoc Ma-] teus a- gens o- min-
5 e [g]e- ne al(iter) i-
pl- et.
Paola Guerrini