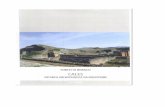Landoni, G., Lomivorotov, V., Pisano, A., Neto, CN, Benedetto, U.
Monasteri e castelli sul Monte Pisano. Insediamenti medievali in un'area di confine (X-XII secolo)
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Monasteri e castelli sul Monte Pisano. Insediamenti medievali in un'area di confine (X-XII secolo)
La collanaÈ destinata alla pubblicazione di studi, editi ed inediti, tappe di itinerari di ricerca, Percorsi, appunto. Offre agli specialisti la possibilità di avere a disposizione, raccolti in un volume, saggi spesso di non facile reperimento e, al lettore ‘comune’, l’opportunità di entrare dentro il ‘laboratorio’ dello storico.
Il libroxxxxxxxxxx
Il curatorexxxxxxx
Volumi pubblicati 1. Marco Tangheroni, Medioevo Tirrenico. Sardegna, Toscana e Pisa2. Franca Leverotti, Popolazione, famiglie, insediamento. Le sei Miglia lucchesi nel XIV e XV secolo3. Silio P.P. Scalfati, Corsica Monastica. Studi di storia e di diplomatica4. Silio P.P. Scalfati, La Forma e il Contenuto. Studi di scienza del documento5. Paola Ventrone, Gli araldi della commedia. Teatro a Firenze nel Rinascimento6. Silio P.P. Scalfati, Diplomatica Corsa7. Lucia Gai - Giancarlo Savino, L’Opera di S. Jacopo in Pistoia e il suo primo statuto in volgare
(1313)8. Bruno Dini, Saggi su una economia-mondo. Firenze e l’Italia fra Mediterraneo ed Europa (secc.
XII-XIV)9. Riccardo Fubini, Quattrocento fiorentino. Politica, diplomazia, cultura10. Emilio Cristiani, Scritti scelti, a cura di Silio P.P. Scalfati e Marco Tangheroni11. Emilio Gabba - Umbero Laffi, Sociedad y politica en la Roma republicana (siglos III-I a.C.)12. Graziella Berti - Catia Renzi Rizzo - Marco Tangheroni, Il mare, la terra il ferro13. Maria Luisa Ceccarelli Lemut, Medioevo Pisano. Chiesa, Famiglie, Territorio14. Franco Cardini - Maria Luisa Ceccarelli Lemut (a cura di), Quel mar che la terra inghirlanda. In
ricordo di Marco Tangheroni15. Maria Luisa Ceccarelli Lemut - Massimo Dringoli (a cura di), Castelli e fortificazioni della
Repubblica Pisana16. Antonio Musarra, La guerra di San Saba17. Rosanna Pescaglini Monti, Toscana medievale. Pievi, signori, castelli, monasteri (secoli X-XIV)
Stud
i di S
toria
deg
li In
sedi
amen
tiin
ono
re d
i Gab
riella
Gar
zella
Collana PERCORSI
Studi di Storia degli Insediamenti
in onore diGabriella Garzella
a cura diENRICA SALVATORI
ISBN 978-88-6315-386-6
9 7 8 8 8 6 3 1 5 3 8 6 6
ENR
ICA
SA
LVA
TOR
IPacini
Editore
PaciniE d i t o r e
Ricerca
PaciniE d i t o r e
Ricerca
a cura diEnrica Salvatori
Studi di Storia degli Insediamenti
in onore diGabriella Garzella
© Copyright 2014 Pacini Editore SpA
ISBN: 978-88-6315-713-0
Realizzazione editoriale
Via A. Gherardesca56121 Ospedaletto (Pisa)[email protected]
Fotolito e StampaIndustrie Grafiche Pacini
Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, comma 4, della legge 22 aprile 1941 n. 633 ovvero dall’accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMER-CIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000. Le riproduzioni per uso differente da quello personale sopracitato potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dagli aventi diritto.
MONASTERI E CASTELLI SUL MONTE PISANO. INSEDIAMENTI MEDIEVALI IN UN’AREA DI CONFINE (X-XII SECOLO)
antonio aLBerti
Il Monte Pisano ha occupato fin dall’alto medioevo una posizione strategica in un’area di confine tra le diocesi di Pisa e Lucca e di con-tinua espansione o riduzione dei territori controllati dalle due città. L’importanza del rilievo, che raggiunge una altezza di 910 m s.l.m. con il Monte Serra, è data anche da una efficace azione di controllo della viabilità che correva sotto monte e che costituiva uno dei nodi viari più importanti della Toscana medievale: la Strata Vallis Arni lungo la Valle dell’Arno, tra Pisa e Firenze; la strada lungo monte attraverso la valle del Serchio, che collegava Lucca a Pisa; la via pedemontana sulla spon-da occidentale del lago di Sesto, per Lucca. A pochi chilometri a est da quest’ultimo tracciato correva poi la via Francigena, che dalla Val d’Elsa e attraverso l’area delle Cerbaie collegava Siena a Lucca passando per il Valdarno. La navigabilità sull’Arno, sul Serchio e sul lago di Sesto pone-va il Monte Pisano al centro di un’efficace rete di collegamenti via terra, lacuali e fluviali. La pedemontana lungo il tratto orientale alle pendici
Fig. 1. Carta del Monte Pisano. Distribuzione dei siti medievali ricordati nel testo.
150 ANTONIO ALBERTI
del Monte Pisano si poneva, inoltre, come alternativa al vicino tratto della Francigena. La presenza di San Leonardo in Treponzio (dove si trovava un ospedale) e di 4 abbazie dove era possibile trovare ospitalità (Cantignano, Guamo, Sesto, Cintoia), ne confermerebbe la funzione1.
La fase di incastellamento sul Monte Pisano: storia e archeologia
In questo contesto territoriale (fig. 1) la vicinanza di Pisa e Lucca ha posto dei forti vincoli allo sviluppo di un insediamento accentrato e alla affermazione di poteri signorili nell’area intorno alle due città. La fase di incastellamento ebbe origine soprattutto tra XI e XII secolo, come altrove in Toscana, attraverso la promozione di famiglie laiche del territorio, del vescovo, di funzionari legati alla corona e in alcuni casi di un monastero, ma il ridotto sviluppo di giurisdizioni signorili fu causata dalla precoce organizzazione comunale di Pisa che, come per Lucca, riuscì abbastanza presto a unificare il proprio territorio2. Questa ege-monia territoriale limitò così la formazione di giurisdizioni concorrenti ai governi cittadini. I castelli che furono fondati in questo ambito non svolsero quindi un effettivo ruolo di affermazione signorile3.
Sul versante pisano del Monte Pisano i castelli nati con questa ori-ginaria funzione furono quindi assai pochi: Vicopisano (Auserissola), Buti, i castelli di Calci, Caprona e Ripafratta, mentre le fortificazioni della Verruca, di Agnano e di Asciano ebbero fin da subito una funzio-ne più strettamente militare.
Di seguito sono elencati i castelli attestati sul Monte Pisano o alle sue pendici:
1 Il presente contributo riprende in parte gli argomenti già trattati in A. aLBerti, I monasteri medievali del Monte Pisano (X-XII secolo), in Monasteri e castelli fra X e XII secolo. Il caso di San Michele alla Verruca e le altre ricerche storico-archeologiche nella Tuscia occidentale, Atti del Convegno di studi (Uliveto Terme, Parco delle Terme-Vicopisano (PI), 17-18 novembre 2000, a cura di R. Francovich-S. Gelichi, Firenze 2003, pp. 79-92.
2 M.L. CeCCareLLi LeMut, Medioevo Pisano. Chiesa, famiglie, territorio, Pisa 2005, pp. 453-454.
3 Per una sintesi aggiornata sull’incastellamento nel territorio pisano si veda M.L. CeCCareLLi LeMut, L’incastellamento del territorio pisano (secoli X-XIV), in Castelli e fortificazioni della Repubblica Pisana, a cura di M.L. Ceccarelli Lemut, M. Dringoli, Pisa 2009, pp. 3-31.
151MONASTERI E CASTELLI SUL MONTE PISANO
n. castelloprima menzione luogo
prima at-testazione castello
promotore sito attuale
17 Auserissola 934 975 Obertenghi ?/ve-scovo di Pisa? Vicopisano (PI)
19 Verruca - 996Ugo di Toscana / Monastero di Sesto ?
Rocca della Ver-ruca (PI)
6 Compito - 1020 S. Salvatore di Sesto
Castellaccio, Pieve di Compito (LU)
7 Castelnuovo - 1027 S. Salvatore di Sesto
Monte Castello, Colle di Compito (LU)
9 Castelvecchio 869 1027 S. Salvatore di Sesto
Castelvecchio di Compito (LU)
2 Vaccoli - 1042 Longobardi di Vaccoli
Monte Cotrozzi? (LU)
23 Castello de Ripabranuli - 1046
Famiglia di Rai-mondo del fu Guido
Calci, località Gangalandi (PI)
27 Caprona - 1051 Da Caprona Caprona (PI)
22
Castello quod
dicitur de lo
Episcopus
Curtis
958 1059 Vescovo di Pisa
Calci, Oasi del
Sacro Cuore (PI)
33 Ripafratta - 1085 Da Ripafratta Ripafratta (PI)
11 Buti villa 960 1099 Upezzinghi Buti (PI)
4 Vorno 1126 Leone Vorno (LU)
25 Agnano 1031 1164 Visconti Pressi di Agnano
(PI)
26 Asciano 1077 1168 - Pressi di Asciano
(PI)
Molti di questi centri nel corso del XII secolo furono sottoposti a Pisa o a Lucca, che intrapresero una politica di controllo capillare dei rispettivi territori: il castrum di Agnano, ad esempio, era già sotto i pisani nel 11654. Diversa sembra apparire la situazione per l’area orientale del Monte Pisano dove la forte signoria territoriale del monastero di S. Salvatore di Sesto, almeno fino a tutto l’XI secolo, ne condizionò l’assetto insediativo. I castelli documentati in questa zona, vale a dire Castelvecchio, Castelnuovo, Compi-to, furono tutti sottoposti all’autorità dell’abbazia5. Solo Vicopisano venne
4 G. GarzeLLa, Il Pedemonte, in La pianura di Pisa e i rilievi contermini. La natura e la storia, a cura di R. Mazzanti, Roma 1994, p. 244.
5 aLBerti, I monasteri, cit., nota 1, p. 81.
152 ANTONIO ALBERTI
fondato senza legami di dipen-denza da Sesto. Secondo l’ipotesi di Nobili6 fu di primo piano il ruolo avuto dagli Obertenghi in quella fondazione (in un livello del 1002 una parte del castello di Vico appartiene agli Obertenghi) e nel successivo ruolo politico di questa famiglia nello stesso territorio. Il consolidamento del patrimonio degli Obertenghi in questa area viene infatti inter-pretato come uno strumento di affermazione e di alleanza col ve-scovo pisano, contrapposto agli interessi del marchese di Tuscia legati invece alla corona, che non a caso poco dopo trasforma San Salvatore in monastero imperia-le. Il castello di Buti è invece ricordato per la prima volta alla fine dell’XI secolo e probabil-mente sottoposto alla signoria degli Upezzinghi7.
Dei centri incastellati ricor-dati, solo alcuni hanno avuto una reale funzione di accen-tramento della popolazione e pochissimi hanno avuto con-
tinuità di insedia-mento nello stesso sito di fondazione. Sul versante orien-tale del Monte Pi-sano solo Vicopi-sano (Auserissola), Castelvecchio di Compito e Buti hanno avuto uno sviluppo postme-dievale e quindi una continuità di
6 M. noBiLi, Le terre obertenghe nelle contee di Pisa, Lucca e Volterra, in Studi di storia medievale e moderna su Vicopisano e il suo territorio, Atti del convegno della Società Storica Pisana (Vicopisano 27 giugno 1982), Pisa 1985, pp. 35-47.
7 CeCCareLLi LeMut, L’incastellamento, cit., nota 3, p. 18.
Fig. 2. Castelmaggiore, Calci. Pilastro di edifi-cio medievale, visibile dopo il distacco dell’in-tonaco moderno.
Fig. 3. Ripafratta. L’interno del castello.
153MONASTERI E CASTELLI SUL MONTE PISANO
insediamento, trasformandosi nei centri attuali. Però con delle diffe-renze: Vicopisano ha mantenuto le evidente medievali del castello, con alcune aggiunte e trasformazioni di epoca moderna; Buti non conserva nessuna emergenza muraria medie-vale visibile, oltre al campanile del-la pieve che è la trasformazione di una torre con l’aggiunta della cella campanaria, mentre l’interno della pieve conserva un prospetto murario a vista di tipo romanico; Castelvec-chio, pur non conservando evidenze visibili ricalca fedelmente, nella sua organizzazione spaziale, la pianta dell’antico castello.
Nel versante meridionale l’uni-co centro incastellato con continuità di insediamento è quello di Calci. Qui, pur non conservandosi nessuna struttura muraria visibile del castello medievale, l’abitato pare concentra-to intorno alla pieve, quindi con uno spostamento, pur minimo, del borgo originale. L’altro centro fortificato calcesano, il castello de Ripabranuli, poco più a nord, sulla strada che porta al Monte Serra (Castelmaggiore), conserva ancora oggi un abitato abbastanza concentrato lungo la viabi-lità principale, nel quale sono visibili alcune strutture in bozze di pietra, genericamente databili all’XI-XII secolo, che potrebbero testimoniare la presenza di edifici coevi al castello documentato a partire dal 1046 (fig. 2). La stessa cosa vale per Ripafratta, dove il cassero del castello, sulla collina che sovrasta l’attuale centro, è ancora perfettamente conservato ma precocemente abbandonato (fig. 3), mentre l’abitato si è concentra-to lungo la viabilità principale, corrispondente all’ultimo ampliamento basso medievale8.
Di alcuni altri castelli di area pisana sappiamo ben poco. I centri fortificati di Agnano e Asciano non conservano evidenti testimonianze materiali rispetto all’ipotizzato sito originale, mentre l’abitato postme-dievale si è sviluppato a valle9.
Per quanto riguarda i castelli del versante meridionale del Monte Pisano, quindi, nessun centro incastellato è stato completamente ab-bandonato, ma ha avuto continuità di frequentazione o nello stesso sito
8 F. redi, Ambiente naturale e intervento dell’uomo nel medioevo, in San Giulia-no Terme. La storia, il territorio, II/1, S. Giuliano Terme 1990, pp. 263-265.
9 Ibidem, pp. 273-276; CeCCareLLi LeMut L’incastellamento, cit., nota 3, p. 17.
Fig. 4. La torre medievale di S. Giusto di Compito.
154 ANTONIO ALBERTI
del castello o in un’area rav-vicinata che ne testimonia comunque la continuità di vita. La stes-sa casistica si registra per i castelli del versante orien-tale, quelli sottoposti ini-zialmente alle dipendenze del monastero di Sesto. Anche in questo caso
l’unico centro conservato è quello di Caltelvecchio, mentre gli altri castelli sono stati abbandonati con il trasferimento dell’abitato a valle: Compito, dal sito di Monte Castellaccio a Pieve di Compito; Castelnuovo, da Monte Castello a Pieve di Compito, in questo caso con un accentra-mento intorno all’antica pieve. In questo sistema di controllo rientrava probabilmente anche la torre di S. Giusto di Compito (fig. 1, n. 5; fig. 4).
D i v e r s o è il caso di Vaccoli, dove la migrazione dell’abitato ri-spetto all’an-tico castello registrerebbe uno sposta-mento mag-giore rispetto agli altri siti ricordati, ma anche in que-sto caso in funzione di un accentramen-to della popo-lazione lungo la viabilità di valle (da Monte Cotrozzi all’attuale Vaccoli). Un’ulteriore fase di raffor-zamento del controllo del Monte Pisano è documentata poi dalle molti torri con funzione di guardia della viabilità principale del Valdarno e del Val di Serchio, oltre a quella minore entro le vallate dell’area collinare. Alcune di queste strutture risulterebbero di nuova costruzione e diretta-
Fig. 5. Monte d’Oro. Vista della collina e del borgo di Buti.
Fig. 6. Torre in pietra inserita nel circuito murario della fortifica-zione di Monte d’Oro (Buti).
155MONASTERI E CASTELLI SUL MONTE PISANO
mente legate alla volontà di controllo della Repubblica pisana a partire dal XIII secolo, altre probabilmente sfruttarono edifici preesi-stenti.
A partire dal territorio butese e fino a Ripafratta sono documentate almeno 14 fra torri e rocche.
La rocca del Monte d’Oro (fig. 1, n. 12) è posi-zionata sulla collina di fron-te a Buti, con un raggio di visibilità che copre la piana dell’antico lago di Sesto, e le Cerbaie (fig. 5). Si tratta con molta probabilità di un recinto fortificato, in parte conservato sotto le macerie e i terrazzamenti a uliveto. Inserita nel circuito mura-rio è ancora visibile la por-zione di una torre a base quadrata, con lati di 4,90 x 4,60 m, e uno spessore di 1,20 m. La muratura è a sacco con il prospetto ester-no costituito da bozzette di verrucano, piccole e medie, spesso di forma allungata, in opera a filari orizzontali, che daterebbero, per confronto con altri edifici dell’area (abside di S. Salvatore di Cantignano), dalla metà dell’XI secolo10 (fig. 6).
Una torre quadrangolare, in bozze di pietra, conservata per alcuni filari in alzato è presente sulla cima di Monte Roncali (fig. 1, n. 13), mentre il toponimo «la Torre», nei pressi di S. Iacopo in Lupeta, si rife-risce ad un edificio turriforme in pietra inserito in epoca moderna nel complesso di un mulino (fig. 1, n. 14; fig. 7). In quella stessa area anche la torre di S. Iacopo di Lupeta potrebbe aver funzionato come punto di avvistamento (fig. 1, n. 16).
La Rocca della Verruca (fig. 1, n. 19) era il punto di avvistamento e di controllo più importante per i pisani, con una visibilità straordinaria su tutto il Basso Valdarno e fino alla costa toscano-ligure. La prima atte-stazione della rocca risale al 996, allorché l’imperatore Ottone III confer-
10 A. aLBerti, I monasteri del Monte Pisano (X-XII secolo). Fondatori, committen-ti, e gestione delle risorse, in L’aratro e il calamo. Benedettini e Cistercensi sul Monte Pisano, a cura di S. Gelichi, A. Alberti, Ghezzano (S. Giuliano T.) 2005, p. 53.
Fig. 7. Edificio medievale turriforme in località La Torre, Vicopisano.
156 ANTONIO ALBERTI
mò al mona-stero di S. Salvatore di Sesto nella diocesi di Lucca la ro-ca (…) que dicitur Ver-ruca donata al cenobio dal mar-chese Ugo di Tuscia11. Ampie por-zioni di cin-ta murarie e la torre c e n t r a l e , in base al-le tecniche m u r a r i e ,
potrebbero appartenere alla fase originaria del castello, ossia al X seco-lo. Il prospetto occidentale interno presenta due distinte murature: la porzione inferiore del prospetto è costituita da pietre spaccate, e non sbozzate, apparecchiate in modo irregolare ma con la tendenza alla regolarità dei filari orizzontali, rispecchiando con questo un ambiente tecnico ancora locale che fa ricorso a «tecniche da muratore» di crono-logia pre-romanica12.
Di un’altra torre esistono resti alla base della cosiddetta «torre Upez-zinghi» (fig. 1, n. 20), sovrastante il centro di Caprona. Della torre medie-vale rimangono pochi filari a vista sul lato sud, quello a valle, come base di fondazione della torretta ricostruita in stile ottocentesco (fig. 8). Questa emergenza di epoca medievale potrebbe far parte della fortificazione fon-data dai Da Caprona nel 1051 Un’altra testimonianza medievale proviene dai muri in conci di pietra visibili nei prospetti di Palazzo Luperi Centoni. Si tratta dei resti di un palazzo fortificato, forse inserito nel tessuto dell’an-
11 CeCCareLLi LeMut L’incastellamento, cit., nota 3, p. 5; la pergamene è pubblicata in G. GiuLiani, Il monastero di San Michele alla Verruca: profilo delle vicende storiche, in L’aratro e il calamo. Benedettini e Cistercensi sul Monte Pisano, a cura di S. Gelichi-A. Alberti, S. Giuliano Terme 2005, p. 14. Sulla Verruca sono stati fatti numerosi studi architettonici; cfr. M. drinGoLi, La Rocca della Verruca. Conservazione e recupero, in La Rocca della Verruca. Dossier (Associazione per la Rocca della Verruca), Bientina 2012, pp. 21-35; L.G. niCoLosi, La Rocca della Verruca nei Monti Pisani. Rilievo e ipotesi di recupero, in La Rocca della Verruca. Dossier (Associazione per la Rocca della Verruca), Bientina 2012, pp. 71-82.
12 Per l’analisi delle murature aLBerti, I monasteri., cit., nota 10, pp. 53-54.
Fig. 8. Struttura muraria residua sulla quale è stata costruita l’otto-centesca Torre degli Upezzinghi a Caprona.
157MONASTERI E CASTELLI SUL MONTE PISANO
tico borgo sviluppatosi a valle del castello della nobile famiglia pisana.Altre torri con simile funzioni sono documentate a Montemagno
e nei pressi di Calci. La prima è una struttura riconvertita a campanile della chiesa del cimitero di Montemagno, immediatamente a sud del pa-ese (fig. 1, n. 21); la seconda evidenza è stata riportata in luce grazie ad uno scavo archeologico in località Campaccio (fig. 1, n. 24), sulla collina immediatamente a ovest dell’imbocco della Val Graziosa13.
Oltre le fortificazioni di Agnano e Asciano, la documentazione scritta bassomedievale ci ricorda della costruzione di una torre di avvistamento sul Monte S. Giuliano, sovrastante la cittadina termale14 (fig. 1, n. 28).
Maggiore conservazione si registra per le emergenze murarie me-dievali di tipo militare presenti lungo la valle del Serchio. Qui, oltre al castello di Ripafratta che costituisce una testimonianza chiara dell’im-portanza del controllo della viabilità tra Pisa e Lucca, sono ben visibili le strutture di altre quattro torri bassomedievali: torre di Mucchieto, torre del Centino, torre Niccolai e un’altra torre di cui si conservano solo i basamenti (fig. 1, nn. 29, 31-34); a queste va probabilmente aggiunto il centro fortificato di Quosa15.
I monasteri del Monte Pisano: storia, archeologia e architetture
L’assenza di fondazioni monastiche nella fascia meridionale del Monte Pisano conferma la difficoltà nell’affermazione di diritti signorili su un territorio dove neppure la fondazione di castelli ha avuto successo. Dove il vincolo posto da Pisa nel controllo deciso del suo ambito territo-riale intorno alla città è risultato meno incisivo, sia la presenza di centri incastellati sia di centri monastici dimostra almeno il tentativo di creare giurisdizioni signorili, anche se di durata piuttosto effimera. Nella fascia orientale, ad esempio, la contrapposizione per il controllo dell’area si gio-ca tra il monastero di Sesto, il vescovo di Pisa e alcune consorterie locali.
I monasteri benedettini sorti sul Monte Pisano tra il X e il XII secolo rientrano nel quadro della grande fioritura di fondazioni monastiche av-venuta in quei secoli, durante la quale si registrano in Toscana circa 130 fondazioni di cenobi ispirati alla regola benedettina16. L’impulso a questa
13 N. taddei, Scavi in località Campaccio (Calci, Pisa). Notizie preliminari, in «Contributi della Scuola di Specializzazione in Archeologia dell’Università degli Studi di Pisa», I (1997), Pontedera, 1998, pp. 87-98.
14 redi, Ambiente naturale, cit., nota 8, p. 272.15 redi, Ambiente naturale, cit., nota 8, pp. 265-270.16 Per un quadro su monasteri e signorie territoriali in Toscana si veda M.L.
CeCCareLLi LeMut, Monasteri e signoria nella Toscana occidentale, in Monasteri e castelli fra X e XII secolo. Il caso di San Michele alla Verruca e le altre ricerche storico-archeologiche nella Tuscia occidentale, Atti del Convegno di studi (Uliveto Terme, Parco delle Terme-Vicopisano, 17-18 novembre 2000, a cura di R. Francovich, S. Gelichi, Firenze 2003, pp. 57-68. Per un approfondimento dei monasteri medievali del territorio pisano cfr. G. GarzeLLa, Tra città e territorio: monasteri pisani medie-
158 ANTONIO ALBERTI
rinascita di monasteri toscani fu dato dalla politica del marchese Ugo di Toscana, che, tra gli altri, rifondò San Salvatore di Sesto17.
Nella promozione di queste fondazioni furono presenti reali e forti motivazioni di carattere religioso. Ai monasteri era però anche affidato il compito di promuovere l’affermazione sociale e politica della casata fondatrice. Per Ugo i cenobi assumevano la funzione di centri organiz-zativi dei beni fiscali, per le altre casate laiche si trattava di monasteri privati, nucleo di coordinazione di un ambito territoriale, in grado di favorire il radicamento signorile dei fondatori, soprattutto per coloro che tendevano a rendere dinastici i loro poteri di origine pubblica, come ad esempio i casati comitali. Sotto questo aspetto, quindi, la fondazione di monasteri è un fenomeno parallelo all’incastellamento.
I monasteri sorti tra X e XII secolo sul Monte Pisano sono di seguito elencati.
n. Monastero Prima atte-
stazione
Fondatore Sito attuale
8
S. Salvatore di
Sesto 796
Rifondazione da parte
del marchese Ugo di
Toscana nel 996
Villa Ravano-Gabin
(LU)
18 S. Michele alla
Verruca
996 Aldobrandeschi ? La Badia, Vicopisano
(PI)
3 S. Salvatore di
Cantignano
1064 Longobardi di Vaccoli La Badia
(LU)
30 S. Paolo di Pu-
gnano
1086 Da Ripafratta S. Paolo, Pugnano
(PI)
10 S. Stefano di
Cintoia
1099 Upezzinghi Villa la Badia, Buti
(PI)
1 S. Cerbone 1140 Convento di S. Cer-
bone (LU)
15 S. Andrea in
Silva
1194 S. Andrea in Lupeta,
Vicopisano (PI)
A questi centri monastici si aggiunsero a partire dal XIII secolo alcuni eremi trasformati poi in cenobi: S. Salvatore di Cavina (Il Romi-torio, Vicopisano), S. Maria di Mirteto (attestato come monastero dal 1227) e S. Pantaleone (1232). A questi si può aggiungere il complesso di S. Iacopo in Lupeta, presso Vicopisano (fig. 1, n. 16). L’antico S. Mami-liano, che cambiò la sua intitolazione in S. Iacopo solo nel XV secolo, fu
vali. Materiali per la ricerca, in Monasteri e castelli fra X e XII secolo, cit., pp. 69-78.17 W. kurze, Monasteri e nobiltà nella Tuscia altomedievale, in Monasteri e
nobiltà nel senese e nella Toscana Medievale. Studi diplomatici, archeologici, gene-alogici, giuridici e sociali, a cura di W. Kurze, Siena 1989.
159MONASTERI E CASTELLI SUL MONTE PISANO
una prioria attestata a partire dalla seconda metà del XII secolo. È stato ipotizzato che la chiesa sia da identificare con quella menzionata, con annesso monastero, in una carta datata al 75718.
Il monastero più importante, per ruolo e distribuzione delle pro-prietà è San Salvatore di Sesto, sul versante orientale del Monte Pisano, documentato dal 796 (fig. 1, n. 10)19. Nel contesto del Monte Pisano la presenza di un ente ecclesiastico come S. Salvatore di Sesto ha senza dubbio condizionato l’assetto politico e territoriale almeno dell’ampia porzione orientale.
Sesto acquisì lo status di monastero imperiale a partire dalla fine del X secolo. In questa fase le sorti di Sesto si legarono alla politica del marchese Ugo di Toscana che in quegli stessi anni fu promotore della fondazione di altre importanti abbazie in Toscana che, dotate di posse-dimenti allodiali e beni fiscali, acquisivano funzione di organo ammini-strativo e di centro di controllo dei dispersi beni fiscali che rientravano nell’amministrazione del marchese20. È per intercessione di Ugo che il cenobio ha ricevuto il diploma imperiale di Ottone III nel 996, attraverso il quale è possibile delineare il quadro degli ampi possessi dell’abbazia. La protezione imperiale fruttò a Sesto altri tre diplomi di conferma e di privilegio concessi da Enrico II (25 aprile 1020), Corrado II (6 aprile 1027), Enrico III (4 luglio 1053). Con il diploma del 1027 i monaci ebbe-ro il privilegio di eleggere il proprio abate e il diritto all’autodifesa, men-tre già con la bolla di Sergio IV del 2 dicembre 1010 il monastero aveva ottenuto l’immediata sottomissione alla Santa Sede e l’indipendenza assoluta dalla gerarchia locale21.
L’autonomia sempre più forte che si era andata creando con i prov-vedimenti assunti dette all’abbazia una posizione di egemonia almeno nel territorio circostante, con un controllo capillare della viabilità via terra e sul lago di Sesto, sul quale si affacciava, attraverso l’acquisizione di beni, la fondazione di castelli e la costruzione di una efficace rete di strutture difensive. Questa situazione di egemonia legata all’autonomia acquisita perdurò almeno fino a tutto l’XI secolo.
A partire dalla fine del X secolo la politica del monastero era in-centrata sull’acquisizione di diritti su beni, proprietà, corti, castelli e dipendenze di chiese ed altri enti ecclesiastici mirante al controllo del
18 a. deL Chiaro-s. renzoni-F. troMBi, Vicopisano. Il patrimonio culturale, Pisa 2000, pp. 106-113.
19 L’altro monastero altomedievale del territorio è San Savino, nella piana di Pisa. Per questo si veda: M.L. CeCCareLLi LeMut, Il Valdiserchio, Porto Pisano e la Val di Tora, in La pianura di Pisa e i rilievi contermini. La natura e la storia, a cura di R. Mazzanti, Roma 1994, p. 335.
20 kurze, Monasteri e nobiltà, cit., nota 17, p. 308. 21 Per la documentazione riguardante Sesto: a.M. onori, L’abbazia di San
Salvatore di Sesto e il lago di Bientina, Firenze 1984. Per i diplomi imperiali con-cessi a Sesto in riferimento a San Michele alla Verruca si veda anche GiuLiani, Il monastero di San Michele alla Verruca, cit.
160 ANTONIO ALBERTI
territorio compreso tra l’Arno e Luc-ca incluso il lago di Sesto e la sponda delle Cerbaie, attraverso l’acquisi-zione del castello di Orentano22. Fu proprio la posizione strategica delle sue proprietà, lungo la linea di con-fine tra i territori sottoposti a Pisa e Lucca, e le sempre più aspre lotte tra le due città che ebbero gravi conse-guenze sulla sua autonomia.
A partire dal 1088 i Lucchesi avevano intrapreso una forte politica espansionistica nei confronti di Pisa, che in quegli stessi anni avrebbe per-messo la sottomissione di numerosi castelli: Vaccoli (1088), Castagno-ri e Vecchiano (1100), Ripafratta (1104)23. In questo contesto di con-tinua guerra i beni di Sesto furono in parte usurpati e in parte distrutti. Pasquale II tra il 1115 e il 1118 affidò il monastero alla tutela del priore di Camaldoli, mentre Innocenzo II nel 1134 ne decretò la sottomissione al monastero di S. Benedetto Po24.
La fine dell’egemonia politica di Sesto sul territorio corrispose, non a caso, ad una serie di iniziative che portarono alla formazione di nuovi protagonisti sulla scena politica ed economica del Monte Pisano e dei maggiori centri contermini, anche se Sesto mantenne un sicuro ruolo preminente; basti pensare ai diritti di sfruttamento della pesca nel lago e la risorsa delle cave di pietra docu-mentate ancora nel XIII secolo: è del 1256 una nomina procuratoria con la quale un certo Vincenzo, converso di Altopascio, veniva incaricato di riscuotere la parte dei proventi dovuti al signore sestese dai cavatori che lavoravano nelle cave dell’abbazia. Il luogo di dislocazione delle cave è in località detta S. Marco de Submonte. In documenti della fine XIII – primi XIV secolo le cave erano tutte situate nell’area di Buti; ciascuna cava era contraddistinta da un toponimo: Malagonella, Tedalgari, Bocha Nova, Valle Petrosa, Mogognone25.
Il monastero era ubicato nel luogo dove oggi si trova la Villa Ravano-Gabin, subito fuori del piccolo agglomerato di case di «Badia», sull’antica sponda del Lago di Sesto, a testimonianza della presenza in quel luogo
22 onori, L’abbazia di San Salvatore di Sesto, cit., nota 21, p. 74.23 Ibidem, p. 18.24 Ibidem, p. 19.25 Ibidem.
Fig. 9. Villa Ravano-Gabin. Prospetto della torre campanaria del monastero di S. Salvatore di Sesto.
161MONASTERI E CASTELLI SUL MONTE PISANO
dell’antica abbazia, con una minima migrazione del nome verso ovest. Le strutture ancora visibili sono piuttosto limitate, e anche in questo caso perlopiù sostituite con la costruzione di una villa padronale. Esse si ridu-cono al prospetto settentrionale della torre campanaria, conservata fino all’altezza attuale della villa, e al prospetto nord della probabile sagrestia, in adiacenza alla torre. La torre (fig. 9) ha una base di circa 8 m; il pro-spetto presenta due semipilastri angolari e una lesena pensile poggiante su mensola a ricassi, la quale intercettava almeno una doppia archeggiatura entro la quale dovevano aprirsi le bifore della cella campanaria26 (fig. 9).
Nel 1097 è documentato per la prima volta un abate a S. Michele al-la Verruca27 (fig. 1, n. 18), decretando con questo la fine della dipenden-za da Sesto, iniziata con il diploma di Ottone III del 996, e il successivo sviluppo del suo ruolo politico ed economico rivolto essenzialmente al territorio pisano e alla stessa città di Pisa28. L’affermazione dell’abbazia benedettina della Verruca a partire dal XII secolo è evidente nel ruolo economico che essa va ad occupare grazie allo sfruttamento delle cave di verrucano, documentato a partire almeno dagli anni venti dello stesso secolo29. Il sito di S. Michele è l’unico dell’intera area ad essere stato oggetto di una lunga campagna di scavi archeologici che hanno permes-so di riportare in luce quasi l’intero complesso monasteriale. Lo scavo ha dato la possibilità di scandire le differenti fasi di interventi edilizi, a partire dal primo insediamento di X secolo fino alle ristrutturazioni camaldolesi della seconda metà del XIII secolo30.
Nel 1099 venne fondato da un esponente della famiglia Upezzinghi il monastero di S. Stefano di Cintoia (fig. 1, n. 12), nel luogo dove con il diploma di Enrico II del 1020 Sesto aveva confermato la dipendenza della chiesa di S. Martino di Cintoia e la proprietà di tre corti nella stessa località. Nello stesso anno è indicato per la prima volta un castello di Bu-ti, anch’essa località precedentemente ricordata per alcuni beni e corti di competenza di Sesto31. Del monastero di Cintoia non rimangono tracce
26 Per un approfondimento sui dati materiali a disposizione per Sesto cfr. aLBerti I monasteri, cit., nota 10, pp. 43-45.
27 GiuLiani, Il monastero, cit., nota 11, p. 16.28 GarzeLLa, Tra città e territorio, cit., nota 16, p. 71.29 Per gli interessi dei monaci di S. Michele alla Verruca nelle cave del Monte
Pisano in rapporto anche con il cantiere del monastero si veda F. andreazzoLi, Omnes Officine sicut abbatia habere debet, in L’aratro e il calamo. Benedettini e Cistercensi sul Monte Pisano, a cura di S. Gelichi-A. Alberti, S. Giuliano Terme 2005, pp. 137-171.
30 Lo scavo è stato condotto dal 1996 al 2003 da Sauro Gelichi (Università Cà Foscari di Venezia) con la direzione di cantiere di Antonio Alberti. L’indagine ha visto la collaborazione dei Comuni di Vicopisano, di Calci e della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana. I risultati dello studio sono in S. GeLiChi-a. aLBerti, L’aratro e il calamo. Benedettini e Cistercensi sul Monte Pisano, S. Giu-liano Terme 2005.
31 Tra i beni confermati all’abbazia dall’imperatore Enrico II nel 1020 figurano la chiesa di S. Martino di Cintoia, la corte di S. Giorgio in località Buti e le cor-
162 ANTONIO ALBERTI
di architetture su-perstiti. Il sito dell’antico mona-stero è stato occu-pato da una gran-diosa villa palla-diana che, molto probabilmente, ha causato la definiti-va scomparsa dell’e-dificio medievale.
Nei dintorni di Vicopisano sorse un monastero fem-minile dedicato a S. Andrea (fig. 1, n. 15). Il primo docu-
mento che attesta l’esistenza della chiesa risale al 1147, mentre il mona-stero è ricordato a partire dal 119432. Il sito, pur rioccupato in parte da edifici di tipo colonico, è ben conservato, con la chiesa abbaziale integra nelle architetture esterne e una buona porzione della struttura del mo-nastero, in appoggio all’abside della chiesa.
Nello scorcio dell’XI secolo si andava consolidando il controllo del territorio da parte del monastero femminile di S. Paolo di Pugnano, sul versante occidentale del Monte Pisano (fig. 1, n. 30). Il cenobio, fondato nel 1086 dai Da Ripafratta33, già detentori dei diritti signorili del castello omonimo, andava a rafforzare la signoria della nobile famiglia su una area strategica di confine tra i contadi di Pisa e Lucca e di controllo della viabilità principale attraverso la Val di Serchio. La politica di ac-crescimento delle proprietà terriere nei dintorni del monastero, operata dalle badesse nel XII secolo, sembrerebbe finalizzata a questo scopo. Le strutture residue del monastero si sono oggi ridotte alla chiesa ab-baziale, a navata unica e abside semicircolare che risulta smontata. In facciata sono ben evidenti due fasi di costruzione: quella originale della fine dell’XI secolo, che consiste nella metà inferiore della facciata, e la successiva di pieno XII, con la ricostruzione della metà superiore. L’area dell’antico monastero anche in questo caso è stata occupata da una villa signorile, con annessi agricoli; il cortile tra la chiesa e la villa dovrebbe corrispondere all’originale chiostro34.
tem Veclam et cortem de Cortesi et cortem Gathari il località Cintoia: L. Carratori sCoLaro, Vicopisano, Bientina, Buti e Calcinaia, in La pianura di Pisa e i rilievi contermini. La natura e la storia, a cura di R. Mazzanti, Roma 1994, p. 266.
32 Ibidem, p. 263.33 CeCCareLLi LeMut, Il Valdiserchio, cit., nota 19, p. 239.34 Per un’analisi delle murature residue si veda aLBerti, I monasteri, cit., nota
10, pp. 47-50. Per le informazioni storiche: CeCCareLLi LeMut, Il Valdiserchio, cit.,
Fig. 10. S. Salvatore di Cantignano. Chiesa abbaziale. Pro-spetto absidale.
163MONASTERI E CASTELLI SUL MONTE PISANO
Sul versante lucchese il monastero di S. Cerbone (fig. 1, n. 1) è ancora funzionante, ma molto rimaneggiato e di cui rimane a vista solo la facciata della chiesa. Un altro centro monastico è quello di S. Salvatore di Canti-gnano (fig. 1, n. 3), trasformato in epoca moderna, con la continuità d’uso della chiesa abbaziale e la costruzione di un palazzo signorile (Palazzo del-le Cento Finestre) nel luogo dell’antico monastero. Il monastero è attestato nel 1064, sui resti di un edificio più antico ricordato in un documento del 91435, in relazione ai cosiddetti «Longobardi di Vaccoli». Del complesso abbaziale rimane la chiesa, pianta a croce latina, con pesanti interventi in facciata e la conservazione di quasi tutto il prospetto settentrionale e di quello absidale. Nel prospetto absidale si individua la porzione dell’edificio di X secolo, costituita da una muratura in pietra, con bozzette e ciottoli di fiume, a filari incerti, con abbondanza di malta, in alcuni tratti posti a spina-pesce. Il resto della muratura è coevo con la data di attestazione del monastero alla seconda metà dell’XI secolo, con il ricorso a filari regolari e paralleli di conci di medie e piccole dimensioni36 (fig. 10).
nota 19, p. 237.35 e. Coturri, Pistoia, Lucca e la Valdinievole nel Medioevo. Raccolta di saggi,
Pistoia 1998, pp. 167-168.36 Per le murature di S. Salvatore di Cantignano si veda J.a. quiros CastiLLo,
Modi di costruire a Lucca nell’altomedioevo. Una lettura attraverso l’archeologia dell’architettura, Firenze 2002, pp. 67 e aLBerti, I monasteri, cit., nota 10, pp. 40-43.