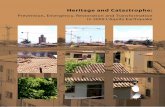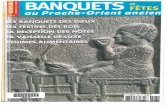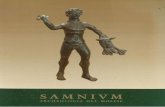Materiali da Castel di Sangro (AQ). Ceramiche medievali e postmedievali fra Abruzzo e Molise / Finds...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
7 -
download
0
Transcript of Materiali da Castel di Sangro (AQ). Ceramiche medievali e postmedievali fra Abruzzo e Molise / Finds...
109
CAP 2.1
Ezio Matt iocco, Diego Troiano, Van Verrocchio
Materiali da Castel di Sangro (AQ).Ceramiche medievali e postme-
dievali fra Abruzzo e Molise
1. Introduzione
Nel 1456 Castel di Sangro veniva disfatto dalcatastrofico terremoto del 4 dicembre, cheapportò danni gravissimi a molte regioni delregno di Napoli: “Guasto ha ancora patito assaiCastel di Sangro ove è caduto il castello vecchiosuperiore e le case che v’erano e molti altri edi-fici sul castello inferiore...” si legge nella notarelazione che il Marchese di Vigliena inviava alre di Spagna per informarlo del disastrosoevento, mentre a dire di un altro anonimo cro-nista del tempo il paese sarebbe stato addirit-tura “tuto ruinato e disfatto ecetto 7 case”1.Da quel disastro Castel di Sangro seppe comun-que trarre nuove motivazioni e incentivi, tantoche già all’inizio del secolo successivo, non soloaveva ricostruito le fortificazioni e l’abitatodella rocca, ma aveva potenziato l’area urbanasottostante e ampliato la cerchia delle mura,mentre l’economia, sostenuta dalle tradizionaliattività agro-pastorali e boschive tipichedell’Abruzzo interno e forse in misura maggioreda un vivace movimento commerciale e da fio-renti botteghe artigianali, riprendeva nuovavigoria. Ai mercati settimanali e alle antiche
“nundine” - frequentatissima in ogni tempoquella novembrina di Ognissanti concessa daCarlo II d’Angiò nel 1302 - si affiancò la fieradella Maddalena, che per otto giorni prese acelebrarsi nella ricorrenza della festività dellaSanta nello spiazzo erboso antistante alla chiesaconventuale dei Minori Osservanti, sorta inquegli anni alla periferia del paese. Le fiere diCastel di Sangro riscossero ben presto largofavore dentro e fuori d’Abruzzo, fin quasi adallinearsi con quella più affermata e conosciutadi Lanciano, configurandosi così come unodegli appuntamenti più importanti del panora-ma fieristico regionale, tanto che riuscì a supe-rare con danni relativi le crisi profonde seguitealle pestilenze del XVII secolo e a tante altre tra-versie, per scomparire solo in tempi recenti2.Ad affiancare questa particolare vocazionemercantile, non potevano mancare le attivitàartigianali, i cui prodotti venivano convogliatinon solo sulla piazza locale, ma trovavanosbocco anche sui mercati regionali ed extrare-gionali; dei lavori in ferro, rinomati fin daltardo Medioevo, ad esempio, non mancanotestimonianze tra gli scrittori del passato enelle fonti d’archivio, che ne documentano lo
1 Sull’argomento, vd. FIGLIOLO 1989.2 Sulle fiere castellane, vd. BALZANO 1942; MATTIOCCO 2005, pp. 25-28.
110
smercio anche in luoghi lontani come, adesempio, Teramo e Montecassino (BALZANO1942, p. 228). In questo luogo strategicamente posiziona-to in coincidenza di uno dei più importanticrocevia della “via degli Abruzzi”, caratte-rizzato da una dinamica mercantile noncomune, in tempi più vicini molto accre-ditate furono anche le fabbriche di con-fetti, di carte da gioco e di tappeti, la con-cia delle pelli - ancora oggi esiste una“via delle Concerie” - l’intensa attivitàdegli scarpari, quindi l’industria moli-toria e le gualchiere dislocate sulSangro e sulla Zittola, come pure lalavorazione di ceramiche e laterizi. Fin dal 1942, Vincenzo Balzano, neltracciare un quadro delle passate attivi-tà artigianali di Castel di Sangro, sullascorta di notizie tratte dalla risposta dianonimo autore ad un “questionario”del 1806 conservata nel suo archivio,scriveva tra l’altro che nella cittadina“vi fiorivano a quel tempo le arti plasti-che colle fabbriche di laterizi - tegoli,mattoni, ecc. alla Pinciara, (Fig. 1) e di
piatti dipinti e non dipinti alla Faenzara:la prima a nord e l’altra a sud dell’abitato”
(BALZANO 1942, p. 229). Di questa Faenzara o,Faenzera come all’epoca venivano chiamati iluoghi ove sorgevano le botteghe dei ceramisti,
conserva memoria anche la toponomastica cit-tadina; difatti insieme alla località Pinciara,esiste una ancora oggi una via Faenzera, cheporta alla periferia dell’abitato ove ancora afine Ottocento esisteva una piccola fabbrica diterraglie e ceramica da fuoco che, stando all’a-nonimo informatore del Balzano, che relazio-nava quando la bottega era ancora in pienaattività, era accreditata anche di una produzio-ne di qualità (Fig. 2).Il recente recupero di gran quantità di fram-menti di varia epoca e provenienza effettuatoin vari siti dentro e fuori l’abitato, ha richia-mato l’attenzione sulla vecchia Faenzera castel-lana e ha indotto ad approfondire la ricerca e lostudio dei materiali, confluiti a più riprese nelMuseo Civico Aufidenate.Un primo gruppo di frammenti furono fu dame raccolto durante le ricognizioni e i rileva-menti planimetrici effettuati nell’area delCastello superiore negli anni novanta del tra-scorso secolo. Successivamente, la scoperta diuna discarica - che gli studiosi del settore indi-cano col termine di “butto” - al davanti diquella che fu Porta Caprara, sito da taluni cono-sciuto come il mondezzaio (Fig. 3), mi consentìdi recuperare una quantità maggiore di mate-riali, comprendente anche cocci di romana edaltri reperti, tra cui una piccola statuina fittileraffigurante una figura femminile stante, lacu-nosa della parte inferiore (Fig. 4).
Ezio Mattiocco, Diego Troiano, Van Verrocchio
Fig. 1. Castel di Sangro(AQ). Esempio di mattone diproduzione locale del XIXsecolo recante il marchio B 8P entro cartiglio ovale.
Fig. 2. Castel di Sangro. Stralcio della planimetria catastale incui si evidenzia il toponimo “via Fainzieri” e l’ubicazione del-l’antica “Faenzera”.
Fig. 3. Stralcio della planimetria catastale con l’esatta ubica-zione della discarica d’uso domestico a fianco della Portadelle Capre o Porta Caprara.
Fig. 4. Statuina fittile d’etàromana raffigurante unafigura femminile stante rin-venuta nella discarica diPorta Caprara.
111
Altro importante recupero è poi avvenutodurante i lavori di disboscamento della conife-ra che copriva quasi tutta l’area della rocca, inparticolare tra le imponenti masse di terrenorimosso dalle ruspe3.Altri materiali - che però non vengono presi inconsiderazione nel corso dello studio condottoda Diego Troiano e Van Verrocchio in questasede e sul quale relazioneranno i responsabilidello scavo - è stato poi acquisito durante gliinterventi operati a ridosso delle mura e in altrisettori interni alla cinta. Piccoli nuclei e fram-menti sporadici provengono infine da vari sitidell’abitato e dai dintorni.Cronologicamente l’insieme dei materialiacquisiti copre l’ampio arco di tempo che dalXII scende fino al XIX secolo, mentre le tecni-che di lavorazione, i colori e lo stile dei decoriconsente nella maggior parte dei casi di accer-tare la provenienza dei manufatti dalle botte-ghe di Anversa degli Abruzzi, di Castelli e dialtri centri della regione e dell’area meridiona-le. Più ardua, invece, l’individuazione di pro-dotti locali, in quanto manca la possibilità diconfronti con manufatti di sicura provenienza.
Difatti, mentre il ricordo della vecchia“Faenzera” tramandatosi nel tempo è ancoraben vivo tra la gente del posto, nessuno è ormaipiù capace di riconoscere tra le poche suppel-lettili domestiche scampate alla distruzionequasi totale del paese operata dai Tedeschidurante l’ultimo conflitto mondiale eventualevasellame della fabbrica locale. D’altro canto,la vorticosa attività edilizia dell’immediatodopoguerra ha letteralmente sconvolta la zonadella Faenzera che, se opportunamente esplo-rata, avrebbe potuto restituire utili campiona-ture di scarti di lavorazione e materiali fram-mentati.Al momento, dunque, appare quanto mai arduodefinire non solo le caratteristiche della pro-duzione locale, ma anche precisarne le originie lo sviluppo. I catasti e le carte d’archivioscampate alle distruzioni non aiutano a far lucesul problema; solo la pianta “di un nuovoborgo da costruirsi in Castel di Sangro”, allega-ta al progetto redatto sullo scorcio delSettecento dall’arch. Giuseppe Vitale (Fig. 5),documenta il sito preciso dell’ubicazione dellaFaenzera4.
3 I provvidenziali recuperi sono dovuti essenzialmente alle pazienti ricerche di Raffaele Buzzelli. Benemerita anche la col-laborazione dei soci della locale sezione dell’Archeoclub d’Italia.
4 Pubblicata sulla copertina del catalogo AA. VV., La città e le piazze. Catalogo della mostra dei progetti per il concorso diidee per le Piazze Plebiscito e Sette Novembre, Tip. Alfa per conto del Comune di Castel di Sangro, 1988; originale inArchivio di Stato dell’Aquila.
Materiali da Castel di Sangro (AQ). Ceramiche medievali e postmedievali fra Abruzzo e Molise CAP 2.1
Fig. 5. Pianta di “un nuovoborgo da costruirsi in Casteldi Sangro” allegata al pro-getto redatto dall’Arch. G.Vitale in cui si evidenzia lacollocazione della“Faenzera” (tratta dallacopertina di AA. VV., Lacittà e le piazze. Catalogodella mostra dei progetti peril concorso di idee per lePiazze Plebiscito e SetteNovembre, Tip. Alfa, perconto del Comune di Casteldi Sangro, 1988; originale inArchivio di Statodell’Aquila, per gentile con-cessione).
112
A giudicare dalla diversa colorazione - grigio afronte del rosa utilizzato per gli edifici di nuovacostruzione - a quel tempo la fabbrica dovevaessere già in funzione, ma da che epoca allaluce delle attuali conoscenze non è possibilestabilire. Neppure aiuta la notizia un po’ sibil-lina rinvenuta in una Storia de’ Pelignimano-scritta di Vincenzo Giuliani, medico umanistanato e morto a Vieste sul Gargano (1733-1799),ma vissuto a lungo in Abruzzo. Anche qui loscrittore traccia un breve quadro delle attivitàartigianali di Castel di Sangro, partendo dalferro battuto, per finire alle carte da gioco e aiconfetti, passando attraverso l’arte della lana ela concia delle pelli. Parlando della ricchezzadelle acque, l’autore prospetta anche la possi-bilità dell’istituzione di una cartiera e a propo-sito dell’arte ceramica fa questa sempliceosservazione: “Un’argilla ottima a far stovigliesi ritrova quasi da presso alla Città nella sini-stra riva del fiume. Col comodo della legna edel carbone, che appresta la selva del convicinomonte non porterebbe molto dispendio ilmantenimento per tali lavori d’una fornace”.Sembrerebbe dunque che al tempo non esi-stesse ancora una struttura specifica per lalavorazione e la cottura delle terraglie, il cheperò sembra contrastare con le indicazionidella pianta annessa al citato progetto.Dovremmo pensare quindi che i Castellaniraccogliessero i suggerimenti del Giuliani,introducendo in paese questa nuova attivitàproprio in quegli anni, il che mi sembra pocoprobabile, anche in considerazione del fattoche l’opera del medico non fu mai data allestampe. Ipotizzabile, comunque, l’eventualitàche al momento in cui scriveva Giuliani unabottega di ceramisti, impiantata in precedenzain paese, avesse temporaneamente sospesal’attività, poi ripresa in quel torno di tempo.Una tradizione già viva in paese, spiegherebbemeglio perché il medico scrittore, tra i tantimestieri possibili, avesse pensato proprio allalavorazione dell’argilla.
E. M.
2. Contesti di rinvenimento: laCivita e l’“immondezzaio” fuoriPorta Caprara
La ceramica presentata in questa sede5 provienedai due contesti sopra citati della Civita e PortaCaprara che pur collocabili in zone ben distintedell’abitato presentano una pressoché totaleanalogia sia cronologica che delle singole classirinvenutevi. Per tali ragioni, non trattandosi dimateriali da scavi archeologici ma di recuperi disuperficie, si è ritenuta opportuna la loro pre-sentazione in maniera unitaria al fine di fornireun primo quadro complessivo il più possibilerappresentativo relativamente a circolazione eproduzione ceramica della città di Castel diSangro fra l’altomedioevo e l’età contemporanea.Con maggior precisione si segnala come i repertirinvenuti fuori Porta Caprara siano da riferirsi adun butto d’uso domestico del soprastante abitatoove confluirono rifiuti di varia natura quali, oltrealla ceramica, ossa animali, vetri e quant’altroattinente alla discarica di rifiuti cittadini, tantoche la zona viene tuttora identificata come“immondezzaro”, luogo lungamente in uso dalMedioevo al XIX secolo, anche se va segnalatauna maggiore concentrazione di reperti colloca-bile fra XV e prima metà del XVI secolo. Da ambedue i contesti provengono inoltrediversi frammenti ceramici di cronologia pre-romana e romana. Dalla Civita si segnala lapresenza di scarsi frammenti di ceramica adimpasto d’età protostorica fra i quali un fondodi olla con piede e due pareti di olle o piccolidolia. Ad età romana tardorepubblicana eprima età imperiale sono ascrivibili alcuniframmenti di ceramica a vernice nera, perti-nenti a forme aperte, un fondo di patera insigillata italica e vari frammenti di ceramicacomune, fra i quali uno di ansa orizzontale adimpasto depurato attribuibile ad un olla digrandi dimensioni, una bugnetta di olla conimpasto ricco di inclusi di varia natura ed unfondo di balsamario in ceramica depurata.Sono altresì presenti diversi frammenti diceramica d’uso comune, sia depurata che ad
5 Si coglie l’occasione per ringraziare la Dott.ssa R. Tuteri della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo cheha autorizzato lo studio e la pubblicazione di tali materiali nonché di Dott. E. Mattiocco che ci ha gentilmente segnalatoi contesti di materiali oggetto di tale studio.
Ezio Mattiocco, Diego Troiano, Van Verrocchio
113
impasto grezzo da fuoco, fra i quali un orlo diolla con attacco dell’ansa complanare. Alperiodo tardoantico si possono ricondurreinfine un orlo di scodella in sigillata africana Ded una parete di brocchetta ad impasto beigedepurato e decorazione dipinta “a bande”rosse. La presenza di analoghi materiali dalcontesto di fuori Porta Caprara (ceramica avernice nera, sigillata italica, ceramica d’usocomune) testimonia delle fasi di occupazionepreromana e romana anche della parte bassadella città, l’antica Aufidena.
D. T., V. V.
3. I materiali
3.1. Ceramica altomedievale
3.1.1. AcromaAlla fase altomedievale (secc. IX-XII) sonoriconducibili diversi frammenti attribuibili perlo più a forme chiuse. Si tratta di olle da fuoco obrocche in ceramica priva di rivestimento, per lopiù caratterizzate da argilla cotta in atmosferariducente, che evidenzia l’anima grigia in sezio-ne, con particolare morfologia costituita da orloleggermente ingrossato ed estroflesso ed ansa anastro complanare. Sono inoltre presenti un orlotrilobato di boccale ed un orlo di testo da pane dalprofilo ingrossato e leggermente appuntito all’e-sterno. Infine tre frammenti di fondi di ollettapresentano all’esterno la caratteristica finitura apettine del tipo cosiddetto “a stuoia”.
3.1.2. Vetrina sparsa (Tav. I, n. 1) Le prime produzioni ceramiche invetriate sievidenziano attraverso il rinvenimento di unorlo con attacco dell’ansa a nastro complanare,del tipo a “vetrina sparsa” di colore verdastrosemitrasparente, nonché un orlo di brocca conbeccuccio (n. 1) e vetrina trasparente, cheappare di colore giallastro, caratteristiche que-ste che permettono di collocare il reperto nel-l’ultima fase della produzione della “vetrinasparsa” (sec. XII)6.
D. T.
3.2. Ceramica medievale
3.2.1. Ceramica smaltata (Tavv. I-IV, nn. 2-50; Figg. 6-7, 10)Il Medioevo è rappresentato da diversi fram-menti attribuibili alle prime produzioni smal-tate. All’interno di tale gruppo si distingue unaproduzione più antica, dalla peculiare bicromiaramina-manganese, con frammenti dallecaratteristiche morfologico-decorative moltodifferenziate tanto da lasciar ipotizzare l’attri-buzione ad una pluralità di centri ancora daindividuare. Si segnalano catini ad orlo appiat-tito superiormente (n. 2), ciotole ad orloappiattito (n. 3), fondi con piede a disco epareti di forme aperte (nn. 4-5), fondo di sco-della con piede ad anello e decoro a cerchi con-centrici in bruno e fascia verde (n. 6). Ununico frammento costituito da una ciotola emi-sferica presenta oltre al verde e al bruno stesocon tonalità molto scura anche una fascia ingiallo (n. 7).Nella tradizione delle prime tipologie smaltatesi colloca un insieme di frammenti omogenei,sia dipinti, sia monocromi, riconducibili dallecaratteristiche di seguito illustrate ad un grup-po inquadrabile all’interno della maiolicaarcaica ma, come vedremo, di cronologia piut-tosto tarda (secc. XIV-XV). Tale tipologia risul-ta in parte già nota e attestata geograficamentefra il basso Lazio (Priverno), il Molise interno(Venafro) ed ora anche nell’Abruzzo meridio-nale interno. Le caratteristiche tecniche che accomunanotali frammenti sono date dallo smalto di ottimaqualità particolarmente brillante che si pre-senta di colore beige, anche se in alcuni casiappare più puro tendente al bianco e più vicinoagli smalti della maiolica rinascimentale che aquelli della maiolica arcaica, dato al risparmioe lasciando il fondo di forme chiuse e l’esternodelle forme aperte nudo. L’impasto è abba-stanza depurato, beige in alcuni casi rosato conpiccoli vacuoli ed inclusi. Le decorazioni inbicromia bruno e verde con particolare tonalitàintensa del bruno e il verde dato diluito contonalità verde acqua, mentre solo in un caso è
6 Per una sintesi sulle produzioni ceramiche altomedievale in Abruzzo, con rimandi alla bibliografia precedente, si vedaSTAFFA 2002, pp. 116-123.
Materiali da Castel di Sangro (AQ). Ceramiche medievali e postmedievali fra Abruzzo e Molise CAP 2.1
114
presente il giallo. Gli ornati si presentano par-ticolarmente originali rispetto al panoramanoto della maiolica arcaica e mostrano nellamaggior parte dei casi sequenze di archettigeneralmente in verde racchiuse da linee con-centriche in bruno, nastri in verde contornatida linee in bruno con sequenze di puntini,
nastri in bruno contornati da sequenze di pen-nellate oblique, o trattini obliqui, fiori centraliquadripetali, “tacche” verdi sull’orlo di ciotole.Per una maggiore comprensione si presentanodi seguito i materiali rinvenuti divisi in gruppiavendo riscontrato all’interno della stessa pro-duzione alcune caratteristiche distinguibili.1.Gruppo di catini con orlo ingrossato ed appun-tito a sezione triangolare (nn. 8-11) chepresen-tano nella parete interna una decorazione a dop-pia fascia di archetti in verde e bruno piuttostodiluito, o solo in verde, racchiusi in fasce di lineeconcentriche in bruno con esterno nudo. Unframmento il cui orlo si presenta simile ai prece-denti ma meno evidenziato e dotato di una legge-ra carenatura (n. 11) si caratterizza per alcunidifetti di cottura quali ad esempio lo smaltoopaco e la decorazione ad archetti quasi incolore,appena visibile. È interessante segnalare chedagli stessi contesti provengono due frammentidi catini in ceramica priva di rivestimento (nn.12-13), che per caratteristiche morfologicherisultano del tutto affini al suddetto gruppo. Allostato attuale, pur non potendosi azzardare ipotesiattributive che riconducano i detti orli ad even-tuali scarti di prima cottura, di certo si può evi-denziare la loro comune provenienza da Castel diSangro e dunque l’assimilazione a tale gruppo. Questa tipologia trova particolari riscontri conanaloghi esemplari rinvenuti a Priverno (DE
MINICIS 1994 p. 186, Fig. 1, nn. 3, 5-8, 10; Tav.XV, nn. 3-6) e Nettuno (BOSI, ROMOLI 1995, p.244, Fig. 2, nn 12-16) datati genericamente alXIV secolo seppur in assenza di una stratigrafiasigillata. Più preciso il confronto con un fram-mento da Napoli datato alla seconda metà delXIV secolo7.2.Gruppo di catini o scodelle con leggera care-natura all’esterno, orlo ingrossato ed appuntitosimile al gruppo precedente ma di dimensioniridotte e fondo apodo. Esterno nudo (nn. 14-21). Oltre alla sequenza di archetti in verde elinee concentriche in bruno, del tutto simile aquello presente nel gruppo precedente, si evi-denzia in un frammento una sequenza di lineedritte ed ondulate disposte obliquamente nel
7 Si segnala un frammento di ciotolone con leggera carenatura esterna con profilo simile all’analogo frammento del nostrogruppo 1 e con impianto decorativo sostanzialmente simile datato alla seconda metà del XIV secolo: VENTRONE VASSALLO1987, pp. 192, 195, p. 194, Fig. 41, C309, Fig. 54, C309.
Ezio Mattiocco, Diego Troiano, Van Verrocchio
Fig. 6. Ceramica smaltatadipinta medievale.
115
cavetto, in cui si utilizza, solo in questo caso,anche il colore giallo (n. 14). I fondi apodi pre-sentano ornati geometrici (n. 20) con nastri inverde contornati da linee in bruno e consequenze di puntini associati a identici nastricontornati da sequenze di pennellate oblique(n. 15), motivi questi ultimi che riscontriamoanche negli ornati delle forme chiuse. Anche inquesto caso stringenti confronti si rinvengonocon materiali da Priverno (DEMINICIS 1994, p.186, Fig. 1, n. 11).3.Gruppo di ciotoloni caratterizzati dall’orloappiattito superiormente e lieve carenaturaesterna. Esterno nudo. Anche in questo casol’ornato è costituito essenzialmente dallasequenza di archetti in verde racchiusa da fascedi linee concentriche in bruno (nn. 22-23)tranne in un unico caso in cui una spessa fasciaverde, sempre racchiusa da linee concentriciin bruno, sostituisce gli archetti (n. 24). 4.Gruppo di scodelle a tesa piana con identicasequenza di archetti in verde racchiusa da lineeconcentriche in bruno disposti sulla tesa (n.25). Esterno nudo. Anche in questo caso strin-genti confronti si ritrovano con materiale daPriverno (DEMINICIS 1994, p. 186, Fig. 1, n.12). A questo gruppo si associano alcuni fram-menti di scodelle con identica morfologia chemostrano identici archetti nel cavetto (n. 26) epresentano la tesa decorata con campiturealternate eseguite da tratti verticali in bruno etratti obliqui in verde (nn. 27-28). In que-st’ultimo caso puntuali confronti si possonosegnalare con un identico esemplare prove-niente dal Castello di Rovere (AQ)8. Infine unframmento della stessa morfologia presenta latesa decorata con tratti in verde e bruno alter-nati a formare un graticcio (n. 29). 5. Forma aperta (catino o scodellone) recantenel cavetto sequenza di archetti che si interse-cano in verde e bruno e fasce di linee concen-
triche in bruno (n. 30). Esterno nudo.6.Gruppo con ciotole a corpo emisferico e piedead anello con decorazione a fiore quadripartitocostituito da una croce centrale con una serie dibarrette all’estremità in bruno e petali in verde(nn. 31-34). Esterno nudo. Confronti puntuali
8 Gli scavi condotti a più riprese nel corso degli anni ’90 dalla Cattedra di Archeologia Medievale dell’Università “G.d’Annunzio” di Chieti hanno portato alla luce una gran quantità di materiali ceramici medievali e postmedievali per iquali si attende da tempo una pubblicazione a carattere esaustivo. Fra la maiolica arcaica (in corso di studio da partedella Dott.ssa E. Di Venanzio) proveniente dai saggi condotti all’interno del borgo fortificato, si segnala la presenza diuna scodella quasi integra recante sull’orlo l’ornato suddetto ed al centro un motivo a graticcio con puntini riempitivi.Tale manufatto è palesemente riferibile, per caratteristiche tecniche e decorative, alla produzione descritta in questasede, documentandone la diffusione a Nord sino all’area dell’Altopiano delle Rocche.
9 DE MINICIS 1994, p. 186, schede 3 e 4; p. 183, Tav. XV, n. 2. All’interno dell’articolo si citano anche confronti con mate-riali non stratigrafici da Palestrina e Veroli.
Materiali da Castel di Sangro (AQ). Ceramiche medievali e postmedievali fra Abruzzo e Molise CAP 2.1
Fig. 7. Ceramica smaltatadipinta medievale.
116
si rinvengono con analoghi ornati da Priverno9,ma anche da Roma10, Tivoli11 ed in regione daScurcola Marsicana12 e Barisciano13 (Fig. 8).Una variante della tipologia è attestata da un
frammento con lo stesso ornato ma presen-te sul fondo di uno scodellone o catino
apodo (n. 35). Questi esemplari da Castel di
Sangro pur presentando mor-fologie ed ornati molto similiai confronti sopra citati, equindi pur collocandosi
all’interno di una produzioneche di certo risente dei medesimi apporti cul-turali - presenti come detto nell’area compresafra il basso Lazio, l’antica Terra di Lavoro, ilMolise interno e l’Abruzzo meridionale - per
altri particolari quali lo smalto luci-do e parte degli ornati, se nediscostano tanto da nonpoterli riferire alla medesimaproduzione.
7.Gruppo con ciotole carenate acorpo emisferico e piede a discocaratterizzate da “tacche” verdispesso eseguite con larghe pennel-late che dall’orlo si estendono allaparte esterna della parete fino all’al-
tezza della carena (nn. 36-39). Unavariante della stessa ciotola, presenta
sull’orlo una sequenza di “tacche” inverde e tratti obliqui dipinti in bruno (n.
40). A questo gruppo se ne associa un altro chepresenta di nuovo “tacche” con sequenze ditratti alternati solamente in bruno (n. 41).8.Gruppo di boccali con alto collo cilindrico(n. 42-45) smaltati solo all’esterno, a rispar-mio verso il fondo e invetriati internamente.La decorazione presenta motivi fitomorfi e
geometrici costituiti da nastri in verde rinfor-zati da linee in bruno con sequenze di puntiniall’esterno associati a identici nastri contornatida sequenze di pennellate oblique e trattini.Tale tipologia di ornato come visto è già atte-stata anche sul fondo di ciotoloni (n. 15) non-ché con materiali inediti provenienti dalla giàcitata Barisciano in un contesto inquadrabilefra la seconda metà del ‘400 e la prima metàdel ‘500 (Fig. 9).9.Gruppo di forme chiuse (boccali ?) invetria-ti internamente che presentano oltre ai nastrisopra descritti con puntinature e sequenze ditrattini e pennellate oblique anche un motivo a“catenella” disposta verticalmente in verdecontornata da fasce di linee in bruno (nn. 46-48). Tale decoro sembra comunque rappre-senti un ornato secondario rispetto ai suddettimotivi a nastro che dovevano di certo ricoprirela parte centrale del manufatto. 10.Altri decori secondari su forme chiuse sonoattestati con le consuete linee ondulate sia inverde che in bruno contornate da linee inbruno (n. 49) e motivi fitomorfi (n. 50).Infine anche su taluni frammenti di anse anastro è attestata in prossimità dell’orlo unasequenza di trattini in bruno. Confronti con questi motivi a nastro (nn. 15,42-45) soprattutto quelli con pennellate obli-que e trattini, si rinvengono unicamente inregione, ad esempio fra i materiali da Trasacco(DI VENANZIO 2002, p. 182, Tav. I; Tav. XXXI,Figg. 1, 2), anzi questi ultimi, congiuntamenteal sopra citato esempio di Rovere (Altopianodelle Rocche), attestando la produzione anchenella Marsica, contribuiscono a circoscriverel’area di diffusione di questa particolare tipolo-gia. Lo stato attuale delle conoscenze non per-mette purtroppo l’individuazione esatta del
10 CINI 1985, p. 288, n. 291; p. 291, Fig. 40. Il frammento in questione, inquadrato per caratteristiche d’impasto e con-fronti con reperti da Genova, fra le produzioni smaltate spagnole del XIV-XV secolo, pur destando qualche perplessitànell’attribuzione, potrebbe a nostro avviso inserirsi nell’ambito di una riproposizione di prototipi provenienti da areeculturali diverse.
11 LEOTTA 2002, p. 191, Figg. 13 e 14, n. 10, datato al XIV secolo per confronto con analoghi esemplari da Palestrina,Priverno e Veroli.
12 DI VENANZIO, PANTALEO 2001, pp. 468, 480. Cfr. p. 471, Fig. 1, n. 1, datato al XIV secolo per confronto con analoghi fram-menti da Palestrina e Priverno.
13 Il frammento in oggetto proviene da un recupero occasionale effettuato nei pressi del castello di Barisciano (AQ) inassociazione a materiali ceramici la cui cronologia non oltrepassa la prima metà del XVI secolo. Si ringrazia laSoprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo nella persona della Dott.ssa R. Proterra per la cortese segnalazio-ne e l’autorizzazione concessa allo studio di detti materiali.
Ezio Mattiocco, Diego Troiano, Van Verrocchio
Fig. 8. Barisciano (AQ).Frammento di forma aperta(ciotola o scodella) conmotivo decorativo adarchetti e trattini.
Fig. 9. Barisciano (AQ).Frammento di boccale condecorazione in monocromiamanganese caratterizzatadalla sequenza di puntini acontorno delle linee princi-pali del disegno.
117
centro di produzione della tipologia sopradescritta. Tuttavia la consistenza dei rinveni-menti castellani, in cui è attestata una ricca suc-cessione di tipologie decorative e morfologichein gran parte inedite, permette di proporre inquesta sede la definizione di tale gruppo quale“tipo Castel di Sangro”, anche in base alla pre-senza dai suddetti contesti di alcuni frammentidi catini privi di rivestimento ma con morfolo-gia del tutto identica a quelli smaltati e dipinti,ritenendo altresì probabile collocare il centrodi produzione non molto lontano dai luoghi deidetti rinvenimenti - fra Castel di Sangro,Trasacco e Rovere, ossia nell’Abruzzo interno.Al gruppo dipinto si associa, per identici smaltidi ottima qualità, impasti beige tendenti alrosato e morfologie, una produzione monocro-ma bianca, anch’essa abbondantemente pre-sente dai contesti di Castel di Sangro (Fig. 10).Ad eccezione di rare forme chiuse, riferibilicon ogni probabilità a orli di boccali, sono
significativamente presenti ciotole emisferi-che (nn. 51-52) e carenate (nn. 53-56), ciotolead orlo ingrossato (n. 57) o leggermente care-nate ed ansate (n. 58), scodelle apode a tesabreve con orlo rilevato (n. 59) e scodelloni dianaloga morfologia (n. 60).
D. T., V. V.
3.2.2. Maiolica arcaica blu (Tav. IV, nn. 61-65; Fig. 10, n. 61)Da Castel di Sangro si segnalano alcuni fram-menti di maiolica arcaica blu collocabile fra gliultimi decenni del XIV ed i primi del XV secolo.Sono presenti due produzioni: la prima sicaratterizza per l’impasto beige, depurato consmalto leggermente opaco e ornati geometricieseguiti in blu con tonalità chiara e brunomanganese su forme chiuse (nn. 61-62). Laseconda, forse di diversa area geografica diproduzione oppure di cronologia più tarda,presenta su forme chiuse un impasto rosato
Materiali da Castel di Sangro (AQ). Ceramiche medievali e postmedievali fra Abruzzo e Molise CAP 2.1
Fig. 10. Maiolica monocro-ma bianca (nn. 51-60);maiolica arcaica blu (n.61).
118
poco depurato con piccoli inclusi scuri, smaltoparticolarmente brillante e ornati in blu ebruno caratterizzati dalla tonalità intensa escura del blu (n. 63-64). Altri particolari tec-nici differenziano le due produzioni. Ad esem-pio i frammenti del primo gruppo presentanolo smalto anche nella superficie interna men-tre per quelli del secondo in un caso è presenteuna vetrina trasparente e di ottima qualitàmentre per l’altro l’interno è nudo.Conclude il quadro dei reperti riferibili allafase bassomedievale e nello specifico alla fasedi transizione fra la maiolica arcaica e quellarinascimentale, periodo cronologicamenteinquadrabile nella prima metà del XV secolo,un rarissimo frammento di mattonella da pavi-mentazione (n. 65), dello spessore di circa cm3, con parte del bordo esterno, caratterizzatoda decorazione di contorno in bruno con moti-vo a sequenza di S e motivo centrale purtropponon identificabile in cui compare l’uso combi-nato del bruno e del blu reso con linee sottili atracciare un motivo vegetale stilizzato a spiga,probabilmente disposto nell’angolo della mat-tonella. Lo smalto è di ottima qualità partico-larmente bianco e brillante mentre l’impasto èpoco depurato con numerosi inclusi e vacuoli.È interessante sottolineare in questa sedecome i rinvenimenti castellani costituisconoun’interessante testimonianza della presenzadi tale classe in regione, classe che da quantoemerso dalle ricerche archeologiche condottenegli ultimi decenni appare scarsamente atte-stata quando non del tutto assente in contestiquattrocenteschi abruzzesi forse a causa dellasua scarsa fortuna produttiva e commerciale inregione. Per quanto detto acquista una ecce-zionale rilevanza il rinvenimento della matto-nella da pavimentazione che ad oggi costituiscel’unico esempio noto in regione di impiantitiquattrocenteschi in maiolica arcaica blu.
D. T.
3.3. Ceramica postmedievale
Entrando in merito allo specifico di questaricerca, inerente le produzioni ceramichepostmedievali rinvenute nella città di Castel diSangro, segnaliamo la presenza di una pluralitàdi classi ceramiche che coprono tutto l’arco del‘500, anche se va evidenziata una preponde-ranza di materiali che si datano nella primametà dello stesso secolo e che forniscono unospaccato significativo della cultura materialecastellana in tale periodo, utile ad una primadefinizione di quadri tipologici di riferimentoper quest’area meridionale dell’Abruzzo alconfine con Molise e Campania.
3.3.1. AcromaLa ceramica priva di rivestimento, caratteriz-zata da impasto beige-giallino depurato, è pre-sente con due frammenti di orli: il primo, rife-ribile probabilmente ad un vaso da fiori, èdotato di orlo a tesa con profilo ondulato; ilsecondo, riferibile ad un orcio con ansa, ècaratterizzato da orlo fortemente introflesso.
3.3.2. Invetriata verde (Tav. V, nn. 67-68;Fig. 11)La ceramica caratterizzata dall’uso di vetrinaverde affonda le sue radici nel pieno medioevo,trovando tuttavia sviluppi successivi sino al“tardo” postmedioevo (XIX-XX secolo). Nelcaso di Castel di Sangro si tratta di un gruppocon caratteristiche non del tutto omogenee main ogni modo riconducibili ad uno stesso ambi-to tipologico che trova precisi rimandi nelleanaloghe produzioni individuate in contestipostmedievali, ed in particolare cinquecente-schi, sia ad Isernia che a Venafro e che nontrova invece diffusione in area abruzzese senon nelle più tarde tipologie ottocentesche14.Possiamo distinguere due diverse produzioniin base all’analisi macroscopica degli impasti.La prima, meno attestata, presenta un’argillarossastra, a frattura irregolare e porosa, con
14 Allo stato attuale non si dispone di materiale edito che possa illustrare in maniera significativa l’invetriata verde otto-centesca in Abruzzo, spesso destinata a contenitori quali vasi da fiori o d’uso domestico variegato, ed arricchiti da appli-que figurate, decori a stampino o a stecca. Per una prima segnalazione vd. TROIANO, VERROCCHIO 2002, pp. 381-382. Fra icentri che sicuramente produssero brocche ed altri recipienti ansati fra XIX e XX secolo va menzionata Lanciano, con letipiche brocche ad orlo quadrilobato dotate di filtro all’imboccatura.
Ezio Mattiocco, Diego Troiano, Van Verrocchio
119
inclusi bianchi, probabilmente destinata ad unuso da fuoco, con vetrina di colore verde scuro.Appartengono a tale produzione una fusaiola(n. 66) ed un fondo di olla. Più abbondante laseconda, caratterizzata da un’argilla ben depu-rata, di colore variabile fra il beige-rosato ed ilgrigio chiaro, a seconda del grado di cottura,dura e compatta a frattura netta. Il colore dellavetrina varia nelle diverse sfumature del verdepiù o meno intenso. Il panorama morfologico (Fig. 11) è più artico-lato in quanto si documenta la presenza di cio-tole emisferiche (n. 69), piccoli coperchi (n.70) e soprattutto frammenti di forme chiuse,in cui la vetrina ricopre sia l’esterno che l’in-terno del manufatto, come testimoniano paretied anse con sezione “a fagiolo”. In particolarespiccano due frammenti pertinenti a brocche eborracce caratterizzati da una decorazione“solcata” a crudo sulla parete (nn. 67-68)15.Tali reperti trovano precisi riscontri in analo-ghi manufatti d’invetriata verde “solcata” astecca provenienti dal contesto di Santa Maria
delle Monache di Isernia e soprattutto dalCastello Pandone di Venafro (Figg. 12-13).In sintesi possiamo ritenere tali materiali qualiimportazioni d’area molisana e nel contemporimarcare il fatto che la diffusione dell’inve-triata verde postmedievale sembra costituireun fenomeno che ancora una volta tende a sot-tolineare il carattere molto articolato dellarealtà abruzzese a livello subregionale. Difattitale classe non trova al momento attestazioninell’area costiera così come in aree interne,quali ad esempio la conca sulmonese, che purerisulta il naturale sbocco della viabilità daCastel di Sangro in direzione Nord attraversol’altopiano delle Cinque Miglia, la cosiddetta“via degli Abruzzi”.
3.3.3. Invetriata (Tav. VI, nn. 71-74; Figg.14-17)Nel gruppo delle invetriate monocrome con-fluisce una serie di frammenti pertinenti aproduzioni piuttosto differenti fra loro sia percaratteristiche tecnico-morfologiche, sia per
15 Tale tecnica decorativa, a differenza della graffita, andava ad incidere direttamente l’argilla ancora cruda che, una voltaessiccata, veniva sottoposta al processo di invetriatura, mentre la graffita, come noto, proponeva repertori decorativiincisi sullo strato di ingobbio bianco disteso sul corpo ceramico.
Materiali da Castel di Sangro (AQ). Ceramiche medievali e postmedievali fra Abruzzo e Molise CAP 2.1
Fig. 11. Invetriata monocro-ma verde.
Fig. 12. Venafro (IS),Castello Pandone.Esemplare di borraccia aquattro passanti invetriatamonocroma verde con deco-razione solcata a stecca.
Fig. 13. Venafro (IS),Castello Pandone.Brocchetta invetriata mono-croma verde decorata a stec-ca sulla spalla con lineeondulate e parallele.
Fig. 11 Fig. 12 Fig. 13
67
66
68
69
70
120
destinazione d’uso. Nel complesso prevalesenz’altro l’invetriata da fuoco nell’ambitodella quale è interessante segnalare la totalepredominanza delle forme chiuse (olle edollette) rispetto a quelle aperte. Si distinguonoi seguenti gruppi:1. Produzione da fuoco (Fig. 14) documentataattraverso frammenti di olle (nn. 71-74) che sicaratterizzano per la vetrina di colore beigegiallino, poco lucido e poco aderente distesaall’interno del manufatto e sulle anse del tipo anastro leggermente rialzate rispetto al pianodell’orlo (nn. 73-74). Diversi frammenti (nn.71-72), fra i quali un orlo del tipo leggermenteingrossato ed arrotondato, presentano unadecorazione incisa a pettine con cinque o seisolchi molto sottili e ravvicinati, con una sin-tassi che alterna la fascia orizzontale a quellaondulata. Tale decorazione rimanda esplicita-mente ad esemplari più antichi, ma non vadimenticato l’attardamento, anche notevole,già documentato per questa decorazione inaltri contesti abruzzesi, in particolare sullaceramica acroma ed ingobbiata monocroma
postmedievale16. Il gruppo nel suo insiemerisulta ben collocabile per caratteristichemateriali, morfologiche e decorative nell’am-bito del XV secolo costituendo quindi la fase dipassaggio alle produzioni cinquecentesche17.2. Produzione da fuoco nella quale si eviden-ziano olle dalla morfologia molto simile algruppo precedente, ossia caratterizzate dabreve orlo leggermente estroflesso, arrotonda-to, con ansa a nastro rilevata (Fig. 15, nn. 75-76). La vetrina ricopre solo l’interno delmanufatto e può essere di colore bruno o ver-dastro (n. 76). Rispetto alla produzione prece-dente va segnalata una migliore qualità chedenota una piena dimestichezza e serializzazio-ne all’interno del processo produttivo di que-sto tipo di pentolame per il quale, così comeper il gruppo precedente, resta da individuareil centro di provenienza. 3. Di certo riferibili ad ambito produttivomolisano i numerosi esemplari di olle che pre-sentano una forte standardizzazione morfolo-gica con la sola variante nella tipologia deirivestimenti (Fig. 15, nn. 77-82). Difatti, seb-bene siano presenti esemplari caratterizzati dauna vetrina trasparente o leggermente gialla-stra che appare di colore marrone sul corpoceramico (n. 77), la gran parte della produzio-ne si caratterizza per l’utilizzo di vetrina dicolore verde più o meno intenso distesa “a rin-forzo”, su un sottostante bagno di vetrinasemitrasparente interna, sull’orlo e parte del-l’ansa. La prima vetrina che riveste l’internodelle olle risulta molto sottile ed assorbita, intaluni casi appena visibile. Questa caratteristi-ca tecnica si associa alla forte omogeneità mor-fologica dato che l’unica tipologia attestatapresenta orlo dal profilo concavo ed anse rial-zate, anche in maniera notevole (nn. 80-81).Gli impasti sono di colore variabile fra il rossa-stro e camoscio, a volte con nucleo grigio, duri
16 TROIANO, VERROCCHIO 2002, p. 96, Fig. 86, n. 3.4; p. 102, Fig. 90: ingobbiate monocrome da Castel Frentano. Dallo stessocontesto, così come da altri contesti cinquecenteschi del pescarese attualmente inediti, provengono frammenti di cerami-ca acroma depurata caratterizzata dalla presenza di decorazione a pettine con fasce di linee parallele, ondulate e a tratti.
17 La forma è ben documentata ad esempio nei contesti quattrocenteschi della SS. Annunziata di Sulmona dove si segnalaun confronto puntuale con un’olla proveniente dall’US 201 databile alla prima metà del XV secolo (per. IV A collocabilein tale arco cronologico per l’associazione con un frammento di ceramica smaltata spagnola con decoro del tipo a pal-mas abiertas) e trova altresì confronto con materiali provenienti dall’Abruzzo interno come nel caso di Rocca Calascio(TOGNOCCHI 2000, Tav. X, nn. 114-115, frammenti assimilati per confronto morfologico alle produzioni d’area romanadi XV-XVI secolo).
Ezio Mattiocco, Diego Troiano, Van Verrocchio
Fig. 14. Ceramica invetriatamonocroma. Produzione dafuoco del XV secolo caratte-rizzata dall’uso di decora-zione a pettine a linee sottilisulla spalla delle formechiuse.
121
a frattura netta e depurati. La colorazione dellasuperficie, che può essere anche grigia, deter-mina la variabilità nella colorazione comples-siva del manufatto, prevalentemente verdescuro. L’ampia presenza di olle di tale tipologiapresso i contesti di Santa Maria delle Monachead Isernia e soprattutto presso il CastelloPandone di Venafro lascia con tutta probabilitàritenere una provenienza dall’area molisanaiserniese18.4. Questo quarto gruppo risulta quantitativa-mente meno numeroso ed all’interno di esso siidentificano rare forme aperte non da fuoco
riconducibili alla produzione di Anversa degliAbruzzi (Fig. 16). In primo luogo si segnala lascodella con orlo a listello caratterizzata davetrina trasparente, sottile ed a tratti distaccatadistesa su impasto di colore rossastro (n. 83)19.Forse riferibile ad uno scodellone o piatto care-nato, con orlo sagomato, un frammento carat-terizzato da vetrina di migliore qualità, lucida ecoprente, su impasto rossastro (n. 84)20. Ununico frammento di olla con orlo dritto ed indi-stinto è riferibile alla produzione da fuoco cin-quecentesca, contraddistinto da vetrina semi-trasparente e di scarsa qualità (n. 85)21.
18 Olle di questa tipologia sono del tutto assenti nel contesto della fornace di Campobasso fra i materiali cinquecenteschirinvenuti (materiali in corso di studio da parte di chi scrive), così come, allo stato attuale delle conoscenze, sono deltutto ignote sul territorio abruzzese.
19 La forma trova riscontri con materiali inediti da Anversa in corso di studio da parte di chi scrive e sembra rappresenta-re l’evoluzione di alcune tipologie di scodelle o ciotole attestate anche presso gli scavi sulmonesi della SS. Annunziata aSulmona databili nella seconda metà del XV secolo.
20 Pur in assenza di confronti con materiali editi da Anversa le caratteristiche della vetrina rimandano in maniera signifi-cativa alla produzione Slip Ware 1 e di conseguenza indicherebbero un inquadramento nell’ambito della seconda metàdel ‘500-inizi ‘600.
21 Il tipo d’olla ad orlo verticale indistinto trova puntuali confronti nella produzione a vetrina bruno-nera anversanadocumentata a Sulmona e nella stessa Anversa nella seconda metà del ‘500-inizi ‘600 (TROIANO, VERROCCHIO 2002, p.373, Fig. 385, nn. 1-7) ed anche in altri ambiti subregionali nell’arco della prima metà del ‘500 (VERROCCHIO 2002, p. 68,Fig. 51, n. 3, da Miglianico).
Materiali da Castel di Sangro (AQ). Ceramiche medievali e postmedievali fra Abruzzo e Molise CAP 2.1
Fig. 15. Ceramica invetriatada fuoco. Produzione di pro-venienza incerta (nn. 75-76)e produzione d’area molisa-na (nn. 77-82).
122
5. Sebbene non esattamente rientrante nelgruppo delle invetriate in quanto il frammentoin questione risulta privo di rivestimentovetroso si segnala in questa sede, vista la pro-venienza anversana, un coperchio (Fig. 16, n.86) appartenente alla tipologia dell’invetriatasu “ingobbio” rosso la cui cronologia si collocanel corso del ‘60022. In realtà questa tipologiaveniva commercializzata in taluni casi anchepriva della vetrina, ossia con il solo “ingobbio”rosso di cui restano scarse tracce sul frammen-to in esame23. Alla stessa classe ceramica, seb-bene riferibile ad una produzione decisamentepiù tarda collocabile nell’800-primi decennidel ‘900, con un “ingobbio” di colore bruno
molto scuro ed una vetrina lucida ed aderente,è riferibile un orlo sagomato appartenente aduna tipologia di contenitori biansati molto dif-fusa ad Anversa nel suddetto periodo, destinatiad uso domestico vario ed ancora oggi presentinelle abitazioni anversane (Fig. 16, n. 87) (DEL
ROSSO 2000, p. 45, Fig. in alto a destra).6. Un discorso a parte meritano due frammentidi casseruole che risultano evidenti scarti diuna produzione locale di ceramica invetriata dafuoco (Fig. 17). Si tratta di un primo frammen-to stracotto e leggermente deformato (n. 88,scarto di seconda cottura) che appare di coloregrigio ferro, molto duro e metallico per ecces-siva cottura. La tipologia di questo primo scar-to, con orlo a breve tesa inclinata e manico “acannone” rientra in un ampio gruppo di manu-fatti analoghi diffusi in Abruzzo a partire dal‘700 e per tutto il secolo successivo, sia nellatipologia Slip Ware che nell’invetriata mono-croma24. Il secondo frammento è allo stato dibiscotto, ossia scarto di prima cottura privo divetrina (n. 89) con impasto rossastro poroso eleggermente polveroso al tatto. Questo secondo
22 Si tratta di una produzione invetriata anversana parallela alla produzione Slip Ware 6 (VERROCCHIO 2002, pp. 55-59, nota303; Fig. 39, materiali da Anversa; pp. 67-72, Fig. 56, Slip Ware 6 e Fig. 57 materiali privi di decoro ad ingobbio, inentrambi i casi provenienti dallo stesso contesto pienamente seicentesco di Sulmona). La tecnica dell’“ingobbio” rossocostituisce una peculiarità all’interno delle ceramiche di Anversa degli Abruzzi e fu utilizzata nel ‘600 anche per la piùelaborata e raffinata produzione decorata a rilievo su committenza di importanti famiglie nobili napoletane(VERROCCHIO 2005, servizio Caracciolo prodotto dalla bottega Ranalli). Le stesse manifatture tuttavia furono interessa-te anche alla produzione d’uso corrente, come testimoniano i materiali editi provenienti dal butto della fornace Ranalli(VERROCCHIO 2005, in part. pp. 248-249, Figg. 74-75 e Tav. a col. f. t. III).
23 La commercializzazione, seppur minima, di prodotti privi di vetrina con il solo ingobbio rosso o bruno è ad esempiodocumentata nella vicina Sulmona fra i materiali provenienti dal contesto seicentesco della circonvallazione Ovest,con tipologie di bacili già illustrate in VERROCCHIO 2002, p. 72, Fig. 57. Per un esame dettagliato del contesto sulmonesesi rimanda al contributo di V. Verrocchio in questo volume.
24 Si veda il contributo di V. Verrocchio sui materiali di produzione anversana rinvenuti a Sulmona in questo stesso volume.
Ezio Mattiocco, Diego Troiano, Van Verrocchio
Fig. 16. Ceramica invetriatada fuoco. Produzioni diAnversa degli Abruzzi.
Fig. 17. Frammenti di casse-ruole, scarti di produzionedi prima e seconda cottura,riferibili a manifatturalocale del XIX secolo.
123
scarto presenta differenze morfologiche signi-ficative rispetto al precedente: l’orlo è legger-mente rivolto all’esterno, con lievi solcature, ilcorpo è bombato ed il manico rialzato, secondouna tipologia che sembrerebbe più tardarispetto al precedente e che quasi preannunciala comparsa del pentolame in bicromia giallo-nero novecentesco25. Il rinvenimento di questi due scarti testimonial’esistenza di una produzione locale di cerami-ca d’uso domestico e nello specifico di pento-lame da fuoco nel corso dell’800, produzionegià nota attraverso le fonti scritte ed in partico-lare, alla fine dell’800, da una statistica chesegnala la presenza a Castel di Sangro di unafabbrica attiva con un forno ed una macina(Statistica 1890, p. 26).
3.3.4. Invetriata dipinta ad ingobbio (SlipWare) (Tav. V, nn. 90-91; Fig. 18)Diversi frammenti provenienti sia dal Castelloche dall’”immondezzaio” di Porta delle Capredocumentano la presenza di questa tipologiainvetriata da attribuirsi al centro di Anversadegli Abruzzi. È anzitutto attestata la produzione1, nelle varianti A e B26 con piccoli frammenti diforme chiuse recanti motivo decorativo florealea rosellina (n. 90) e pezzi di maggiori dimensio-ni riferibili a brocche con becco “a pellicano”(cfr. TROIANO, VERROCCHIO 2000, Tav. 2, n. 5;VERROCCHIO 2002, p. 56, Fig. 38, n. 2) ed ornatoprobabilmente di tipo fitomorfo (n. 91). Fra leforme aperte, sempre ascrivibili alla produzione1 A con l’uso del nero abbinato all’ingobbio èpresente un bacile con orlo a tesa piana, corpotroncoconico e fondo apodo (n. 92) e decorazio-ne costituita da tipica sequenza di larghe pen-nellate sulla tesa, cerchi concentrici in nero dimanganese all’esterno in associazione a deco-razione ad ingobbio sotto una vetrina brillanteed aderente. Un secondo bacile è documentato
attraverso un orlo la cui morfologia risultacaratteristica della produzione anversana dimaggior successo commerciale nella secondametà del ‘500-inizi ‘600 (n. 93). Il decoro èlimitato a semplici “tacche” sulla tesa (cfr.TROIANO, VERROCCHIO 2000, Tav. 2, n. 1, daSulmona; VERROCCHIO 2002, p. 56, Fig. 38, n.12, da Anversa). Sono altresì attestati alcuni frammenti riferibilia brocchette realizzate nella produzione 6 ad“ingobbio” rosso e rare testimonianze della pro-duzione Slip Ware settecentesca, oramai orienta-ta quasi esclusivamente verso manufatti dafuoco. Da Porta Caprara proviene difatti un orlodi olla lievemente estroflesso ed appiattitosuperiormente con impasto di colore grigiastro,poco depurato e vetrina dall’aspetto granulosoin cui la decorazione a pennellate d’ingobbiosottostante risulta appena comprensibile (n.94). La forma è ampiamente documentata nelpanorama delle produzioni Slip Ware regionali e
25 Il pentolame da fuoco in bicromia con interno giallo ed esterno nero (cosiddetto tipo “Alpi Marittime”), importato daaltre aree geografiche, fa la sua prima apparizione in Abruzzo dopo l’Unità d’Italia soprattutto con lo sviluppo della reteferroviaria che permise la commercializzazione di prodotti provenienti da regioni anche molto distanti quali la Liguria.Sulla presenza di produzioni invetriate del XIX - prima metà XX secolo in Abruzzo provenienti da centri di produzioneextraregionali si rimanda alla discussione riguardante i rinvenimenti sulmonesi in Verrocchio in questo vol.
26 Per la descrizione delle produzioni invetriate individuate ad Anversa si faccia riferimento ai contributi già editi inTROIANO, VERROCCHIO 2000, pp. 38-44, VERROCCHIO 2002, pp. 55-58, nota 303; VERROCCHIO 2003; VERROCCHIO 2004,VERROCCHIO 2005.
Materiali da Castel di Sangro (AQ). Ceramiche medievali e postmedievali fra Abruzzo e Molise CAP 2.1
Fig. 18. Invetriata dipintaad ingobbio (Slip Ware).Produzione di Anversa degliAbruzzi della seconda metàdel XVI - XVIII secolo.
124
corrisponde ad una variante locale dell’olla tipo1 documentata a Castel Frentano (CH) ed in altrinumerosi contesti dell’Abruzzo costiero(VERROCCHIO 2002, p. 73, Fig. 58).Per concludere possiamo sottolineare come tutti
i frammenti rinvenuti nei due contesti di Casteldi Sangro analizzati appartenenti a tale tipologiainvetriata risultino attribuibili alla produzione diAnversa degli Abruzzi. Il dato appare molto inte-ressante poiché conferma il monopolio anversa-no che si registra anche per altre classi cerami-che (ingobbiata dipinta, maiolica) e che denotal’esistenza di larghe fette di mercato non coperteda altri centri di produzione e dunque piena-mente abbordabili per le manifatture anversaneche, specie fra XVI e prima metà del XVII secolo,si mostrano molto attive e competitive tanto dasaturare taluni mercati subregionali ed esportarei propri prodotti anche fuori regione.
V. V.
3.3.5. Ingobbiata e graffita (Tavv. V-VII, nn95-119; Figg. 19-22)La ceramica graffita presente dai contesti diCastel di Sangro è nella quasi totalità ascrivibi-le alla cosiddetta produzione denominata “tipoIsernia”27 che recenti ricerche hanno permes-so di attribuire con certezza alla città diCampobasso28 con una cronologia estesa atutto il ‘500. Fanno eccezione pochi frammenti riconducibilia due produzioni del tutto inedite ed una terzavicina a quella di “tipo Isernia”. Nello specifico
27 Per la produzione “tipo Isernia”, oggi attribuibile alla città di Campobasso, si rimanda alle prime segnalazioni inTROIANO, VERROCCHIO 2001, pp. 229-235; TROIANO, VERROCCHIO 2002 b, pp. 52-62, Figg. 8-11; Tav. a col. IX-XI.
28 Le indagini in corso da parte di chi scrive sulla produzione ceramica di Campobasso fra medioevo ed età modernahanno permesso di individuare un consistente nucleo di frammenti ascrivibili a scarti di prima cottura della suddettaproduzione. Tali materiali, provenienti dal già noto butto di fornace di via Monticelli, oggetto di interventi di scavonegli anni ’80 (GENITO 1984), permettono oggi di attribuire con certezza la suddetta produzione al centro diCampobasso. Tuttavia, vista l’ampia diffusione della classe fra Molise, Abruzzo e Campania sino a Napoli, e consideran-do la città di Isernia come accertato centro di produzione di altre tipologie graffite già dalla fine del ‘400 (TROIANO,VERROCCHIO 2001; TROIANO, VERROCCHIO 2002 b) non si può escludere che ci si trovi di fronte ad una tipologia che ebbepiù centri di produzione con analoghe caratteristiche morfologico-decorative, tanto da lasciare aperta l’ipotesi dell’e-sistenza di altri centri di produzione comunque collocabili in area molisana e strettamente connessi al capoluogo. Sicoglie occasione per ringraziare la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Molise nella persona della dott.ssa V.Ceglia per aver autorizzato lo studio e la pubblicazione dei suddetti materiali.A proposito della graffita “tipo Isernia” (ora Campobasso) preme segnalare in tale sede come il panorama delle conoscen-ze al riguardo in Abruzzo risulti per taluni studiosi tuttora alquanto carente nonostante la bibliografia sopra citata. In talsenso è esemplare il caso di alcuni frammenti di tale tipologia graffita rinvenuti presso il Castello di Rovere (AQ) ed inqua-drati, nell’ambito dagli studi condotti presso il Dipartimento di Archeologia Medievale dell’Università “G. d’Annunzio” diChieti, e nello specifico da F. Sozio (GIUNTELLA, SOZIO 2005, p. 112, Figg. 10, 12-13) all’interno di un discorso evolutivo di ununico contesto di manufatti tanto che “anche questo gruppo di ceramiche evidenzierebbe una fabbricazione locale, marsi-cana, comunque circoscritta tra l’area dello scavo, l’Altopiano delle Rocche, appunto, e quella circostante il Fucino fino araggiungere i Campi Patentini e Tagliacozzo”, argomentazioni prive di alcun sostegno scientifico che possa avvalorare taleperegrina ipotesi. Appare davvero sconcertante constatare non tanto l’ignoranza degli studi sull’argomento, che avrebbe-ro certo immediatamente giovato all’attribuzione di tali graffite al gruppo di produzione molisana e di cronologia cinque-centesca, quanto il fatto che nello stesso convegno di studi ove i materiali di Rovere sono stati presentati, le Dott.sse V.Carsana e S. Pomante (CARSANA, POMANTE 2005, pp. 227-231) presentando materiali dagli scavi di Piazza Bovio a Napoli,ben illustravano quella stessa graffita abbondantemente presente nel contesto partenopeo e giustamente attribuita allasuddetta produzione molisana. Ogni ulteriore commento appare superfluo.
Ezio Mattiocco, Diego Troiano, Van Verrocchio
Fig. 19. Ceramica ingobbia-ta e graffita di produzionemolisana (Campobasso) delXVI secolo.
125
si tratta di una scodella a tesa decorata in bicro-mia verde e bruno con sequenza di foglie bipar-tite triangolari e piccolo fiore trilobato su altostelo (Fig. 19, n. 95), vetrina di ottima qualitàtrasparente e lucida, impasto depurato, rosato.Un altro frammento di scodella in bicromiaverde e giallo (n. 96) presenta un ornato in cuicoesistono elementi solo dipinti (sulla tesa:fascia in verde e tratti decrescenti in verde egiallo alternati) secondo modalità più tipichedella produzione ingobbiata dipinta, con ele-menti graffiti (cerchi concentrici nel cavetto),vetrina trasparente, opaca, con impasto rosatopoco depurato, nell’insieme tecnicamente diqualità minore rispetto agli altri pezzi illustratiin questa sede. Infine due frammenti di scodel-le evidenziano elementi riconducibili alla pro-duzione già nota della città di Isernia sia perl’uso di ornati molto simili sia per l’uso dellatricromia verde, bruno e giallo con quest’ultimoin tonalità accesa tendente all’arancio. Si trattadi pareti di scodelle che presentano nel cavettoin un caso una sequenza di rombi tagliati a
croce e nell’altro un motivo a nastro spezzato(nn. 97-98). Inquadrabile cronologicamentefra l’ultimo quarto del XV secolo ed gli inizi delXVI secolo, questa produzione di Isernia risultaesportata anche in Abruzzo come appare dairinvenimenti di Sulmona29. Alla produzione di Campobasso come dettosono assegnabili tutti gli altri frammenti rinve-nuti. Si tratta anzitutto di scodelle caratterizzateda tesa breve (2,5 cm ca) lievemente concava estacco molto pronunciato all’interno fra tesa ecavetto (Fig. 19, nn. 99-102). Tipiche scodelleo scodelloni (Fig. 19) con più ampia tesa lieve-mente convessa all’interno (largh. 4,5 cm ca) inalcuni casi con orlo dentellato (n. 103) e connetto stacco fra tesa e cavetto (nn. 103-110) efondi apodi (nn. 112-115). In entrambi i casi ladecorazione è dipinta nella tipica tricromiaverde, giallo e azzurro, anche se non mancanopiù rari frammenti in sola bicromia giallo-verde; il colore è sempre steso a fasce e spessoindipendentemente dall’ornato graffito. Alla stessa produzione appartengono alcuni
29 Per le importazione in Abruzzo a Sulmona: TROIANO, VERROCCHIO 2001, p. 227 e p. 228, Fig. 1.
Materiali da Castel di Sangro (AQ). Ceramiche medievali e postmedievali fra Abruzzo e Molise CAP 2.1
Fig. 20-21. Venafro (IS),Castello Pandone.Esemplari di piatti e sco-delle riferibili alla produ-zione graffita diCampobasso.
126
frammenti di più rare forme chiuse. Si tratta ditipiche brocche monoansate a corpo ovoide supiede a disco internamente prive di ingobbioma solo invetriate. Rinvenute ampiamente informa intera a Venafro (TROIANO, VERROCCHIO2002 b, Tav. a col. X b) si caratterizzano per ladecorazione resa a fusi sul corpo con sequenzadi pennellate in verde, bruno e giallo alternatee rinforzate da linee verticali graffite, collocarenato con linea ondulata graffita (nn. 116-118). Infine si segnala un piccola olletta (Fig.19, n. 119) che presenta sul corpo una decora-zione a linee verticali graffite e pennellatesempre verticali in verde e giallo. Per quanto riguarda gli ornati delle formeaperte essi si caratterizzano per le tipiche fascedi graffiti eseguiti a tratti paralleli mediante unapposito strumento a forchetta con due o trepunte. Si segnalano sul fondo motivi centrali acerchi concentrici e girandole (nn. 112, 115) esequenza di archetti (n. 114). Sul cavettosequenze di archetti (n. 112) o fascia a quartie-ri (nn. 113-114), sulla tesa semplici sequenzedi trattini variamente disposti e alternati fra diloro (nn. 99-101, 108), sequenze di archetti(n. 102) o sequenze di trattini variamente dis-posti a formare una ghirlanda con nastro (nn.103-107, 109-110). In quasi tutti i frammentisono presenti come ornato secondario fasce dilinee concentriche disposte a sottolineare l’or-lo o il distacco fra tesa e cavetto. Anche in que-sto caso sono numerosi i rimandi a manufattida Venafro (Figg. 20-21, Tav. f.t. V).
D. T., V. V.
3.3.6. Ingobbiata dipinta molisana (Tav. VII,n. 120; Figg. 22-24)Dai rinvenimenti di Castel di Sangro si ricono-scono due gruppi di ingobbiata e dipinta, unprimo molisano ed un secondo abruzzese(Anversa degli Abruzzi).
Il primo gruppo, costituito da soli pochi fram-menti, è riconducibile a produzioni molisaneanaloghe alla già descritta graffita di Campobassocon la quale condivide alcune caratteristichecome la cronologia, gli impasti e l’uso di stenderel’ornato con grosse pennellate a formare fasceorizzontali o linee ondulate. La tipologia è benricostruibile grazie ai rinvenimenti dal CastelloPandone di Venafro (Figg. 23-24).Caratteristica principale della produzione èquella di disporre la decorazione eseguita “arisparmio” ossia con solo pennellate di vetrinacolorata spesso in verde lasciando il resto delmanufatto con solo ingobbio bianco a vista.Sono attestate esclusivamente forme aperte(Fig. 23) costituite da ciotoloni carenati (nn.120-121).
3.3.7. Ingobbiata dipinta di Anversa degliAbruzzi (Tavv. VIII-XII, nn. 122-165)A parte i pochi frammenti di produzione moli-sana la quasi totalità della ceramica ingobbiatadipinta rinvenuta è costituita dalla produzionedi Anversa che, nel corso del XVI secolo,monopolizzò larghe fette di mercato abruzzese
Ezio Mattiocco, Diego Troiano, Van Verrocchio
Fig. 22. Ceramica ingobbia-ta dipinta di produzionemolisana.
Figg. 23-24. Venafro (IS),Castello Pandone.Esemplari di scodelle appar-tenenti alla produzionemolisana ingobbiata dipin-ta caratterizzata da decoro afasce concentriche a rispar-mio.
Figg.23-24
127
ma anche extraregionale, come confermanotali rinvenimenti ed altri quali quelli diVenafro, Isernia, Campobasso ovvero dell’areagravitante fra l’Abruzzo interno ed il Molise30. La tipologia anversana, oggetto di recenteattenzione da parte degli studiosi, appare conmorfologie e decorazioni piuttosto variegate edin gran parte mutuate dalla coeva produzionein maiolica. Fra gli esemplari di più antica cro-nologia si segnalano: un orlo di ciotola carena-ta con decoro a semplici “ tacche” in blu sul-l’orlo, probabile derivazione del più anticomotivo presente sulle maioliche arcaiche (n.122); frammenti di piatti con decoro a monti-celli disposti sia sulla tesa che nel cavetto o nelfondo, nei colori verde (nn. 123, 124, 126) oazzurro (n. 125) raramente in arancio-rosso eazzurro alternati (n. 127). Agli inizi del Cinquecento si può datare un raroframmento di fondo di piatto di grandi dimen-sioni recante al centro una figura di “belladonna” inserita in una cornice polilobata confondo azzurro. Si intravede parte del suo abbi-gliamento con le spalline in ocra, la camicia inblu ed una collana in bruno (n. 128).Non mancano boccali con medaglioni a scalettaarancio fra linee in blu (n. 129); motivi centralidi piatti con graticci di linee di diverso spessore(nn. 130-131), fasce di linee più o meno alte econcentriche (n. 132) e motivi centrali diforme aperte geometrici e floreali (nn. 133-136), tutti ornati che come detto rimandano ainoti repertori alla coeva produzione in maioli-ca.Al pieno XVI secolo si datano alcune formeaperte che presentano come decorazione trattidecrescenti. Nello specifico si documenta unaciotola emisferica su piede a disco e decorointerno con sequenza di tratti decrescenti inrosso ed azzurro alternati (n. 137). Più comuneappare l’uso di inserire tratti decrescenti, gene-ralmente in arancio-rosso e blu, all’interno digraticci (nn. 138-139) o reticoli a squame (nn.140-141). Tale motivo fu largamente prodotto
ed è attestato anche come riempitivo in ornatipiù complessi (nn. 142-143). Alla stessa fasecronologica si attribuiscono vari altri decori fra iquali sequenze di fiori stilizzati e barrette unci-nate oblique (n. 144), motivi geometrici campi-ti a graticcio (nn. 145-146), motivi a scacchiera(n. 147), motivi ad ovuli (nn. 148-149), foglieaccartocciate (n. 150) con abbondante uso delcolore bruno che, oltre a testimoniare la direttaascendenza dalla produzione in maiolica, neattesta l’attardamento cronologico nel reperto-rio della produzione anversana. Seguono motivigeometrici campiti da giraline (n. 151-152),sequenze di foglie bipartite (n. 153), fogliami(n. 154), motivi in monocromia blu (n. 155). Un gruppo di forme aperte (ciotole e piatti) sicaratterizza per l’imitazione del motivo “allaporcellana”, fra i quali un frammento inmonocromia blu, più vicino nell’uso del coloreagli originali (n. 156), mentre altri pezzi ripro-ducono il repertorio con varianti nel tralcio esoprattutto nell’introduzione dei colori ocra erosso (nn. 157-162). Rare sono le raffigurazioni umane (n. 163)forse identificabile con la figura di un porta-bandiera, disegnato in bruno, la cui cronologiasi orienta verso la seconda metà del XVI secolo(cfr. DI VENANZIO 2005, p. 150, Fig. 42).Pochi altri frammenti si caratterizzano per l’usopredominante del bruno di manganese stesocon tonalità molto scura tendente al nero (n.164-167) che rimandano anche per l’estremasemplicità del repertorio decorativo alla faseoramai finale della produzione anversanainquadrabile cronologicamente nel secondoquarto del ‘600. Si tratta nello specifico di unorlo di piccola “panata” con semplice decoro abarrette oblique in giallo sul collo racchiuseentro doppia filettatura in bruno (n. 164), dueframmenti di fondi di scodelle decorate con altefasce o filettature concentriche in bruno e gial-lo-ocra e linea ondulata in bruno (nn. 195-196) ed infine un piccolo beccuccio di ampollacon semplice doppia barretta in bruno (n. 167).
30 Sulla produzione ingobbiata e dipinta ad imitazione della maiolica di Anversa degli Abruzzi si rimanda a TROIANO,VERROCCHIO 2001, pp. 235-239; TROIANO, VERROCCHIO 2002, pp. 146-153. Per la diffusione della classe in Molise vd.TROIANO, VERROCCHIO 2001, p. 237 (Isernia); TROIANO, VERROCCHIO 2002 a, pp. 35-37; Fig. 4-9 (Venafro), cui si aggiungeun raro frammento inedito, in corso di pubblicazione, proveniente dal già citato butto di via Monticelli a Campobasso.
Materiali da Castel di Sangro (AQ). Ceramiche medievali e postmedievali fra Abruzzo e Molise CAP 2.1
128
3.3.8. Ingobbiata monocroma di Anversa (Fig.25)Alla produzione anversana ingobbiata dipinta siaffiancano, come spesso già segnalato in altricontesti regionali ed extraregionali, materialiappartenenti alla produzione monocroma bian-ca di Anversa del XVI - secondo quarto del XVIIsecolo. Il panorama morfologico non si discostanel repertorio dalla coeva produzione dipinta.Numerosi frammenti sono ascrivibili a formeaperte quali una ciotola emisferica caratterizza-ta dall’orlo appuntito e da leggere scanalaturesulla parete sotto l’orlo, ingobbiata e invetriatasia sulla superficie interna che esterna (n.168), piatti a tesa breve anch’essi ingobbiati edinvetriati su ambedue le superfici (n. 169-170),ed una ciotola con presa trilobata (n. 171). Frale forme chiuse si segnala un orlo di piccolabrocca ad alto collo (n. 172) ed un raro fondo dialzata (n. 173). Tutti i frammenti sopra descrittipresentano impasto e vetrina identici a quellidella produzione dipinta.
D. T.
3.3.9. Maiolica di Anversa (Fig. 26)La maiolica rinascimentale risulta significati-vamente attestata nei contesti in esame.All’interno di tale classe ceramica si sottolineala predominanza dei manufatti riferibili anco-ra una volta al centro di Anversa degli Abruzzinelle sue varie tipologie all’interno delle qualirisultano del tutto minoritarie le forme chiuserispetto a quelle aperte.1. Un primo gruppo è costituito da piatti a tesalarga con orlo appena rilevato ed arrotondato(nn. 174-176) caratterizzati dal classico moti-vo a monticelli alternati a cespugli filiformi inmonocromia blu.2. Sempre in monocromia blu un secondogruppo di frammenti è ascrivibile alla tipologiaispirata ai motivi cosiddetti “alla porcellana”(nn. 177-180) di cui si seguono, in manierapiù o meno fedele, i modelli in voga pressonumerosi centri di produzione di maiolica cin-quecentesca italiana. Si segnala in particolarela maggior presenza di scodelle con repertoridiversificati (intrecci con campiture, elementicruciformi, tralci fitomorfi, elementi geome-trici a rombi). Una parete di piatto o scodellapresenta invece una sequenza di larghe foglietriangolari oblique alternate a tratti filiformi,sempre in monocromia blu (n. 181).3. Un terzo gruppo comprende alcuni esempla-ri di ciotole carenate caratterizzate da decora-zione “a tacche” sull’orlo e fasce concentriche(n. 182), oppure con sole fasce concentriche(nn. 182-183) e con uso del blu associato alrosso, ocra, giallo e verde. In tale gruppo pos-siamo associare anche fondi di ciotole caratte-rizzati da decorazione geometrica a graticcio insolo blu, in blu e arancio o in arancio e verde(nn. 184-186).4. Seguono altri frammenti recanti repertoridecorativi in parte già abbondantemente notinella produzione anversana ed in taluni casi di
Ezio Mattiocco, Diego Troiano, Van Verrocchio
Fig. 25. Ceramica ingobbia-ta ed invetriata monocromabianca di produzione anver-sana.
Fig. 26. Maiolica di Anversadegli Abruzzi. Frammento divaso a pigna con smaltogiallo del XVI secolo (n. 193)e frammento di piatto riferi-bile alla produzione a rilievodella seconda metà del XVIsecolo raffigurante unmascherone (n. 194).
Fig. 25
Fig. 26
129
nuova individuazione. Si segnalano piatti a tesamedia con motivo a sequenza di archi campitida graticci in ocra e giallo (n. 187) e trattinisull’orlo e gli unici due frammenti di boccali:una parete con il noto motivo della scalettaarancio fra linee in blu (n. 188) ed un fondocaratterizzato dalla sequenza di tratti verticaliin blu, arancio e giallo (n. 189).Un fondo di grande piatto presenta carattere dieccezionalità per la sua decorazione: al centro èpresente un leone rampante che tiene in unazampa un fiore a sei petali, il tutto in blu edocra-arancio, mentre nella tesa si dispone unmotivo a quartieri con una sequenza di fogliefrastagliate nei colori blu, giallo ed ocra-arancio(n. 190). Si tratta di un motivo decorativo dichiara ispirazione umbra che, ancora una volta,porta a sottolineare i contatti che la produzioneanversana ebbe con quella derutese ed eugubinadella fine del ‘400 - primi decenni del ‘50031. 5. Alla più tarda produzione in maiolica anver-sana che oramai rientra pienamente nello stilecompendiario, si possono attribuire un fondodi ciotola o scodellina raffigurante nel centroun animale, probabilmente un cavallo, reso inocra scuro entro un sottile contorno in blu suun fondo in blu e giallo (n. 191) ed un orlo diciotola polilobata recante all’interno un’origi-nale fiore circolare composto da quattro petalied elementi filiformi in giallo, ocra, blu everde, alternato a campitura in blu (n. 192).6. Una particolare attenzione meritano dueframmenti (Fig. 26). Il primo da riferirsi ad unraro vaso “a pigna” con smalto giallo dato siaesternamente sia internamente (n. 193), giàattestato nell’ambito della produzione anver-sana (DE POMPEIS 2002, p. 30, Fig. 17) e che dinuovo rimanda esplicitamente a contatti con lecoeve produzioni umbre e nello specificoderutesi (FIOCCO, GHERARDI 1994, p. 235, Fig.130, in lustro dorato; BUSTI, COCCHI 1999, p.179, Fig. 66). Il giallo dello smalto, nel nostrocaso, potrebbe giustificarsi quale imitazione
dell’effetto a lustro dei prototipi umbri32. Il secondo frammento, particolarmente degnodi nota, rientra nella rara tipologia a rilievoottenuta a stampo già attribuita alle manifattureanversane e che di nuovo trae ispirazione dallacoeva e pregiata produzione umbra. Si tratta diun fondo di grande piatto recante la figura di unmascherone (n. 194) che coincide esattamentee quindi proveniente da medesima matrice, conun analogo esemplare già edito rinvenuto nellastessa Anversa (VERROCCHIO 2004, p. 77). Ilframmento in questione pone l’attenzione sullacircolazione di oggetti indubbiamente di pregioe di certo facenti parte di servizi destinati acommittenza di alto rango sociale attorno allametà del XVI secolo.
3.3.10. Importazioni (Tav. XIII, nn. 195-196)Fra i rari reperti in ceramica di sicura prove-nienza extraregionale spicca la presenza dellaciotola raffigurante San Francesco orante arilievo nei colori blu e lustro dorato piuttostoscuro, quasi vicino all’ocra. Lo smalto ricopreanche l’esterno della ciotola ed il fondo carat-terizzato da piccolo piede ad anello e leggeraumbonatura (n. 195). Si tratta di una tipologia di manufatti e di unrepertorio decorativo ben consolidato nell’am-bito umbro ed in maniera più specifica nei cen-tri di Deruta (BUSTI, COCCHI 1999, p. 223, Figg.130-131; p. 224, Figg. 132-133) e Gubbio ove leproduzioni in rilievo con l’uso del lustro metal-lico ebbero gran diffusione nel corso del XVIsecolo. Il rinvenimento castellano si pone almomento come un unicum in regione33 fornen-do altresì un importante testimonianza dellacommercializzazione di tali prodotti umbri dipregio, veicolati quasi di certo attraverso la “viadegli Abruzzi”, in regioni meridionali.Un frammento di tesa di forma aperta presentainvece un motivo decorativo cosiddetto “sertodi bacche” (n. 196) che fu ampiamente in usoin molteplici centri di produzione ceramica
31 Confronti significativi rimandano alla produzione molto diffusa a Deruta fra la fine del XV ed i primi decenni del XVIsecolo, per cui vd. ad esempio FIOCCO, GHERARDI 1994, p. 171, n. 38; p. 201, n. 83, piatto databile al 1539.
32 Si cogli occasione per segnalare in questa sede la presenza di un altro raro ed inedito frammento di vaso “a pigna” fra imateriali già citati provenienti dal contesto di via Monticelli di Campobasso anch’esso coperto da smalto giallo.
33 L’attestazione di un tondino recante lo stesso motivo di San Francesco orante in blu e lustro, anch’esso d’importazioneumbra ma non a rilievo, è già nota dalla città di Penne e nello specifico proveniente dal convento francescano di SantaMaria in Colle Romano (COSTANTINI 1989, p. 36).
Materiali da Castel di Sangro (AQ). Ceramiche medievali e postmedievali fra Abruzzo e Molise CAP 2.1
130
dislocati nell’area alto adriatica, dalle Marcheall’area veneta, in un periodo orientativamentecollocabile fra XVI e XVII secolo (TROIANO,VERROCCHIO 2002, p. 181, nota 120). Data lamoltitudine dei centri interessati è impossibileproporre un’attribuzione più specifica per ilframmento da Castel di Sangro.
3.3.11. Maiolica marmorizzata (Tav. XIV, nn.197-198)La produzione di ceramica marmorizzata e nellospecifico di maiolica marmorizzata, è già notain Abruzzo a Castelli nel tardo XVI secolo (RICCI1989, pp. 136-137). Più recenti ricerche hannopermesso di allargare il quadro dei centri diproduzione regionali anche ad Anversa degliAbruzzi34. In particolare va segnalato come laproduzione anversana, anch’essa rara all’inter-no delle altre classi ceramiche locali fra XVI eXVII secolo, al pari di quanto riscontrabile aCastelli, si caratterizzi per una marmorizzazio-ne ottenuta su una base di vetrina piombifera edunque si dovrebbe più correttamente parlaredi invetriata marmorizzata35. Il dato che vale lapena sottolineare per le produzioni anversane ècostituito dal fatto che, coerentemente con lararità di tale produzione destinata a manufatti
esclusivi, imitanti lavori in pietre dure di gustopienamente manierista, tale tipo di marmoriz-zazione fu utilizzato anche per manufatti ancorpiù di pregio, come nel caso della produzioneceramica a rilievo ottenuta a matrice databilefra tardo XVI e primi decenni del XVII secolo36.I soli due frammenti rinvenuti a Castel diSangro presentano caratteristiche esecutive edecorative che allo stato attuale delle conoscen-ze non forniscono sufficienti elementi attribu-tivi a specifici centri di produzione regionali oad importazioni extraregionali (nn. 197-198).Sembra comunque poter escludersi una prove-nienza da Anversa degli Abruzzi.
V. V.
3.3.12. Maiolica monocroma di Anversa (Tav.XV, n. 202; Fig. 27)Dai contesti castellani si segnalano pochi fram-menti ascrivibili alla produzione monocromabianca di Anversa degli Abruzzi. Si tratta dipiatti a media e piccola tesa (nn. 199-200), unfondo di ampollina (n. 201) e un raro orlo di“panata” (n. 202). Il dato che con evidenzaemerge ed allo stato attuale risulta poco noto èrappresentato dalla testimonianza della circola-zione anche a lungo raggio di questa classe cheaffianca di certo la più appariscente produzionedipinta. Contrariamente al quadro restituitodalla produzione ingobbiata, in cui la monocro-ma bianca ricopre una percentuale decisamenteelevata, in questo caso invece la maiolica biancasembra ricoprire un ruolo assolutamenteminoritario rispetto alla produzione dipinta. Laclasse sembra comunque presente costante-mente nella produzione anversana per tutto ilXVI secolo a partire da esemplari più antichi,come il sopra citato orlo di “panata”, formaquest’ultima attestata anche nella produzioneingobbiata e dipinta (vedi infra n. 165). Premesottolineare infine una forte omogeneità fra le
34 Per una prima segnalazione della classe si rimanda a VERROCCHIO 2003, pp. 100-101; Fig. 6, manufatti marmorizzati inbianco-brino o bianco-blu databili fra XVI ed inizi XVII secolo.
35 Difatti, come accennato, l’effetto marmorizzato è ottenuto miscelando macchie irregolari, gocciolature o colature dicolore bianco probabilmente ottenuto con base stannifera opacizzante, oppure attraverso la stesura di vetrina piombi-fera di colorazione non regolare.
36 Lo testimoniano frammenti inediti provenienti da rinvenimenti presso la città di Chieti (Largo Barbella) attribuibilialla produzione anversana ed in corso di studio da parte di chi scrive unitamente a D. Troiano. Si coglie occasione perringraziare la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo nella persona della Dott.ssa A. Campanelli per averautorizzato lo studio di tali materiali.
Ezio Mattiocco, Diego Troiano, Van Verrocchio
Fig. 27. Maiolica monocro-ma bianca di Anversa degliAbruzzi.
131
varie produzioni sia ingobbiate che in maiolica,anche all’interno della differenziazione mono-croma o dipinta, tanto che il quadro emergentedel centro di produzione appare fortementestandardizzato. Quest’ultimo dato è inoltreavvalorato dalla concordanza fra gli impasti levetrine e gli smalti utilizzati.
3.3.13. Maiolica in stile compendiario e tar-docompendiario di Castelli (Tavv. XV-XVI,nn. 203-215)La ceramica di Castelli, il più importante centrodi produzione regionale, sembra rivestire unruolo del tutto marginale rispetto alle attestazio-ni molisane ed anversane presenti nei contestidi Castel di Sangro. Essa è documentata solo apartire dal tardo XVI secolo attraverso pochiframmenti in stile compendiario sia su smaltobianco che su smalto turchino37. Nello specificoalla produzione su smalto bianco è ascrivibile unorlo di catino con tipico ornato a festone conghirlanda (n. 203) (TROIANO, VERROCCHIO 2002,p. 188, motivo 1c) nonché forme chiuse conornati a quartieri (n. 204). Negli esemplari insmalto turchino si segnalano frammenti di pic-cole ampolle per olio e aceto con ornato in bian-co e giallo-ocra (nn. 205-207) ed un orlo e unfondo di piatto (nn. 208-209) con identicabicromia. Si coglie l’occasione per rimarcarequanto già espresso nel 2002 quando si ebbemodo di segnalare come la maiolica turchina,generalmente considerata negli studi quale pro-duzione prevalentemente rivolta a manufatti sucommissione, in realtà, sulla base dei datiarcheologici emergenti negli ultimi anni, si stiarivelando una tipologia abbondantemente dif-fusa, di frequente rinvenimento, come mostraanche il caso di Castel di Sangro, e dunque daritenersi d’uso decisamente più comune diquanto in precedenza ipotizzabile38.Altrettanto sporadici sono i frammenti attri-
buibili al tardocompendiario seicentesco comead esempio scodelle con tralci stilizzati confascia gialla e trattini inclinati (n. 210)(TROIANO, VERROCCHIO 2002, p. 193, motivo 4),con linea ondulata e fiore stilizzato (n. 211)(TROIANO, VERROCCHIO 2002, p. 220, motivo 8),raffigurazioni umane (n. 212), figure di santi(n. 213) presenti sul fondo di forme aperte, opiù semplici motivi secondari a cordicella conabbondante utilizzo del colore bruno di man-ganese (n. 214). Si segnalano infine un fondodi ciotolina con simbolo religioso e un orlo dipiatto con tipica sequenza di foglie e girali pie-namente seicenteschi (n. 215).
3.3.14. Maiolica dell’Ottocento (Tav. XVI,nn. 216-220)Pur in presenza di scarsi materiali riconduci-bili al XIX secolo si è tuttavia cercato di trarrealcune considerazioni di carattere generale cheinvestono circolazione e produzione ceramicalocale nell’area in cui la città di Castel diSangro gravitava. Anzitutto, come già segnala-to, si è potuto per la prima volta isolare unaproduzione locale di ceramica da fuoco inve-triata (cfr. supra nn. 88-89) a cui si affianca-rono alcuni rari prodotti della non lontanaAnversa (vd. supra, n. 87). Tale quadro abba-stanza circoscritto dal punto di vista geograficoemerge anche dall’analisi dei pochi frammentiin maiolica rinvenuti. Ad una produzione cera-mica locale della “faenzera”, ancora tutta daindagare nei suoi molteplici aspetti ed attual-mente nota solo attraverso la documentazionearchivistica (vd. MATTIOCCO, supra) si affianca-no presenze relative a grossi centri di produ-zione regionali quali Bussi sul Tirino e Palenasiti in un ambito territoriale circoscritto ecomunque prossimo alla città39.Sono riconducibili a produzioni ottocenteschedi Bussi sul Tirino (nn. 216-219)40 frammen-
37 Per la più recente sintesi sulla produzione in compendiario su smalto bianco di Castelli si rimanda a TROIANO,VERROCCHIO 2002, pp. 185-219 ed in particolare per la produzione su smalto turchino pp. 206-207. Per il tardocompen-diario vd. Ibid., pp. 220-240.
38 Si veda ad esempio la prima carta di distribuzione regionale redatta nel 2002 in TROIANO, VERROCCHIO2002, p. 207, Fig. 204.39 La produzione della locale “Faenzera” di certo dovette essere abbastanza circoscritta rispetto alla copiosa produzionepopolare di Bussi che proprio nell’800 trovò la sua massima diffusione regionale ed extraregionale dovuta principal-mente a prodotti fortemente competitivi per la scarsa qualità degli smalti utilizzati e per l’uso di ornati fortementestandardizzati e corsivi. Vd. Troiano in questo vol.
40 Sulla produzione di Bussi nell’800 si veda il contributo specifico di D. Troiano in questo vol.
Materiali da Castel di Sangro (AQ). Ceramiche medievali e postmedievali fra Abruzzo e Molise CAP 2.1
132
ti di piatti con semplici filettature in bruno ocon fascia giallo-ocra (nn. 217-218) cui siaffiancano un boccale ed un piatto su smaltoazzurrato con identica decorazione (nn. 216,219). Infine un orlo di piatto rimanda allaproduzione di Palena41 della prima metàdell’Ottocento (n. 220).
D. T.
4. Considerazioni
Alla luce di quanto sinora descritto possiamobrevemente soffermarci su alcuni aspetti legatia produzione e circolazione della ceramicamedievale e postmedievale nell’Abruzzo meri-dionale interno, area tutt’oggi poco rappresen-tata negli studi e ricerche sull’argomento.Appare subito evidente che, pur con le grosselacune appena segnalate e pur in presenza dimateriali non provenienti da contesti archeo-logici stratigrafici ma da recuperi di superficie,la grande quantità di frammenti rinvenuti edanalizzati in questo lavoro permette di delinea-re un primo quadro dal quale la città di Casteldi Sangro emerge chiaramente quale luogo dicerniera e d’incontro nella circolazione di pro-dotti sia abruzzesi, e nello specifico dei centridell’Abruzzo interno, sia di prodotti della vici-na regione molisana. Inoltre i materiali castel-lani permettono di segnalare o meglio focaliz-zare alcune tipologie che probabilmente pos-sono riferirsi a produzioni locali.
1.Dai materiali medievali si documenta unaparticolare tipologia di maiolica arcaica, defi-nita in questa sede “tipo Castel di Sangro”, chepur ricollegandosi a repertori già noti presentauna serie di aspetti peculiari che ne fanno rite-nere con buona probabilità una produzione“locale”, intendendosi con tal termine un’areageografica prossima al centro castellano. Taleacquisizione costituisce un notevole contributoall’avanzamento delle conoscenze relative aproduzione e circolazione di maiolica arcaica emaiolica arcaica “tarda” fra XIII e XV secolo fra
l’Abruzzo, il Molise interno ed il basso Lazio.
2. Per quanto riguarda il postmedievo la città diCastel di Sangro emerge quale importante cen-tro che attirò nel ‘500 - di certo grazie al ruolosvolto dalle note fiere (vd. supra) e dalla posi-zione geografica favorevole all’intersezione diimportanti direttrici viarie in direzione Nord-Sud e verso la costa adriatica - dal Molise lamigliore produzione ingobbiata e graffita locale(di Campobasso), tanto che la sua unicità nelcontesto castellano contribuisce di riflesso afocalizzare ulteriormente l’importanza dallastessa. Dalla stessa area molisana pervengono,sempre nel corso del ‘500, produzioni ingob-biate dipinte, produzioni invetriate verdi edinvetriate da fuoco monocrome le cui cono-scenze vengono significativamente allargatecon i rinvenimenti di Castel di Sangro. Emergein sintesi un quadro piuttosto articolato e con-sistente di presenze molisane che si configuradel tutto inedito rispetto a quanto sinora noto osoltanto intuibile in contesti di rinvenimentoabruzzesi.Allo stesso tempo dall’Abruzzo abbiamo testi-monianza dell’arrivo copioso, sempre nelcorso del ‘500, di produzioni riconducibili alcentro di Anversa degli Abruzzi, quali le ingob-biate dipinte ad imitazione della maiolica, lemaioliche policrome e le produzioni sia ingob-biate che in maiolica monocrome bianche. Atale tipologie d’uso corrente, si affiancano rarepresenze di produzioni di pregio come adesempio un frammento di piatto in maiolica arilievo forse eseguito su commissione, desti-nate di certo ad una fruizione locale d’élite.Rare presenze extraregionali aiutano a deli-neare con sempre miglior definizione la circo-lazione in Abruzzo di prodotti di pregio umbri,come nel caso della ciotolina a lustro a rilievoraffigurante San Francesco orante e maiolichemarmorizzate di pregio forse anch’esse di pro-venienza extraregionale.Castelli, il maggior centro di produzione regio-nale, sicuramente a causa della forte concorren-za dei più economici manufatti anversani, stenta
41 Per una recente sintesi sulla produzione ceramica di Palena (CH) fra XIX e XX secolo si rimanda al contributo diI. Palmisano in questo vol.
Ezio Mattiocco, Diego Troiano, Van Verrocchio
133
Materiali da Castel di Sangro (AQ). Ceramiche medievali e postmedievali fra Abruzzo e Molise CAP 2.1
a affermarsi sul mercato locale, tanto che solocon il tardo Cinquecento, e gli inizi del secolosuccessivo, è attestata con scarsi frammentiriconducibili alla produzione in stile compen-diario su smalto bianco e su smalto turchino.
3. Mentre la presenza seicentesca e settecente-sca appare alquanto lacunosa, forse per lanatura dei contesti di rinvenimento, o forseper una reale contrazione dei traffici in que-st’area, l’Ottocento pur con scarsi frammentioffre maggiori spunti di riflessione vista ladocumentata presenza in città di una manifat-tura ceramica denominata “faenzera”. Di certo
maggiori studi e ricerche potranno aiutarci achiarire l’introduzione, la produzione e la cir-colazione dei manufatti e delle maestranzerelative a questa bottega, forse già attiva neltardo Settecento come sembrerebbe emergeredai dati anagrafici del già noto “faenzaro”Raffaele Bozzelli nato proprio a Castel diSangro nel 1796 e che ritroviamo agli inizi deglianni ’20 dell’Ottocento come fautore dell’a-pertura di una fabbrica di maiolica nel piccolocentro di Rapino in provincia di Chieti(TROIANO , VERROCCHIO 2005, pp. 314-317).
D. T., V. V.
Bibliografia
Atti Pescara, Atti della I Giornata di Studi sulla
Maiolica Abruzzese, a cura di V. de Pompeis,
Pescara 29 marzo 2000 (Quaderni del Museo
delle Genti d’Abruzzo, 35-36), Teramo, 2002.
Atti Chieti, La ceramica graffita tardomedievale e rina-
scimentale. Le produzioni laziali e abruzzesi a con-
fronto con altre realtà italiane, Atti del Convegno di
Studi, Chieti, 7-8 marzo 2002, a cura di E. De
Minicis e A. M. Giuntella, Roma 2005.
BALZANO V., 1942, La vita di un comune del reame.
Castel di Sangro, Pescara, 1942 (ed. Lighea, Castel
di Sangro, 1985).
BOSI S., ROMOLI V., 1995, Appunti su alcune ceramiche
medievali e moderne dall’Antiquarium comunale di
Nettuno (Roma), in Le ceramiche di Roma e del Lazio
in età medievale e Moderna, Atti del II Convegno di
Studi, Roma 6-7 maggio 1994, a cura di E. De
Minicis, Roma, pp. 241-251.
CARSANA V., POMANTE S., 2005, La ceramica graffita
dallo scavo della metropolitana di Napoli di Piazza
G. Bovio, in Atti Chieti, pp. 222-234.
CINI S., 1985, Ceramica d’importazione, in D.
MANACORDA (a cura di), Archeologia urbana a
Roma: il progetto della Cripta Balbi. 3. Il giardino del
Conservatorio di S. Caterina della Rosa, vol. 2,
Firenze, pp. 281-291.
COSTANTINI M., 1989, La ceramica di Penne, Penne.
DEL ROSSOM., 2000, La ceramica anversana,
Sulmona.
DEMINICIS E., 1994, Ceramiche medievali della casa
in via Gallo a Priverno (LT), in Le ceramiche di Roma
e del Lazio in età medievale e moderna, Atti del I
Convegno di Studi, Roma 19-20 marzo 1993, a
cura di E. De Minicis, Roma 1994, pp. 185-190.
DE POMPEIS V., 2002, Osservazioni preliminari sui
risultati delle prime ricerche effettuate ad Anversa
degli Abruzzi, in Atti Pescara, pp. 14-32.
DI VENANZIO E., 2002, Ceramica medievale e rinasci-
mentale dal monastero di San Martino di Trasacco
(AQ): osservazioni preliminari, in Atti Pescara, pp.
181-183.
DI VENANZIO E., 2005, Le produzioni ingobbiate del XVI
e XVII secolo rinvenute nel castello di Rovere (AQ),
“Azulejos”, 2, pp. 137-153.
DI VENANZIO E., PANTALEOM. 2001, Il vasellame da
mensa medievale e rinascimentale dal Castello
Orsini di Scurcola Marsicana, in Il Fucino e le aree
limitrofe nell’antichità, Atti del II convegno di
Archeologia in ricordo di Antonio Mario Radmilli
e Giuliano Cremonesi, Celano 26-28 novembre
1999.
FIGLIOLO, Il terremoto del 1456,Nocera Inferiore,
Edizioni Studi Meridionali, II, 1989.
FIOCCO C., GHERARDI G., 1994, La ceramica di Deruta
dal XIII al XVIII secolo, Perugia.
GENITO B., 1984, Campobasso. Fornace di ceramica
medievale, “Conoscenze”, 1, pp. 233-235.
GIUNTELLA A. M., SOZIO F., 2005, La ceramica graffita
e incisa dallo scavo del Castello di Rovere (AQ), in
Atti Chieti, pp. 106-115.
LEOTTAM. C., 2002, Tivoli: l’anfiteatro nel Medioevo
attraverso i materiali di scavo, in Le ceramiche di
Roma e del Lazio in età medievale e moderna, Atti
del IV Convegno di Studi, Viterbo 22-23 maggio
134
1998, a cura di E. De Minicis e G. Maetzke, Roma
2002, pp. 185-197.
MATTIOCCO E., 2005, Il Museo Aufidenate nel Convento
della Maddalena in Castel di Sangro, Sulmona.
RICCIM., 1989, Le forme della produzione Rinascimentale
e Compendiaria castellana. Il Compendiario
Cinquecentesco, in AA. VV., Le maioliche cinquecente-
sche di Castelli. Una grande stagione artistica ritrovata,
catalogo della mostra in Pescara, Museo delle Genti
d’Abruzzo, 23 aprile - 25 giugno 1989,Brescia, pp.
135-145.
STAFFA A. R., 2002, Alle origini della maiolica rinasci-
mentali: le produzioni ceramiche in Abruzzo fra tarda
antichità e XV secolo, in Atti Pescara, pp. 108-145.
Statistica 1890, Statistica Industriale. Notizie sulle con-
dizioni industriali delle provincie di Aquila, Chieti e
Teramo, Ministero di Agricoltura, Industria e
Commercio, Roma, 1895, ristampa anastatica a
cura del Mediocredito regionale abruzzese -
Unione Regionale delle Camere di Commercio
d’Abruzzo, Bologna, 1987.
TOGNOCCHI L., 2000, Novità dagli scavi di S. Maria del
Monte di Paganica e Rocca Calascio, in Atti Pescara,
pp. 85-103.
TROIANOD., VERROCCHIO V., 2000, Ceramiche ingob-
biate dipinte e Slip Ware da contesti urbani in
Sulmona (AQ), “Archeologia Uomo Territorio”, 19,
pp. 37-59.
TROIANOD., VERROCCHIO V., 2001, Ceramiche quali
indicatori di traffici commerciali fra Abruzzo, Molise e
regioni limitrofe fra XV e XVII secolo, “Archeologia
Postmedievale”, 5, pp. 225-245.
TROIANOD., VERROCCHIO V., 2002, (a cura di), La cera-
mica postmedievale in Abruzzo. Materiali dallo scavo
di Piazza Caporali a Castel Frentano (CH),
(Documenti di Archeologia Postmedievale, 1),
Firenze.
TROIANOD., VERROCCHIO V., 2002 a, Ceramiche post-
medievali dal Castello Pandone di Venafro (IS),
“Centro studi per la storia della ceramica meri-
dionale. Quaderno 2002”, pp. 33-46.
TROIANOD., VERROCCHIO V., 2002 b, Grafite postmedie-
vali fra Abruzzo e Molise. Centri di produzione, tipolo-
gie, diffusione ed influenze nell’ambito delle produ-
zioni dell’Italia centro-meridionale, “Museo della
ceramica di Cutrofiano”, Quaderno 7, pp. 43-70.
TROIANOD., VERROCCHIO V., 2005, Le più antiche
maioliche di Rapino (CH). Materiali inediti da colle-
zioni private, “Azulejos”, 2, pp. 313-331.
VENTRONE VASSALLO G., 1987, L’invetriata, la maiolica
e la ceramica comune medievale, in Ricerche archeo-
logiche a Napoli. Lo scavo in largo S. Aniello (1982-
1983), a cura di A. M. D’Onofrio e B. D’Agostino,
Napoli.
VERROCCHIO V., 2002, Invetriata dipinta ad ingobbio
(Slip Ware), in TROIANO, VERROCCHIO 2002, pp. 21-
88.
VERROCCHIOV., 2003, La ceramica postmedievale di
Anversa degli Abruzzi (AQ). Fonti archivistiche ed
archeologiche, “Archeologia Postmedievale”, 7, pp.
93-121.
VERROCCHIOV., 2004, Anversa degli Abruzzi (AQ). Primi
dati ed attribuzioni sulla ceramica a rilievo del XVI-
XVII secolo, “Azulejos. Rivista di Studi Ceramici”, 1,
pp. 74-84.
VERROCCHIO V., 2005, Anversa degli Abruzzi fra i
Belprato e di Capua del Balzo (XVI-XVII secolo). La
fioritura della stagione barocca: i servizi ceramici
decorati a rilievo, “Azulejos. Rivista di Studi
Ceramici”, 2, pp. 197-260.
Ezio Mattiocco, Diego Troiano, Van Verrocchio