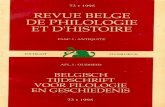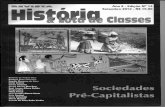Un "jubé" in Molise? A proposito del pulpito di Santa Maria di Canneto a Roccavivara
Transcript of Un "jubé" in Molise? A proposito del pulpito di Santa Maria di Canneto a Roccavivara
107
UN CAPITELLO FIGURATO
NEL MUSEO DIOCESANO DI GENOVA
ANNA ROSA CALDERONI MASETTI
In occasione dei restauri relativi al chiostro dei Canonici di San Lorenzo aGenova, vennero scoperti tre significativi capitelli, che si conservano oggi nelMuseo Diocesano aperto nelle sale dello stesso complesso edilizio. La campagnadei lavori aveva avuto inizio nel 1987, sotto la direzione della SoprintendenzaArcheologica della Liguria e la responsabilità di Piera Melli, con la collaborazio-ne, fra altri, di Gianni Bozzo. A questo studioso dobbiamo la stesura delle rela-tive schede in occasione di un primo resoconto degli scavi pubblicato nel 1996,mentre il Museo è stato aperto al pubblico nel 2000; la puntuale descrizione dalui fattane, mi esime dallo stenderne una oggi, che sarebbe soltanto ripetitiva1.I capitelli vennero trovati casualmente, inglobati nella muratura in una “rise-
ga muraria dei fondi”: la scarsa considerazione del loro aspetto, in un momentoin cui evidentemente la produzione artistica medievale non era adeguatamenteapprezzata, li aveva declassati a materiale da costruzione, trattandosi pur sempredi solidi blocchi di candido marmo apuano. Il loro riutilizzo va fatto risalire, conogni probabilità, ai secoli XVI e XVII, quando vennero ricostruite le ali est e suddel porticato e gli ambienti destinati ai canonici che si aprivano su di esso.Prima di soffermarmi sopra uno di questi esemplari, sembra però opportuno
ripercorrere le tappe del problema critico pertinente al chiostro, ricorrendoall’amata filologia; l’edificio, infatti, non gode di una datazione unanime, impe-dendo una solida base metodologica a ogni discorso che si voglia sviluppare inproposito.In sostanza, la critica si divide in due fazioni: quella che riporta l’inizio della
sua edificazione al 1176-11772; l’altra convinta che «i lavori per l’edificazione delchiostro dovevano essere già avviati nel 1176-77»3. Soltanto Guglielmo Salvi
Immagini del Medioevo 17x24 ok_Layout 1 03/04/13 11.13 Pagina 107
108
ANNA ROSA CALDERONI MASETTI
afferma genericamente che il chiostro è stato costruito contemporaneamente allacattedrale4. Tre sono in realtà i documenti risalenti al XII secolo sui quali potersi basare:
il primo è la bolla di consacrazione della cattedrale avvenuta il 10 ottobre 1118per mano di papa Gelasio II - vescovo di Genova il benedettino Ottone I - doveci si limita a citare, come destinatari della cerimonia, altare hoc [et] oratoriu[m]5.È ragionevole presumere che gli ambienti canonicali siano stati costruiti in epocacontemporanea o immediatamente successiva, identificandosi la vita comunita-ria del clero con uno dei pilastri di quella riforma della Chiesa che la consuetu-dine chiama gregoriana, nella quale tanto peso ebbero i monaci di provenienzacluniacense: non è un caso che tali furono, oltre allo stesso Gregorio VII, i pon-tefici Urbano II e Pasquale II.Il secondo documento è un atto risalente al 26 marzo 1176 o 1177, con il
quale Oberto da Recco dona al monastero di San Siro il terzo di un oliveto situa-to in Recco, nella località di Fontana. Esso viene stipulato in claustra vetula, iuxtaportam Sancti Iohannis, e segnala senza incertezze la realtà di un chiostro nuovo,se già agibile o appena iniziato non è dato sapere6. Indubbia è l’esistenza di unprogetto pertinente, che va dunque ricondotto ad anni precedenti questa data,e, con ogni probabilità anche una sua, almeno parziale, edificazione. Nel 1184 Giovanni del fu Bonvassallo Straleria lasciava operi claustri sancti
Laurentii 5 lire, senza però specificare se la destinazione era legata alla sua costru-zione o alla manutenzione dell’insediamento7.Il terzo atto riconduce, ma dubitativamente, al 1189, quando l’arcivescovo di
Genova Bonifazio pronuncia sentenza di scomunica, fra altri, contro coloro cheardiranno commettere violenze nel chiostro e nelle case dei canonici di SanLorenzo8. A questa data l’edificio doveva essere già completato.Tirando le fila di quanto ricavabile dai dati documentari riproposti sopra, la
costruzione del chiostro deve ricondursi inequivocabilmente a un momento pre-cedente gli anni 1176-1177; a mio avviso, addirittura una cinquantina di anniprima quando, in parallelo con la consacrazione della Cattedrale avvenuta nel1118, dovettero avviarsi le condizioni per consentire una vita comunitaria delclero. Il chiostro era il cuore dell’edificio e proprio su di esso si affacciavano lestanze di abitazione dei canonici.I legami stilistici avanzati dalla critica, fra il capitello contenente la raffigurazione
del cavallo impastoiato e l’immagine identificata come San Matteo posta sulla men-sola destra del portale di San Giovanni in duomo, attestato probabilmente già nel1142, sostengono questa proposta9: come ha segnalato Clario Di Fabio nel 1981,un atto risalente a questa data ricorda che il «cintragus - una sorta di banditore pub-
Immagini del Medioevo 17x24 ok_Layout 1 03/04/13 11.13 Pagina 108
109
blico - debet custodire in sabbato sancto portas sancti Johannis donec archiepisco-pus et canonici veniant ad benedicendos fontes cum processione»10.Mi sono soffermata altrove su questo capitello, individuando nella raffigura-
zione del cavallo impastoiato sulla faccia frontale, un riferimento ai milites Chri-sti che Bernardo di Chiaravalle identificava nel suo trattato sulla cavalleria comei difensori della Chiesa: difensori materiali, nel loro ruolo di protettori dei pel-legrini che si recavano a Gerusalemme per visitare il Santo Sepolcro, difensorispirituali nella lotta contro le eresie11.Com’è noto, l’Ordine dei Templari venne costituito a Gerusalemme nel
1119, per trovare però nell’opera di Bernardo spunti determinanti per la formu-lazione della Regola intorno al 1130, seppure la stesura di quest’ultima non vadaassegnata direttamente alla sua responsabilità. Molteplici furono i legami di Bernardo con Genova, dove è testimoniato già
nel 1133, messaggero di pace inviato da Innocenzo II nel tentativo di risolverela lotta contro Pisa: risultato raggiunto, benché di breve durata12. La città lo acco-glie esultante e assiste con entusiasmo alla sua indefessa predicazione; il suo suc-cesso è strepitoso, e la sua presenza si coniuga indissolubilmente non tanto congli inizi della diffusione dell’Ordine cistercense in Italia, quanto con il suo con-solidamento. Già negli anni precedenti gli era stata addirittura offerta la cattedravescovile13.A questo proposito è doveroso, e molto gradito, ricordare i fondamentali
contributi forniti da Colette allo studio di questi insediamenti a Genova e inLiguria14, nonché le significative riflessioni di Valeria Polonio15. Devo confessareche le mie limitate competenze in materia non mi consentono di approfondirel’argomento; posso però offrire un ulteriore contributo di ambito figurativo,oltre a quelli già proposti, al quale mi auguro che anche gli storici possano dedi-care un momento di riflessione.Pressappoco allo stesso periodo di quella del chiostro di San Lorenzo, deve
ricondursi la costruzione del chiostro di Sant’Andrea, sempre a Genova, cheperò, a differenza del precedente, ha subito un processo di anastilosi tutt’altroche infrequente fra Otto e Novecento16. Il primo documento che lo ricorda risaleal 24 marzo 1158 e quindi la sua esecuzione deve riportarsi ad anni precedenti:quanti, non è dato sapere, forse una decina, forse qualcuno di più.È merito di Anna Dagnino aver ricostruito con scrupolo e attenzione le fasi
di questa operazione, dallo smontaggio avvenuto nel 1905 per consentire la siste-mazione urbanistica del centro della città, alla sua ricostruzione nella frequenta-tissima piazza Dante nel 1923, sotto la responsabilità di Angelo De Marchi17.Quel che preme rilevare in questa occasione, è che, nel contesto di numerosi
UN CAPITELLO FIGURATO NEL MUSEO DIOCESANO DI GENOVA
Immagini del Medioevo 17x24 ok_Layout 1 03/04/13 11.13 Pagina 109
110
capitelli figurati con storie tratte da vari repertori, compaiono anche due esemplaricon scene cavalleresche. Nel 1987 i diversi episodi sono stati correttamente indivi-duati come testimonianza di una «tendenza narrativa» in città18, e basterebbe ricor-dare la scena dell’aratura, con il vomere infisso nel terreno e i solchi paralleli del-l’aratro tracciati intorno al calato; quella della caccia, con la segnalazione naturali-stica del bosco dove si svolge la scena; l’altra con il trasporto di merci per mezzo diun carro guidato e seguito da due barrocciai, dove la ruota del veicolo, quasi unideogramma, si staglia al centro sopra di esso; l’altra ancora dove il trasferimentodel carico avviene per mezzo di cavalcature che si susseguono su tutta la superficie,il basto gravato da merci varie, fra cui due botticelle.Tornando però agli episodi cavallereschi, essi si sviluppano continuativamen-
te su ciascuno dei due capitelli: nel primo, un personaggio riccamente vestito,con mantello e speroni, poggia la mano sinistra sulla spalla di una dama, anch’es-sa fornita di ampio mantello sopra una veste a pieghe, alla quale è unito ulterior-mente nel gesto della dexterarum iunctio, di tradizione romana; sulla sinistra uncavallino bardato con briglia, sella, gualdrappa e fregio pettorale, dal quale evi-dentemente il personaggio maschile è appena disceso come dimostra la staffapenzoloni, aspetta paziente. Proprio il confronto con alcune scene cavalleresche che fanno parte del patri-
monio artistico dei Templari in Europa19, consente a mio avviso, in seconda let-tura, di identificare questo episodio con una testimonianza, o una promessa, difedeltà; ovvero, di un legame indissolubile, una sorta di patto matrimoniale, frail cavaliere templare e la Chiesa.Sul paramento esterno della cattedrale di San Lorenzo a Genova, più precisa-
mente sul lato nord della torre sinistra di facciata, è murata la frammentarialastra frontale di un sarcofago strigilato risalente al III-IV secolo d.C.: nella tabel-la centrale è raffigurata la scena della dexterarum iunctio, che, pur essendo affattodiversa nei risultati compositivi, testimonia la diffusione di questa specificatematica in città, ammesso che sia questo stesso sarcofago, o invece un altro simi-le, il riferimento per la scena del capitello risalente al XII secolo20.Se la proposta avanzata risultasse convincente, ne trarrebbe conforto l’ipotesi
già avanzata di identificare il cavaliere del chiostro di San Lorenzo – mi sembradifficile possa provenire dalla cattedrale, come pure è stato dubitativamente pro-posto – con un miles Templi, ossia un personaggio appartenente alla militia diuno dei più importanti ordini militari del Medioevo. Siamo nella prima metà delXII secolo, quando, con ogni probabilità, si sta ancora costruendo un’iconografia“templare”.Sul capitello adiacente del chiostro di Sant’Andrea, la medesima dama com-
ANNA ROSA CALDERONI MASETTI
Immagini del Medioevo 17x24 ok_Layout 1 03/04/13 11.13 Pagina 110
111
pare eretta, riproponendosi nella faccia opposta, mentre sorregge un oggetto chepotrebbe essere un grande calice, ma il consistente degrado delle superfici nonpermette certezze, mentre sull’altro lato gli stessi personaggi si presentano ingroppa a un medesimo destriero: se appare più difficile identificare nel gruppoun riferimento al miles Christi e alla Chiesa, che procedono uniti nella medesimadirezione, è doveroso ricordare come il sigillo dei Templari risalente al Duecentomostri due cavalieri in groppa a uno stesso cavallo, quasi a segnalare la loro unitàdi intenti. In quest’ultimo caso sono forniti di armatura, speroni e spada, addob-bo che non può fornire equivoci, ma anche nel capitello di Rivalta, conservatopresso il Museo di Palazzo Madama a Torino, la scena della vestizione riguardaun semplice saio monastico con il cappuccio21. Soprattutto, il personaggiomaschile indossa inequivocabilmente gli speroni, che non sono soltanto, comepotrebbero sembrare a prima vista, un oggetto funzionale a condurre il cavallo,ma un elemento altamente simbolico e un vero e proprio contrassegno distintivodella militia.Non escluderei, quindi - pur avanzando l’ipotesi con cautela estrema - che
agli albori della sua costituzione, i capitelli genovesi possano aver fornito più diun suggerimento a un’iconografia che si consoliderà in epoca successiva.Sembrerebbe confortare questa lettura la stella che compare in duplice copia
nel capitello dei Magi, verso la quale tutti e tre i personaggi volgono la mano oaddirittura puntano il dito, come l’angelo ad ali spiegate reggente una croce.Costituita da un fiore stilizzato a sei petali, racchiuso entro un esagono regolarei cui lati sono ulteriormente decorati con un semicerchio - pur non essendo unmotivo originale perché già presente, per esempio, sopra un capitello della criptadi San Giovanni ad Asti risalente al IX secolo -, essa trova riscontro, come sim-bolo templare, sia nel capitello torinese, sia nel decoro aniconico della chiesa diSan Bevignate a Perugia.Infine, non deve stupire la presenza di scene cavalleresche in un chiostro
canonicale o in un monastero femminile benedettino - ne esistono esempi anchealtrove - quando in essa non era difficile leggere, in controluce, il doveroso impe-gno a combattere i nemici della Chiesa, spirituali e politici, e l’invito a procederetenacemente su questa strada.
UN CAPITELLO FIGURATO NEL MUSEO DIOCESANO DI GENOVA
Immagini del Medioevo 17x24 ok_Layout 1 03/04/13 11.13 Pagina 111
112
NOTE
1 G. Bozzo, Marmi medievali e post medievali, in P. Melli, a cura di, La città ritrovata. Archeologiaurbana a Genova 1984-1994, Genova 1996, pp. 260-262 nn. 6.55, 6.58, 6.59; la prima sche-da riproposta in C. Di Fabio, a cura di, La Cattedrale di Genova nel Medioevo, secoli VI-XIV,Cinisello Balsamo-Milano 1998, p. 107 n. 17. Sul chiostro in generale: C. Dufour Bozzo, G.Rebora, C. Varaldo, Il chiostro di San Lorenzo, “Liguria”, 45 (1978) 11/12, pp. 3-11; G. Bozzo,Il chiostro dei Canonici: architettura e scultura, in Di Fabio 1998, pp. 97-107, 203-213; L. DeStefani, Il chiostro di San Lorenzo a Genova, “Tema”, 4 (1998), pp. 22-37; R. Mantelli, M.Ravera, Il chiostro nei documenti, in G. Bozzo, a cura di, Cattedrale e Chiostro di San Lorenzo aGenova: conoscenza e restauro, Genova 2000, pp. 210-214; G. Bozzo, Il chiostro dopo il Medioe-vo, ivi, pp. 215-226; F. Cervini, Liguria Romanica, Milano 2002, pp. 83, 95; A.R. CalderoniMasetti, Dal chiostro dei Canonici alla mostra, in Mandylion, intorno al Sacro Volto, da Bisanzioa Genova, catalogo della mostra (Genova, 18 aprile – 18 luglio 2004) a cura di G. Wolf, C.Dufour Bozzo, A.R. Calderoni Masetti, Milano 2004, pp. 249-253; G. Bozzo, Considerazionisullo smontaggio e la ricomposizione nel chiostro di San Lorenzo a Genova del monumento funebredel cardinale Luca Fieschi. Il luogo: il chiostro di San Lorenzo e i cicli di affreschi medievali, inArnolfo di Cambio: il monumento del cardinale Guillaume de Bray dopo il restauro, Atti del Con-vegno internazionale di studio (Roma-Orvieto, 9-11 dicembre 2004), Firenze 2010, pp. 289-298.
2 A. Basili, L. Pozza, Le carte del Monastero di San Siro di Genova dal 952 al 1224, Genova 1974,p. 153; Bozzo 1996, p. 226.
3 A. Dagnino, C. Di Fabio, San Lorenzo e il Museo del Tesoro, Genova 1988, p. 32.4 G. Salvi, La Cattedrale di Genova, Torino 1931, pp. 953-960; Id., Italia sacra, le chiese d’Italia
nell’arte e nella storia, Torino 1932, p. 955.5 C. Di Fabio, Le origini della cattedrale nuova e la consacrazione di Gelasio II: 1099-1118, in Di
Fabio 1998, pp. 51-59 (in part. pp. 56-57).6 Cfr. Basili Pozza 1996, pp. 153-154 n. 122; Salvi 1931, pp. 954-955.7 Cfr. Salvi 1932, p. 955.8 L. T. Belgrano, Il Registro della Curia arcivescovile di Genova, “Atti della Società Ligure di Storia
Patria”, II (1862), pp. 461-462 n. XLII.9 Cfr. Bozzo 1996; A.R. Calderoni Masetti, Un cavaliere per Genova (c.d.s. negli Studi in onore
di Maria Andaloro).10 C. Di Fabio, I portali romanici della cattedrale di Genova, “Bollettino d’arte”, 12 (1981), pp.
89-122 (in part. p. 118 n. 29); Id., Origini e vicende medievali del battistero della cattedrale diGenova, in C. Montagni, a cura di, Il Battistero di San Giovanni in San Lorenzo a Genova,Genova 2011, pp. 11-28.
11 Cfr. Calderoni Masetti c.d.s.12 San Bernardo e l’Italia, Atti del Convegno di studi (Milano, 24-26 maggio 1990) a cura di P.
Zerbi, Milano 1993, pp. 69-99, con ampia bibliografia.13 La critica non è concorde circa la data: o tra il 1129 e il 1130, oppure già prima, tra il 1120
e il 1123.14 C. Dufour Bozzo, A. Dagnino, a cura di, Monasteria nova: storia e architettura dei Cistercensi
in Liguria (secc. 12.-14.), Genova 1998.15 V. Polonio, Un’età d’oro della spiritualità femminile a Genova: devozione laica e monachesimo
cistercense nel Duecento, in Storia monastica ligure e pavese. Studi e documenti, Cesena 1982, pp.297-403; Ead., S. Bernardo, Genova e Pisa, in San Bernardo e l’Italia 1993.
ANNA ROSA CALDERONI MASETTI
Immagini del Medioevo 17x24 ok_Layout 1 03/04/13 11.13 Pagina 112
113
16 C. Dufour Bozzo, a cura di, Medioevo restaurato, Genova 1860-1940, Genova 1984; C.Dufour Bozzo, M. Marcenaro, a cura di, Medioevo demolito. Genova 1860-1940, Genova1990.
17 A. Dagnino, Ricerche di architettura romanica a Genova. Il monastero di Sant’Andrea della Porta,in Storia monastica ligure e pavese 1982, pp. 173-257; C. Di Fabio, Scultura romanica a Genova,Firenze 1984, pp. 49-65; C. Di Fabio, Geografia e forme della scultura in Liguria, in La sculturaa Genova e in Liguria dalle origini al Cinquecento, Genova 1987, pp. 94-95; A. Dagnino, ivi,pp. 167-168; Ead., Sant’Andrea della Porta, in Dufour Bozzo, Marcenaro 1990, pp. 25-56;Cervini 2002, pp. 205-208.
18 Cfr. Di Fabio 1987, p. 95.19 Della vastissima bibliografia in proposito, mi limito a segnalare: G. Viti, a cura di, I Templari.
Una vita tra riti cavallereschi e fedeltà alla Chiesa e G. Viti, A. Cadei, V. Ascani, a cura di,Monaci in armi. L’architettura sacra dei Templari attraverso il Mediterraneo, entrambi Atti del IConvegno “I Templari e San Bernardo di Chiaravalle” (Firenze, 23-24 ottobre 1992), Firenze1995; G. Curzi, La pittura dei Templari, Cinisello Balsamo-Milano 2002; Milites Templi. Ilpatrimonio monumentale e artistico dei Templari in Europa, Atti del Convegno (Perugia, 6-7maggio 2005) a cura di S. Merli, Perugia 2008.
20 C. Dufour Bozzo, Sarcofagi romani a Genova, Genova 1967, p. 33 n. 5.21 G. Romano, a cura di, Piemonte romanico, Torino 1994.
UN CAPITELLO FIGURATO NEL MUSEO DIOCESANO DI GENOVA
Immagini del Medioevo 17x24 ok_Layout 1 03/04/13 11.13 Pagina 113
114
ANNA ROSA CALDERONI MASETTI
Fig. 1. Genova, Museo Diocesano, capitellocon cavaliere.
Fig. 2. Genova, Chiostro di Sant’Andrea, capi-tello con dexterarum iunctio.
Fig. 3. Genova, Cattedrale, torre meridionale, lastra frontale di sarcofago romano (foto di G. Roli,Archivio Franco Cosimo Panini Editore).
Immagini del Medioevo 17x24 ok_Layout 1 03/04/13 11.13 Pagina 114
115
UN CAPITELLO FIGURATO NEL MUSEO DIOCESANO DI GENOVA
Fig. 4. Genova, Chiostro di Sant’Andrea,capitello con Coppia a cavallo.
Fig. 5. Genova, Chiostro di Sant’Andrea, Capitello dei Magi, part.
Immagini del Medioevo 17x24 ok_Layout 1 03/04/13 11.13 Pagina 115
117
UN “JUBÉ” IN MOLISE?A PROPOSITO DEL PULPITODI SANTA MARIA DI CANNETO
FRANCESCO GANDOLFO
Sapendo dei miei interessi per il medioevo molisano e chiedendomi se ilmateriale mi poteva interessare, qualche tempo addietro Adriano La Regina miha consegnato copia di una lettera e di alcuni rilievi del pulpito conservato nellachiesa di Santa Maria di Canneto, nei pressi di Roccavivara, che Giuseppe Zan-der gli aveva inviato nell’ormai lontano 19891. Nella lettera Zander gli chiedevase, nel corso delle sue indagini archeologiche in Molise, si fosse imbattuto inreperti medioevali provenienti dalla chiesa e se gli paresse accettabile l’idea che(cito testualmente) «il creduto “ambone”, ricomposto in modo maldestro e forseerrato, a ridosso di una delle due pareti, fosse invece un “jubé” unico - direi -nell’Italia meridionale, da pensare disposto ad angolo retto con l’asse longitudi-nale della chiesa?». Quell’interrogativo non trovò seguito nel rapporto tra i duestudiosi, tuttavia esso conserva intatto un notevole interesse.Non vi è dubbio che la definizione di pulpito male si adatta all’arredo con-
servato nella chiesa2 (fig. 1). Allo stato attuale si tratta infatti di una strutturacaratterizzata da un impianto molto largo e poco profondo, decisamente ecce-zionale per un pulpito che di solito tende a una sezione quadrangolare mai cosìsbilanciata nel senso del lato maggiore. Quello che per comodità continuerò achiamare pulpito, retto sulla fronte da quattro colonne, si trova addossato, a par-tire dalla facciata, al terzo intercolumnio di sinistra della navata centrale, inquanto per reggersi sfrutta come punti di appoggio non solo due pilastri, maanche la muratura dei pennacchi a essi soprastanti. Occorre dire subito che ilpulpito ha raggiunto questa posizione dopo il 1931, nel corso degli imponentilavori di restauro all’intero monumento posti in atto dall’allora rettore don Dui-lio Lemme, intervento nel corso del quale, tra l’altro, venne totalmente ricostrui-
Immagini del Medioevo 17x24 ok_Layout 1 03/04/13 11.13 Pagina 117
ta la muratura d’ambito della navata sinistra3. Come testimonia una vecchiafotografia (fig. 2), il pulpito in precedenza era collocato lungo lo stesso asse, maimmediatamente a ridosso dell’attacco dell’abside, appoggiato alla muratura cheaveva tamponato l’arcata retrostante. È ovvio che né l’una né l’altra collocazionesono quella originaria, ma che entrambe, specie la seconda, sono state le conse-guenze di scelte che in qualche modo hanno tenuto conto della possibile siste-mazione di un pulpito secondo le consuetudini medievali, ovviamente partendodalla considerazione che si trattasse effettivamente di tale tipo di arredo e senzadare peso alcuno all’anomalia delle sue forme.La vecchia fotografia mostra che il pulpito in quel momento si presentava in
condizioni ben diverse dalle attuali in quanto mancava di tutta la porzione con-clusiva del tratto superiore sulla destra e dei fianchi, almeno nello stato in cui sipresentano oggi, in quanto è proprio in questi due punti che si è maggiormenteaccanita la fantasia ricostruttrice di don Lemme, inserendo nel complesso scul-ture che decisamente non gli appartengono. La prima operazione da compieredunque è sottrarre idealmente al pulpito questi materiali. Del resto è evidenteche la figura di arpia, sulla destra della fronte (fig. 3), così come il tralcio di vitee la sottostante scena con due arpie che si tirano la coda, sul fianco sinistro (fig.4), non hanno nulla da spartire con il resto della decorazione. La maniera linearee bidimensionale con cui questi rilievi sono stati realizzati, intrisa di un senso difabulistica fantasia, trova un puntuale termine di confronto in figurazioni di ana-logo tenore presenti nel ciborio della abbazia di San Clemente a Casauria, unrimando che ne colloca l’esecuzione nei primi decenni del Quattrocento4. Tral’altro non è da escludere che anche questi frammenti facessero parte di un cibo-rio, visto che sul fianco, al di sotto delle arpie, si riconosce il breve tratto super-stite di un archetto trilobo.Le basi, caratterizzate dalla presenza di testine paraspigoli, le colonne e i capi-
telli, dal sobrio e lineare decoro fogliato, tranne nel caso del primo sulla sinistrain cui una figuretta a mezzo busto viene morsa sulla testa dal muso in comunedi due mostri alati, compongono un insieme omogeneo per qualità e per dimen-sioni. Questo tuttavia non porta elementi utili alla definizione delle caratteristi-che originarie della struttura. Ha anche creato perplessità la presenza sulla destradell’arcata più ampia rispetto alle altre due, quella lungo la quale, immediata-mente al di sopra della cornice, corre l’iscrizione che riporta la data del 1223. Ladistribuzione sbilanciata ha fatto pensare che, alla data indicata su di essa, l’arca-ta sia intervenuta in una struttura di qualche decennio precedente, in sostituzio-ne di una sistemazione su tre arcate uguali5. Una arcata più stretta in quel puntoavrebbe pareggiato la larghezza della porzione inferiore del pulpito con quella
118
FRANCESCO GANDOLFO
Immagini del Medioevo 17x24 ok_Layout 1 03/04/13 11.13 Pagina 118
119
suggerita dalle soprastanti figure sotto arcate. Inoltre al mezzo di queste si dispo-ne un lettorino che, riprendendo una soluzione largamente documentata neipulpiti, aveva sotto di sé un’aquila di cui rimangono soltanto le tracce degli arti-gli sul piano retto da una colonna. Calibrato sull’arcata centrale, il lettorinoappare decentrato rispetto alla fronte, mentre con tre arcate eguali si sarebbeposto al centro. Chi ha avanzato la soluzione ha anche immaginato che il pulpi-to, ridotto in larghezza, fosse disposto all’attacco dell’abside, con la fronte rivoltaverso la navata: una proposta che lascia intendere la volontà di superare l’anoma-la situazione attuale, con il non disprezzabile riconoscimento di una funzionecome tramezzo che risulta improponibile soltanto per via del luogo scelto, inquanto la struttura avrebbe invaso e strozzato lo spazio liturgico concesso dalretrostante catino absidale.In ogni caso, anche a fronte di queste considerazioni, non vi sono argomenti
per pensare che chi ha realizzato le palmette che decorano le due arcate piccolenon abbia posto in opera anche quelle dell’arcata grande, visto che le dimensio-ni, il disegno e la qualità formale sono esattamente gli stessi ed è difficile pensareche, a distanza di tempo, dei lapicidi abbiano ripreso il modello suggerito da unaprecedente bottega con tanta esattezza ripetitiva, perché la realizzazione di queltipo di ornato era condizionata dalla conoscenza di schemi grafici di impostazio-ne del lavoro che dovevano costituire un patrimonio operativo gelosamentecustodito6. La seconda obiezione scaturisce dal fatto che la data del 1223 calzabenissimo alle figure sotto le arcate le quali mostrano forme che possono essereinterpretate come una volgarizzazione dei modi alti e cosmopoliti delle sculturedella facciata della cattedrale di Termoli (fig. 5)7. Così come allo stesso monu-mento si rifanno le ghiere con il loro ornato a palmette che riprende, nel gustoe nella stesura, la soluzione decorativa che, lungo la facciata della cattedrale, sirincorre da una arcata all’altra.In definitiva, l’ipotesi che la porzione inferiore del pulpito nasca nelle forme
attuali appare la più ragionevole. Ciò non significa che il manufatto non abbiasubito pesanti manomissioni. Intanto è stato certamente smontato e rimontatoalmeno due volte, visto che entrambe le collocazioni che conosciamo non pos-sono essere quelle originarie. Questo ha comportato modifiche e alterazioni neltratto di muratura soprastante alle arcate, con episodi bene evidenziati dal fattoche i due grandi fiori oggi posti sul fianco sinistro (fig. 4), al di sotto delle arpie,nel 1931, insieme con un ulteriore frammento a decoro vegetale, si trovavano aldi sopra delle due arcate piccole (fig. 2). Sulla fronte attuale (fig. 1) poi è possi-bile vedere, al di sopra dell’arcata di sinistra, un concio con l’attacco di una iscri-zione ormai priva di senso perché largamente frammentaria. Lo stesso si può dire
UN “JUBÉ” IN MOLISE? A PROPOSITO DEL PULPITO DI SANTA MARIA DI CANNETO
Immagini del Medioevo 17x24 ok_Layout 1 03/04/13 11.13 Pagina 119
a proposito delle lettere RI capovolte che compaiono a fianco del fiore dispostoin corrispondenza del pennacchio sulla destra, segno anche questo di una mano-missione, se non di una integrazione con pezzi estranei, una cattiva abitudineche, nel caso specifico, non può essere addebitata ai restauri promossi da donLemme perché la presenza del frammento è già testimoniata dalla fotografiaantecedente ad essi. Del resto, in linea di principio, non si può escludere che idecori floreali e le iscrizioni facessero parte della fronte del pulpito fin dalle ori-gini, sia pure sotto altra forma e collocazione, visto che anche questi motivi tro-vano un puntuale riferimento nelle arcate della facciata della cattedrale di Ter-moli di cui decorano i pennacchi (fig. 5).Vi è comunque in tutto questo un fattore di unificazione rappresentato dalla
cornice che conclude la porzione inferiore del pulpito. Le palmette che la com-pongono sono in tutto simili a quelle delle arcate sottostanti e malgrado che aldi sotto delle due figure sulla destra si noti la presenza di un tratto dalla fatturaimpropria e raffazzonata, certamente dovuta ai restauri, essa mostra agli estremidue svolte d’angolo di indiscutibile genuinità che contribuiscono a confermarecome originaria, almeno fino a questo livello, la fronte attuale, oltre che nelle sueragioni formali soprattutto in quelle dimensionali. Tanto più che l’arcata piùampia sulla destra si conclude con un concio le cui dimensioni sono state atten-tamente calcolate per coincidere con quelle dell’abaco del capitello sottostante eda quello stesso concio è stato ricavato il tratto terminale della cornice a palmettedell’arcata, a conferma della sua originarietà.La situazione della porzione superiore del pulpito è decisamente più compli-
cata. La fotografia del 1931 (fig. 2) ci attesta che in quel momento la condizionedelle figure sotto arcate, ivi compreso l’angolo sinistro, era identica a quellaattuale, mentre sulla destra la sequenza si concludeva con la semicolonna e ilsemicapitello su cui appoggia l’ultima arcata addossati a un breve tratto di mura-tura liscia formato da due conci sovrapposti con cui fanno corpo ancora oggi,ovviamente ognuno per conto proprio (fig. 3). Nell’insieme del percorso dise-gnato dalle arcate e dagli ornati delle loro fronti non vi sono segnali di sostanzialianomalie, salvo sulla sinistra un cambiamento nel tipo di ornato, in corrispon-denza della figura di vescovo al centro, con un passaggio dalla generalizzata coro-na di fogliette a un più classicheggiante fascio di foglie che evidentemente vuoleavere valore glorificante nei confronti del personaggio. Un motivo analogo ritor-na a segnare l’angolo e poiché il dettaglio è perfettamente integrato e materica-mente omogeneo con le semicolonnine che gli si accostano, sia sulla fronte siasul fianco (fig. 4), questo garantisce che ci troviamo in presenza della sistemazio-ne originaria, considerazione rinforzata anche dalla svolta d’angolo, con il con-
120
FRANCESCO GANDOLFO
Immagini del Medioevo 17x24 ok_Layout 1 03/04/13 11.13 Pagina 120
121
sueto decoro a palmette che si dispone subito sopra e che mostra anch’esso diessere antico e non di restauro, come sono invece i tratti realizzati nei due conciimmediatamente successivi lungo la fronte.Se ci si trasferisce al capo opposto del pulpito (fig. 1) o meglio al termine del-
la porzione verosimilmente antica, dunque alla conclusione delle arcate, è facilenotare come non sia possibile ricomporre una situazione corrispondente a quellaappena descritta. A suggerirlo è il fatto che la fronte decorata dell’archetto con-clusivo della sequenza ricade al mezzo del sottostante capitello e non, come acca-de dalla parte opposta, alla conclusione esterna. Questo dettaglio impone la pre-senza di una sostanziale diversità tra i due estremi della fronte. È ciò che nonhanno intuito i restauratori il cui maggiore difetto è stato di inventare una con-clusione che pareggiasse i conti con quella dalla parte opposta e con la porzioneinferiore, realizzandola per di più con del materiale avventizio. Che già in originela porzione superiore della fronte, quella figurata, non si adeguasse all’ampiezzaindicata dalla inferiore con le arcate lo suggerisce il fatto che lo spazio compresotra l’ultima colonnina e l’angolo non consente l’inserzione di una ulteriore nic-chia e dunque una conclusione in simmetria con quella dalla parte opposta.Un’altra considerazione da fare è che il posizionamento reciproco delle due por-zioni del pulpito, quella inferiore e quella superiore, dovette essere fin dall’origi-ne quello attuale perché il lettorino è volutamente collocato sulla verticale sug-gerita dal culmine dell’arcata intermedia e non vi sono argomenti per pensareche possa essere esistita una prima fase in cui, con uno spostamento generale ver-so destra di tutta la porzione superiore, il posizionamento del lettorino fosse cal-colato sul centro del complesso.Poste queste premesse, si arriva alla invitabile domanda di che cosa manchi al
pulpito per essere effettivamente agibile. È evidente che la sua attuale collocazio-ne a ridosso di due pilastri consecutivi non ha senso sul piano funzionale e nonfa i conti con il fatto che in origine anche da quella parte della chiesa dovevanoesistere delle colonne sulle quali il pulpito avrebbe potuto contare decisamentemeno per reggersi. Questo sta a significare che, una volta appurato che, malgra-do le tante manomissioni, la fronte riflette nella sua sostanza di fondo la condi-zione originaria, occorre arrivare alla conclusione che doveva esistere un retro,deputato a svolgere anche una funzione portante, del quale è andata perdutaogni traccia, per cui è perfettamente inutile domandarsi quali forme avesse, vistoche poteva presentare come sostegni delle colonne allineate con quelle della fron-te, ma poteva anche essere formato da una muratura piena, con un unico pas-saggio, verosimilmente centrale. L’altro aspetto intrigante, eluso dalla ricostru-zione novecentesca, è come si salisse sul pulpito, una questione che si lega all’in-
UN “JUBÉ” IN MOLISE? A PROPOSITO DEL PULPITO DI SANTA MARIA DI CANNETO
Immagini del Medioevo 17x24 ok_Layout 1 03/04/13 11.13 Pagina 121
terrogativo di quale fosse la effettiva profondità della struttura, ma soprattutto dicome fossero conclusi i fianchi e quali fossero le ragioni dell’esistenza di unaarcata più ampia.Occorre dire subito che gli argomenti archeologici in proposito sono assolu-
tamente scarsi. Come si è già visto il fianco sinistro è stato totalmente ricostruitoe questo lo rende particolarmente infido. Un elemento sicuro da cui partire peròè rappresentato dalla svolta d’angolo della balaustra perché, come si è detto, ilsuo decoro a palmette è indiscutibilmente originario e organico alla struttura.Lungo il fianco (fig. 4) la cornice va ad interrompersi bruscamente contro laparete, ma nel percorso una vistosa cesura rompe l’ordine distributivo delle pal-mette e rivela l’intervento dei restauratori che hanno provveduto a unire tra loroframmenti discordanti. La cesura però si dispone ben oltre la metà dell’interopercorso in direzione della parete, una posizione che rende verosimile che già inorigine questo fianco fosse chiuso. Dalla parte opposta (fig. 3) la situazione èaltrettanto complicata e abbiamo già visto come l’ansia regolarizzatrice deirestauratori abbia portato a dei fraintendimenti. Gli unici elementi che fannocorpo con il capitello e con la sottostante colonnina sono i conci lisci ai qualiseparatamente si addossano e che, insieme ad essi, sono stati legati tra loro conun abbondante strato di malta, mentre la figura di arpia è stata forzata a sovrap-porsi a quello inferiore. Tutto questo prova, quanto meno, che da questa partevi era una sistemazione diversa rispetto a quella della terminazione opposta.Anche in questo caso la balaustra presenta una svolta d’angolo perfettamente
integrata nella sua funzione come dimostra la continuità della cornice a palmet-te, solo che, nella prosecuzione verso la parete, i restauratori sono stati costrettia integrarla, per un buon tratto, con una cornice del tutto diversa, così comeavviene anche in basso, lungo la stessa verticale. Era questo il punto di attaccodella scala di ingresso al pulpito, immediatamente al di là della svolta della balau-stra? Può essere ma ovviamente si entra nel campo delle pure ipotesi. L’unicaulteriore considerazione che si può fare è che se la scala di accesso fosse stata col-locata da questa parte avrebbe trovato un senso l’apertura più ampia sbilanciataverso di essa, a creare una sorta di ingresso monumentale, nel momento in cui siimmaginasse un sistema di salita con almeno due rampe e un ballatoio interme-dio, che attaccasse sulla destra, immediatamente al di là di essa. Ovviamente ditutto questo non si può avere conferma senza degli scavi che mettano in luce nel-la navata le inevitabili fondamenta che una struttura del genere avrebbe compor-tato.Tirando le somme della situazione e riprendendo la questione da cui si è par-
titi, l’ipotesi che ci si trovi in presenza di un pontile o di una struttura similare
122
FRANCESCO GANDOLFO
Immagini del Medioevo 17x24 ok_Layout 1 03/04/13 11.13 Pagina 122
123
deve tenere conto del fatto che la chiesa aveva un impianto basilicale ed era privadi presbiterio rialzato per cui non poteva accogliere le soluzioni che di quel tipodi arredo conosciamo attraverso i pochi casi superstiti, come quello campionesedella cattedrale di Modena8. Nello stesso tempo però Santa Maria di Canneto erauna chiesa monastica che pretendeva la separazione tra fedeli e celebranti e que-sto poteva avvenire grazie a una struttura più simile ai lettners tedeschi9. Questasua funzione del resto è in qualche modo allusa dalle figure sotto le arcate (fig.1), del tutto insolite nella loro ragione iconografica, se pensate per un pulpito,più congrue invece nell’ottica di un tramezzo. Sulla sinistra abbiamo un diaconoche mostra l’evangeliario aperto, un vescovo con gli attributi del suo ruolo e unvolume chiuso nella sinistra e infine un chierico turibolante. Sulla destra sidispongono un monaco che porta le specie per la celebrazione, un altro monacoin preghiera e quello che è da interpretare come un abate mitrato piuttosto checome un secondo vescovo, con una bene individuata partizione tra clero secolarea sinistra e monastico a destra10.Si tratta dunque di una rappresentazione del clero, avviato a una concelebra-
zione, descritto nelle sue componenti e nelle sue ragioni gerarchiche, collocataall’ingresso dello spazio ad esso riservato. Detto questo, l’ipotesi che il pulpito sidisponesse in posizione perpendicolare rispetto all’asse longitudinale della navatacentrale, in corrispondenza di un intercolumnio che solo una indagine archeo-logica potrebbe essere in grado di individuare ritrovandone le fondazioni, apparecome la più plausibile in relazione alla presumibile forma e ai contenuti icono-grafici ma anche alle dimensioni11. Non vi sono strumenti per dire se si collegavaa un sistema di recinzione che coinvolgeva anche le navate laterali. Certamente,nell’ipotesi che sulla destra si agganciasse la scala di accesso, l’insieme andava adoccupare completamente lo spazio concesso dalla ampiezza della navata centralee spostava ancora di più verso sinistra la posizione del lettorino, rincorrendo unacollocazione canonica. Di più sulla questione non è possibile dire: l’ipotesi del“jubé”, formulata da Giuseppe Zander, rimane comunque, allo stato dei fatti, lamigliore per spiegare la singolarità di quello che tutto fa pensare sia stato fattodiventare un pulpito, dopo essere stato creato come un tramezzo adatto a unasituazione basilicale, riuscendo a sopravvivere alle distruzioni controriformisti-che forse proprio in virtù dell’ambiguità delle sue forme che, con una semplicerotazione di novanta gradi, permettevano di risolvere il problema posto dal suoingombro.
UN “JUBÉ” IN MOLISE? A PROPOSITO DEL PULPITO DI SANTA MARIA DI CANNETO
Immagini del Medioevo 17x24 ok_Layout 1 03/04/13 11.13 Pagina 123
NOTE
1 In generale sulla chiesa cfr. H.W. Schulz, Denkmäler der Kunst des Mittelalter in Unteritalien,Dresden 1860, II, p. 49; É. Bertaux, L’art dans l’Italie méridionale, Paris 1903, II, pp. 541-543;M. Galluppi, S. Maria di Canneto sul Trigno nell’archeologia, nella storia e nell’arte, Roma 1941;A. Trombetta, Arte medioevale nel Molise, Roma 1971, pp. 49-56; V. Pace, Profilo di Storia del-l’Arte dal Medioevo ai giorni nostri, in S. Gattei, A. La Regina, a cura di, Molise, Milano 1980, p.83; O. Lehmann-Brockhaus, Abruzzen und Molise. Kunst und Geschichte, München 1983, p.106; L. Mortari, Molise. Appunti per una storia dell’arte, Roma 1984, p. 15; A. Trombetta, Artenel Molise attraverso il medioevo, Campobasso 1984, pp. 31-46; V. Ferrara, La vicenda storica earcheologica di “Santa Maria di Canneto” sul fiume Trigno, “Archivio storico molisano”, 7(1983/1984), pp. 29-97; V. Ferrara, Le diocesi di Alfedena e di Trivento e la chiesa di “Santa Mariadi Canneto” sul fiume Trigno dal tunnel del vandalismo barbarico all’incipiente affermazione bene-dettina del secolo VI, in E. Nocera, a cura di, Almanacco del Molise 1986, Campobasso 1986, II,pp. 5-29; G. Fangio, Il santuario di Santa Maria di Canneto in Roccavivara (Campobasso): tesorodi fede e di archeologia, “Quaderni dell’arte”, 4 (1994) 7, pp. 4-22.
2 Sul pulpito, oltre alla letteratura ricordata a proposito della chiesa, cfr. anche O. Lehmann-Brockhaus, Die Kanzeln der Abruzzen im 12. und 13. Jahrhundert, “Römisches Jahrbuch fürKunstgeschichte”, 6 (1942-1944), pp. 257-428, in particolare pp. 385-391; V. Ferrara, L’am-bone-pulpito di S. Maria di Canneto sul Trigno (A.D. 1223), in E. Nocera, Almanacco del Molise1979, Campobasso 1979, pp. 295-357; B. Incollingo, La scultura romanica nel Molise, Roma1991, pp. 97-102; G. Palma, Il pulpito di Canneto e la prospettiva come esempio di estetica dellaproportio, “Conoscenze”, 8 (1995), pp. 55-77.
3 Sui restauri cfr. D. Catalano, Il Molise medievale tra perdite, trasformazioni e decontestualizza-zioni, in C. Ebanista, A. Monciatti, a cura di, Il Molise medievale. Archeologia e arte, Borgo SanLorenzo 2010, pp. 175-189. La muratura della navata sinistra, in corrispondenza dei sostegni,aveva già subito una ricostruzione nel 1505, per volontà dell’abate Scipione Caracciolo al cuiintervento si deve la sostituzione delle originarie colonne con gli attuali pilastri: cfr. Galluppi1941, p. 16.
4 Incollingo 1991, pp. 101-102 data i pezzi inseriti nel pulpito al XIII secolo, sulla scia di quan-to proposto da Lehmann-Brockhaus 1942-1944, p. 387. Personalmente ritengo che il con-fronto più calzante, per qualità formale e per contenuti iconografici, sia con i rilievi del fiancosinistro del ciborio in stucco della abbazia di San Clemente a Casauria per la cui datazione aiprimi del Quattrocento rimando a F. Gandolfo, San Clemente a Casauria. I portali e gli arrediinterni, in L. Franchi dell’Orto, a cura di, Dalla valle del Fino alla valle del medio e alto Pescara,Teramo 2003 (Documenti dell’Abruzzo teramano, VI, 1), pp. 272-297.
5 Per questa ipotesi cfr. Palma 1995.6 Per l’analisi di un caso concreto di utilizzo di schemi ai fini della realizzazione di un decoro
aniconico cfr. F. Gandolfo, L’uso dei modelli in una bottega di stuccatori abruzzesi alla metà delXII secolo, in Medioevo: I modelli, Atti del Convegno internazionale di studi (Parma, 27 set-tembre - 1 ottobre 1999) a cura di A. C. Quintavalle, Milano 2002, pp. 319-329.
7 Sulle sculture della cattedrale di Termoli cfr. F. Jacobs, Die Kathedrale S. Maria Icona Vetere inFoggia. Studien zur Architektur und Plastik des 11.-13- Jh. in Süditalien, (Diss. Phil. Hamburg1966), Bamberg 1968, passim; H. Buschhausen, Die süditalienische Bauplastik im KönigreichJerusalem, Wien 1978, pp. 333-343; M.S. Calò Mariani, Due cattedrali del Molise. Termoli eLarino, Roma 1979, pp. 7-54; Lehmann-Brockhaus 1983, pp. 153-154; Trombetta 1984, pp.95-123; F. Aceto, “Magistri” e cantieri nel “Regnum Siciliae”: l’Abruzzo e la cerchia federiciana,
124
FRANCESCO GANDOLFO
Immagini del Medioevo 17x24 ok_Layout 1 03/04/13 11.13 Pagina 124
125
“Bollettino d’arte”, 59 (1990) 1, pp. 15-96; R. Legler, La “sindrome gotica”. Nuove precisazionisulla scultura pugliese, “Kronos”, Supplemento 3, Galatina 2007, pp. 5-76: malgrado esistanodivergenti opinioni circa la cronologia delle sculture della facciata della cattedrale di Termoli,la data del 1223 del pulpito di Santa Maria di Canneto si propone come un sicuro ante quem,quali che siano le posizioni in proposito.
8 Per le ragioni archeologiche che hanno portato alla ricostruzione del pontile modenese comeun balcone proteso dal presbiterio verso la navata cfr. T. Sandonnini, Relazione sulla ricostru-zione del pontile nel duomo di Modena, Modena s.d. (1915) e Id., Appendice alla Relazione sullaricostruzione del pontile nel duomo di Modena, Modena 1916.
9 Cfr. su questi l’ampia rassegna tipologica fornita da M. Schmelzer, Der mittelalterliche Lettnerim deutschsprachigen Raum. Typologie und Funktion, Petersberg 2004. In Italia una strutturasimile a quella che si può ipotizzare che esistesse a Santa Maria di Canneto è rappresentata daltramezzo di Santa Maria di Vezzolano, sostanzialmente coevo: cfr. M. Durliat, La tribune deSerrabone e le jubé de Vezzolano, “Monuments et mémoires de la Fondation Eugène Piot”, 60(1976), pp. 79-112; E. Pagella, Scultura gotica in Piemonte: tre cantieri di primo Duecento, inG. Romano, a cura di, Gotico in Piemonte, Torino 1992, pp. 129-163; Ead., Scultura gotica aSanta Maria di Vezzolano, in V. Pace, M. Bagnoli, a cura di, Il Gotico europeo in Italia, Napoli1994, pp. 109-117; P. Salerno, a cura di, Santa Maria di Vezzolano: il pontile. Ricerche e restau-ri, Torino 1997. La definizione di pontile mal si adatta alla struttura esistente a Santa Mariadi Vezzolano perché, in assenza di un presbiterio retrostante sopraelevato, le sue caratteristichefunzionali sono in tutto quelle di un lettner.
10 Già Lehmann-Brockhaus 1942-1944, p. 390 e Incollingo 1991, pp. 97-98 hanno sottolineatoil carattere liturgico espresso dalle figure al di sotto delle arcate, sia pure con delle variantiinterpretative, visto che il primo coglieva nel monaco con la borraccia al fianco un riferimentoagli ordini mendicanti, ovviamente una indicazione difficile da ammettere in relazione a unpossedimento cassinese quale era all’epoca Santa Maria di Canneto, mentre per il secondo ildettaglio risulta inspiegabile.
11 Il pulpito ha una larghezza complessiva di 4,08 m e una altezza di 3,80 m, a fronte di una lar-ghezza della navata centrale oscillante tra 4,80 m e 4,96 m, con una differenza che lascia spazioall’ipotesi di una presenza della scala di accesso in posizione laterale, sulla destra.
UN “JUBÉ” IN MOLISE? A PROPOSITO DEL PULPITO DI SANTA MARIA DI CANNETO
Immagini del Medioevo 17x24 ok_Layout 1 03/04/13 11.13 Pagina 125
126
FRANCESCO GANDOLFO
Fig. 1. Santa Maria di Canneto, pulpito, visione d’insieme.
Fig. 2. Santa Maria di Canneto, pulpito, visione d’insieme risalente al 1931.
Immagini del Medioevo 17x24 ok_Layout 1 03/04/13 11.13 Pagina 126
127
UN “JUBÉ” IN MOLISE? A PROPOSITO DEL PULPITO DI SANTA MARIA DI CANNETO
Fig. 3. Santa Maria di Canneto, pulpito, par-ticolare della fronte.
Fig. 4. Santa Maria di Canneto, pulpito, par-ticolare del fianco sinistro.
Fig. 5. Termoli, Cattedrale di San Bas-so, particolare della facciata.
Immagini del Medioevo 17x24 ok_Layout 1 03/04/13 11.13 Pagina 127