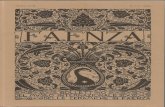C. Aleo Nero, Reperti ceramici medievali e postmedievali dallo scavo presso le mura urbiche di via...
Transcript of C. Aleo Nero, Reperti ceramici medievali e postmedievali dallo scavo presso le mura urbiche di via...
CENTRO LIGURE PER LA STORIA DELLA CERAMICA
ATTIXLIV
CONVEGNO INTERNAZIONALEDELLA CERAMICA
LA CERAMICA POST-MEDIEVALE NEL MEDITERRANEO.GLI INDICATORI CRONOLOGICI:
SECOLI XVI-XVIII
SAVONA, 27 - 28 MAGGIO 2011
Tra il 2008 e il 2010 la SoprintendenzaBeni Culturali ed Ambientali ha effet-tuato alcuni saggi di archeologia preven-tiva in un cantiere edilizio di proprietàprivata del centro storico di Palermo1.L’area, compresa tra le odierne vie delCelso e via Candelai, ricade sul versantesettentrionale delle fortificazioni dellacittà punica, una volta lambito dal fiumePapireto (fig. 1); a meridione la città si af-facciava, invece, sul torrente Kemonia. Iltracciato delle mura è noto oggi nel suopercorso essenziale ma è visibile soltantoin alcuni tratti2, mentre per il resto lemura, sulle quali si è ininterrottamenteedificato a partire dal tardomedioevo,giacciono inglobate nell’attuale tessutourbano della città.
Le attuali Via del Celso e Via Candelai,dall’andamento tortuoso ed irregolare, ri-calcano la viabilità antica all’interno ed al-l’esterno delle mura, rispettivamente amonte e a valle, correndo a quote diffe-renti. Nel luogo che ci interessa tra le duestrade esiste un dislivello di circa 7 m chedenota come la fortificazione antica sor-
gesse a mezza costa sulle pendici dellapiattaforma calcarenitica, digradanti bru-scamente verso l’alveo del fiume Papi-reto3.
* Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Pa-lermo. Disegni di R. Catalano, elaborazioni grafichedi L. Artale. Si ringraziano la d.ssa M. Reginella e ildott. F. D’Angelo per le preziose indicazioni sui ma-teriali ceramici.
1 Anche questo intervento si inserisce nell’am-bito delle ricerche di archeologia urbana a Palermo,per le quali molto si è fatto, soprattutto nell’ultimodecennio, sotto la direzione scientifica della d.ssa F.Spatafora, ai cui contributi si rimanda per un quadro
aggiornato delle conoscenze oggi disponibili sulla to-pografia della città antica e per la bibliografia prece-dente sull’argomento: SPATAFORA 2003, p. 1175 ss;EAD. 2004a, p. 47 ss; EAD. 2005a, p. 721 ss; EAD.2005b, p. 19 ss.; EAD. 2006, p. 529 ss; EAD. 2007, p.17 ss.; EAD. 2009, p. 623 ss. Si veda anche: SPATA-FORA-MONTALI 2006, p. 133 ss. In particolare, sui re-centi scavi di Via Candelai, SPATAFORA c.d.s.
2 SPATAFORA 2004b, pp. 18-22. 3 Analoga situazione si riscontra nel tratto di
299
Carla Aleo Nero*
REPERTI CERAMICI MEDIEVALI E POSTMEDIEVALI DALLO SCAVO PRESSO LE MURA URBICHE DI VIA CANDELAI A PALERMO
Fig. 1 – Pianta schematica di Palermo antica elocalizzazione degli scavi
Non si sa molto sull’edilizia storica delluogo4, che comunque già nel medioevodovette essere occupato dalle case signorilidelle famiglie più importanti, autorizzate acostruire i loro palazzi sulle mura urbiche5.Di sicuro, nell’Ottocento l’area era occu-pata da una delle residenze dei principiLanza di Trabia. Il Palazzo Trabia aveval’accesso principale a Sud dalla via Celso(a monte), nella odierna piazza del GranCancelliere, mentre a nord il prospetto se-condario si affacciava chiuso da una cortea terrazzo sulla via Candelai (a valle), aquota più alta rispetto alla strada; il terrazzoera delimitato sulla via Candelai da unmuro a grossi blocchi, alto rispetto al pianostradale ca 4 m. Il palazzo venne bombar-dato durante il secondo conflitto mondialee, in ultimo, negli anni ’50 del secoloscorso, l’area fu oggetto di estesi sbanca-menti che stravolsero la configurazione ori-ginaria dei luoghi e portarono ad unabbassamento di quota dell’originario ter-razzo fino al livello della Via Candelai.
In seguito agli sbancamenti furono sco-
perti, e purtroppo in gran parte distrutti,notevoli resti di strutture antiche, tra lequali un consistente tratto delle mura pu-niche, lungo 11 m ca (fig. 2), che rimaseda allora a vista6.
Le recenti indagini, oltre a restituire unagrande quantità di dati che occorrerà stu-diare nelle diverse prospettive storico-ar-cheologiche, hanno permesso di isolare
fortificazione presso il Convento di S. Chiara, sul ver-sante meridionale della città antica, cfr. SPATAFORA
2005a, p. 730 ss.; EAD. 2007, p. 26 ss.; EAD. 2009, p. 625.
4 Qualche cenno in DI GIOVANNI 1889, p. 45, 51. 5 LA DUCA 1998, pp.28-29.6 SPATAFORA 2004b, p. 22; EAD. c.d.s.
300
Fig. 2 – Via Candelai, il tratto di fortificazionevisto da Sud.
Fig. 3 – stralcio cartografico e rilievo: a) abitato asud del muro punico, b) corte del palazzo attuale,resti “rasati” delle fortificazioni, c) stratigrafia ovest,d) parte alta delle mura all’interno dell’avancorpotardocinquecentesco, e) struttura absidata.
anche alcune sequenze stratigrafiche diampia articolazione diacronica, la cui ana-lisi è stata avviata; tuttavia, è ancora troppopresto per affrontare problematiche di ca-rattere complessivo sulle classi di materiali.
Si può, preliminarmente, dire che lacontinuità di vita nell’area urbana apparedocumentata, almeno, dal III sec. a. C. finoad oggi, scandita in quattro fasi principali:a) età ellenistica (abitato-mura); b) età ro-mana (mosaico tessellato b/n e reperti ce-ramici; c) età medievale, articolata inalmeno due momenti, probabilmente rife-ribili al periodo islamico; d) età postme-dievale.
Il muro di fortificazione (fig. 2; fig. 3 d)fu costruito sopra i resti di strutture abita-tive in uso probabilmente fino alla metà delIII sec. a. C., come dimostrano i numerosimateriali ceramici rinvenuti e la tipologiadei rivestimenti parietali e pavimentali7.
Nella cortina muraria sono distinguibilipiù fasi costruttive (fig. 2): la parte inferioreattribuibile al III sec. a.C. è costituita da al-
cuni filari in grossi blocchi squadrati di cal-carenite, posti per testa e per taglio, senzauso di malte, mentre la parte superiore delmuro in piccoli blocchi squadrati di tufobiancastro e legante di terra appartiene adepoca medievale, essendo probabilmenteriferibile ad uno degli interventi di manu-tenzione della cinta muraria effettuati in etàaraba di cui abbiamo notizia dalle fonti sto-riche. Sul lato nord, il paramento murarioesterno è frutto di un ulteriore, più radi-cale, rifacimento della cinta muraria, data-bile sulla base dei dati stratigrafici, ancorain corso di studio, al X-XI secolo.
Sopravvissuto alle continue trasforma-zioni edilizie della città ed alle demoli-zioni recenti, il tratto di muro difortificazione di via Candelai risultatronco a est e malamente rattoppato congli stessi materiali lapidei di risulta, il chenon facilita la lettura delle varie fasi co-struttive, che hanno via via incrementatolo spessore del muro, oggi visibile in se-zione nella corte del palazzo per com-plessivi 4,80 m circa (fig. 5).
Verso la fine del XVI sec. o poco piùtardi, sopra le mura fu costruita una strut-tura a grossi blocchi, forse pertinente aduna delle fasi edilizie del palazzo signorileche allora insisteva nell’area, caratterizzatoda una sorta di avancorpo che appare con-dizionato dalla morfologia delle struttureantiche sottostanti, all’epoca già interrate.All’interno dell’edificio tardocinquecente-sco oggi è visibile la parte sommitale su-perstite della fortificazione (fig. 3, d).
Un successivo radicale ampliamentodel palazzo, probabilmente sei/settecen-tesco, è documentato da pilastri e mura-ture che raggiungono il banco dicalcarenite.
Al di sotto del piano di calpestìo at-
7 SPATAFORA c.d.s.
301
Fig. 4 – Corte del palazzo attuale. Le strutturedella probabile porta urbica
tuale della corte (fig. 4), gli scavi hannoevidenziato quel che rimane delle fonda-zioni delle strutture difensive dopo glisbancamenti.
I dati archeologici, avendo eviden-ziato una soluzione di continuità nellacinta muraria, orientano verso l’ipotesiche in questo tratto della cortina difensivaesistesse una porta urbica nell’età medie-vale, in corrispondenza di una probabilestrada selciata; forse anche in età elleni-stica doveva esserci una porta.
Senza inoltrarci in uno dei più spi-nosi problemi della topografia di Pa-lermo8, è importante sottolineare come idati stratigrafici di quest’area indichinoper l’ultima fase costruttiva del muro ur-bico un periodo compreso all’incirca tra
la seconda metà del X e l’XI secolo, tral’età islamica e non oltre gli inizi dell’etànormanna. Tali indicazioni archeologi-che, che occorrerà valutare e meglioprecisare sotto gli aspetti storici oltreche topografici, acquistano un certo ri-lievo in quanto potrebbero trovare cor-rispondenza in una fonte arabaanonima, recentemente scoperta, chedescrive la città intorno ai primi decennidell’XI sec. e che riferisce dell’esistenzadi una porta urbica in prossimità deiluoghi oggetto di indagine (JOHNS 2004,p. 419)9.
Dopo il X-XI secolo (fig. 5) all’esternodelle mura si accumularono in sequenzaconsistenti strati di deposito che hannorestituito numerosi reperti ceramici di etàmedievale e postmedievale (fig. 3, c; fig.5, c.d. stratigrafia ovest), oltre ai resti dialcune strutture di modeste dimensioniprobabilmente destinate ad attività arti-gianali quali, per esempio, la lavorazionedella canna da zucchero, documentatadal rinvenimento di numerosi vasi tipicidella produzione (TULLIO 1997, p. 475, fig.6). Si tratta di un deposito archeologicoformatosi nel corso di molti secoli (dal X-XI al XVII e oltre) e non di un’unicaopera di riempimento della corte-terrazzosulla via Candelai.
Gli strati più potenti sono quelli ri-feribili al X-XI sec., relativi alla ultimafase costruttiva medievale delle mura, equelli relativi al XVI secolo (US 9 inparticolare, formatasi probabilmenteentro la prima metà del XVI sec.), ma
8 SPATAFORA c.d.s. e ivi bibliografia precedente.9 Potrebbe trattarsi della porta Bab al bi’r (Porta
del Pozzo) citata nel manoscritto arabo, non elencata,invece, nella descrizione delle porte dal geografo IbnHawqal che scrive prima, nel 973. La stessa potrebbeessere identificata con la Porta Sclavorum, esistita,
pare, fino al 1460, menzionata dalle fonti più tarde,da localizzare probabilmente in questa stessa area delpalazzo Trabia (DI GIOVANNI 1889, pp. 46-47; 341-342). Lo studio dei dati archeologici relativi alle muraurbiche di via Candelai e delle problematiche corre-late è in corso da parte di chi scrive.
302
Fig. 5 – sezione est della fortificazione e c.d.“stratigrafia ovest”
sono anche ben documentati i periodidi vita dal XII al XV secolo.
Saggi in un’altra area del cantiere edi-lizio, lungo la via Celso all’interno dellafortificazione, hanno interessato parte diuna struttura absidata quasi completa-mente interrata rispetto alla quota attualedella strada e non visibile dall’esterno(fig. 3, e), essendo stata obliterata dallefondazioni del palazzo Trabia.
Pur non essendo stato possibile in-dagarne la pianta completa, tuttavia, al-cuni elementi porterebbero ad escludereche possa trattarsi di un edificio reli-gioso. Si tratta, infatti, di un ambiente co-struito contro terra e sotto i livellistradali, mentre è chiaro che la facciavista dell’apparecchio murario si trovaall’interno della struttura. Essa presenta,inoltre, sempre all’interno, un rivesti-mento ed un cordolo in cocciopesto incorrispondenza del fondo (nessuna trac-cia, invece, di un pavimento né di bat-tuto); infine, è stata rinvenuta nelriempimento una lastra della probabilecopertura con una tipica concrezionecalcarea da condensa.
Tutto ciò consentirebbe di qualificarel’ambiente rinvenuto come probabile ci-sterna e di ipotizzarne la fase di oblitera-zione tra la seconda metà del XVI secoloe la seconda metà del XVII, a giudicaredagli strati più antichi del riempimento(US 534) (v. ultra, “struttura absidata”).
Si ritiene opportuno presentare, in viapreliminare, una selezione di materiali dai
due contesti che hanno restituito sequenzemedievali e postmedievali: la “stratigrafiaovest” e la “struttura absidata”10.
I MATERIALI. “STRATIGRAFIA OVEST”.
Per quanto riguarda i materiali, ci li-mitiamo a segnalare la presenza di alcunetipologie ceramiche poco documentatenei contesti palermitani.
Dagli strati (UUSS 12-13), che sem-brano comprovare la circolazione di pro-dotti nel pieno XIII secolo, si segnala, inassociazione con ceramiche di importa-zione quali le protomaioliche di Gela eBrindisi, le dipinte sotto vetrina (Spiralware) e le ingobbiate e graffite arcaiche,un frammento di scodella (fig. 6), ingob-biata graffita e dipinta in verde con mo-tivo a graticcio sulla tesa, corpo ceramicodi colore rosato con inclusi micacei, ri-conducibile probabilmente a produzionidel Mediterraneo orientale, databili al XII-XIII secolo, di cui poche attestazionisono finora note in Sicilia11.
Dalla Us 12 proviene anche un fram-mento di manico di boccale in invetriata po-licroma (per la presenza della classeceramica in contesti palermitani ARCIFA-LE-SNES 1997, p. 413, fig. 4,j; PEZZINI 2001, pp.154-155) che documenta le importazionidall’Italia meridionale verso le coste setten-trionale della Sicilia, molto probabilmentedalla Calabria (CUTERI 2007, p. 181), dove laproduzione è attestata nei secoli XIII- XIV.
Al XIV sec. sono databili le ceramiche
10 Tra i pochi scavi a Palermo di cui sianostate studiate le ceramiche bassomedievali e po-stmedievali, si ricordano, a titolo esemplificativo,quelli del complesso dello Steri (FALSONE 1976), delConvento dell’Annunziata alla Zisa (ARDIZZONE
1994), del rione Castello S. Pietro (ARCIFA-LESNES
1997), del chiostro di S. Domenico (LESNES 1993),del Museo archeologico “A. Salinas” (LESNES 1997).
11 Segesta (MOLINARI 1997, p. 148, fig. 182,tipo IV.9.1); Cefalù (TULLIO 1993, p. 243, fig. 6);Monte Iato (ISLER 1987, p. 18, fig. 18; ISLER 1995, p.143, A109); un esemplare quasi completo a Messina(FIORILLA 2001, p. 113, p. 126, M/46, fig. 15, tav. XI).Un altro frammento è stato rinvenuto, a quantopare, anche a Milazzo (ringrazio la d.ssa Fiorilla perl’informazione).
303
smaltate con motivi araldici o geometriciin bruno, alcune di importazione. Si se-gnala un frammento del fondo di unaforma aperta con stemma della famigliaChiaramonte con i cinque monticelli12.
Attestata la presenza in via Candelaidelle ceramiche spagnole13 (rinvenutesoprattutto nella US 9), importate pre-valentemente dall’area valenzana; si ri-scontrano sia le produzioni in blu diseconda metà - fine del XIV sec. (lozaazul con motivi fitomorfi stilizzati), siaquelle più recenti di lustri dorati (motivigeometrici o a palmas abiertas y circulos)che quelli caratterizzati dalla presenza delblu nel motivo a foglia (XV sec.) (GOB-BATO 2001, p. 270 SS.).
Si segnalano, in particolare, due fram-menti di lustro, uno con la tipica coronareale valenzana in blu (fig. 7)14, l’altro conlettere gotiche in blu sulla tesa, in questocaso della serie Ave Maria (fig. 8), dibuona fattura, entrambi databili entro la
prima metà del XV sec.15. Alcuni frammenti documentano la
presenza di ceramica graffita monocromadi produzione savonese o albisolese (figg.9-10) con il tipico motivo della croce conraggi ondulati, una classe di vasellame damensa molto diffusa nei contesti liguridel XV e XVI secolo e che conosce ancheuna discreta circolazione extraregionale(BENENTE – PIOMBO 2001, p. 241), la cuipresenza a Palermo era già nota perl’esemplare rinvenuto negli scavi delloSteri (FALSONE 1976, p. 13, fig. 26).
Nella US 9, particolarmente ampia èl’attestazione di ceramica di produzionemontelupina o di area valdarnese, ricon-ducibile a manufatti databili verso la finedel XV e soprattutto nel corso della primametà del XVI secolo: alle produzioni piùantiche sono riconducibili alcuni fram-menti del genere “occhio di penna di pa-vone” (BERTI 1998, Gen. 20, p. 109, fineXV), e del genere “palmette persiane”
12 Cfr. FALSONE 1976 fig. 10, dallo Steri. 13 Per la presenza di importazioni spagnole nel
contesto dello Steri, FALSONE 1976, p. 13; nel rione diCastello S. Pietro, ARCIFA-LESNES 1997 p 416.
14 Cfr. FALSONE 1976, fig. 21, dallo Steri.15 Cfr.: GOBBATO 2001, p. 273, n. 942; RAMAGLI
2010, p. 22, n. 13, da Genova; FIORILLA 2001, p. 138,M/128 da Messina.
304
Fig. 6 – ceramica di importazione orientale daUS 13.
Fig. 7 – lustro con corona reale in blu.
(BERTI 1998, Gen. 21, p. 111, 1480-1520). Sono abbastanza frequenti i frammenti
con le tipiche serie decorative “a ovali erombi” (fig. 11)16 (BERTI 1998, gen. 26, p.121, 1510-1520); alcuni altri apparten-gono al più tardo genere “spirali arancio”(fig. 12) (BERTI 1998, gen. 54, p. 191, se-conda metà del XVI)17, mentre decisa-
16 Cfr. Falsone 1976, fig. 23, dallo Steri.17 Nel frammento da via Candelai i colori
appaiono invertiti, le spirali sono in blu.
305
Fig 8 – lustro serie “Ave Maria”.
Fig. 9 – graffita monocroma.
Fig. 11 – ceramica di Montelupo, genere “ovali erombi”.
Fig. 10 – graffita monocroma.
Fig. 12 – ceramica di Montelupo.
mente più numerosi appaiono quelli ri-feribili ai generi “blu graffito” (BERTI
1998, gen. 34, p. 131, primi decenni XVIsec.) e “motivi vegetali delle famigliebleu“ (BERTI 1998, gen.40, p. 147, primametà del XVI sec.), al quale ultimo pos-sono ricondursi un frammento di piatto
con il nodo orientale reso corsivamente(fig. 13 a) e un frammento di piatto conmotivi vegetali stlizzati (fig. 13, b)18.
Molto interessante, considerato il con-testo, il rinvenimento di un piatto quasicompleto con leone a d. che sorreggeuno stemma araldico con croce latina, suuno sfondo paesistico con pochi ele-menti vegetali stilizzati ed una ricca cor-nice con motivi fitomorfi incisi sul blu edaltri elementi decorativi del repertoriomontelupino (genere “blu graffito”19)(fig. 14). A giudicare dai fori per la ripa-razione effettuata in antico, che denotanouna lunga permanenza in uso dell’og-getto, poteva trattarsi di un piatto pregiatoda esposizione, forse eseguito su com-missione tra la fine del XV e i primi de-cenni del XVI secolo.
Sembra che nella US 9 sia assente lamaiolica ligure con smalto berettino, cheinvece compare negli strati immediata-mente successivi (UUSS 7-6), con produ-zioni ascrivibili alla seconda metà del XVI.In questi strati compaiono anche le cera-
18 Cfr. Ventura 2001, p. 294, n. 101219 Diam. cm 33,5. Cfr. BERTI 1998 gen. 34, p.
131, primi decenni XVI sec., nn. 124 e 126,
rispettivamente per l’elaborato motivo sulla tesa eper il soggetto animalistico (qui cavallo) sulfondo.
306
Fig. 13 a, b – ceramica di Montelupo.
Fig. 14 – piatto in ceramica di Montelupo.
miche smaltate bianche diffuse in contestidella seconda metà del XVI secolo20, dueframmenti di ceramica di Montelupo delleserie più recenti e, infine, un frammento dipiccolo mattone decorato in blu su fondobianco (il retro è liscio), che si colloca nel-l’ambito delle produzioni spagnole o ditradizione spagnola (fig. 15). Esso trova di-retti confronti con un pavimento dallachiesa di S. Maria di Gesù a Naso databilefine XV – inizi XVI secolo, di accertata im-portazione valenzana (REGINELLA 2003 p.77, fig. a p. 79; pp. 93-94), e con la paretedel palazzo Vacciuoli a Savona, an-ch’essa ritenuta di produzione spagnolae datata tra gli ultimi decenni del XV e iprimi del XVI secolo (GIANNOTTI 2007,pp. 66-67, figg. 4-5). Un confronto strin-gente si può fare anche con pavimentidel XV secolo ad Avignone, in Francia
(cfr. DEMIANS D’ARCHIMBAUD – VALLAURI
2000, p. 75, figg. 1-3)21. Se non ci sono dubbi sull’ampia dif-
fusione delle manifatture valenzane, nécirca la loro influenza sullo sviluppo diproduzioni locali autonome, come quellesavonesi del XVI sec. (BARILE 1975, pp.348-349; RAMAGLI - CAPELLI 2001, p. 281),o quelle provenzali, resta il fatto che, almomento, sulla base del solo esame ma-croscopico dell’argillla, non è possibileattribuire con certezza il manufatto aduna fabbrica definita22.
Sempre dagli strati più recenti (US 5)si segnala un frammento di scodella (fig.16) ingobbiata e dipinta in bianco e nerosu fondo rosso, esterno nudo, corpo ce-ramico micaceo di colore beige rosato; sitratta di una classe ceramica ancora di in-certa definizione, forse di importazione,
20 Smaltate bianche sono presenti, in ambitopalermitano, nei contesti riferibili alla seconda metàdel XVI secolo di Castello S. Pietro (ARCIFA 1994, p.234, tav. 1,1) e del Museo Archeologico “A. Salinas”di Palermo (LESNES 1997, p. 27 ).
21 Gli AA. lasciano aperta la questione sulla
individuazione della fabbrica, ipotizzando ancheuna possibile produzione locale.
22 Un aiuto a risolvere il problema della pro-venienza potrà venire dai risultati delle analisi petrografiche a cui il frammento è stato sottopo-sto.
307
Fig. 15 – mattone di importazione. Fig. 16 – scodella ingobbiata fine XVI – inizi XVII.
della quale si conoscono pochi frammentiprovenienti da area della Sicilia orientalein contesti di fine XVI – inizi XVII23.
STRUTTURA ABSIDATA
Concludiamo con alcuni repertiprovenienti dallo scavo della strutturaabsidata, soprattutto quelli dello stratoinferiore di riempimento (US 534), la
cui cronologia copre un periodo ab-bastanza ampio.
Segnaliamo due piatti quasi com-pleti di maiolica ligure in smalto be-rettino: il primo (fig. 17) condecorazione del tipo a quartieri24, con
23 Per gentile segnalazione della dott.ssa Fio-rilla: rinvenimenti a Gela (CL), Siracusa-Ortigia,
Catania, S.Cataldo (CL), Enna, Milazzo (ME). 24 FARRIS – FERRARESE 1969, p. 39, tav. X, fig. 3
308
Fig. 17 – piatto maiolica ligure da US 534. Fig. 18 – piatto maiolica ligure da US 534.
Fig. 19 – framm di anfora con impressioni digi-tali da US 534.
Fig. 20 – fornello da US 534.
25 FARRIS – FERRARESE 1969, p. 26, tav. IX,fig. 2
26 BERTI 1998, gen. 26, p. 121, 1490-1520. 27 BERTI 1998, GEN. 45, p. 168 ss, 1540-1580
309
Fig. 21 – brocca invetriata con manici a torti-glione da US 534.
Fig. 22 – ceramica di Montelupo da US 534.
Fig. 23 – maiolica ligure stile calligrafico naturalistico
paesaggi nel medaglione, è attestato aSavona (LAVAGNA 1992, p.138, fig. 11)prevalentemente nella seconda metàdel XVI sec.; il secondo (fig. 18)con il motivo sulla tesa derivato dal«Calligrafico a volute tipo C»25 abbi-nato al motivo della raggiera sulfondo, sembra un prodotto diffuso aSavona più che altro nella prima metà
del ‘500 (LAVAGNA 1992, p.138, fig. 8). I piatti erano associati a un fram-
mento di ceramica di Montelupo (fig.22) della serie “ovali e rombi” data-bile fine XV-inizi XVI26, e ad un fram-mento di piatto Montelupo serie«compendiario della famiglia blu» da-tabile nella seconda metà del XVI27.Gli altri reperti rinvenuti nello strato
sembrano essere alquanto più tardi, inquanto databili alla seconda metà delXVII secolo per confronto con mate-riali dello stesso tipo rinvenuti nelConvento dell’Annunziata della Zisa aPalermo (ARDIZZONE 1994).
Essi sono: alcuni frammenti di an-
310
Fig. 24 – terraglia di produzione italiana
fora acroma con superficie schiarita eimpressioni digitali sulle pareti (fig.19)28, un fornello portatile in terra-cotta (fig. 20)29, frammenti di ceramicaacroma con sovraddipintura in brunoe bianco di produzione palermitana(ARDIZZONE 1994, p. 237).
Quest’ultima classe ceramica sembraessere già prodotta a partire dalla secondametà del XVI, come si è visto nei contestidi Castello S. Pietro (ARCIFA 1994, p. 233).Nello stesso strato sono presenti alcuniframmenti di vasi con invetriatura verdescuro e manico a tortiglione (fig. 21).
Negli strati più recenti, infine, che do-cumentano le importazioni liguri ancoranel XVII secolo30, si rinvengono numerosiframmenti di stoviglie in maiolica liguresmaltata decorati in blu su fondo bianco,tra cui quelli in stile calligrafico naturali-stico (fig. 23) (Varaldo 1992, fig 11 p. 314,MILANESE 1992, fig. 6) databili nel XVII se-colo, e un contenitore cilindrico da di-spensa frammentario in terraglia biancacon decorazione a stampo (fig. 24) data-bile tra la fine del XIX e gli inizi del XXsecolo, di produzione italiana seriale (MA-RAZZONI 1956).
28 Cfr. ARDIZZONE 1994, p. 240, fig. 1, n.8. 29 diam. Base 20,5 alt.max 19, diam piano fo-
rato 12,5, cfr ARDIZZONE 1994, p. 240, tipo 15, fig. 2,
n. 13.30 Per la diffusione in Sicilia della maiolica li-
gure, MILANESE 1992, p. 212.
ARCIFA L. 1994, Palermo: scavo archeologiconel quartiere Castello S. Pietro, «Albisola»XXVII, pp. 231-236.
ARCIFA L. - LESNES E. 1997, Primi dati sulle pro-duzioni ceramiche palermitane dal X alXV secolo, in La céramique médiévale enMéditerranée, Actes du 6e congrès del’AIECM2 (Aix-en-Provence, 13-18 novem-bre 1995), Aix-en-Provence, pp. 405-418
ARDIZZONE F. 1994, La ceramica comune pro-veniente dal Convento dell’Annunziataalla Zisa di Palermo, «Albisola» XXVII, pp.237-242
BARILE C. 1975, Antiche ceramiche liguri. Ma-ioliche di Genova e Savona, Savona
BENENTE F. – PIOMBO N. 2001, Graffita mono-croma, in VARALDO 2001, pp. 242-251
BERTI F. 1998, Storia della ceramica di Monte-lupo. Uomini e fornaci in un centro di pro-duzione dal XIV al XVIII secolo, II. Leceramiche da mensa dal 1480 alla fine delXVIII secolo, Cinisello Balsamo
CUTERI F. A. 2007, Ceramiche invetriate di-pinte bassomedievali nella Calabria cen-tro-meridionale. Annotazioni su forme edecorazioni, «Azulejos», 4, pp. 179-206
DÉMIANS D’ARCHIMBAUD G. – VALLAURI L. 2000,Images du pouvoir, pavements de faïenceen France du XIIe au XVIIe siècle, Brou àBourg-en-Bresse
DI GIOVANNI V. 1889, La topografia antica diPalermo dal secolo X al secolo XV, vol. I,Palermo
FALSONE G. 1976, Gli scavi allo Steri, in Atti delColloquio Internazionale di ArcheologiaMedievale, Palermo-Erice, 20-22 settembre1974, Palermo
FARRIS G. – FERRARESE V.A. 1969. Contributoalla conoscenza della della itpologia edella stilistica della maiolica ligure del XVIsecolo, in Atti della società Ligure di StoriaPatria, ns. IX (LXXXIII), fasc. II, pp. 13-45
FIORILLA S. 2001, Primi dati sulla produzionee la circolazione ceramica fra XIII e XVsecolo a Messina alla luce dei rinvenimentidel municipio, in BACCI G.M., TIGANO G.,(a cura di), Da Zancle a Messina. Un per-corso archeologico attraverso gli scavi, II,
Messina, pp. 110-140GIANNOTTI R. 2007, Il laggione e l’architettura
savonese e ligure, in L. PESSA – E. MATTIA-DUA, (a cura di), Azulejos Laggioni. Cera-mica per l’architettura in Liguria dal XIVal XVI secolo, pp. 55-70, Genova
GOBBATO S. 2001, Smaltate di produzione spa-gnola. XIII-XV secolo, in VARALDO 2001,pp. 270 - 274
ISLER H. P. 1987, Monte Iato: la diciassettesimacampagna di scavo, «Sicilia Archeologica»,XX, 65, 29-48
ISLER H. P. 1995, in DI STEFANO C.A. – CADEI A.(a cura di), Federico e la Sicilia dalla terraalla corona. Archeologia e architettura,Palermo, pp. 121-150
JOHNS J. 2004, Una nuova fonte per la geogra-fia e la storia della Sicilia nell’IX secolo, inMélanges de l’École Française de Rome,Moyen Age, t. 116, 1, pp. 409-449
LA DUCA R. 1998, Norme edilizie nella Pa-lermo del Trecento, in Palermo medievale.Testi dell’VIII Colloquio Medievale, Pa-lermo 26-27 aprile 1989, Palermo, pp. 19-30
LAVAGNA R. 1992, Tipologie della maiolica li-gure del Cinquecento dagli scavi del Pria-màr a Savona, «Albisola» XXV, pp. 135-147
LESNES E. 1997, La recente ricerca archeologicanel museo, Quaderni del Museo archeolo-gico regionale “A. Salinas”, 3, pp. 17-61
MARAZZONI G. 1956, La terraglia in Italia, Mi-lano
MILANESE M. 1992, La maiolica ligure come in-dicatore archeologico del commercio di etàmoderna e la sua diffusione nei contestistratigrafici della Toscana, «Albisola» XXV,pp. 211-226
MOLINARI A. 1997, Segesta II. Il castello e la mo-schea (scavi 1989-1995), Palermo
PEZZINI E. 2001, Ceramiche dal butto di unastruttura privata nel quartiere della Kalsaa Palermo, «Albisola» XXXII – XXXIII, pp.149- 170
REGINELLA M. 2003, Maduni Pinti, CataniaRAMAGLI P. 2010, Il Medioevo: ceramiche dal
mondo islamico e bizantino e dalla Spa-gna, in “Ceramiche tra Oriente e Occi-
311
BIBLIOGRAFIA
dente. I reperti di epoca medievale e rina-scimentale delle raccolte civiche genovesi”,catalogo della mostra 15 maggio – 3 otto-bre 2010, Genova, pp. 12-24
RAMAGLI P.– CAPELLI C. 2001, Piastrelle smal-tate e invetriate, in VARALDO 2001, pp.275-289
SPATAFORA F. 2003, Nuovi dati sulla topografiadi Palermo, in Atti Quarte Giornate Inter-nazionali di Studi sull’Area Elima (Erice1-4 dicembre 2000), Pisa 2003, pp. 1175-1188
SPATAFORA F. 2004a, Nuovi dati preliminarisulla topografia di Palermo in età medie-vale, in Mèlanges de l’École Française deRome, Moyen Age, 116, 1, pp. 47-78
SPATAFORA F. 2004b, Palermo, La città punico-romana. Guida breve, Palermo
SPATAFORA F. 2005a, Panormos: scavi nell’abi-tato e alle fortificazioni, in Spanò Giam-mellaro A. (a cura di), Atti del V CongressoInternazionale di Studi Fenici e Punici(Marsala-Palermo, 2-8 ottobre 2000), II,Palermo, pp. 721-737
SPATAFORA F. 2005b, Da Panormos a Balarm.Nuove ricerche di archeologia urbana, Pa-lermo
SPATAFORA F. 2007, Vecchie e nuove ricerchearcheologiche nell’area della Casa deiPadri teatini, in PURPURA G. (ed), La Fa-coltà di giurisprudenza dell’Universitàdegli Studi di Palermo, Palermo, pp. 17-29
SPATAFORA F. 2009, Scavi e ricerche nel territo-rio di Palermo nel triennio 2004-2006, inAtti delle Seste Giornate Internazionali di
Studi sull’area elima e la Sicilia occiden-tale nel contesto mediterraneo (Erice 12-16ottobre 2006), Pisa, 623- 625
SPATAFORA F. c.d.s., Scavi e ricerche nel territo-rio di Palermo. Triennio 2007-2009, inAtti delle Settime giornate Internazionalidi Studi sull’area elima e la Sicilia occi-dentale nel contesto mediterraneo (Erice12-15 ottobre 2009), in c.d.s.
SPATAFORA F. – MONTALI G. 2006, Nuovi scavinell’area di Piazza della Vittoria, inOSANNA M. – TORELLI M. (edd.), Sicilia elle-nistica. Consuetudo italica. Alle originidell’architettura ellenistica d’Occidente,Roma, pp. 133-151
TULLIO A. 1997, Strumenti per la lavorazione dellozucchero a Maredolce (Palermo), in Archeo-logia e territorio, Palermo, pp. 471 – 479
TULLIO A. 1993, Cefalù, in Di terra in terra, Pa-lermo, pp. 241-250
VARALDO C. 1992, La maiolica ligure del Cin-quecento nello scavo della cattedrale di Al-benga, «Albisola» XXV, pp. 171-193
VARALDO C. 1994, Maiolica ligure: contributodella ricerca archeologica alla conoscenzadelle tipologie decorative del vasellame,«Albisola» XXVII, pp. 309-322
VARALDO C. 2001, Archeologia urbana a Sa-vona: scavi e ricerche nel complesso mo-numentale del Priamar. II.2 Palazzo dellaLoggia (scavi 1969-1989). I materiali,“Collezione di monografie preistoriche edarcheologiche”, Bordighera-Savona
VENTURA D. 2001, Maiolica del Centro Italia,in VARALDO 2001, pp. 290-297
312















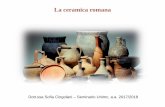






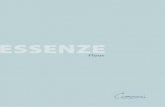

![Locuirea eneolitică târzie de la Oradea - str. Cireşilor [Late Copper Age Settlement from Oradea - Cireşilor Street], in Crisia, XLIV, 2014, 7-17](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6322db2264690856e10959ec/locuirea-eneolitica-tarzie-de-la-oradea-str-ciresilor-late-copper-age-settlement.jpg)





![con F. M. TOMMASI, Ceramica dipinta tardoromana dagli scavi nelle Catacombe di san Sebastiano sull'Appia [Roma]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631ed6b1dc32ad07f307c80a/con-f-m-tommasi-ceramica-dipinta-tardoromana-dagli-scavi-nelle-catacombe-di-san.jpg)