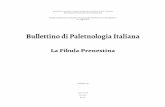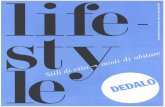karl Popper versus theodor Adorno: lições de um confronto histórico
Dallo scavo all’edificio. Esperienze di registrazione tridimensionale a confronto
-
Upload
univ-paris1 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Dallo scavo all’edificio. Esperienze di registrazione tridimensionale a confronto
2
archeologia virtuale: la metodologia prima del software Comitato Scientifico: Simone Gianolio, Sofia Pescarin, Davide Borra, Andrea D’Andrea, Fabio Remondino Redazione: Simone Gianolio Realizzazione grafica della sovracoperta: Alfredo Corrao L’edizione cartacea del volume è pubblicata da:
© 2012 – Espera s.r.l. Editoria e Servizi per Archeologi Via Fulvio Palmieri, 4 00151 Roma [email protected] www.archeologica.com Contattare la Libreria Archeologica di Roma per l’acquisto del volume al prezzo di €26 1° edizione
ISBN 9788890644313 Il volume viene distribuito in versione cartacea ed elettronica secondo la licenza Crea-
tive Commons, Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 3.0 Unported. Il lettore è libero di: riprodurre, distribuire, comunicare ed esporre in pubblico quest’ope-ra, a condizione che il suo contenuto non venga alterato o trasformato, che venga attri-buita la paternità dell’opera al curatore del volume e ai singoli autori dei contributi, e che l’opera non venga utilizzata per fini commerciali.
3
ARCHEOLOGIA VIRTUALE LA METODOLOGIA PRIMA DEL SOFTWARE
Atti del II Seminario
Palazzo Massimo alle Terme
(Roma, 5-6 aprile 2011)
a cura di
SIMONE GIANOLIO
5
INDICE
Indice .............................................................................................................. 5
Introduzione ................................................................................................... 7
D. FERDANI-F. OLARI-F. MALARAGGIA: Laus Pompeia tra spazio reale
e spazio virtuale ....................................................................................... 13
V. FIASCONARO-S. GUIDUCCI: Il progetto ARAS ......................................... 23
R. MANGANELLI DEL FÀ-P. PALLECCHI-C. RIMINESI: Il metodo micro-
fotogrammetrico per la catalogazione di reperti archeologici ................. 40
A. ARRIGHETTI-P. GILENTO: Dallo scavo all’edificio: esperienze di registrazione tridimensionale a confronto ............................................... 49
C. DEL VAIS-V. PINNA-I. SANNA: Tridimensionalizzazione dei rilievi
cartacei e virtualizzazione di un contesto archeologico subacqueo
di età fenicio-punica: il caso della laguna di Santa Giusta (OR) ............. 68
M. MANFRÉ: Misurazioni GNSS e modelli digitali del terreno applicati
allo studio di alcuni centri fortificati d’altura di età preromana .............. 86
D. DEGRASSI-D. GHERDEVICH-S. GONIZZI BARSANTI- G. MONTAGNER:
Itinerari storico-archeologici per la conoscenza del Friuli longobardo ... 95
L. BORDONI-S. PIERATTINI: Esperienze di fruizione virtuale del
patrimonio archeologico ........................................................................ 116
G. SCARDOZZI: Ricerche per la carta archeologica di Hierapolis di
Frigia (Turchia): indagini multidisciplinari integrate per la
ricostruzione di una città antica ............................................................. 131
E. DEMETRESCU: Modellazione 3D, visualizzazione scientifica e
realtà virtuale ......................................................................................... 147
6
A. CORRAO: La documentazione fotografica dei Beni Culturali:
comunicazione e scientificità ai tempi di Google.................................. 154
S. GIANOLIO: Modellazione tridimensionale e modelli digitali 3D in
archeologia ............................................................................................ 178
F. REMONDINO: Introduzione alla fotogrammetria digitale ........................ 190
S. GONIZZI BARSANTI-M. BRAINI: La carta archeologica su supporto
digitale. I casi di Trieste e Cividale del Friuli ....................................... 200
S.G. MALATESTA: @rcheoNet: una proposta di real time-multitasking
archeologico .......................................................................................... 219
G. LAGIONIS: Archeologia Virtuale: il contributo del Conservatore,
Due casi di studio: Villa dei Pisoni – Golfo di Baia (NA) .................... 222
Glossario fondamentale .............................................................................. 227
Tavole ......................................................................................................... 232
DALLO SCAVO ALL’EDIFICIO: ESPERIENZE DI REGISTRAZIONE TRIDIMENSIONALE A CONFRONTO
INTRODUZIONE Lo stato attuale di un edificio storico viene definito dagli archeo-
logi struttura materiale; essa riveste un’importanza fondamentale in quanto fonte principale di “lettura” da cui scaturiscono tutte le informa-zioni registrate sull’edificio. La registrazione delle sue caratteristiche, sia esso un Complesso Architettonico oppure un Sito Archeologico, richiede strumenti che siano in grado di fornire la maggior quantità possibile di dati, a prescindere dalle finalità disciplinari. La registrazione deve cioè essere effettuata in modo tale da fornire elementi utili ad analisi che pos-sano avere finalità differenti: analisi strutturali, studio delle tecniche co-struttive, restauro, evoluzione edilizia, ecc.
La tecnologia oggi ci offre alcune strade percorribili; la scelta di questi percorsi dipende da molti fattori: economici, tecnico-pratici, socia-li o semplicemente mentali.
Con questo contributo vengono presentate, attraverso una serie di esperienze effettuate negli ultimi anni dal Laboratorio di Archeologia dell’Architettura e Restauro1 dell’Università di Siena, in collaborazione con la Menci Software
2, alcune delle possibili vie che possono essere percorse, sottolineando i risultati raggiunti, i problemi incontrati e, ove possibile, risolti. Naturalmente, non si vuole promuovere una tecnologia piuttosto che un’altra (laser scanning o fotogrammetria), anche perché quasi sempre l’integrazione3 delle medesime è la strada più produttiva; l’intento è piuttosto mostrare, attraverso esempi concreti, una metodolo-gia di registrazione del patrimonio storico costruito rappresentata da un software, basato sulle leggi della fotogrammetria, in grado di elaborare immagini digitali che generano nuvole di punti RGB e modelli 3D a re-stituzione fotografica.
1 http://www.laarch.unisi.it
2 Per maggiori informazioni sulla tecnologia sperimentata vd http://www.menci.com 3 REMONDINO et alii 2009.
50
LA REGISTRAZIONE DELLA STRUTTURA MATERIALE Le dinamiche di lavoro delle discipline archeologiche sono in con-
tinua evoluzione. L’Archeologia dell’Architettura, ad esempio, in questi anni si è sempre più legata ad interventi di monitoraggio e restauro dei beni architettonici, ponendosi come strumento essenziale in cantieri di re-stauro, progetti di ricerca (archeologica, storico-costruttiva, ecc.) ed atti-vità di tutela (come ad esempio la prevenzione del rischio sismico o il monitoraggio dello stato di conservazione di interi siti archeologici, vedi il caso di Pompei).
Dotarsi di metodologie adattabili a contesti eterogenei è quindi, ad oggi, una prerogativa imprescindibile per chi si occupa di rilievo ar-cheologico. Il mercato offre la possibilità di poter scegliere molti stru-menti di rilievo rapidi, più o meno economici e precisi.
Risulta poi importante sottolineare che questo “rinnovamento tec-nologico” tende a modificare anche l’approccio e la prassi operativa nella documentazione archeologica ed architettonica. Nel nostro caso, ad e-sempio, l’operatore, dopo aver registrato sul campo tutti i dati dell’e-dificio (pareti, solai e tetti, aperture, elementi decorativi, ecc.), è in grado di lavorare e fare le sue osservazioni in laboratorio su di una superficie tridimensionale a diversi livelli di definizione. Inoltre, vi è la possibilità di un’efficace e realistica esplorazione del modello 3D della struttura. Modello che si può considerare il prodotto di una serie di operazioni di registrazione, elaborazione e catalogazione dei dati che devono essere re-si fruibili al più ampio numero possibile di gruppi di ricerca (archeologi, architetti, storici dell’arte, restauratori, ingegneri) anche con finalità mol-to differenti, sia oggi che in futuro. Per questo motivo viene anche af-frontato il problema della quantità e qualità delle informazioni, nonché della loro conservazione ed utilizzazione nel tempo.
RAPPRESENTAZIONE DELL’EVOLUZIONE STORICO/COSTRUTTIVA DI UN
EDIFICIO Ricostruire l’evoluzione di un’architettura nel tempo è spesso
un’operazione molto complessa. In genere, un edificio è l’insieme di a-
51
zioni costruttive, di ripensamenti e cambiamenti nel progetto iniziale, nonché di crolli e ricostruzioni dovute a fattori antropici (demolizioni) o naturali (ad esempio i terremoti). Tutte queste informazioni si registrano nella struttura stessa dell’edificio e devono essere attentamente indivi-duate e decodificate.
Il problema della rappresentazione del passare del tempo è molto sentita in campo archeologico, proprio perché si occupa della inter-pretazione stessa dei segni lasciati sulle superfici orizzontali e verticali dell’edificio. Si tratta di riconoscere non solo l’evoluzione costruttiva di una fabbrica, ma anche la sua dinamica strutturale e funzionale. Dalla storia costruttiva si può infatti risalire a molti dati utili ad un eventuale progetto di conservazione.
Nell’indagine delle strutture murarie, ad esempio, un accurato rilie-vo è necessario, non solo a documentare le caratteristiche formali di una struttura, ma a comprenderne la logica costruttiva che ha presieduto alla sua realizzazione4. Avere pertanto la possibilità di registrare il dato ma-teriale attraverso i dati metrici tridimensionali assieme a quelli cromatici, fornisce uno strumento ideale per arrivare ad un grado di approfondimen-to sufficiente delle vicende costruttive della fabbrica antica.
Naturalmente, la quantità di informazioni che possono essere rica-vate dalla documentazione a nostra disposizione dipende dal grado di ap-profondimento a cui vogliamo arrivare nella lettura dell’edificio, dalla preparazione e dagli interessi dell’operatore. Sarà proprio l’interpretazio-ne dell’operatore che guiderà la redazione dei modi di utilizzo dei dati (rilievi grafici, osservazioni sulle superfici, cinematismo del degrado, ve-rifiche dimensionali, ecc.). La possibilità, infatti, di un utilizzo diacroni-co del modello da parte anche di operatori con bagagli culturali e prepa-razioni differenti, risulta uno dei vantaggi delle nuove tecnologie, at-traverso cui ad esempio può essere mappato e controllato l’avanzamento o la buona riuscita di un intervento di consolidamento a distanza di anni. Si pensi a Pompei, un grande sito archeologico che potrebbe essere moni-
4 MANNONI 1991.
52
torato in modo molto rapido e con costi relativamente bassi, rispetto alle necessità degli interventi di messa in sicurezza o di restauro.
METODOLOGIA DI RILIEVO
Il lavoro sul campo. La metodologia utilizzata per la registrazione della struttura materiale riguarda in primo luogo l’acquisizione dei dati attraverso una campagna fotografica delle superfici e delle strutture ar-chitettoniche che compongono l’edificio. I fattori che incidono forte-mente sul progetto di presa fotografica possono essere suddivisi in fattori
oggettivi, ossia le dimensioni dell’edificio da rilevare, le condizioni di il-luminazione, le condizioni generali dove il sito è collocato (ambiente ur-bano, area isolata, presenza della vegetazione), le modalità di presa (sen-sore complanare o fortemente incidente alla superficie dell’edificio), e fattori soggettivi, legati alla scala di risoluzione richiesta dalle specifiche del rilievo. Se la risoluzione del modello deve essere elevata, la camera fotografica sarà più vicina all’edificio; una maggiore vicinanza alle su-perfici richiede una distanza dall’oggetto, dai 50 cm ai 3/4 m (a seconda dell’obiettivo impiegato), che incide fortemente sulla quantità di foto-grammi necessari per ottenere il modello completo. Il sopralluogo risulta lo strumento migliore per conoscere l’edificio e quindi pianificare il pro-getto di presa fotografica.
La campagna fotografica si appoggia ad un rilievo topografico, con cui vengono determinate le coordinate delle marche fiduciali (targets) posizionate precedentemente sulle superfici da rilevare. La realizzazione di un rilievo topografico (anche se non obbligatoria) aiuta in modo deter-minante tutto il lavoro di elaborazione e restituzione ed è lo strumento di controllo esterno al programma. Naturalmente il rilievo fotografico può essere effettuato anche senza marche fiduciali, in questo secondo caso però il lavoro di laboratorio comporta un ulteriore passaggio (vedi oltre) per l’elaborazione dei dati. Sul campo vengono realizzate triplette foto-grafiche con una camera digitale posizionata su una barra metrica. Le ot-tiche calibrate utilizzate (20mm, 28mm e 60mm) variano in base alla de-
53
finizione richiesta e alle condizioni oggettive di ripresa. Devono essere pertanto studiate le migliori soluzioni per evitare forti distorsioni, zone d’ombra ed elevata disomogeneità cromatica. Le fotografie sono accom-pagnate da una scheda cartacea in cui vengono segnate le caratteristiche di presa (distanza sulla slide-bar e tipo di obiettivo) e la porzione di edi-ficio fotografata; questo lavoro addizionale, ma molto rapido sul campo, facilita e velocizza la fase di riorganizzazione delle informazioni in labo-ratorio.
Non si tratta infatti di realizzare delle fotografie per la generazione di ortofotopiani o per un più classico progetto di fotogrammetria mono-scopica, ma si tratta di fotogrammetria stereoscopica per cui risulta basi-lare la posizione dell’operatore, e quindi della camera, nel cogliere tutte le parti della struttura necessarie alla costruzione del modello.
Bisogna pertanto saper cogliere la tridimensionalità dell’oggetto e fotografare tutte le parti necessarie. È impossibile comunque fissare rego-le generali e bisogna trattare la registrazione sul campo caso per caso.
Il lavoro di laboratorio. La restituzione in laboratorio può essere
suddivisa in due fasi. Una prima riguarda l’elaborazione dei dati attra-verso l’utilizzo del programma (in questo caso ZScan di Menci Software) per la generazione di nuvole di punti. Dopo una prima rettifica automa-tica delle tre foto, l’operatore utilizza le coordinate geometriche (punti di controllo) per orientare le singole triplette. Successivamente, viene indi-viduata sulla foto l’area da generare e viene impostato il passo di rico-struzione della nuvola di punti in funzione del valore del GSD (Ground
Sample Distance)5. Nel nostro caso i modelli tridimensionali sono stati generati con un
GSD medio pari a 0,005 (5 mm) che corrisponde, nelle specifiche del-l’English Heritage, ad una scala 1:50. Naturalmente l’impostazione del
5 Nel telerilevamento il GSD è la dimensione nel mondo reale di quella parte del sogget-
to rappresentato da un pixel di un'immagine digitale. Nelle specifiche dello English
Heritage si raccomandano dei valori puntuali per la fotogrammetria su scale architet-toniche tipiche (1:50, 1:20, 1:10). Cfr. Metric Survey Specifications for Cultural Heri-
tage 2009.
54
GSD dipende dal tipo di elaborato finale richiesto dalla committenza. Un GSD impostato a 0,001, significherebbe avere la possibilità di generare piante o prospetti in scala 1:10, il problema è la gestione di nuvole di punti che in questo caso verrebbero generate dall’elaborazione di tutti i pixel dell’immagine, comportando un’eccessiva pesantezza del file.
Nel caso in cui il lavoro venga realizzato senza marche fiduciali, una volta generati i modelli tridimensionali, c’è un ulteriore passaggio che consente di orientare manualmente ogni singolo modello rispetto al precedente in relazione ad un piano stabilito dall’operatore. L’operazione avviene scegliendo sul modello tridimensionale da orientare un minimo di tre punti naturali presenti anche sul modello già orientato e registrato. Questa seconda opzione rende il lavoro di laboratorio più lungo e meno preciso metricamente; il programma consente comunque di calcolare e registrare la media dell’errore di ogni singolo modello orientato. Oltre una determinata soglia (ca. 4-5 cm) di errore il sistema automaticamente non consente l’elaborazione dei dati. Sono state effettuate varie espe-rienze di registrazione senza punti topografici che hanno comunque por-tato a risultati soddisfacenti nel caso in cui i modelli da unire non siano in numero eccessivo (più modelli vengono collegati manualmente e più l’er-rore medio si propaga sul modello generale) e le superfici da rilevare ri-sultino complanari al sensore della camera (vd Figg. 5, 6 e 7).
Le nuvole di punti vengono salvate in formato *.vtp. È inoltre pos-sibile salvare i singoli modelli in formato *Ascii XYZ ed *Ascii XYZ RGB; in questo caso l’estensione permette la portabilità dei file in altri programmi per la gestione di nuvole di punti o in semplici visualizzatori. Le esperienze finora realizzate hanno dato ottimi risultati per la gestione della nuvola di punti RGB con texture associata (le nuvole di punti sono state infatti esportate su un altro programma proprietario, Geomagic, e su un visualizzatore web, Cortona
6).
6 A Tal proposito vorremmo ringraziare per il supporto tecnico e per i suggerimenti il dott. Álvaro Rodríguez Miranda, UPV/EHU.
55
Cam
era
Sen
sore
Fu
ll F
ra
me
Ott
ich
e
An
golo
di
cam
po
Dis
tan
za
cam
era
/
ma
nu
fatt
o
Alt
ezza
La
rgh
ezza
Are
a
cop
eeta
Ris
olu
zio
ne
geo
met
rica
Ris
olu
zio
ne
tex
ture
Nikon D700
23,9x36,0 mm
12,1 MP
20 mm
94.53°
4 metri
4,67 m 6,62 m 30,96
m² 1,65 mm
0,20 mm
28 mm
75.42° 5,06 m 3,370 m 15,72
m² 1,19 mm
0,14 mm
60 mm
39.60° 1,61 m 2,015 m 3,24 m² 0,57 mm
0,07 mm
Tab. I Caratteristiche del progetto di presa con il rapporto tra Base e Altezza rispetto alle ottiche utilizzate. I dati riportati si riferiscono ad una situazione ideale in cui il sensore della macchina risulta perfettamente complanare alla superficie da rilevare
(PARENTI-VECCHI-GILENTO 2008, p. 19).
Una volta generati i modelli, la loro gestione avviene attraverso il
software ZMap. L’interfaccia di questo programma si avvicina molto a quelle dei software CAD ed infatti una delle funzioni principali è proprio quella di creare disegni vettoriali direttamente sulla texture 3D (Figg. 1 e 2). Il vantaggio di uno strumento di questo genere è quello di sfruttare non solo la tridimensionalità, ma anche la cromìa di un oggetto per regi-strarne e mapparne le caratteristiche.
Completezza e qualità della registrazione. La completezza della
registrazione è il risultato di vari fattori che intervengono sull’elaborato, sia prima che dopo la generazione dello stesso. La ricchezza della regi-strazione incide molto sul tipo di lavoro da realizzare. Nel caso dei rilievi di edifici storici le Linee Guida (MiBAC 2007), indicano lo standard da seguire. Le specifiche del MiBAC per il miglioramento sismico degli edi-fici storici prevedono, infatti, la realizzazione, dopo un primo rilievo spe-ditivo, di un rilievo analitico molto approfondito con particolare atten-zione alle tecniche di realizzazione e ai dettagli costruttivi.
Gli elementi dell’edificio da registrare possono essere così suddi-visi:
- Corpi di fabbrica
56
Figg. 1 / 2 Particolari del modello 3D con texture di una porta archi voltata
(Sesto Fiorentino – Firenze).
- Fasi costruttive
- Elementi strutturali - Lesioni e deformazioni
Le deformazioni della geometria architettonica e le lesioni sono u-
na parte integrante del rilievo perché rappresentano uno dei degradi strut-turali più importanti della fabbrica. È il metodo stesso della fotogram-metria che consente di rilevare questo tipo di danni senza astrazioni e, pertanto, risulta uno degli strumenti più adatti per il monitoraggio statico di un edificio storico7.
La gestione dei dati. La quantità di informazioni generate ed im-
magazzinate durante il processo di registrazione è enorme. Per questo motivo risulta fondamentale organizzare con criteri molto precisi, già quando si incomincia il lavoro, la gestione dei dati. Le fotografie infatti, 7 CUNDARI 1982.
57
portano con sé una serie di informazioni (metadati) che deve essere con-servata8. Oltre alle foto, esistono poi i punti topografici, i disegni realiz-zati durante la campagna e tutti i dati digitali generati dalle differenti ela-borazioni.
CASI STUDIO Negli ultimi anni, attraverso i progetti di ricerca portati avanti dal
LAArch, è stato possibile sperimentare il sistema di rilievo ZScan/ZMap su diversi contesti di studio. In particolare, i contesti analizzati possono essere ricondotti alle seguenti categorie:
Unità Topografiche: il rilievo effettuato in Giordania è stato rea-
lizzato nell’ambito della missione archeologica dell’Università di Siena “Building Archaeology in Jordan” nel sito di Umm as-Surab, Giordania Settentrionale. Il lavoro svolto si è concentrato sulla realizzazione di un modello tridimensionale del complesso architettonico, identificato attra-verso un’unità topografica (la UT 28), costituito dalla chiesa dei Santi Sergio e Bacco e da ulteriori corpi di fabbrica come il campanile/minare-to, il cortile della chiesa ed i probabili ambienti monastici (Fig. 3). Il fine è stato quello di avere a disposizione un rilievo della situazione attuale del complesso, attraverso cui ricostruire le vicende evolutive del sito. Il rilievo fotografico delle superfici è stato accompagnato dal classico rilie-vo topografico, con cui sono stati anche ridefiniti volumi e superfici po-co chiare nelle piante realizzate in precedenza. È stato così possibile in-tegrare e confrontare rilievi pregressi con rilievi aggiornati metodolo-gicamente.
Le difficoltà operative principali hanno riguardato la necessità di operare con luce diretta molto forte e superfici composte da un materiale da costruzione di colore scuro, il basalto. Si è lavorato pertanto con tempi di esposizione bassi e diaframma chiuso.
Sono state rilevate le superfici murarie esterne del complesso nella 8 RODRÍGUEZ MIRANDA et alii 2008.
58
Fig. 3 Rilievo wireframe 3D con caratterizzazione delle aperture. (Umm as-Surab –
Giordania).
loro interezza, le aperture, gli orizzontamenti e gli elementi decorativi ad una distanza variabile tra 1,50 e 3 metri. La scelta di effettuare foto ad u-na distanza così ravvicinata dalle superfici da rilevare è stata voluta con lo scopo di distinguere e caratterizzare in modo molto analitico le tec-niche costruttive. Dal modello tridimensionale a restituzione fotografica è stato elaborato un rilievo wireframe delle superfici, a cui si è aggiunta la creazione di ortofotopiani ad alta risoluzione dei prospetti, sia interni che esterni (Fig. 4). La possibilità di operare direttamente sul modello 3D ha fornito vantaggi nel complesso lavoro di caratterizzazione delle tecniche edilizie, in un caso, come quello giordano, dove i modi di costruire si so-no mantenuti quasi immutati per secoli e distinguere piccoli particolari, come l’impiego delle zeppe, diventa determinante. In questo caso lo strumento utilizzato si è dimostrato molto versatile, ha garantito infatti una buona riuscita anche in condizioni di luce particolari.
59
Fig. 4 Ortofotopiano e lettura stratigrafica dell’interno della chiesa (elaborazione Pietro
Caciagli). (Umm as-Surab – Giordania).
Complessi Architettonici e Corpi di Fabbrica: sono questi i casi
studio nei quali la metodologia è stata sfruttata in modo quantitativamen-te più rilevante, con sperimentazioni che non si sono concentrate solo su progetti di ricerca, ma anche su tesi di laurea, laboratori per studenti, ecc. La maggior parte dei contesti di studio può essere geograficamente com-presa fra Toscana (in particolare Siena e provincia di Firenze) e Abruzzo.
Nel caso toscano, le strutture analizzate hanno offerto la possibilità di produrre modelli 3D di contesti molto eterogenei; si è passati infatti da rilievi di interi volumi (sia esterni che interni), proponendo analisi gene-rali di contesto (es. analisi stratigrafiche tridimensionali di intere struttu-re), ad analisi specifiche (es. caratterizzazione delle tecniche costruttive), nelle quali l’elemento tridimensionale è stato aggiunto al consueto rilievo di dettaglio (Figg. 5, 6 e 7). Nel secondo caso, quello abruzzese, i rilievi si sono unicamente concentrati su due edifici colpiti dal sisma del 6 Apri-
60
le 2009. La sperimentazione della tecnologia ZScan/ZMap in questi con-testi, avvenuta pochi giorni dopo il sisma, è stata fortemente innovativa dal punto di vista della metodologia di lavoro e da quello dei risultati prodotti. Nel caso della chiesa di San Pietro a Coppito, danneggiata dal sisma ma non crollata, era richiesto un sistema di rilievo che permettesse di lavorare in sicurezza a debita distanza dalla struttura e che producesse elaborati utili ad analisi quantitative e qualitative della struttura.
Mediante la tecnologia ZScan è stato possibile effettuare prese fo-
tografiche sufficientemente lontane dall’oggetto, che hanno restituito i seguenti prodotti: ortofotopiani dei prospetti esterni (sui quali sono state effettuate analisi stratigrafiche e mappatura delle lesioni), DEM e sezioni (fondamentali per individuare spanciamenti e fuori piombo, difficilmente rilevabili in altro modo). Nel caso della chiesa di Castelnuovo, in gran parte crollata dopo il sisma, è stato invece possibile costruire un modello 3D dell’edificio prima e dopo la rimozione delle macerie, individuando i volumi relativi al crollo e proponendo un’analisi stratigrafica delle prin-cipali fasi costruttive della struttura venute in luce a causa del crollo di murature ed intonaci dalle superfici sia interne che esterne.
Fig. 5 Modello 3D della chiesa di San Bartolomeo a Carmignanello realizzato senza
l’ausilio di punti topografici. (Sesto Fiorentino – Firenze).
61
Figg. 6 / 7 Modello 3D e prospetto wireframe della chiesa di Santa Maria a Fabbrica
realizzati senza l’ausilio di punti topografici. (Vicchio – Firenze).
I due rilievi della chiesa di Castelnuovo, ovviamente effettuati in momenti diversi, sono stati poi integrati, proponendo un unico modello tridimensionale delle situazioni pre- e post-rimozione delle macerie, of-frendo così la possibilità di effettuare analisi incrociate dei due prodotti.
Fronti Stradali: la sperimentazione di rilievo di fronti stradali ha riguardato Palazzo Campatelli, edificio di San Gimignano (SI) proprietà del FAI, costituito da diversi Corpi di Fabbrica prodotti in un arco crono-logico compreso fra il Medioevo ed il Settecento. Il rilievo, richiesto per il successivo restauro del complesso, è stato effettuato su una superficie con un altezza massima di circa 27 metri ed una lunghezza complessiva di 33 metri. In un primo momento le prese fotografiche sono state realiz-zate da terra; ciò ha portato alla produzione di fotografie complanari per la parte bassa della struttura e molto scorciate per la parte alta. In questo caso però, data l’imponenza della struttura, in particolar modo della torre centrale, e del poco spazio a disposizione (le strade di San Gimignano hanno un’ampiezza di circa sei metri), nonostante l’appoggio topografi-co, le foto scorciate hanno creato un’elevata distorsione, producendo per-tanto in fase di restituzione modelli poco affidabili metricamente. La
62
scelta è stata perciò dirottata, in un secondo momento, sull’utilizzo di un cestello elevatore di 19 metri per le fotografie della parte alta dell’edi-ficio, producendo in questo modo un modello metricamente e morfologi-camente corretto in ogni sua parte. Da questo elaborato sono poi stati prodotti: un ortofotopiano dell’intero prospetto esterno, un modello wire-
frame 3D del prospetto rilevato (al quale sono state agganciate sezioni e piante prodotte dagli architetti dell’Ufficio Tecnico del FAI, al fine di creare un volumetrico interno dell’intero palazzo), sezioni verticali delle superfici esterne a precisione millimetrica (fondamentali per ricavare spanciamenti o fuori piombo).
Scavi Archeologici: in questo caso, la sperimentazione si è con-centrata su due scavi (Aiano-Torraccia di Chiusi e Baratti-Populonia) con l’intento di rilevare le superfici verticali portate alla luce e la stratigrafia visibile sulle sezioni. Nel caso di Baratti9 i risultati sono sorprendenti: i modelli riescono a riprodurre con grande accuratezza la cromìa degli strati visibili in sezione, arrivando ad apprezzare la più piccola distor-sione della sezione stessa, producendo in tal modo un modello 3D geo-metricamente fedele alla zona rilevata (Figg. 8 e 9). Per quanto riguarda il caso studio di Aiano-Torraccia di Chiusi10, villa romana con frequen-tazioni artigianali altomedievali, il rilievo si è concentrato su un ambiente triabsidato interno alla villa. Il risultato prodotto è un modello tridimen-sionale dell’intera struttura triabsidata (prospetti esterni, interni e creste dei muri) (Figg. 10 e 11), che offre la possibilità, disegnando sulla texture del modello, di creare una pianta 3D wireframe dell’ambiente. Passo suc-cessivo sarà la produzione del modello tridimensionale in fasi e la carat-terizzazione delle tecniche costruttive individuate.
9 Lo scavo è diretto dal Prof. Franco Cambi, che ringraziamo per la collaborazione.
10 Missione italo-belga guidata dal 2005 dall’Université catholique de Louvain, nell’am-bito del progetto internazionale “VII Regio. The Elsa Valley during Roman Age and Late Antiquity”, sotto la direzione scientifica del Prof. Marco Cavalieri, che ringra-ziamo per la collaborazione.
63
Figg. 8 / 9 Modelli 3D con texture di particolari dello scavo di Baratti-Populonia
(Populonia - Livorno).
Fig. 10 Modello 3D con texture del prospetto interno di un abside del sito di Aiano –
Torraccia di Chiusi. (San Gimignano - Siena).
Ambienti di cava: un’ulteriore sperimentazione della tecnologia ZScan è avvenuta presso le cave della Necropoli etrusca di Populonia11. Il rilievo di un ambiente di cava risulta molto complicato, soprattutto a li-vello rappresentativo, in quanto composto da numerose superfici che fra di loro instaurano complessi rapporti stratigrafici; inoltre vi è l’esigenza da parte dell’operatore di rappresentare non solo i piani individuati, ma an-che le tracce degli strumenti utilizzati per la cavatura. A Populonia, la pos-sibilità di disporre di modelli tridimensionali ad alta risoluzione (Fig. 12) ha permesso da un lato di poter visualizzare il contesto in modo reale da diversi punti di vista (con la possibilità di mettere in evidenza in modo dettagliato le tracce lasciate dagli strumenti di lavoro sulle superfici) e
11
A tal proposito si veda la tesi di laurea di Elena Vattimo “Sperimentazione di tecniche
di rilievo per l’integrazione di dati differenziati. Il caso delle cave di calcarenite di
Populonia” discussa il 13 aprile 2011 presso l’Università degli Studi di Siena. Si rin-graziano Elena Vattimo e Cynthia Mascione per la collaborazione e la disponibilità.
64
dall’altro, mediante il disegno wireframe effettuato sul modello 3D, di porre in risalto con layer diversi la stratigrafia individuata.
Fig. 12 Visualizzazione del modello 3D per punti RGB del fronte 1 delle cave di calca-
renite di Populonia; il modello è stato realizzato processando 13 triplette di immagini (4256x2832 pixel; formato TIFF; peso 35.329 KB) e 80 punti d’appoggio.
Elaborazione Elena Vattimo - Università degli Studi di Siena, Laboratorio di Archeologia dell’Architettura (R. Parenti), Laboratorio di Disegno (C. Mascione).
Inoltre, la possibilità di produrre DEM e sezioni di superficie del
contesto ha facilitato molto la possibilità rappresentativa del sito e la pos-sibilità di analisi della morfologia delle superfici e dei segni lasciati dagli strumenti da lavoro.
Concludendo, l’applicazione della tecnologia ZScan/ZMap nelle diverse situazioni incontrate, ha permesso di conoscere nel dettaglio limi-ti e caratteristiche di questo strumento. La metodologia è risultata estre-mamente versatile e ha prodotto risultati soddisfacenti sia nei “tipici” contesti archeologici, che nei casi di studio “atipici” (che richiedono cioè particolari accorgimenti a livello di sicurezza, velocità di esecuzione, ecc.).
I rilievi archeologici “classici” (analisi stratigrafica, caratterizzazio-ne delle tecniche costruttive, ecc.) e le analisi di dettaglio (spanciamenti, fuori piombo, distacco di intonaci, dislocazione di conci, ecc.) prodotti su modelli cromaticamente corretti e metricamente affidabili, hanno avuto
65
una ricaduta positiva non solo a livello archeologico, ma anche a fini re-staurativi, architettonici, ecc. In alcuni contesti, si sono potuti osservare alcuni limiti della tecnologia, ovvero la difficoltà nel creare modelli da foto non complanari (che generano molto rumore nel modello creato) e da superfici troppo chiare ed omogenee (come quelle completamente in-tonacate).
CONCLUSIONI
La possibilità di integrare le tecnologie oggi a nostra disposizione, assieme alla necessità di utilizzare nel migliore dei modi i prodotti digi-tali creati da queste stesse tecnologie, risulta il passo fondamentale per arrivare ad un obiettivo comune: conoscere ciò che stiamo registrando per conservarlo e promuoverlo, seguendo l’idea che oggi un monumento non è più solo un oggetto da conoscere in se stesso, ma diventa parte atti-va della società, trasformandosi in un generatore, non solo di risorse cul-turali, ma anche economiche e sociali. La sfida del prossimo futuro sarà quindi quella di creare un sistema sicuro per la circolazione e la fruibilità di questi dati. Un altro punto da affrontare è poi quello della codifica di metodologie standardizzate di lavoro sull’ampia gamma di modelli digi-tali a nostra disposizione, che consentano di produrre una documentazio-ne omogenea del Patrimonio Culturale. Altra nota importante, oltre alla gestione e l’organizzazione dei dati, è la conservazione degli stessi. Bi-sogna essere perfettamente consapevoli che il materiale oggi prodotto è ancora utilizzato in percentuale molto bassa rispetto alle potenzialità che intrinsecamente contiene. Il rapido sviluppo della tecnologia consentirà nel giro di poco tempo un loro migliore utilizzo e, fino a quel momento, tutti questi dati devono essere debitamente conservati. Problematica risul-ta ancora la gestione di nuvole con milioni di punti. I visualizzatori di-sponibili sul web, e gratuitamente scaricabili, costituiscono una risorsa ancora da sondare in tutte le sue possibilità.
ANDREA ARRIGHETTI – PIERO GILENTO
Università degli Studi di Siena Laboratorio di Archeologia dell’Architettura e Restauro - www.laarch.unisi.it
66
ABSTRACT
La “descrizione” della struttura materiale richiede un alto grado di oggettività in funzione degli interessi scientifici di alcune discipline (documentazione archeologica, conservazione e restauro, tutela dei Beni Culturali). Il dato geometrico e la documenta-zione fotografica delle superfici risultano gli strumenti migliori per una registrazione efficace, chiara ed oggettiva di un manufatto architettonico e di altre manifestazioni an-tropiche. In particolare, la completezza e la diacronia della documentazione fotografica si sono sempre dimostrate essenziali nella registrazione della struttura materiale di edifi-ci storici. L’avanzamento tecnologico ha messo inoltre a disposizione della comunità scientifica alcuni prodotti da cui si ottengono modelli che, non solo hanno la grande proprietà di rappresentare fotograficamente, con una definizione elevata, le superfici, ma sono anche corretti geometricamente nelle tre dimensioni. In questo modo, la docu-mentazione della struttura materiale risulta molto più completa e risponde alle esigenze di una documentazione rapida, ma al contempo ricca di tutte le informazioni necessarie per un’analisi approfondita dell’oggetto.
BIBLIOGRAFIA
ANDREWS 2009: D. Andrews (edited by), Metric Survey Specifications for Cultural
Heritage, Swindon 2009. http://www.english-heritage.org.uk/publications/metric-survey-specification/
CUNDARI 1982: C. Cundari (1982), Fotogrammetria architettonica, Edizioni Kappa, Roma 1982.
GHEZZI-SANTARSIERO 2009: M. Ghezzi, D. Santarsiero, “ZScan: Scansione tridi-mensionale digitale”, in Archeomatica 0 (2009), pp.38-40.
MANNONI et alii 1991: T. Mannoni, A. Cagnana, S. Falsini, P. Ghislanzoni, D. Pitta-luga, “Archeologia ed archeometria dei muri in pietra. Superfici e strutture in Li-guria”, in G. Biscontin, D. Mietto (a cura di), Le pietre nell’Architettura: struttu-
re e superfici, Atti del Convegno di Studi, Bressanone 25-28 giugno 1991), Vo-lume 7 di Scienza e Beni Culturali, Padova 1991, pp. 151-162.
MIBAC 2006: Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del
patrimonio culturale, Gangemi, Roma 2006. PARENTI-VECCHI-GILENTO 2008: R. Parenti, A. Vecchi, P. Gilento, “Archeologia
dell’architettura e rischio sismico”, in Archeologia dell’Architettura XIII, All’in-segna del Giglio, Firenze 2008, pp. 15-28.
REMONDINO et alii 2009: F. Remondino, S. El-Hakim, S. Girardi, A. Rizzi, S. Benedetti, L. Gonzo, “3D Virtual reconstruction and visualization of complex ar-chitectures”, in The 3D-ARCH project. Proceedings of the 3rd ISPRS Inter-national Workshop 3D-ARCH 2009, Trento.
67
RODRIGUEZ MIRANDA et alii 2008: A. Rodríguez Miranda, J.M. Valle Melón, A. Lopetegi Galarraga, “Time transcendence, metadata and future utilization in 3D models of point clouds for heritage elements”, in R. Verghieux, C. Delevoie (ed-ited by), Archéovision 3. Actes du Colloque Virtual Retrospect 2007, Bordeaux 2008, pp.115-123. http://archeovision.cnrs.fr/pdf/vr07_pdf/07_galarraga.pdf
236
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Tavola V Esempi di elaborati. a e b: rispettivamente ortofoto e DEM delle absidi della
chiesa di San Pietro (AQ). c e d: modelli tridimensionali a restituzione fotografica di
due elementi architettonici della chiesa dei Santi Stefano e Silvestro, Castelnuovo (AQ).
e: texture 3D di una finestra decorata del Monastero de San Prudencio de Monte
Laturce, La Rioja, Spagna. f: digitalizzazione in tre dimensioni direttamente sulla
texture a risoluzione fotografica.