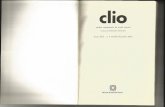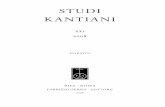STRUTTURE SEMANTICHE DI MODELLI DIGITALI 3D DI OPERE PALLADIANE
Archivi digitali sulla cultura ebraica: da “Stella di David e Tricolore” e “Judaica...
-
Upload
ephe-sorbonne -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Archivi digitali sulla cultura ebraica: da “Stella di David e Tricolore” e “Judaica...
CENTRO RICERCHE DI STORIA RELIGIOSA IN PUGLIA
Storia Arte Devozione
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
© 2013 Progedit
Prima edizione maggio 2013
Progedit – Progetti editoriali srl
Via De Cesare 15 – 70122 Bari
Tel. 0805230627
Fax 0805237648
www.progedit.com
e-mail: [email protected]
ITINERARI
CENTRO RICERCHE DI STORIA RELIGIOSA IN PUGLIA
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
a cura diDora Donofrio Del Vecchio
Arte Cultura Società
nell’Ottocento meridionale
Studi per i 25 anni di fondazionedel Centro Ricerche di Storia Religiosa in Puglia
Progedit
ISBN 978-88-6194-172-4
Proprietà letteraria
Progedit – Progetti editoriali srl, Bari
Finito di stampare nel maggio 2013
presso Arti Grafiche Favia srl
Modugno (Bari)
per conto della
Progedit – Progetti editoriali srl
Centro Ricerche di Storia Religiosa in Puglia
Via Ravanas, 99 – 70123 Bari
Tel. 0805792435 – 0805301790 – 3331399478
PresidenteMimma Pasculli Ferrara
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
VicepresidenteDora Donofrio Del Vecchio
Referenze fotograficheIl materiale iconografico, ove non indicato,
è stato fornito dagli autori dei rispettivi saggi.
INDICE
Prefazione di Mimma Pasculli Ferrara ix
Introduzione di Dora Donofrio Del Vecchio xi
Sezione prima
IL REGNO DELLE DUE SICILIE E IL MEZZOGIORNO
NELLA STORIOGRAFIA, NELLA LETTERATURA E NELLE FONTI
Regno delle Due Sicilie, Mezzogiorno e Unità d’Italia. Alcune riflessioni
storiografiche di Angelantonio Spagnoletti 3
Il brigantaggio nella letteratura di Raffaele Nigro 13
Le radici storiche della “diversità” meridionale di Giuseppe Poli 24
Fonti per la storia della Capitanata dall’Unità ad oggi: gli archivi della Prefettura
di Foggia e delle Sottoprefetture di Bovino e San Severo di Maria C. Nardella 40
Sezione Seconda
LA “TRANSIZIONE” E LE NUOVE INFRASTRUTTURE NELLA SECONDA
METÀ DEL XIX SECOLO
Note sul mutamento istituzionale ed amministrativo nel Mezzogiorno con l’Unità
d’Italia di Viviano Iazzetti 51
Altamura, 30 agosto-8 settembre 1860. Il primo governo provvisorio in Terra di
Bari di Maria Letizia Berloco, Tommaso Berloco 62
Vincenzo Rogadeo e la provincia di Terra di Bari dalla dittatura di Garibaldi
alla luogotenenza di Farini (settembre-novembre 1860) in trentuno documenti
inediti di Rosario Jurlaro 89
Note storiche sull’evoluzione della “vita politica e sociale in Terra di Bari durante
l’epopea garibaldina” (1860-1866) di Giuseppe Dibenedetto 112
La Provincia di Bari ente periferico del nuovo Stato: viabilità e nuove
infrastrutture di Teresa De Francesco 120
La Capitanata nella “Statistica” Scelsi del 1867 di Rina Di Giorgio Cavaliere 128
L’impresa di Felice Garibaldi e il Risorgimento in Puglia di Riccardo Riccardi 137
Sezione terza
SOCIETÀ E CULTURA
Tra prammatiche e codici. Note su donna e famiglia nel Mezzogiorno d’Italia
dal Settecento all’Unità di Elena Papagna 147
vi Arte Cultura Società nell’Ottocento meridionale
La scuola postunitaria in uno scritto inedito del 1868 indirizzato
a Niccolò Tommaseo di Luciana Del Vecchio 156
“Una d’arme, di lingua, d’altare”. L’unificazione terminologica del vocabolario
militare nel XIX secolo di Lucia Cristina Larocca 167
La regina Margherita: la “regina borghese” di Cinzia Petrarota 174
Del melodramma risorgimentale di area meridionale: Mercadante e De Giosa
di Pierfranco Moliterni 184
Il plebiscito dell’Abruzzo nel dipinto di Enrico Gamba e nelle vicende conclusive
dell’Unità d’Italia di Vittorio Casale 192
Presentazione della Mostra “Cinema 150 anni” di Anna Vita Perrone 205
Presentazione della mostra documentaria “La Chiesa, la città di Bari e l’Unità
d’Italia” di Carla Palma 211
Archivi digitali sulla cultura ebraica: da “Stella di David e tricolore” e
“Judaica Europeana” alle esperienze recenti di Mariapina Mascolo 218
Sezione quarta
LE “IMPRESE”. PATRIOTI ED EROI
I pugliesi alla Spedizione di Sapri di Antonietta Latorre 231
Eroi e patrioti della Murgia tarantina e di Terra d’Otranto di Raffaella Bongermino 249
Salvatore Morelli, patriota in Terra di Brindisi di Antonella Golia 263
I Mille ed i garibaldini di Capitanata di Dora Donofrio Del Vecchio 271
La Free Church scozzese per la sanità militare garibaldina
di Alfredo Musajo-Somma, Laura Musajo-Somma 285
Sezione quinta
“O EMIGRANTI O BRIGANTI”
Il 3 settembre 1860 a Bitetto di Rosa Antonacci 295
Brigantaggio e repressione di Carmen Morra, Giuseppe Schinco 310
La difficile fase della regolamentazione legislativa del fenomeno migratorio.
La situazione in Capitanata di Maria Rosaria Tritto 317
Sezione SeSta
IL DIFFICILE RAPPORTO TRA STATO E CHIESA
Cenni sulla politica anticlericale del Piemonte. I Terziari e la società. Inedito
documento del Terz’Ordine francescano di Antonio Alemanno, Vito Fumarola 335
Vincenzo Materozzi, un vescovo filoborbonico del Mezzogiorno di Stefano Milillo 350
Governo pastorale e soppressioni monastiche postunitarie a Lucera
di Massimiliano Monaco 362
La soppressione del monastero della SS.ma Annunziata di Matera e la dispersione
del suo patrimonio culturale di Maria Teresa Cascione 376
Indice vii
Sezione Settima
L’UNESCO E “IL PAESAGGIO URBANO STORICO”.
NOTE SULLA MEMORIA STORICA TRA TUTELA, RESTAURI
E GIARDINI PUBBLICI
La “Raccomandazione sul Paesaggio Urbano Storico” dell’UNESCO
di Elena Cattarini Léger 387
L’architetto napoletano Giovanni Castelli: il Palazzo Ateneo e i suoi “giardini
storici” nel cuore della Bari murattiana di Mimma Pasculli Ferrara, Franco Macchia 398
Ferdinand Gregorovius e la salvaguardia dei beni artistici e della memoria storica
nell’Italia postunitaria di Teodoro Scamardi 413
Architettura dell’Unità. Note in margine ad una mostra di Fabio Mangone 438
Restauri, completamenti e ricostruzioni “in stile” del secondo Ottocento. Esempi
in Italia e in Puglia di Nicoletta Ingelido 443
Prime opere urbanistiche ed igienico-sanitarie a Noicattaro dopo l’Unità
di Leonardo Petrosino 451
Bibliografia generale 461
Gli autori 485
Premessa
Ispirato al centocinquantenario dall’Unità d’Italia, il progetto “Stella di David e tricolore” (http://www.culturaitalia.it/opencms/static/stella_di_david_e_tricolore/index_it.jsp) presenta nei suoi contenuti le riflessioni sull’apporto della presenza ebraica al processo di definizione della nascente identità nazionale italiana. All’im-portante contributo della minoranza ebraica al processo di costruzione dello Stato unitario è stato dedicato nel 2010 il congresso quadriennale organizzato dall’U-CEI – Unione Comunità Ebraiche Italiane, aperto dall’intervento della storica Anna Foa1 (Università Sapienza di Roma) e incentrato sul “processo di emancipazione ebraica caratterizzato come adesione alla patria italiana, come assimilazione a un sistema di valori”.
Anna Foa ha evidenziato come l’intreccio tra i due processi di emancipazione (degli ebrei) e di identificazione (con lo Stato italiano) abbia origini risalenti nel tempo, testimoniate dal “profondo radicamento del mondo ebraico italiano” e dal “fatto che dall’antichità romana in poi gli ebrei d’Italia, o almeno una gran parte di essi, restassero cives romani, sia pure di seconda categoria”. Arrivando ai tempi moderni, altro punto nodale – secondo la Foa – “risiede nella natura stessa del Risorgimento italiano e della cultura che lo permea: lontana, almeno nei primi de-cenni, dalle chiusure nazionalistiche che caratterizzano paesi come la Francia o la Germania, aperta a una visione più ampia e cosmopolita, di impronta mazziniana, ostile alla Chiesa per motivi sia politici, il suo essere ostacolo primo al processo uni-tario, che ideologici, il rifiuto da parte della Chiesa della tolleranza religiosa, della
ARCHIVI DIGITALI SULLA CULTURA EBRAICA: DA “STELLA DI DAVID E TRICOLORE” E “JUDAICA EUROPEANA”
ALLE ESPERIENZE RECENTI*
di Mariapina Mascolo
* Si ringraziano Maria Teresa Natale e Marzia Piccinnino (MiBAC-ICCU), intervenute al conve-gno “Memoria storica e web: Judaica Europeana” (Bari, 26 gennaio 2012) organizzato dalla So-printendenza Archivistica per la Puglia nell’ambito del Mese della Memoria, promosso dalla Regione Puglia – Assessorato al Mediterraneo in collaborazione con i Presìdi del Libro; si ringraziano, inol-tre, Raffaella Rodomonti (ICCU, progetto “Judaica Europeana”) e Nicola Ruggieri (IBAM/CNR, progetto “Stella di David e tricolore”), che hanno presentato i progetti relativi alla digitalizzazione degli Archivi sull’Ebraismo nel convegno “Il Mezzogiorno, la Puglia e la memoria storica nel pro-cesso di Unificazione nazionale” (Bari, 1-3 dicembre 2011).
1 A. foa, intervento al congresso UCEI (Roma, 5-8 dicembre 2010), su http://www.culturaita-lia.it/opencms/it/contenuti/focus/focus_0901.html.
M. Mascolo, Archivi digitali sulla cultura ebraica 219
modernità, della pluralità dei culti”. La vicenda dell’emancipazione degli ebrei, convinti che il nascente Stato italiano li portasse a uscire fuori dal novero delle mi-noranze discriminate, vedrà in effetti “all’uscita dal ghetto” le affermazioni di molti ebrei soprattutto nella pubblica amministrazione, nella politica (in età giolittiana Ernesto Nathan diventa sindaco di Roma e Luigi Luzzatti presidente del consiglio dei ministri) e nella vita culturale e universitaria, “piuttosto che, come vuole un diffuso stereotipo, nel successo imprenditoriale”, rileva la storica Paola Magnarelli2. Al di là dei veri e propri approfondimenti storici sul ruolo dell’ebraismo nella for-mazione del processo nazionale (che durante le manifestazioni per il centocinquan-tenario dall’Unità hanno trovato specifica sede in altre iniziative), per offrire uno spazio alla conoscenza della storia e delle tradizioni dell’ebraismo dall’Unità d’Italia ai giorni nostri è stato realizzato il progetto “Stella di David e tricolore”, proposto dall’ICCU – Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche del Ministero per i Beni e le Attività Culturali nell’ambito di “CulturaItalia” (il portale del MiBAC dedicato alla cultura italiana). Lo spazio dedicato al ruolo della presenza ebraica nel contesto unitario è stato allestito in stile web 2.0: aperto ai contributi degli utenti di CulturaItalia, con testi, video, foto e audio sul contributo ebraico alla vita sociale, culturale e politica del Paese. Il progetto “Stella di David e tricolore” si è ispirato anche alla più complessa operazione di “Judaica Europeana” (http://www.judaica-europeana.eu/), un progetto europeo – finanziato nell’ambito del program-ma eContentplus – di cui l’ICCU è partner. A sua volta, “Judaica Europeana” nasce con “l’obiettivo di identificare contenuti digitali che documentino la presenza e il patrimonio ebraico delle città europee per renderli disponibili” sul portale3.
1. L’esperienza di “Stella di David e tricolore” e la situazione italiana
Nato con l’obiettivo di coinvolgere il maggior numero di cittadini e di istituzioni intorno al tema del ruolo della presenza ebraica in Italia dall’epoca del processo unitario ai giorni nostri, il progetto “Stella di David e tricolore” ha rappresentato anche un’occasione per avviare altri progetti di digitalizzazione di archivi sull’ebrai-smo, per approfondire questo campo della ricerca storica (ancora da indagare), per promuovere attività legate alla didattica nelle scuole in ordine alla divulgazione dei contenuti4. Il progetto raccoglie una vasta tipologia di file scansionati: pubblicazioni (libri, giornali, riviste); documenti; video.
Tra le riviste: “Ha Keillah” (Gruppo di studi ebraici di Torino; info: http://www.hakeillah.com), “Rassegna mensile di Israel” e (UCEI; info: http://www.ucei.it/
2 maGnarelli 2011, pp. 115-153. 3 piccininno 2012, pp. 145-150. 4 natale 2011, pp. 297 sgg. La metodologia adottata prevede le fasi: invio dei file da parte dell’utente alla redazione; selezione della redazione; formattazione; sottoscrizione di una liberatoria dell’utente in ordine all’autorizzazione rilasciata online secondo Licenza Creative Commons 2.5 By-Nc-Sa.
220 III. Società e cultura
default.asp?cat=7&cattitle=cultura&pag=84&pagtitle=rassegna_mensile_di_israel), «Shalom» della Comunità Ebraica di Roma (http://www.romaebraica.it).
Tra i volumi: La comunità ebraica di Roma nel secondo dopoguerra. Economia e società (1945-1965), a cura dell’Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma; Gli ebrei e la città: Fotografie dagli album di famiglia, di Paolo Battaglia e Federica Francesconi; Patrie dei superstiti. Letteratura ebraica del dopoguerra in Italia e in Polonia, di Laura Quercioli Mincer; La brigata ebraica in Italia 1943-1945, a cura di Bice Migliau e Ghila Piattelli.
Tra i video: il progetto del MEIS (Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah); il video della Fondazione del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea – CDEC (Una storia particolare. Ebrei in Europa tra Otto e No-vecento).
Tra i contributi musicologici: i testi di Gabriele Coen e Isotta Toso, di Moni Ovadia e di Ariela Bohm.
Il progetto legato al centocinquantenario – raccogliendo in modo trasversale adesioni in tutto il territorio nazionale – ha rappresentato per il MiBAC più che altro lo spunto per sensibilizzare enti e istituzioni a intraprendere percorsi di tutela e salvaguardia delle testimonianze riguardanti la cultura ebraica mediante la ripro-duzione digitale.
Il fenomeno delle digitalizzazioni di materiali in possesso di istituzioni di cultura (come biblioteche, archivi e musei), definito “Rinascimento digitale”5, richiede la ricerca continua di nuovi modelli6 per garantire facilitazioni di accesso ai materiali da consultare a distanza. Intorno a questo tema sono commissionate sempre nuove ricerche ed elaborate linee guida7, che coinvolgono tutti i siti e i portali riguardanti le digitalizzazioni di beni culturali e scientifici. In particolare, le Soprintendenze Archivistiche italiane fanno capo al sistema informativo unificato SIUSA8 e SAN.
Tra gli Archivi storici italiani che hanno intrapreso un importante percorso di digitalizzazione verso l’accessibilità in rete spicca l’Archivio della Comunità Ebraica di Mantova, che conserva materiali dal 1522 al secondo dopoguerra. Di questi sono consultabili sul web (http://www.adacta.fi.it/digitalib/archeb/) 84.200 immagini di documenti e volumi appartenenti a entrambe le due sezioni “Antica” e “Storica”. Le immagini si riferiscono a 42 Registri (6.365), 75 Volumi e 24 Pergamene (11.420), 52 Partiture Musicali (2.635), 11 Repertori (6.664), 69 Filze (57.116). La sezione “Storica” raccoglie il carteggio della Comunità in materia amministrativa, patri-moniale, di assistenza e istruzione, oltre a documenti della Commissione Israelitica di Culto e Beneficenza, delle Pie Case Israelitiche di Ricovero e Industria, di con-fraternite e istituti vari (il Pio Istituto Samuele Trabotti, i Consorzi Bikur Kolim, Nacim, Mazal Bedullà, la Pia Confraternita Kessed-El, l’Asilo Infantile Israelitico e
5 SpaGnolo 2011, pp. 251-265. 6 aGoSti 2012, pp. 47-56; aGoSti, ferro 2010, pp. 95-12; natale 2010, pp. 57-61. 7 http://www.minervaeurope.org/publications.htm; feliciati, natale 2009. 8 http://siusa.archivi.beniculturali.it; ciddio, taGlioli, di tota 2012, pp. 131-139; Bondielli 2001; athena wp3 “Working Group” (ed.) 2011; athena wp7 “Working Group” (ed.) 2011.
M. Mascolo, Archivi digitali sulla cultura ebraica 221
il Tempio Maggiore). L’Archivio digitale è ospitato sulla piattaforma della Biblioteca comunale Teresiana di Mantova, in cui dal 1931 – a seguito del deposito di par-te dei codici appartenenti alla Comunità – è stato costituito il fondo “Manoscritti Ebraici”, che comprende 161 codici databili fra il XIV e il XVIII secolo, con numerosi esemplari miscellanei (le 28.911 immagini a colori provengono da un precedente progetto di digitalizzazione, iniziato nel 1991 e concluso nel 2003).
La Soprintendenza Archivistica del Piemonte (http://www.sato-archivi.it/Sito/index.php/progetti/progetti-in-corso/archivi-ebraici.html) ha recentemente con-cluso un progetto (finanziato con la L. 175/2005 per la tutela dei beni culturali ebraici) relativo al censimento, al riordino e all’inventariazione degli Archivi delle Comunità ebraiche piemontesi ancora esistenti e di quelle estinte: Cuneo, Mondovì, Saluzzo, Carmagnola, Alessandria, Casale Monferrato, Biella, Trino, Vercelli, Tori-no. Le descrizioni di questi archivi – insieme a quelli delle scuole “Artom” e “Colon-na e Finzi” – saranno immesse sul web dal SIUSA. Lo stesso lavoro di censimento, riordinamento e inventariazione ha investito quasi tutti gli archivi delle Comunità ebraiche italiane.
Negli archivi e nelle biblioteche dell’Italia centro settentrionale il fenomeno del-la “sopravvivenza” dei manoscritti ebraici è collegato anche alla pratica del riuso, invalsa a partire dalla metà circa del Cinquecento fino a tutto il Seicento e anche ol-tre, per l’impiego nelle legature dei volumi. La pratica ha portato alla conservazione di frammenti di manoscritti ebraici databili tra X e XVI sec., quasi “riemersi” da una sorta di Genizah italiana, come l’ha definita Mauro Perani, direttore del Laborato-rio di Epigrafia e Codicologia ebraica (LECE) dell’Università di Bologna – Campus di Ravenna (http://www.beniculturali.unibo.it/DISMEC/Risorse+e+strutture/Laboratori/LECE.htm)9 e che ha lavorato per quasi trent’anni al progetto di recu-pero sistematico di censimento e catalogazione di frammenti di manoscritti ebraici medievali italiani (già circa 14.000), fondato nel 1981 da Giuseppe Baruch Ser-moneta (Hebrew University of Jerusalem) per il censimento, la catalogazione, il re-stauro e la fotoriproduzione dei frammenti di manoscritti ebraici medievali reperiti nelle biblioteche e negli archivi italiani. Mauro Perani, che presiede l’Associazione Italiana per lo Studio del Giudaismo (www.aisg.it), collabora – tra gli altri – con Josè Ramon Magdalena (Filologia Semítica, Università di Barcellona) al progetto nazionale Catalogna Ebraica III sul tema della circolazione dei manoscritti ebraici nel Mediterraneo ed è responsabile per l’Italia del progetto “Books within books: Hebrew Fragments in European Libraries” (http://www.hebrewmanuscript.com), diretto da Judith Olszowy-Schlanger (École Pratique des Hautes Études, Sorbon-ne, Parigi).
“Books within books” è una rete europea di studiosi che lavorano su fram-menti di libri ebraici medievali e documenti recuperati da legature e documenti notarili ritrovati nelle biblioteche e negli archivi europei (di: Austria, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Inghilterra, Italia, Polonia, Slovacchia, Spagna, Svizzera
9 perani 2013, pp. 9-15; id. 1999.
222 III. Società e cultura
e Ungheria) e israeliani. Anche qui si parla di “Genizah europea”, per analogia con la “miniera” di frammenti ebraici recuperati nella Genizah de Il Cairo. Il progetto, operativo dal 2007, prevede la realizzazione di una banca dati online accessibile agli utenti registrati.
Purtroppo, la forma di ritrovamento dei frammenti nelle legature è rarissima nel Sud Italia10, a causa delle vicende della presenza ebraica che vedono una cesura nella data dell’espulsione definitiva segnata nel 1541. Solo in seguito, dalla seconda metà del 1500 – come rileva Perani (Figg. 1-2)11 – “il fenomeno del riuso diviene massiccio e sistematico, ma a quell’epoca dalle principali regioni meridionali gli ebrei erano già stati espulsi o se n’erano già andati”, portando con loro – nella mi-sura del possibile – i manoscritti.
Nel Sud un progetto di digitalizzazione deve giocoforza rivolgersi – oltre che verso i rari manoscritti ebraici di provenienza meridionale sparsi in Europa – alle testimonianze fotografiche delle iscrizioni e dei manufatti e, naturalmente, alla pon-derosa mole di documenti notarili in latino e in volgare attestanti la presenza ebrai-ca sul territorio.
In gran parte il lavoro di recupero di queste testimonianze è stato opera di Cesare Colafemmina (Figg. 1-2) (Teglio Veneto, Venezia 23 aprile 1933 – Gru-mo Appula, Bari 12 settembre 2012), professore di Epigrafia e Antichità Ebraiche nell’Università di Bari (anni 1992-1999) e di Letteratura Ebraica nell’Università della Calabria (anni 2002-2006 e 2008-2009), che alla ricerca delle testimonianze sulla presenza ebraica nell’Italia Meridionale ha dedicato un’intera vita di studi, collaborando con il progetto “Italia Judaica” diretto da Shlomo Simonsohn alla Tel Aviv University (coordinatore del The Goldstein-Goren Diaspora Research Center (http://www1.tau.ac.il/humanities/ggcenter/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=26&lang=english).
Lo studioso pugliese ha fondato il CeRDEM – Centro di Ricerca e Documenta-zione sull’Ebraismo nel Mediterraneo “Cesare Colafemmina” (www.cerdem.com), a cui ha donato la biblioteca e il suo Archivio privato, dichiarato di importante interesse culturale dal MiBAC – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesag-gistici della Puglia (con Decreto del 6 agosto 2012, prot. 8170). Tra i programmi del CeRDEM: la catalogazione dell’Archivio privato e del Fondo bibliografico di Cesare Colafemmina, l’attuazione di ricognizioni sistematiche e catalogazioni di fonti e testimonianze sulla presenza ebraica nel Mediterraneo; la creazione di data base e la digitalizzazione dei materiali; gli allestimenti di mostre, l’organizzazione di convegni e in generale la promozione scientifica e sociale della cultura ebraica nel contesto del Mediterraneo (sia per gli aspetti storici che documentali, artistici, ar-chitettonici e altro) e degli aspetti multiculturali del territorio dell’Italia meridionale, in rapporto alle esperienze nazionali e internazionali e in dialogo con le altre culture.
Istituito nel 2007, il Centro di Studi Ebraici – CSE (http://www.iuo.it/index2.php?content_id=536&content_id_start=1) dell’Università L’Orientale di Napoli
10 id. 2011, pp. 31-51. 11 id. 2013, pp. 9-15.
M. Mascolo, Archivi digitali sulla cultura ebraica 223
organizza seminari, conferenze, convegni ed eventi culturali sulla storia e la cultura ebraica, con approccio critico e scientifico, aconfessionale, il coinvolgimento del pubblico e l’ausilio di docenti, relatori e ospiti nazionali e internazionali.
Il CSE pubblica la collana “Archivio di Studi Ebraici” e il periodico “Sefer Yuh.a sin”, bollettino dedicato alla storia degli ebrei in Italia meridionale, fondato da Cesare Colafemmina e diretto da Giancarlo Lacerenza (direttore scientifico del CSE).
Un progetto di digitalizzazione dei materiali sugli Archivi per l’Ebraismo è pro-mosso dalla Soprintendenza Archivistica per la Puglia (www.sapuglia.it) con l’ap-porto scientifico del CeRDEM “Cesare Colafemmina” e il sostegno della Fondazio-ne Cassa di Risparmio Puglia.
Il progetto è rivolto alla ricognizione di testimonianze e documenti in cui si evidenziano le presenze e le tracce della cultura ebraica – oltre che delle culture del Mediterraneo –, partendo da un nuovo approccio alle ricerche archivistiche con il sussidio della tecnologia (digitalizzazione e consultabilità informatizzata) e sperimentando strategie innovative nell’applicare i risultati della ricerca al turismo culturale. Sono coinvolte per studi e iniziative culturali le competenze legate al ter-ritorio (Università, enti pubblici, istituzioni e associazioni culturali) interessate a un programma in cooperazione, che parte dalla ricerca scientifica per approdare alla divulgazione e alla predisposizione di itinerari e di strumenti flessibili rivolti alla valorizzazione dei beni culturali.
Tra gli archivi sulla storia e documentazione dell’ebraismo contemporaneo in Italia spicca quello del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea – CDEC (http://www.cdec.it), dichiarato nel 1992 di notevole interesse storico dalla Soprintendenza per i Beni Archivistici della Lombardia. Il CDEC – costituito in Fondazione dal 1986 – nasce nel 1955 nell’ambito della Federazione Giovani Ebrei d’Italia (FGEI) al fine di promuovere “la ricerca e l’archiviazione di documenti di ogni tipo riguardanti le persecuzioni antisemite in Italia e il contributo ebraico alla Resistenza” e la loro divulgazione. La Fondazione CDEC, per statuto, è soggetta alla vigilanza dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (art. 17) e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (art. 18). Occupandosi di temi che spaziano dalla memoria alla didattica della Shoah in Italia, dall’antisemitismo al pregiudizio dal secondo dopoguerra ai giorni nostri, il CDEC si occupa di cinque settori di attivi-tà: Biblioteca (con 24.000 volumi); Archivio fotografico, con 23.000 immagini di ebrei in Italia dalla metà dell’Ottocento ai giorni nostri; Archivio storico, con fondi personali e di enti, raccolte di documenti per la ricerca sulla Shoah e sulla storia degli ebrei dalla fine del Settecento ai giorni nostri; Didattica della Shoah (con-sulenze e collaborazioni a progetti inerenti la didattica della Shoah); Osservatorio sul pregiudizio antiebraico (documenti, indagini demoscopiche e ricerche sui vari aspetti ed espressioni dell’ostilità e del pregiudizio antiebraico in Italia dagli anni Sessanta a oggi); Videoteca, con documentari storici, film, inchieste e rubriche te-levisive sui temi della cultura e della storia ebraica contemporanea. Nelle modalità di trasformazione dei materiali in risorse digitali sono stati realizzati i progetti “I Volti della Memoria. Le fotografie degli ebrei deportati dall’Italia”, “Dalla Legge
224 III. Società e cultura
Rattazzi all’Intesa del 1989. Leggi e documenti sul rapporto fra Stato e Comunità ebraica in Italia (1857-1989)” e “Il fondo archivistico Israel Kalk”, mentre sono in preparazione i progetti: “Israel (1916-1938)” e “Le fotografie degli ebrei in Italia dall’Ottocento ai giorni nostri”.
Una realtà importante a livello nazionale è costituita dal Centro Bibliografico “Tullia Zevi” (http://moked.it/centrobibliografico), istituito nell’ambito dell’Unio-ne Comunità Ebraiche Italiane – UCEI negli anni Ottanta allo scopo di realizzare un polo nazionale in grado di riunire, conservare, valorizzare e tutelare libri, ma-noscritti e archivi relativi alla cultura ebraica, per evitarne il deterioramento e la dispersione. L’Archivio del Centro “Tullia Zevi” – che ha digitalizzato gli inventari – è stato dichiarato di notevole interesse storico dalla Soprintendenza Archivistica per il Lazio. Promotore di attività di ricerca (catalogo edizioni del XVI sec., raccol-ta di testimonianze sulla legislazione antiebraica italiana, in collaborazione con il Ministero per i Beni Culturali e l’Archivio di Stato) e di divulgazione didattica, il Centro Bibliografico si articola nelle sezioni: Sezione Archivistica, con l’Archivio Sto-rico dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (19111950), gli archivi Storici delle Comunità di Pitigliano (secc. XVII-XX) e Senigallia (secc. XVII-XX), il fondo “Samuel David Luzzatto” (XIX sec.), la collezione di ketubboth (secc. XVI-XIX) pro-venienti dalle Comunità di Senigallia e Ancona e i fondi “Augusto Segre” e “Isacco Artom”; Sezione Libraria, con 25.000 volumi fra opere a stampa e manoscritti delle biblioteche delle piccole comunità ebraiche italiane, tra cui Pitigliano, Pisa, Ferrara, Senigallia, Mantova, Siena, Firenze, oltre alle opere del Collegio Rabbinico Italiano (15.000 volumi, numerose cinquecentine e manoscritti); Sezione fotografica, con foto degli anni Trenta (FACE) e Cinquanta riguardanti la vita delle singole comuni-tà ebraiche, nonché una ricca collezione di diapositive relative a località e oggetti di carattere ebraico (beni artistici, architettonici, archeologici e archivistici) realizzate negli anni Ottanta all’interno del progetto finanziato dal Ministero per i Beni Cul-turali (Consorzio ARS); Sezione musicale, con alcune registrazioni liturgiche (canti sinagogali) caratteristiche di alcune Comunità Ebraiche Italiane.
Nel Sud Italia il progetto “Profughi ebrei in Puglia” (http://www.profughie-breinpuglia.it), diretto da Fabrizio Lelli (Università del Salento), si propone di ren-dere accessibili sul web le testimonianze delle storie di ebrei provenienti soprattutto da paesi mitteleuropei o balcanici, scampati allo sterminio nazista, che raggiunsero in diversi modi la Puglia a partire dal 1944. Ospitati in campi di transito gestiti dall’UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration), in coope-razione con le Forze Alleate, i profughi ebrei furono dislocati vicino Bari e Barletta nel nord della regione, e nelle località salentine di Santa Maria al Bagno, Santa Maria di Leuca, Santa Cesarea e Tricase Porto, campi che furono luoghi di recupero fisico e psicologico soprattutto per quanti erano scampati alla Shoah. Le testimo-nianze della presenza dei profughi sono ripercorse attraverso le loro biografie e nei documenti degli archivi delle principali istituzioni coinvolte nell’organizzazione dei campi.
M. Mascolo, Archivi digitali sulla cultura ebraica 225
2. Il portale “Judaica Europeana” e altri progetti internazionali di digitalizzazione
Il progetto “Judaica Europeana” nasce nell’alveo di “Europeana” (http://www.europeana.eu/portal/aboutus_faqs.html), il portale internet che opera da interfac-cia per milioni di libri, dipinti, filmati, oggetti museali e documenti d’archivio digi-talizzati in tutta Europa. Attraverso “Europeana” si può accedere a differenti tipo-logie di materiali (dalla produzione pittorica di un artista al suo archivio privato), anche per mezzo di ricerche su materiali di altri siti.
In particolare, “Judaica Europeana”12, progetto europeo biennale avviato nel 2010 con il coordinamento della Goethe Universität di Francoforte, vede la par-tecipazione di molti partner. In Italia il coordinamento è affidato all’ICCU-Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche italiane (ICCU) che sta seguendo la digitalizzazione di alcuni fondi dell’Archivio di Stato di Venezia e di 150 opere della collezione De Rossi della Biblioteca Palatina di Parma.
Il progetto “Judaica Europeana” è stato realizzato – in una prima fase – da un consorzio che comprende come partner: Associazione Europea della Cultura Ebraica (Londra); Judaica Sammlung der Universitätsbibliothek der Universität Goethe (Francoforte/M); Alleanza Israélite Universelle di Parigi in collaborazione con il Centro-yiddish Medem Biblioteca; Amitié, Centro per la ricerca e l’innovazio-ne (Bologna); British Library (Londra); Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC, Roma); Archivio ebraico Ungherese (Budapest); Jewish Historical Institu-te (Varsavia); Museo ebraico di Grecia (Atene); Museo Ebraico di Londra; partner associati: Central sionista Archive (Gerusalemme); MAKASH (Gerusalemme).
Si tratta in tutto di una ventina di istituzioni culturali europee che conservano una vasta documentazione nell’ambito del contributo ebraico allo sviluppo delle città europee. Tra le finalità di “Judaica Europeana”, oltre alla digitalizzazione, ci sono anche l’aggregazione dei contenuti in collezioni tematiche coerenti e la pos-sibilità di utilizzo per la ricerca e la didattica, per l’allestimento di musei e mostre virtuali, per l’organizzazione di iniziative di istituzioni culturali nelle città europee e la valorizzazione nell’ambito del turismo culturale.
Tra i progetti israeliani più importanti di messa in rete di tutto un archivio di immagini tramite il web di fonti manoscritte c’è il progetto The Digital Dead Sea Scrolls realizzato dal The Israel Museum – The Leon Levy Dead Sea Scrolls Di-gital Library, riguardante la digitalizzazione dei manoscritti di Qmran (http://dss.collections.imj.org.il). Recentemente la Israel Antiquities Authority (IAA) sul nuovo sito www.deadseascrolls.org.il (The Leon Levy Dead Sea Scrolls Digital Library) ha pubblicato 5.000 immagini ad alta definizione, con mille immagini inedite e archivi relativi al periodo storico in cui i testi furono elaborati. Tra i materiali visionabili: brani della Bibbia (fra cui una porzione della Genesi e i 10 comandamenti); testi che hanno attinenza con le origini del cristianesimo; lettere scritte da ebrei inseguiti dalle legioni romane negli anni 132-135 e.v.
12 piccinnino 2011, pp. 267-276.
226 III. Società e cultura
La Jewish National and University Library, Biblioteca Nazionale (http://web.nli.org.il/ e http://jnul.huji.ac.il) e Universitaria Ebraica, raccoglie anche i materiali del popolo ebraico – in tutte le lingue ebraiche (ebraico, yiddish, ladino...) di ogni luogo e tempo – della Diaspora. Si tratta di libri, periodici, manoscritti, documen-ti, registrazioni, piante e figure che riflettono o rappresentano la storia del popolo ebraico e la sua cultura senza distinzione di orientamento, scopo, importanza, ab-bracciando tutti gli aspetti della vita e dell’espressione culturale ebraica: storia, biografie, lingua, educazione, religione, folklore, filosofia, arte e altro. La Biblioteca Universitaria, fondata nel 1892 come centro mondiale per la conservazione di libri relativi al pensiero e alla cultura ebraica, nel 1920 è diventata la Biblioteca generale dell’università e raccoglie materiali di ricerca su studi ebraici, islamici e sul Medio Oriente, sulla storia occidentale, sul cristianesimo antico, la filosofia, l’arte, la musi-cologia e altre discipline. Interessante, tra le collezioni virtuali, quella delle kettuboth digitalizzate (http://jnul.huji.ac.il/dl/ketubbot). Il progetto è mirato a realizzare un registro mondiale di ketubbot in collezioni pubbliche e private in tutto il mondo, sulla base della collezione della Jewish National and University Library. Con più di 1600 documenti digitalizzati copre un periodo di oltre 900 anni di produzione di ketubbot, rappresentando una risorsa importante per la ricerca nella storia ebraica, il diritto e la storia dell’arte.
Il progetto “Judaica Freimann Sammlung” (http://sammlungen.ub.uni-frank-furt.de/freimann) della Universitätsbibliothek Frankfurt am Main prevede la digi-talizzazione completa della raccolta Hebraica Judaica. Risalente al XIX secolo (fino al 1933), la biblioteca ebraica digitale è una delle più importanti in Europa, con circa 18.000 titoli. La collezione digitale può essere consultata attraverso diverse categorie: Allgemeine Schriften; Sprachwissenschaft und Literatur; Geographie und Geschichte; Philosophie und Kabbala; Pädagogik; Künste; Rechtswissen-schaft; Staatswissenschaft; Naturwissenschaften; Theologie.
In America il The Jewish Teologhical Seminary di New York (http://www.jtsa.edu), oltre a proporre nella sua biblioteca una collezione di libri digitalizzati, sta realizzando un ulteriore progetto di digitalizzazione di manoscritti tramite il Po-lonsky Foundation Digitisation Project (riguardante 120 manoscritti in precedenza non digitalizzati). Al termine del progetto, nella biblioteca JTS si potranno visionare 50.000 immagini tratte da più di 300 manoscritti.
La Biblioteca Apostolica Vaticana dal 2010 ha avviato un progetto sulla digita-lizzazione di 80.000 manoscritti latini da mettere in rete (www.vaticanlibrary.va). Nel 2012, intanto, sempre tramite il Polonsky Foundation Digitisation Project, ha preso il via un’altra iniziativa di digitalizzazione portata avanti dalla Bav insieme alle Bodleian Libraries di Oxford. Il programma riguarda la digitalizzazione di un milione e mezzo di pagine, circa 2.500 volumi – tra manoscritti e incunaboli – delle due istituzioni. Della collezione di manoscritti ebraici saranno digitalizzate opere di particolare valore, come il Sifra (IX-X secolo), probabilmente il più antico codice ebraico sopravvissuto fino ai giorni nostri.