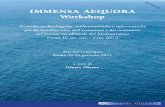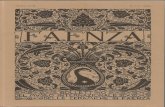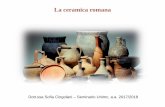CIPRIANO S., SANDRINI G.M., Dallo scavo al Museo: la fornace per la ceramica di Altino
Il furto dei cavalli di Reso nella ceramica apula
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Il furto dei cavalli di Reso nella ceramica apula
Iconografia 2006
Tra le storie di eroi e dei dell’epopea omerica scelte dai pittori di miti della ceramica a figure rosse apula, tre esemplari raffigurano la vicenda raccontata nel X libro dell’Iliade e nella tragedia pseudo-euripidea Reso1. Si tratta di una situla conservata a Napoli opera del Pittore di Licurgo2, e due esemplari ora al Staatliche Museen di Berlino: un cratere prodotto dall’officina del Pittore dell’Ilioupersis e un cratere a volute del Pittore di Dario3.
La vicenda mitica narrata è quella di Reso, re della Tracia giunto nel decimo anno di guerra per sostenere le forze troiane; Reso viene ucciso nella notte insieme a dodici compagni da Odisseo e Diomede penetrati furtivamente nell’accampamento tracio. Bottino eccellente di tale spedizione sono i cavalli di Reso, “… cavalli bellissimi e grandi; più bianchi della neve, nel correre simili al vento …” (Iliade X, 436-437, trad. R. Calzecchi Onesti); i cavalli sono trafugati da Odisseo mentre Diomede fa strage di Traci. Nell’Iliade è Dolone, la spia/delatore che denuncia l’arrivo, la posizione ai margini dell’accampamento troiano (quindi la loro vulnerabilità) e i beni preziosi del re tracio: i cavalli, il carro intarsiato d’oro e d’argento, l’armatura d’oro smisurata. Nella tragedia Reso è invece Atena che incita i due eroi greci, penetrati nell’accampamento troiano e indecisi sul da farsi, ad uc-cidere Reso manifestandone la pericolosità. È sempre Atena a suggerire il furto delle puledre trace, sottolineandone la bellezza “… si distinguono anche nella notte; scintillano come l’ala di un cigno sul fiume … sarà la vostra spoglia più bella: non c’è luogo che ne abbia di uguali” (vv. 619-621, trad. G. Paduano). In entrambi i testi non si accenna alla profezia, probabilmente successiva, secondo la quale Troia sarebbe stata inespugnabile se i cavalli di Reso avessero bevuto l’acqua dello Scamandro4;
IL fuRTO DeI CAvALLI DI ReSO NeLLA CeRAMICA APuLA
1 Hom. Il. X, 433-514. Il canto X fu probabilmente aggiunto successivamente alla stesura dell’Iliade, forse nel vI secolo a.C. Sulla questione si veda Giuliani 1996, p. 76, nota 25, con bibliografia critica di riferimento. La tragedia Reso è stata trasmessa nel corpus euripideo e fa parte delle dieci tragedie fornite di scoli, anche se la sua autenticità era già stata messa in dubbio nell’antichità. Sulla questione RitcHie 1964; Paduano 1991, pp. 5-25. Sulla tragedia si rimanda a BuRlando 1993; BuRlando 1997.
2 Napoli, Museo Archeologico Nazionale inv. 81863. Da Ruvo di Puglia. Heydemann 1872, pp. 439-440, n. 2910; moRet 1975, p. 187, n. 125; RVAp, I, pp. 417-418, n. 18; tRue 1997, p. 1046, n. 6; M. lista in Miti Greci 2004, p. 235, n. 240 con bibliografia precedente; L. FioRini in Iliade 2006, p. 229, n. 48.
3 Rispettivamente Berlin, Staatliche Museen v.I. 3157, ex Coll. fontana, Trieste. moRet 1975, pp. 187-188, tav. 86; RVAp, I, p. 441, n. 102a (attribuito al Rhesus Painter), toucHeFeu-meynieR 1992, p. 951, n. 47; tRue 1997, p. 1045, n. 3. Cratere del Pittore di Dario: Berlin, Staatliche Museen 1984.39. RVAp, Suppl. 2/1, p. 146, 17a, tav. 35,1; Giuliani 1988, 10.13; Giuliani 1995, pp. 31-33, tavv. 1; 4, 2; 5, 3; 7, 4; tRue 1997, pp. 1045-1046, n. 4.D’incerta interpretazione, forse riferite al mito di Reso sono anche frammento a figure rosse apulo conservato a Würz-burg (Wagner-Museum, H 4705) proveniente da Taranto attribuito alla cerchia del Pittore della Nascita di Dioniso con la raffigurazione di Traci dormienti con costume orientale, scena interpretata dal Brommer come appartenente al mito di Reso (BRommeR 1973, p. 440; tRue 1997, p. 1046, n. 8) e un altro frammento di un vaso apulo conservato a Basilea (Coll. Cahn HC 220) con la rappresentazione della morte dei Traci (tRue 1997, p. 1046, n. 9).
4 Tale tradizione è presente solo negli scolia all’Iliade: Schol. Ven. A ad Il. 10, 435 e eust. ad Il. p. 817, 25. Accolta anche da Servio Dan. ad Aen. 1, 469. virgilio sembra alludere alla profezia quando enea, giunto nel tempio sacro a Giunone, tra le
Iconografia 2006
208 FedeRica GiacoBello
nella tragedia vi è un vago riferimento profetico al destino di Troia, in relazione però al re Reso: “Se supererà questa notte né Achille, né la lancia di Aiace potranno impedirgli di abbattere il muro … se uccidete lui avete fatto tutto” (vv. 598-605).
Il tema appare non consueto nel repertorio d’immagini della ceramografia magnogreca: non esiste un antecedente nella produzione vascolare attica, frequentemente ispiratrice di modelli mi-tici delle officine italiote5; l’episodio sembra unicamente essere stato precedentemente raffigurato su di una anfora calcidese a figure nere della metà del vI secolo a.C. conservata al J. Paul Getty Museum di Malibù: il particolare narrativo selezionato è l’uccisione di Reso, circondato dai corpi dei suoi compagni, da parte di Diomede colto nell’atto di sferrare il colpo mortale6.
I tre ceramisti apuli rappresentano l’episodio utilizzando un comune schema iconografico che prevede nel registro inferiore come figura centrale, l’immagine di Odisseo che tiene per le briglia i due cavalli simmetricamente disposti; intorno sono collocati i corpi dei Traci, vestiti con abito orientale, abbandonati in un sonno ambiguamen-te confuso con la morte.
Partendo da un medesimo sistema d’imma-gini i tre artisti propongono nella scena figurata delle varianti attingendo dalla tradizione letteraria apparentemente senza un criterio univoco, crean-do un’eclettica commistione di particolari narrati-vi tratti ora dall’Iliade, ora dal Reso e forse anche da altre fonti. La fedeltà al testo passava, probabil-mente, in secondo piano rispetto all’estro creativo dell’artista e alla finalità comunicativa dell’imma-gine e del racconto mitico7. Non è da escludere, come è stato recentemente proposto, che oltre alla selezione e alla originale combinazione di motivi scelti dai testi letterari, vi fossero particolari tratti dalla tradizione orale quindi difficilmente rico-struibili, come motivi inventati dall’artista8.
Nel cratere a volute attribuito all’offici-na del Pittore dell’Ilioupersis9 (fig. 1) la scena si svolge su registri differenti, posti in connessione dalla linea del terreno indicata da elementi pun-tiformi, dagli alberi schematizzati e dagli scudi a
vicende degli eroi troiani osserva con viva partecipazione quella di Reso: (En. I, 469-473): Nec procul hinc Rhessi niveis tentoria velis / agnoscit lacrimans, primo quae prodita somno / Tydides multa vastabat caede cruentus, / ardentisque avertit equos in castra prius quam / pabula gustassent Troiae Xanthumque bibissent. Per la questione si rimanda a laudizi 1988, p. 450.
5 Sull’argomento si veda muGione 2000.6 Malibù, Paul Getty Museum 96.Ae.I. tRue 1997, p. 1045, n. 2.7 Sul mito come racconto cfr. del coRno 2004. Tale rapporto ‘libero’ tra le immagini vascolari e racconto (mythos)
è stato indagato e sottolineato da Luca Giuliani in particolare in relazione al cratere del Pittore di Dario. Luca Giuliani rifiuta l’abitudine, non corretta, di leggere la scena figurata in base ai testi e viceversa di colmare le lacune dei testi attra-verso le immagini. Giuliani 1996, p. 85.
8 Penny small 2003, p. 170. La studiosa evidenzia una stretta analogia nella narrazione di miti tra il sistema che regolava la creazione letteraria e quella artistica: entrambi selezionavano e combinavano elementi dalle diverse fonti disponibili, ma mentre per gli autori la selezione avveniva dopo una rilettura delle fonti, gli artisti si affidavano spesso alla memoria, creando delle versioni personali del mito. Penny small 2003, p. 171.
9 Berlino, Staatliche Museen inv. 3157, già Coll. fontana di Trieste.
fig. 1 - Berlin, Staatliche Museen v.I. 3157, ex Coll. fontana, Trieste. Cratere apulo a figure rosse (moRet 1975, tav. 86).
Iconografia 2006
il FuRto dei cavalli di Reso nella ceRamica aPula 209
pelta abbandonati sul terreno; il pittore dà un’indicazione temporale introducendo il motivo della stella che brilla vicino al capo di Reso il quale, barbato, con la tipica veste decorata con bretelle incrociate, giace tra due Traci. Nel registro inferiore la scena si fa dinamica: un tracio a sinistra fugge, sul lato opposto un guerriero greco sfodera la corta spada, e fa strage di Traci: gli attributi e l’azione compiuta porterebbero a riconoscerlo come Diomede, ma l’eroe è in realtà raffigurato sul lato opposto, mentre guarda Odisseo allontanarsi, incerto se continuare la strage o ritirarsi come è raccontato nell’Iliade (X, 503-511). L’insolita scelta del doppio Diomede, che secondo il Moret è stata introdotta dal pittore per creare un maggior equilibrio nella composizione grazie a simmetrie alterne10, potrebbe far pensare alla volontà di una divisione della scena in due momenti distinti: il sonno di Reso e dei Traci nel registro superiore, la strage e il furto dei cavalli in quella inferiore11. La composizione della scena è comunque ambigua: il pittore contraddice per ben due
volte il racconto mitico, introducendo un ter-zo eroe greco, qualora non lo si voglia consi-derare ‘un secondo Diomede’, e raffigurando un tracio in fuga, nonostante la tradizione let-teraria sottolinei che tutti i Traci dormivano al momento della strage12. Tali scelte innova-tive confermano l’estro creativo e l’autonomia dalla tradizione del pittore apulo: la scena si caratterizza per la dinamicità dell’azione e una certa ingenuità. Il lato B presenta una generica raffigurazione a carattere dionisiaco sviluppa-ta su due registri: Dioniso è seduto tra eros e un satiro, al di sotto un satiro con situla tra una donna stante e una assisa.
Stesso sistema di rappresentazione dei due eroi greci è utilizzato nella situla conser-vata al Museo Archeologico Nazionale di Na-poli13 proveniente da Ruvo opera di raffinata esecuzione del Pittore di Licurgo, databile in-torno al 350 a.C.14 (fig. 2). Il maestro focalizza l’attenzione sul furto dei cavalli, scegliendo di non inserire elementi che possano far di-stinguere Reso tra i Traci che giacciono morti, avvolti nelle tipiche vesti decorate ‘all’orien-tale’, i loro corpi sono abbandonati senza vita al suolo. Nel registro inferiore si concentra-
no i protagonisti della vicenda: Odisseo, come nell’opera del Pittore dell’Ilioupersis, è raffigurato in nudità eroica con sulle spalle una clamide, sul capo il pileo o un elmo a pileo15 e ai piedi alti
10 moRet 1975, pp. 188-189.11 Contro tale ipotesi Giuliani 1996, p. 78.12 Stesse osservazioni in ibid., pp. 78-79.13 La situla fu rinvenuta in una tomba di Ruvo di Puglia in località Sant’Angelo, il 27 maggio 1836. Alt. cm 29; diam.
orlo cm 25,5; diam. piede cm 13. Integra piccole scheggiature superficiali. Sopra la scena figurata fregi a ovoli; al di sotto motivo a menadri interrotti da riquadri con croce di Sant’Andrea. Sotto le anse tralci e girali.
14 Per l’attività del Pittore di Licurgo si veda sena cHiesa 2004, pp. 226-227; ead. 2006a.15 Il copricapo che appartiene all’iconografia sia di Odisseo sia di Diomede, potrebbe in tale situazione essere letto
come l’elmo a pileo, tipologia di elmo significativamente documentata nella Puglia di Iv secolo a.C. Su tale tipologia e sua diffusione mazzei 1996, p. 120 e p. 125.
fig. 2 - Napoli, Museo Archeologico Nazionale inv. 81863. Situla a figure rosse apula, da Ruvo di Puglia (Miti greci 2004, p. 235).
Iconografia 2006
210 FedeRica GiacoBello
calzari con pelliccia, identificabili con i mullei, segni distintivi eroici16; con gli stessi attributi è raffigurato Diomede, privo però del copricapo. evidente è la ‘svista’ del Pittore che nonostan-te abbia raffigurato la corta spada impugnata da Odisseo nella mano destra, secondo la formula usata anche dal Pittore dell’Ilioupersis, ne dipinge una seconda nel fodero. Altro elemento anoma-lo è la scelta di non sovraddipingere in bianco il cavallo alla sinistra di Odisseo, negando il loro ‘leggendario’ candore e luminosità. Indubbia-mente la luce irradiata dai cavalli rimandava alla dimensione divina, così come a qualcosa di sedu-cente e irresistibile. Non si tratta a mio parere di una rottura voluta dal Pittore di Licurgo: l’indi-cazione del colore del pelo è data dalle brevi pen-nellate bianche visibili sulle zampe e sul muso, si tratta invece di una scelta ‘stilistica’ e abitudina-ria del maestro come documentano i cavalli della quadriga di eracle, nel cratere a mascheroni con scena di apoteosi dell’eroe attribuibile alla stes-sa bottega17. Nuovamente sul lato secondario del vaso è raffigurata una scena dionisiaca: Dioniso seduto riceve il vino in una phiale da un satiro, accanto stanno due figure femminili.
È con il più tardo Pittore di Dario, che ven-gono introdotte le maggiori ‘novità’ narrative: il cratere a volute del museo di Berlino faceva parte di un complesso vascolare recuperato nell’Otto-cento, proveniente probabilmente da una tomba ipogeica canosina18 (fig. 3). La raffigurazione si caratterizza per un andamento più spiccatamente ‘teatrale’ sottolineato da un inedito Odisseo travestito con abiti traci. Tale variazione è a mio pa-rere attinta dal Pittore di Dario dal passo del Reso pseudo-euripideo, in cui Odisseo dopo la strage nel campo tracio, viene inseguito e fermato dal coro, composto da sentinelle troiane, le quali sem-brano scambiare l’eroe greco per un tracio (vv. 686-688): ciò fa supporre che Odisseo indossasse l’armatura di Reso e che fosse camuffato19 (fig. 4). Tale situazione è perfettamente plausibile in que-
16 Per questo tipo di calzature si veda Goette 1988.17 Collezione Banca Intesa 183. Collezione Banca Intesa 2006, pp. 311-315, n. 111.18 Alt. cm 82; alt. all’orlo 71 cm; diam. orlo cm 36,5; diam. piede cm 21. Lato A: sul collo figura femminile di pro-
spetto sorgente da un fiore tra girali. Lato B: sul collo testa maschile con corna, di profilo a sinistra. L’Antikenmuseum di Berlino acquistò l’intero complesso vascolare già restaurato nel 1984 dalla nobile famiglia ginevrina dei Cramer che possedeva i vasi dall’Ottocento, quando un antenato li aveva comprati a Napoli in frammenti. I venti esemplari risultano stilisticamente omogenei, opera di manifatture tarantine operanti intorno al 340 a.C.: a conferma della loro pertinenza ad un unico contesto, Luca Giuliani ha evidenziato come 6 siano i casi di vasi ‘gemelli’, ovvero vasi disposti a coppie all’interno di tale contesto. Giuliani 1992, p. 519.
19 Per il commento al passo molto dibattuto, si veda Paduano 1991, p. 84, nota 53. Ritengo inverosimile che il travestimento di Odisseo sia un motivo autonomamente introdotto dal pittore, si tratterebbe di una innovazione trop-po forte e apparentemente immotivata: è più plausibile che il Pittore di Dario si rifaccia alla rappresentazione tragica, come dimostra l’attenzione per alcuni particolari resi con minuzia nella scena figurata. Si veda ad esempio l’assenza
fig. 3 - Berlin, Staatliche Museen 1984.39. Cratere a fi-gure rosse apulo (Giuliani 1995, pp. 31-33).
Iconografia 2006
il FuRto dei cavalli di Reso nella ceRamica aPula 211
sta tragedia dove il modulo del travestimento è fortemente e insistentemente presente come dimostra il camuffamento di Dolone/lupo20.
Sul cratere l’azione si divide in due regi-stri: in quello superiore Diomede si accinge a colpire Reso addormentato, esplicitamente connotato dalla barba e dallo scettro, sdraiato su cuscini decorati; la dimensione notturna è sottolineata dal fuoco ormai spento dipinto al centro del vaso. Introdotta dal ceramografo è la figura di Atena che sia nel racconto omerico che nel Reso, riveste una funzione importante nell’azione, nel primo incitando e consiglian-do Diomede, nella tragedia suggerendo l’eli-minazione del re tracio la potenza del quale
avrebbe reso Troia inespugnabile (Il. X, 482, 497. 507-511; Reso, 595-605). Accanto alla dea il Pittore di Dario, coerentemente al racconto tragico, rappresenta come spettatrice la Musa, madre di Reso, seduta con il capo coperto, mentre nel registro inferiore ad assistere al furto dei cavalli compiuto da Odisseo, è il fiume Strimone, padre dell’eroe sfortunato21. Sul lato secondario, in affi-nità con gli altri due vasi analizzati, una scena dionisiaca si articola su due registri: in alto Dioniso
delle briglie dei cavalli, non particolare dimenticato, ma dimostrazione di una maggiore fedeltà al racconto: i cavalli erano infatti sciolti per la notte (Hom. Il X, 498; Reso 767-772).
20 Sulla questione ringrazio per le preziose indicazioni il Prof. Giuseppe Zanetto dell’università degli Studi di Mila-no; la formula del camuffamento ritorna ancora nella tragedia quando Atene appare a Paride sotto le spoglie di Afrodite: Reso 637-674.
21 L’interpretazione di questa figura maschile certamente identificabile con la personificazione di un fiume per la presenza di corna e conchiglia, è discussa. Christian Aellen ritiene più verosimile che si tratti del fiume Scamandro, pen-sando ai due registri come indiziari di due scene distinte dello stesso mito: la personificazione del fiume non è collegata alla morte di Reso, ma al furto dei cavalli che sarebbero divenuti invincibili se avessero bevuto le acque dello Scaman-dro. aellen 1994, pp. 145-146. Diversamente ritengo che si tratti della personificazione del padre di Reso, identificato nell’Iliade come eioneo (Hom. Il. X, 435), quindi nella tradizione post omerica riconosciuto come Strimone (Reso 915-931, Pseudo PlutaRco de fluviis XI, 1). Tra i motivi a sostegno di tale ipotesi ritengo significativa la presenza della Madre/Musa, che assiste alla scena nel registro superiore parallelamente al padre, scena da concepire in maniera unitaria e sincronica, e l’influenza della tragedia pseudo-euripidea Reso.
fig. 5 - Berlin, Staatliche Museen 1984.39. Cratere a fi-gure rosso apulo; lato B (Giuliani 1995, pp. 31-33).
fig. 4 - Berlin, Staatliche Museen 1984.39. Cratere a fi-gure rosso apulo; particolare di Odisseo travestito.
Iconografia 2006
212 FedeRica GiacoBello
seduto stringe il tirso con la destra e con l’altra porge una phiale ad una giovane donna che a lui si rivolge (Arianna); ai lati una fanciulla con timpano e un pan. Nel registro inferiore un satiro attinge il vino da un cratere a calice con una oinochoe, ai lati un pan danza mentre una menade suona un doppio flauto (fig. 5).
Pur nelle evidenti diversità stilistiche e iconografiche, palese nei tre vasi in esame, è l’utilizzo di identici schemi appartenenti a un repertorio d’immagini comuni, utilizzate per suggerire una specifica azione a prescindere dalla diversità della scena e dei personaggi. una delle formule utiliz-zate sarebbe, secondo lo studio di Moret teorizzatore di tale linguaggio formulare, il tipo araldico dell’arciere che conduce per le briglia due cavalli affrontati22.
Altra formula ripetuta è quella della figura di Diomede sui primi due vasi nella posa dell’ince-dere veloce, con una gamba tesa e l’altra piegata e il capo rivolto dalla parte opposta. Tale linguag-gio formulare è plausibile fosse realizzato con l’ausilio di cartoni, che probabilmente diventavano un vero e proprio repertorio d’immagini a cui attingere ereditato da bottega in bottega. Ne è una prova tangibile la rappresentazione del tracio dormiente raffigurato dal Pittore di Dario accanto a Reso: appare identico a quello raffigurato dal Pittore di Licurgo, che opera un ventennio prece-dente, sul grande cratere con Orfeo e i Traci della Collezione Banca Intesa23 (figg. 6-7). una nuova
22 Nel cratere del Pittore dell’Ilioupersis i cavalli impennati hanno la testa rivolta nella direzione opposta creando una commistione tra la fissità della posizione araldica e il dinamismo della scena di cui fanno parte. Tale schema viene più coerentemente fatto aderire alla raffigurazione nella situla del Pittore di Licurgo: i cavalli si dirigono nella stessa di-rezione spinti da Odisseo, del tipo araldico originario rimane il rivolgersi verso Diomede del cavallo di sinistra alla quale azione corrisponde il voltarsi anche di Odisseo, come se l’attenzione si fosse spostata su Diomede, ancora desideroso di uccidere. Stesso accorgimento è utilizzato dal Pittore di Dario che però, meno efficacemente, fa rivolgere lo sguardo del cavallo e di Odisseo, verso un Tracio dormiente. moRet 1975, pp. 187-188.
23 Collezione Banca Intesa 2006, pp. 316-321, n. 112.
fig. 6 - Berlin, Staatliche Museen 1984.39. Cratere a figure rosso apulo; particolare del tracio addormentato (Giuliani 1995, pp. 31-33).
fig. 7 - Palazzo Leoni Montanari, Collezione Banca Intesa 111. Cratere a figure rosse apu-lo; particolare del tracio dormiente (Collezione Banca Intesa 2006, p. 316).
Iconografia 2006
il FuRto dei cavalli di Reso nella ceRamica aPula 213
pista d’indagine nella difficile ricostruzione delle attività delle officine ceramiche, potrebbe quindi essere costituita dall’analisi dell’uso e della continuità di tali formule iconografiche nelle diverse botteghe.
Il rinato interesse, sebbene sino ad ora testimoniato da soli tre esemplari, per un mito secon-dario come quello di Reso dovette avere una qualche forte motivazione nella ancora non chiara di-namica di scelta dei soggetti delle botteghe ceramiche, e nel rapporto tra richieste del committente e autonomia del ceramografo24.
Adottato all’interno delle tre importanti botteghe ceramiche apule attive tra il secondo e il terzo venticinquennio del Iv secolo a.C., il racconto mitico del furto dei cavalli di Reso dovette riscuotere interesse e acquistare funzionalità nel linguaggio per immagini del quale si avvalevano i ceramografi apuli.
La chiave di lettura, a mio avviso, è rappresenta dai cavalli, bottino impareggiabile per bellez-za e virtù, cavalli che appaiono, in tutti e tre i vasi considerati, in primo piano nel registro inferiore, sino a soppiantare totalmente nella situla di Napoli la raffigurazione dell’uccisione di Reso volon-tariamente ‘dimenticata’ dal Pittore di Licurgo.
Il cavallo nel sistema di rappresentazione ideologica delle comunità apule, come è stato con-fermato da enzo Lippolis nello studio della necropoli tarantina di età arcaica e classica, identifica una condizione di status: a cavallo si combatte e si caccia, il cavallo è pregiato bottino di guerra, il possesso del cavallo indica l’appartenenza a un ceto aristocratico25. È forse questa nobiltà di stirpe e di potere che i committenti volevano rivendicare, avvalendosi di un mito in cui i cavalli, preda della scorreria, potevano assumere il ruolo principale; un mito che, in maniera significativa, li vede-va associati a Diomede ‘domatore di cavalli’, il culto del quale fu particolarmente presente in Apu-lia26. Infatti le immagini dei cavalli/cavalieri ritornano costantemente in ambito funerario apulo: il tema del dominio sul cavallo e del combattente a cavallo è adottato nei costumi degli aristocratici delle élites indigene già del vI secolo a.C.27
Nel cratere del Pittore di Dario a tale funzione di affermazione ‘sociale’ sembra affiancarsene una seconda più prettamente consolatoria, affettiva e intima espressa attraverso l’immagine inedita dei genitori di Reso che assistono impotenti alla morte del figlio. Nei versi del Reso pseudo-euripi-deo, che probabilmente accompagnarono la cerimonia di sepoltura alla quale il vaso era destinato, attraverso la voce di un cantore28, si svela la forza e la drammaticità della scena figurata. La Musa, racconta la breve e gloriosa vita del figlio Reso interrotta per volere di Atena con sfogo disperato, “… ma per me nel futuro sarà come morto, non vedrà la luce del sole né il volto di sua madre, non verrà più con me … oh pene dei mortali, oh sciagure di chi ha figli! Chi le considerasse saviamente, passerebbe la vita senza figli e non seppellirebbe le creature che ha generato” (Reso 967-969; 980-982, trad. G. Paduano).
Con cautela si può forse ipotizzare che il dolore della madre dell’eroe Reso fosse espressione del dolore di chi, umano, si vede privato dalla morte degli affetti più grandi, forse proprio di un figlio; il potere consolatorio del racconto mitico era quindi garantito dalla comunanza del destino che unisce uomini ed eroi.
FedeRica GiacoBello
24 Sulla questione da ultimo sena cHiesa 2006b, p. 244.25 liPPolis 1997a e id. 1997b.26 Per il culto di Diomede in Italia meridionale si veda GaGé 1972, pp. 772-773; lePoRe 1989, pp. 113-132.27 taGliante 1999, p. 423.28 Probabile era la presenza durante la cerimonia funebre di mimi e cantori che facevano rivivere le storie raccontate
sui vasi destinati alla sepoltura, ricordando ai partecipanti le vicende del mito: il significato esemplare del mito e contin-gente era quindi svelato. Sulla questione sena cHiesa 2006b, p. 244.
Iconografia 2006
214 FedeRica GiacoBello
BiBlioGRaFia
aellen c. 1994, A la recherche de l’ordre cosmique. Forme et Fonction des personnifications dans la céramique italiote, Zürich.Atleti e guerrieri 1997 = Atleti e guerrieri. Tradizioni aristocratiche a Taranto tra VI e V sec. a.C. Catalogo del Museo Nazionale Archeologico di Taranto I, 3, a cura di e. Lippolis, Taranto, 1997.BRommeR F. 1973, Vasenlisten zur grieschichen Heldensage, Marbourg3, p. 440.BuRlando a. 1993, Luci e ombre sul Reso, in SIFC, 1993 (II), pp. 112-128.BuRlando a. 1997, Reso, i problemi e la scena, Genova.Collezione Banca Intesa 2006 = Ceramiche attiche e magnogreche. Collezione Banca Intesa, a cura di G. Sena Chiesa, f. Slavazzi, Milano, 2006.del coRno d. 2004, Mito e miti dalla parola all’immagine, in Miti Greci 2004, pp. 30-34.GaGé J. 1972, Les traditions “Diomédiques” dans l’Italie ancienne, in MEFRA, 84, 2, pp. 735-788.Giuliani l. 1988, Bildervasen aus Apulien. Bilderhefte der Staatlichen Museen preussicher Kul-turbesitz, Berlin.Giuliani l. 1992, Il complesso vascolare del Pittore di Dario, in Principi, imperatori vescovi. Due-mila anni di storia a Canosa, Catalogo mostra (Bari, 1992), a cura di R. Cassano, venezia, pp. 516-519.Giuliani l. 1995, Tragik, Trauer und Trost. Bildervasen für eine apulische Totenfeier, Berlin.Giuliani L. 1996, Rhesus between Dream and Death: on the Relation of Image to Literature in apulian vase-panting, in BICS, 41, pp. 71-86.Goette H. R. 1988, Mulleus-Embas-Calceus. Ikonografische Studien zu Römischem Schuhwerk, in JdI, 103, pp. 401-464.GuéPin J. P. 1966, «Othryades», in BullAntBesch, 41, p. 69, fig. 11.Heydemann H. 1872, Die Vesensammlungen des Museo Nazionale zu Neapel, Berlin.Iliade 2006 = Iliade, Catalogo della mostra (Roma, 2006-2007), a cura di A. Bottini, M. Torelli, Milano, 2006.laudizi G. 1988, s.v. Reso, in Enciclopedia virgiliana, Iv, firenze, p. 450.lePoRe e. 1989, Diomede, in L’epos greco in Occidente, Atti del diciannovesimo Convegno di studi sulla Magna Grecia (Taranto, ottobre 1979), Napoli, pp. 113-132.liPPolis e. 1997a, Aristocrazia e società in età arcaica in Atleti e guerrieri 1997, pp. 3-17.liPPolis e. 1997b, Guerra, caccia e cultura mitica, in Atleti e guerrieri 1997, pp. 51-67.mazzei m. 1996, Le armi, in I Greci in Occidente. Arte e artigianato in Magna Grecia, Catalogo della mostra (Taranto, 1996), a cura di e. Lippolis, Napoli, pp. 119-128.menicHetti m. 2006, La donna alla fontana. Charis e matrimonio sulle ciste prenestine, in Icono-grafia 2005. Immagini e immaginari dall’antichità classica al mondo moderno, Atti del Convegno Internazionale (venezia, 26-28 gennaio 2005), a cura di I. Colpo, I. favaretto, f. Ghedini, Roma, pp. 51-64.Miti greci 2004 = Miti greci. Archeologia e pittura dalla Magna Grecia al collezionismo, Catalogo della mostra (Milano, 2004-2005), a cura di G. Sena Chiesa, e. A. Arslan, Milano, 2004.Modi e funzioni del racconto mitico nella ceramica greca italiota ed etrusca dal VI al IV secolo a.C., Atti del Convegno internazionale (Raito di vietri sul Mare, Auditorium di villa Guariglia, 29-31 maggio 1994), Salerno, 1995.
Iconografia 2006
il FuRto dei cavalli di Reso nella ceRamica aPula 215
moRet J. M. 1975, L’Ilioupersis dans la céramique italiote. Les mythes et leur expression figurée au IV siecle, Roma (Bibliotheca Helvetica Romana, 16).muGione e. 2000, Miti nella ceramica attica in Occidente. Problemi di trasmissioni iconografiche nelle produzioni italiote, Taranto.Paduano G. 1991, Pseudo-euripide, Reso, con introduzione, traduzione e note di G. Paduano, Milano.Penny small J. 2003, The Parallel Worlds of classical Art and Text, Cambridge.RitcHie W. 1964, The Authenticity of the Rhesus of Euripides, Cambridge.RVAp I = tRendall a.d., camBitoGlou a. 1978, The Red-Figured Vases of Apulia, I, Early and Middle Apulian, Oxford.RVAp II = tRendall a.d., camBitoGlou a. 1982, The Red-Figured Vases of Apulia, II, Late Apulian, Oxford.RVAp Suppl. I = tRendall a.d., camBitoGlou a. 1983, First Supplement to The Red-Figured Va-ses of Apulia, Oxford («Bulletin. Institut of Classical Studies, university of London», Suppl. 42).RVAp Suppl. II = tRendall a.d., camBitoGlou a. 1991, Second Supplement to The Red-Figured Vases of Apulia, Oxford («Bulletin. Institut of Classical Studies, university of London», Suppl. 60).sena cHiesa G. 2004, Un pittore di miti: il Pittore di Licurgo, in Miti Greci 2004, pp. 226-227.sena cHiesa G. 2006a, Un pittore di vasi e la realtà visiva del mito, in Il mito oltre il mito. Archeo-logia, arte, storie di eroi e dei, a cura di G. Sena Chiesa, Milano, pp. 77-94.sena cHiesa G. 2006b, I vasi a figure rosse del periodo apulo medio: il nuovo linguaggio figurativo, il prestigio del mito e la celebrazione aristocratica, in Collezione Banca Intesa 2006, pp. 236-249.taGliente m. 1999, Immagini e mito nel mondo indigeno della Puglia e della Basilicata, in Le mythe grec dans l’Italie antique. Fonction et image, Actes du colloque international (Roma, 1996), Roma, pp. 423-433.toucHeFeu-meynieR o. 1992, Odysseus, in LIMC, vI, Zürich und München, pp. 951-970.tRue m. 1995, The Murder of Rhesos on a Neck Amphora by the Inscription Painter, in The Ages of Homer, p. 423, fig. 25.4.tRue m. 1997, Rhesos, in LIMC, vII et supplementum, Zürich und Düsseldorf, pp. 1044-1047.