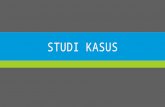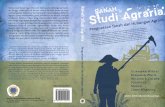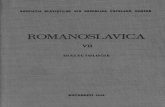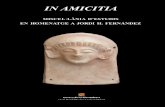Studi sulla ceramica fenicia e punica di Sardegna (= Collezione di Studi Fenici,15), Roma 1983.
Transcript of Studi sulla ceramica fenicia e punica di Sardegna (= Collezione di Studi Fenici,15), Roma 1983.
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RJCERC HE
ISTITUTO PER LA CIVILTÀ F ENICIA E PUNICA
•
STUDI SULLA CERAMICA
FENICIA E PUNICA DI SARDEGNA
di
PIERO BAR TOLONI
•
1983 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
ROMA
COLLEZIONE DI STUDI FENICI, 15
•
FENICIA E P~ ICA DI SARDEGNA
1983 CONSIGLIO NAZIONALE DELI.E RICERCHE
ROMA
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
ISTITUTO PER LA CIVILTÀ FENICIA E PUNICA
FENICIA E P~ ICA DI SARDEGNA
di
PIERO BAR TOLONI
1983 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
ROMA
SOMMARIO
PREMESSA ............... . ...... . . ............... . ............ Pag. 9
INTRODUZIONE. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 11
ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI. . . ................. . ................. " 13
AVVERTENZE . • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '' l 7
CAPITOLO l.
Ceramiche vascolari arcaiche dal tofet d i Sulcis ........................ . " 19
•
CAPITOLO Il.
Note sulla ceramica punica di Sulcis e di Monte Sirai .......... . ........... " 33 •
CAPITOLO III.
Ce . ti . . . d Th " 55 ranuca eruc1a e pu ruca a arros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• •
ELENCO DELLE FIGURE ......... . ................................. " 83
INTRODUZIONE
In seguito a numerose c reiterate istanze affettuosamente rivohcmi da parte di Amici e Colleghi riguardanti il mio lavoro attorno alla ceramica fenicia c punica di Sardegna e.
quindi, i contributi da esso risultanti. sono stato esortato a ripubblicare in raccolt" quanto da me edito in precedenza al riguardo. Fermo restando che quanto edito non solo è ampia
mente reperibile, perchè pubblicato in prevalenza sulrunica testata spccialist ica del ;ramo esistente, ma che è, come sempre. disponibile alla consultazione degli interessati. non ho re· putato opportuno ridare alle stampe quanto già scritto. poichè cib avrebbe avuto un indubbio sapore di rivisitazione, che non ritengo in questo caso opportuna. Si afferma questo poi· chè gli studi da mc editi, anche se gravidi di innumerevoli possibili emendamenti. propri del divenire degli studi, hanno avuto cd hanno. oltre a un intrinseco interesse scientifico. un oggettivo valore storico, nell'ambito dell'evolversi dci miei stessi studi. Pertanto. disattemlendo le amichevoli aspettative, non riproduco in questa sede quanto già edito. ma offro a quanti hanno avuto e. mi auguro, avranno la compiacenza di tollaborare o di interessarsi alle mie ricerche, e non solo. in definitiva~ a queste persone. tre nuovi contributi d i differente taglio. ma tutti scritti con il medesimo intento: la riccrcà de.Ue fonti storiche non scritte o reventuale loro integrazione ove quelle scritte siano carenti, ché a ciò deve essere unicamente preposto lo scopo dell'indagine archeologica.
In questo breve volume sono raccolti, come si è detto. tre contributi. che vengono qui stampati senza ordine cronologico. Essi sono stati scritti in diversi momenti della ricerca e sotto i più diversi auspici e stimoli. Non mi si faccia dunque una colpa se questi appari· ranno tra di loro in qualche modo scollati o se si riscontrerà qualche ovvia ripetizione. Si tenga unicamente presente che~ nati in momenti differenti, hanno come unico comune de-
• nominatore. la prepotente spinta e il profondo amore verso l'indagine scientifica.
Che la ricerca sulla ceramica fenicia e punica sia gravata da pesantissimi handir;aps metodologici e disciplinari si percepisce immediatamente dal taglio specificamente storico-artistico che è stato dato a questi studi fin dall'origine in ambiente vicino-orientale. Ne è egre;.
• gia testimonianza in questo contesto geografico la specifica predilezione per· gli aspetti de· curativi che hanno indubbiamente soverchiato raspetto formale. Sicchè forme indubbiamen·
• • •
'
12 Introduzione
te simili sono state talvolta avulse dal1a loro ambientazione temporale per essere, in qualche caso del tutto arbitrariamente, riunite sotto una comune e solo apparentemente coerente sintassi decorativa.
Nel mondo fenicio e punico di Occidente, invece, si percepisce appieno il duplice aspet
to formale e decorativo, strettamente connesso e precisamente collocato nel tempo. Che questi aspetti valgano anche per la ceramica vascolare d'uso domestico o sacro o di funzio· ne funeraria delle città della costa e dell'entroterra della Fenicia è indubbio. A maggior ragione ciò costituisce un parametro imprescindibile per le ceramiche che formano H frutto
della diaspora fenicia di Occidente. Infatti, queste rispondono, almeno negli aspetti mag-. giormente noti . e relativi a tutto iJ VII sec. a. C., ad una indubbia koiné, che costituisce la < somma occidentale > delle più diverse componenti che parteciparono alla espansione ver
so il bacino occidentale del Mediterraneo. Pertanto, anche nei contesti coloniali più arcaici, almeno allo stato attuale, non sono
minimamente visibili le diverse componenti che parteciparono alla <impresa occidentale >, •
mentre i più diversi influssi, fenici o ciprioti che siano, seppure ben identificabili, appaiono . .
strettamente connessi tra di loro: Mutazioni formali o decorative che distinguano i prodotti ceramici arcaici della . penisola iberica da quelli del Nord-Africa, o quelli della Sicilia· da quelli della Sardegna, non sono apprezzabiJi se non dalla ime del VII sec. a. C., quando cioè l'elemento fenicio assume nel suo repertorio anche aspetti di influsso locale.
Desidero, a questo punto, rivolgere alcuni ringraziamenti che reputo non solo imprescindibili in quanto tali, ma perchè le persone e Je Istituzioni che ringrazierò hanno avuto e, spero, continueraqno ad avere, grande parte nel divenire del mio lavoro. Sono grato dapprima al mio Maestro, Prof. S. Moscati. che, con la sua profonda dedizione al mondo di que-
-sti studi, mi ha accolto tra i suoi allievi e instradato nell'ambito della ricerca scientifica. So-no del pari grato al Pro f. F. Barreca, che mi ha accolto come collaboratore in alcuni dei suoi
campi di scavo offrendomi la sua fiducia, che oggi tento di cont~accambiare. Ringrazio l'ami· co e collega S. F. Bondi, Direttore del Centro di Studio per la Civiltà fenicia e punica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, poichè ha dato indubbio impulso a questi miei studi. Parimenti ringrazio gli amici e colleghi .E. A~qu~ro e M. L. Uberti per il costante appoggio datomi nell'attuazione e nel compimento dei miei programmi di indagine. Un affettuoso riconoscimento vada anche al Personale della Soprintendenza Archeologica per le Province di Cagliari e Oristano, operante oltre che nel capoluogo anche nelle sedi di S. Antioco e di Carbonia, e, in particolare ai responsabili del locale Gabinetto di Restauro, Sigg. E. Putzu .. . .
e F. Tidu, che, assieme al Sig. I. Sanna, con. profonda abnegazione e grande senso del dove-'
re, hanno voluto agevolare ampiamente il mio lavoro. Uguale riconoscimento rivolgo a tut-. te le maestranz~ déi. cantieri archeologici istituiti· dalla: .Regione Autonoma della Sardegna
a Chia (Domusdemaria), a S. Antioco e a Monte Sirai (Carbonia). Sono grato, infme, ai miei
Amici G. Lai, V. Pispisa e A. Zara, che con illo_ro appoggio e con quanto di loro competen;. . .
za non mi hanno mai fatto mancare il loro imprescindibile aiuto .
.Roma, 18 gennaio 1982
Piero Bartoloni
ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI
L ibr.i e tU tico li
Barreca, Sardegna = F. Barrec~ La Smdegna fenicia e punica2, Sassari 1979.
Bartoloni, Anfore = P. Bartoloni, Due anfore gr~co-orientali di imitazione fenicia dal Sulcis: OA, 18 (1979),
pp. 323-27.
Bartoloni, Bithia = Id., La ceramica fenicia di Bithia: tipologilz e diffusione areale: ACSF, Roma 1983,
pp. 491-500. /
Bartoloni, Cronologia = Id., Contributo alla cronologill delle necropoli fenicie e pt.miche di SQI'degna:
RSF, 9 (1981) supplemento, pp. 13-29.
Bartoloni, Oinochoe = Id., Una oinochoe italo-gtometrica di imitazione fenicia da Blthitl : RSF, 8 (1980),
pp. 47-50.
Bartoloni, Recuez1 = Id., Contribu«J alla cronologid delùz fortezza feniciiZ e punict1 di Monte Sirai: Archéo-,
logie au Levant. RecueO à la mémore de Roget Saiillzh (= CMO, 12: Sbie Archéologique,
9), Lyon 1982, in stampa.
Bartoloni - Tronchetti, Nora = P. Bartoloni - C. T~bnchetti, La necropoli di Nora (= CSF, 12), Roma
1981. ..
Byrsa - l = J.-M. Carrié - J. Deneauve - P. Gros - S. Lancel- N. Sanviti- J.-P. Thuillier - F. Villedieu,
Byrm -l Rapporta préliminairerdesfouiOes (1974-76) (= CEFR, 41 ), Rome 1979. • • • •
ByrSil - O = S. Lancel - J.-P. Morel - J.-P. Tbuii.Uer, Byrsg -Il. Rapporta préliminaires sur /es fouaJes
1977-1978: nt.eaux etvestiges puniques <= CEFR, 41), Romel982. ' . . .
Cintas, Manuel- l :!:: P. Cintas, Manuel d"Arcltéolog/f! punique- l<= Collections des Manuels d'Archéo·
logie et d'DistolTe de l'Art), Paris 1970.
/chnus~a = E. Atzeni -F. Barreca - .M. L. Ferrarese Ceruti - E. Contu - G. Lilliu - F. Lo Schiarvo -
F. Nicosia - E. Equini Schneider, Ichnussa. Lll Sardegna daUe origini all'età cllzssictz, Mila
no 1981.
Marras, Saggio = L A. Manas. Saggio di esplorazione stratigrafica nell'acropoli di Monte Sirai: RSF, 9 . . (1981), pp. 187~209.
Monte Sll'ai - l = F. Barreca - G. Garbini, Monte Sirai - l . Rapporto preliminllre della Missione archeo-
14 Studi sulla ceramica fenicia e punica di Sardegna
. logica dell'Università di ROIIkl e del/4 Soprintendenza alle Antichità di Cagliari (= SS, Il),
Roma 1964.
Monte Sirai- Il = M. G. Amadasi - f. Barreca - P. Bartoloni - l. Brancoli - S. M. Cecchini - G. Gar
bini - S. Moscati - G. Pesce, Monte Sirai - Il. Rapporto p~liminare·del/4 Missione lll"cheo
logica deii'Unwersità di Roma e della Soprintendenza alle Antichità di Cagliari (= SS, 14),
Roma 1965. . .
Monte Sirai - 111 = M. G. Arnadasi - F. Barreca - G. Garbini -- M. e D. Fantar - S. Sorda, Monte Si-
rai - /Il Rapporto preliminare (iel/4 Missione archeologica dell'Università di Roma e della
Soprintendenza alle AntichitàdiCaglillri (= SS, 20), Roma 1966.
Monte Sirai - l V = M. G. Amadasi - F. Barreca - P' Bartoloni - M. e D. Fan tar - S. Moscati, Monte
Sirai - IV. Rapporto preliminare della Missione archeologica dell'Università di Roma e del-. . •
la Soprintendenza alle Antichità di Ca~liori <= SS, 25), Roma 1967.
Monte Sirai 1980 = P. Bartolonà -· S. F. Bondì. Monte Sirai 1980: RSF, 9 (1981), pp. 217-30.
Monte Sirai 1981 = P. Bartoloni -S. F. Bondì - L. A. Marras - S. Moscati, MonteSirai.l981 :
l O (1982 ), in stampa.
Moscati, Italia = · S. Moscati, l Cartaginesi in ltalilz, Milano 1977.
Mozill - l = A. Cia.~ca - M. forte - G. Garbini - S. Moscati - B. Pugliese - V. Tusa, Mozia - l. .
RSF •
Rap·
porto prelimiiuzre deUa Missione archeologu:a della Soprintendenza alle Antichità della Si-. .
dlia oc:c:identale e dell'Università di Roma (= SS, 12)~ Roma 1964.
Mozia - Il = A. Ciasca - M. Forte - G. Garbini - V. Tusa - A. Tusa Cutroni - A. Verger, Mozia - Il.
Rapporto prelin:Jinare de//4 Missione tucheologica della Soprintendenza aDe Antichità della
Sicilia oc(:idemale e cle//'UniiJersitò di Roma (= SS, 19), Roma 1966 . .
M ozia - Il/ = l. Brancoli - A. Ciasca - G. Garbini - B. Pugliese - V. TUsa - A. Tusa Cutroni~ Mozilz - /Il.
Rapporto preliminare della Missione archeologica della Soprintendenza alle Antichità clelia
Sidlia occidentale c dell'Università di Roma<= SS, 24), Roma 1967.
Mozia - IV ::=: A. Ciasca - G. Garbini ··- P. Mingazzini - B. Pugliese - V. Tusa, Mozia - IV. Rapporto
preliminare della Missione archeologica 'della Soprintendenza aUe Antichità della Sicilia oc
cklentale e dell'Universitìz di Roma(= SS, 29), Roma 1968 . . Mozia - V = A. Ciasca - M. G. Gozzo· AmadÙi - G. Matthiae ~done - B. Olivieri Pugliese - V. Tu-
sa ·- A. Tusa OJtroni, Mozia - V. Rapporto preliminare della Missione congiunta c:on la
Soprintendenza aDe Antichità de/la Sicilia Occidentale <= SS, 31; PCFP, 1), Roma 1969.
Mozia - VI = A. Ciasca - M. G. Guzzo Amadasi - S. Moscati - V. TUsa, Mozilz - VI. Rapporto preliml·
nare della Mi11ione congiunta con 14 Soprintendenza :alle Antichità delfa Sicilia Occidentil- · ·
le(= SS, 37; PCFP, 7), Roma 1970 . . Mozia - VII = F. Bevilacqua - A. Ciuca - G. Matthiae Scandone - S. MosC4tti - V. Tusa - A. Tusa
. Cutroni, Mozia - VII. Rapporto preliminare dèOa Minione congiunta ·t'On kl Soprintenden-
za alle Antichitò della Sicililz Occidentale(= SS, 40; PCFP, 10), Roma 1972.
Mozia - VII/ = A. Ciasca - V. Tusa - M. L. Uberti, Mozi4 - VII/. Rapporto preliminare della Missio
ne congiunto c:on 14 Soprintendenza aUe Antichità ddlll Sicilia Ocddenta/e (= SS, 45; PCFP,
14>~ Roma 1973.
Mozia - IX = A. Ciasca - G. Coacci. PolseW - N. Cuomo dì Caprio - M. G. Guzzo Amadasi - G. Mat
thiae Scandone - V. Tusa - A. Tusa Cutroni, Mozia r IX. Rapporto prelimill'lllre dellil Mis·
none congiunta con la Soprintendenza aUe Antichità della Sicililz Occidentale(= SS, 50; PCFP,
18), Roma 1978. . .
Tharros - l = E. Acquaro - A. Ciuca - S. Moscati - M. L. Uberti, Tharros - / : RSF, 3 (1975), pp.
Elenco delle ohbreJ•iazioni 15
89-ll9.
Tharros - Il ' 1·:. Acquaro - M. L Ubcrti, 17ta"os ·- l/: RSF, 3 (1975 ), pp. 213-25.
Tharros - Il l =- E. Acquaro -· F. Barre ca - M. T. 1-'ranèisi - · S. Moscati ~ M. L Uber ti, Tharros - /Il:
RSF, 4 (1 .976), pp. 197-228.
Tharros - IV ~ E. Acquaro - F. Fedele - S. Moscati ... V. Santoni -- M. L. Uberti, Tharros - IV : RSF.
6 (1978), pp. 63-99.
T}la"os - V = 1·:. Acquaro - F. De Horatiis -· F. hxlelc .. V. Righini -- M. L. Uberti, Tharros - V: RSF,
7 ( 1979), pp. 42-121.
Tharros - VI = L Acquaro - F. Fedele - L. Fozzati - R. Nisbct - V. Righini ... M. L. Ubcrti, Thar
ros- VI: RSF, 8 (1980), pp. 79-145.
Tharros - VII = E. Acquaro - P. Bartoloni .. S. Moscati · G. S. Petruccioli - · V. Righini CanteUi ·- A. . .
Rodero Riaza - M. L. Uberti -· R. Zucca, Thorros - Vl/: RSF, 9 (1981), pp. 29-119.
Tharros - VIII = E. Acquaro -- C. Huertas Jiménel .. F . Molina Fajardo -· V. Righini Cantelli - A. Ro
dero Riaza- V. Santoni, Tharros - VIII : RSF, IO (1982), pp. 37-127.
Tore, Cippi .. G. Tore, Due cippi-trono del tophet di Tharros: SSor, 22 (1971-1972), pp. 99-251.
Tore, Notiziario = Id., NotiziJJrio archeologit"!J. Ricerche puniclle in Sardegna: l. (1970-1974). Scavi
e scoperte: SSar, 23 (1973-1974 ), pp. 4- J 7.
Tofe - · Gras, BithiJJ =- G. Tore - M. Gras, Di alt:imi repenl dall'antic:a Bithia (To"e di Chia - Sardexna) :
MEFRA, 88 (1976), pp. 51·90.
Vuillemot, Reconnaissances = G. Vuillemot, Recmmaissanc:es aux éciJeUes puniques d 'Oranie, Autun
1965.
Riviste e collezioni
AAlr = Antiquités A/rictlines.
ACSF = Alli del l CongrestKJ Internazionale di Studi Fenici e Punil'i.
BAA = Bulletin d'Archéologie Algérienne.
BAM = Bulletin d'Arehéo/ogie Marm·aine.
BASOR = Bulletin of the American Schools of Orientai Rerarch.
BCH = ·Bulle t in de Correspondenc:e Héllenique.
BMB = Bull~tin du Musée de Bevrouth . • .
CEf.R = Collec:tbn de l'E cole Française de Rome.
CMO = Collel·tion de la Maison de l'Orient Méditerranéen.
CSF = Collezione di Studi Fenici •
EAE = Exetz'PilciOnes Arqueologicas en Esptlffa.
MAL = Monumenti Antichi dell'Accademia Nazion11le dei Lincei.
MEFRA = Mé/anges d 'Archologie et d'Histoùe de l'E:cole Française de Rome. Antiquité.
NSc = Notizie degli Scavi di Antichitd.
OA = Oriens Anti'/uus.
PdP = La Parola del PasSDto.
PCFP = Pubblicazioni del Centro di Studio per la Civiltti fenicia e punica.
RSF = Rivista di Studi Fenici
SS = Studi Semitici
SSar = Studi Sardi.
AVVERTENZE
Le. sigle che accompagnano i reperti presentati indicano la loro collocazione museo-•
grafica e il numero di scavo attribuito ~ciascun reperto all'atto stesso della sua scoperta. In particolare la sigla MC indica il Museo Nazionale di Cagliari mentre il numero che la segue indica il relativo numero di inventario. La sigla MSA indica il Museo Comunale di S. Antioco. Il secondo gruppo di sigle corrisponde, coine si è detto, al numero di scavo del reperto, quando questo esista, per cui MSN indica la necropoli ipogeica di Monte Sirai, i due numeri successivi ranno della campagna di scavo, il terzo numero, preceduto da una barra trasversale, indica il numero della tomba, mentre l'ultimo numero indica il numero del pezzo nel· l'ambito della tomba stessa. La sigla BTH indica la necropoli di Bithia e si riferisce alle campagne di scavo effettuate dal 1976 al 1981, il numero che segue indica il numero di scavo progressivo.
Tutti i recipienti riprodotti nelle ftgure sono· ridotti ad un quarto del naturale, tranne le anfore di cui alla Fig. 6, b-d, che sono invece ridotte ad un ottavo del naturale. Per quanto concerne la decorazione delineata sui disegni, il colore rosso è espresso dal puntinato obliquo; tuttavia, nei reperti di cui alle Figg. 2, a, c-f, h, i, 4, c, 5, d-e, lo stesso p~n-
•
tinato indica n colore bianco.
.
CERAMICHE VASCOLARI ARCAICHE DAL TOFET DI SULCIS
L'area sacra destinata al sacrificio dei fanciulli , relativa al centro fenicio e punico di· Sulcìs e), è stata rinvenuta, ricono~iuta come tale, parzialmente scavata e, del pari, edita ad opera di Gennaro Pesce nel corso degli anni cinquanta e). A questo studioso è senza dub-. bio da ascrivere il merito di aver messo in luce una quanto meno cospicua messe di materiali, che, per cause che hanno palesemente esulato dai suoi intenti, sono oggi in massima parte inediti Da questa situazione sono disgiunte una parte delle stele, alcune perchè rinvenute prima dell'inizio degli scavi e rese note dal fondamentale studio di Giovanni Lilliu e), altre, che, quantunque frutto dell'indagine archeologica,. sono state prese in esame da Sabatino Moscati, appunto nella loro qualità di monumento più eminente e significativo nelle
sue valenze storico-artisticHe di questo tiPQ di area sacra. Sono stati del pari editi gli amuleti, per quanto avulsi dal loro contesto. origifiario ~)
e, quindi, privi di un .supporto cronologico preciso. Per quanto .riguarda la ceramica vascolare, costituita in misura preponderante dalle
urne-contenitore e dai loro coperchi, è stato reeentementè edito un recipiente (Fig. 7, a) é ), rinvenuto nello strato più arcaico del tofet. D luogo stesso del reperimento suggeriSce la funzione dell'urna, che, assième ·.al suo cope~èhio.- viene giustamente classificata dal suo edito
re come uno tra i reperti più antichi dell'area sacra sulcitana. ~ sua stessa supposta provenienza - la.,çolonia calcidese di Ischia, contemporanea sede di un fondaco fenicio · ~) · cor-
(1) Su questo centro, capoluogo f"m da.U'antidtità della regione s\l(l-occldentale deUa Sardegna,
d. Moscati, /ta/14, pp. 210.27.
(l) Cf. G. Pe.ce, StmlegM punicll, Cagliari 1961, pp. 68-70, 85, figg. 41-4 7; per ulteriori e più . ampie ROtWe su quest'area saaa, cf. S. Moscati, l Fenici e Outllg/ne, Torino 1972, pp. 204-205; Barnca,
. .
S(Udeg1Ul, pp. 145-60; S. Moscati, Cartaginesi. Milano 1982, p. 73.
(3) G. Ulliu, Le stele punidle di Sulcu (Ozgliari): MAL, 40 (19+1), coll 293-418. . .
(4) P •. Bartoloni, Gli 11muleti putùci del tofot di Sulcis: RSF, l (1973), pp. 181·203; E. Acqua· ..
ro, UNI monetll ibicenCII diii. tofet di Sulci8: lbid.. pp:l05·206.
{5) CC. C. Tronche«i,-·Ps- llz cronologilz del. tophet di S. AntltJc(): RSF, 7 (19.79), pp. 201-lQS.
(6) .Moscati,. ltalill, pp. 299-301; G. Budmer, Tenimonilmze epiQtlrlChe remitiche dell'V IO s~
colo fl. C. fl PitlrekoUUIIi: Pd.P, 179 (1978), pp. 130-42.
22 Studi sulla ceramica fenicia e punica di Sardegna
roborata con cognizione di causa da autorevoli pareri ('), porta l'autore del contributo citato a collocare cronologicamente il recipiente tra i reperti più antichi del tofet e, dunque, della stessa Sardegna. Tuttavia, lo stesso autore rende parimenti noto di non aver potuto reperire, sia nell'ambiente ischitano in particolare, che nell'ambito mediterraneo in generale (che supponiamo sia da intendersi ristretto esclusivamente alla sua parte orientale), alcun confronto formale apparentemente adeguato. Riguardo a quest'urna, della quale non si stenta di certo a disconoscere una paternità fenicia, sembra sterile .la pur accurata ricerca di un confronto formale aderente in modo speculare. Ciò perchè non paiono certo peculiari ed ascrivibili a questo pe-
•
riodo della civiltà greca - fine dell'VIII, inizi del VII sec. a. C. • l'identità, la standardizzazio-ne e la reiterazione delle fonne ceramiche. L'insieme di queste manifestazioni, identificabile con la cosciente consapevolezza di una perfezione, di una completezza e di una funzionalità ormai raggiunte, non poteva informare ancora le tecniche fJgUline in uso da parte dell'elemento greco nello scorcio dell'VIII sec. a .. C. Come si evince con estrema chiarezza dai relativi reperti, esso era palesemente teso ancora in questa .ricerca e i risultati, pienamente validi sotto questi aspetti, vennero conseguiti solo due secoli più tardi.
Ciò per quanto riguarda quest'urna che, oltre ad acclarare evidenti e forse non del tutto inconsueti rapporti tra Sulcis e Pithekoussai nel momento storico indicato, ci mostra la
'
conferma di una ~discutibile simbiosi tra re~mento calcidese e quello ftmicio. Questo rap-porto di <buon vicinato >, evidenziato e sostenuto dal compianto Vitaliano Meran te. sopra t-. .
tutto per i secoli successivi, informò palesemente i rapporti tra i due ethnoi, spesso minati dalla brutale azione espansionistica. della componente dorica (8
).
Queste considerazioni sono motivate dall'attuale constatazione che il reperto citato, pur costituendo al momento della sua edizione la più antica testimonianza di una importa· zione nell'ambiente fenicio sulcitano, particolarmente avvalorata dal luogo della sua sistemazione e del suo conseguente rinvenimento. non rappresenta per l'area sacra in questione
. il reperto più antico. Infatti, alcuni tra q~elli che seguiranno sono senza dubbio più areai-. '
ci e sono . offerti non certo con la presunzione che lo siano in assoluto tra le testimonianze l
fenicie di Sardegna. Le urne che saranno illustrate più sotto sono tutte comprese tra la seconda metà del~
'
t'VIII e i primi decenni del VI sec. a. C. ~i tratta dunque di poco più di centocinquanta an-ni, nei quali si ha la testimonianZa delle più varie e differenti forme, che, con la loro diver· sità, costituiscono un peculiare esempio di <unicità> e, quindi, quasi una <personalizzazione> _del rito sacriflcale al quale partecipano e del quale sono parte integrante.
· Questa palese difformità tipologiça, relativa senza dubbio al periodo della prima accessione fenicia U. Sardegna, .non è certamente esclusiva del nostro centro, ma è stata nota-. .
ta in precedenza anche a Mozia {') ove Antonia Ciasca, nell'ultimo rapporto preliminare, precisa che: c ... il VI (strato) ... documenta .irivece una varietà indubbiamente ·maggiore di forme, di provenienza da repertori diversi, alcune delle quali non sembrano superare nell'
(7) C. T~dtetti. Pu 111, cro1t0logill del tophet di S. A1ttbco, cit., p. 203, nota 4. (8) V.' Merante, Maleo e 111 cronologia Cllrttlg/lte.e /ilio alla battqlil d'lms-11: KOI:tzlor, 13 (1967).
'·
pp; 105~16.
(9) A Oasca, Lo 1aJ110 ~e/1969: Mozit1 - VI, pp. 78-81.
Capitolo/ 23
uso il limite cronologico inferiore di questo periado ... > e 0 ). In antitesi con questo. stato di cose :e, dunque, a sua ulteriore conferma, negli strati successivi del to{et di Mozia la situazione si· inverte a tal punto ché la stessa autrice non manca di osservare che: < ... i vasi cinerari sono molto numerosi benchè con tipologia notevolmente uniforme e costante ... > (1 1
).
· Anche nel· tofet dell'antica · Bithia, apparentemente abbandonato a partire dalla me-. . .
tà. del VI sec. a. C., senza motivazioni per il momento palesi; ma probabilmente causate da-gli accadimenti derivanti dalla conquista cartaginese della Sardegna, come è documentato in modo inequivocabile dalle deposizioni in quest'area sacra costituita da una superficie estremamente esigua e 2
), le urne seguono, pur nell'ambito della medesima tipologia, soluzioni differenti tra di loro e, talvolta. uniche nel loro genere (' 1
).
Nel tofet della metropoli sulcitana, in palese contrasto con la succitata più che evidente diversificazione delle forme comprese tra la secondà metà dell'VIII e la metà del VI sec. a. C., a partire da quest'ultimo periodo si può constatare una monotona quanto costante . iterazione delle urne-contenitore, nel nostro caso urne globulari monoansate, che persisto-no con minime varianti nel corso dei secoJi successivi e si accompagnano -a rare eccezioni fino all'abbandono del lUogo di culto, avvenuto dopo la conquista romana della Sardegna.
Nella corrispondente area sacra·· di Monte Sirai (~ 4 ), ove, per quanto concerne le de-. . .
posiZioni, non si hanno testimonianze anteriori al IV sec. a. c·., è stato possibile documen-tare come, nel periodo compreso tra la metà del IV e i primi decenni delHI sec. a. C., siano assolutamente prevalenti le urne biansate con orlo verticale, mentre, nel periodo successivo, imo alla fine del III o ai primi anni del Il sec. a. C., data presunta dell'abbandono del santuario, compaiano in fonna maggioritaria le urne biansate con orlo a risalto interno (1 5 ).
Per quanto ·riguarda lllarros, al momento attuale non è documentabile lo stato del-. . . la questione poichè si è volutamente e consapevolmente evi~ta un,.analisi statistica, comb~-nata con i livelli cronologici, almeno per quanto riguarda i rapporti preliminari di scavo. Questo problema. data. la situazione iniziale dei lavori, verrà affrontato ed esposto, come è logi-. .
co, in sede di rapporto conclusivo, ove è preannunciato un cOrpus completo delle urne rin-venute nei differenti interventi e 6 ). In ognj caSo, da quanto .li ·può evincere dal materiale edito, tra gl'i inizi del VII e la metà del VI ·tec. · i. C:.; vi ·è una notevole diversificazione delle ·forme. Dalla data più bassa sembrano invece prevalete, come gjà noJat() a Mozia, le btoc- ' che con cordolo in rilievo alla metà del collo, affiancatè, ma· in · minor numero, ·daRe lime
. (10) A. ·CJaiQ, Lo 1C11P0 d~ll972 e 1973: Mozill -IX, p •. 128.
(11) · E.d •• Lo ICifJO dd 1971: Mozitl - YUI, p. 60; si veda inoltre quanto detto ttpUd A. Ciasca,
Lo ICliPO de/196 9: Mozt. ~ YI, p. 77.
(12) SuO, ·citti ferdda di Bitlùa e, iD particolare, 11111110 tof~t, cl. Motcatl, ltt~lia, pp • . 198-209; . Bm:eca, S.dfQtM, p. 250.
(13) CC. F. Barrec:a, L 'ap/twalorte illfi'O k cott11111tdtlliul: Morrt~ Sllwl- Il, pp. 145-52; P. Bar-. .
tokmi, ù ~mieti WIIC06nt MoftN D.l1980. p. 226 . . . .
(14) Cf. F. Banèca- S. F~ BoR4ì. SctmneliD/et di M011te Shi, CII"''JCNN 1979: RSF,.8(1980),
pp. 143-4S. . (15)
(16)
. . . . .
Cf. P. Bartoloni, ù «<MIItkll PGCOitve: Mt>n~ SFili 1980, pp. 225·27 . ' .
E. Acquaro, Lo ICIIPO thll919: 1'111rJoor· - VI, p. 87.
24 Studi sulla ceramica fenicill e punica di Sardegna
globulari monoansate e 7 ). Nell'ultimo periodo, accanto a queste ed in loro parziale sostituzione compare l'anfora con spalla carenata, affiancata da un certo numèro di forme di uso tipicamente domestico (' 8 ).
Ma, tornando al ierna centrale di questo contributo, i nostri pezzi più antichi sono rappresentati da due brocche provviste di orlo gonfio, leggermente espanso verso l'esterno, breve collo troncoconico, rastremato verso l'alto e carenato còn un cordolo in rilievo a cir· ca metà dell'altezza. Entrambe le urne hanno una pancia ovoide, di dimensioni cospicue . .
e abnormi in rapporto con f rispettivi _colli. Le loro anse, con sezione circolare, sono impo· state, in alto, sul cordolo della carenatura e, in· basso,- sulla spalla leggennente ribassata. l piedi anulari sono provvisti al centro di un umbone tondeggiante che, sia pur di poco, travalica il piano di appoggio del fondo, rendendo precario e instabile l'equilibrio dei due recipienti. Questo particolare sembra rendere esplicito che. queste brocche non erano state destinate fm dalla loro origine a poggiare su piani rigidi, ma unicamente su terra. I prototipi orientali, citati tra l'altro dal Cintas (' 9 ), ci paiono estremamente affini ai nostri, anche in virtù deU'umbone tondeggiante al centro del piede, che non sembra attestatò tra i reper· ti del tofet di. Cartagine, ove invece compare un esemplare con collo rastremato verso l'alto, associato quest'ultimo ad una bocca dal diametro certamente aberrante nell'ambito di questa tipologi~. ma che è al contempo da considerare un aspetto certamente arcaico delle for·
(17) Per n periodo fino aUa aecomta metà del VI sec. a. C., cf. ad .empio E. Acquaro, Lo rcizPD
de/1975 : 1'luurol- Il, THT 75/83. p. 219~ tav. XLVIII. l; Id., Lo.ICtlPO de/1977• T'llturol- IV, THT
11/51, TilT 77/64, THT 77/65, THT 77/68, THT 11n1. THT 77/127, TIIT 77/131, THT 77/152, TIIT 77/181 , THT 17/190, THT 77/340, mT 77/371, THT 77/382, p. 68;figg. 11·14; Id., LorctZvodell979:
17uuros - VI, THP 140, THP 144, THP 220. THP 323, THP 478, p. 87. tavv. XXXII·XXXIII; Id., Lo ICtl
vo del 1980: '1'7rtu1or. - VII, THT 80/9, tav. XIII; per l~ urne con collo carenato nlative al periodo suc
mavo, compreso tra la f"me del VI e ·il III sec. a. C., si veda ad esempio, A. Ciasca, Lo raJPO d~l1974: Thtzr. •
1'01 -l, THT 74/471, p. 103, tav. XXXII. 5; E. Acquaro,/...() 1ciwo del 1975: '11utrro1 - O, THT 75/134, pp. 218·19, tav. XLVIII. 5; Id., Lo ICIIVO dd_ 1976: 1Juuro1 - 111, THT 76/59, pp. 191·203, tav. LIV,
• l; Id., Lo BctlPO del 1-977: Tluuror-: IV, THT 77/133, p. _68, f11~ 11; Id.. Lo sano dal 1980: ThiuTol - VII,
THT 80/6, p. 51, tav. XJIL
(18) E' altrettanto evidente che, "nell'arco di tempo comp,reso tra la fme del VI e ll III sec. a. C., •
la tip(JJogia delle urne di q"~Jesto santlJario, pur risultando apparentemente diYenificata, è al contempo ab-
bastanza costante, soprattutto se conaiderata nell'ambito delle differenti .· ni neJle quali pos
sono easere suddiYiai i tle secoli suindicati; cf. ·m proposito A. Cilsea; Lo ICflW) de/1974: Tll4n.ol- l ; . .
THT 74/29, THT 74/37, M 74/136, THT 74/139, THT" 74/158, Tifi' 74/190, THT 74/335, pp. 103,
107, taw. XXX, 1-4, 6, XXXI, 3 •. S, XXXII, S; E. Allquar~. Lo 1atP0 del197S: 'l'hltrro:r -Il, THr 75/27,
THT 7S/97, THT 75/111, THT 75/117, THT 75/162, PP~ 21~l9, tavv. XLVI. l·l. S-.6, XLVIII. 3; i:l.,
Lo 8Ctl110 del 1976: 1'1uuro• - m. TIIT 76/55, THT 76/57, THT 76/88; TIIT 76/92, TIIT 76/103, THT . .
76/104, pp. 198·99, tavv. LIII, 2-4, LIV, 24; Id., Lo ICIIJIO de/1977: "l"'umom - IV, THT 77/39, THT
11/SO, THT 77/73, THT 77/105, THT 77/128, niT 77/156, THT 77/194, THI' 77/218, THT 77/255, p. 68, fig. 9-11; Id., Lo 6a1PO d~/1979: '11uzrlo$- VI, THP lSS, THP 190. THP 262, tavY. XXXII-XXXIII;
Id., Lo ICtiVO dell980: '11ulrro1 - VII, TKI' 8.0/4, THT 8(}/7, p. S 1, tav. Xlll
(19) Cintas, Manuel-1, pp. 34044, tav. XXIX.
Capitolo/ 25
me occidentali (1°). In ogni caso, gli unici recipienti del repertorio fenicio pau-mediterraneo nei quali com
paia un·· piede apparentabile al nostro sono le piccole ~rocche piriformi del tipo più arcaico, che non sembrano proseguire oltre Ja seconda metà del VII sec. a. C. f 1
).
Passando alla descrizione della ,decorazione, possiamo osservare come il primo dei due vasi (Fig. 7, d) sia quasi completamente ricoperto di vernice· rossa: a prescindere dall'interno, risultano risparmiati la parte terminale della pancia e il piede. La seconda brocca (Fig. 7, c), oltre a presentare una seconda risega alla base del cono, è decorata in modo meno SO·
brio ed è certamente più aderente ai modelli vicino-orientali: una serie di righe nere, .isolate o a gruppi di due o di tre, e di fasce rosse sono delineate dalla sommità del collo ali~ massima espansione della pancia.
Sia la forma che la decorazione dei nostri recipienti denunciano immediatamente la loro aderenza agli originali fenici di Oriente. Per quanto attiene alla forma, risulta senz'al· tro tipica la rastremazione verso l'alto del collo che, come vedremo, si perde invece nelle forme occidentali leggermente più tarde e derivate dalle. nostre, mentre compare quasi costan· temente negli esemplari della madrepatria nei secc. IX e VIII a. C. Se ne riproduce uno a titolo esemplificativo, proveniente dalla necropoli di Tambourit (Fig. 7, e) e senza dubbio particolarmente vicino ai nostri, anche per quanto attiene alla cronologia e 2
), ma si posso· no citare r numerosi recipienti simili, diffusi sia sulla costa orientale del Mediterraneo, tra i quali è da citare un esemplare molto simile ai nostri come dimensioni e proporzioni rinve nuto nella necropoli arcaica di Rachgoun, che a Cipro, ma in questo caso limitati apparentemente alla regione di Amatunte f 3
). La particolare. similitudine sia formale che decorativa dei nostri pezzi rispetto ag1i originali citati, permette certamente di porre le due brocche sulcitane nell'ambito della seconda metà dell'VIII sec. a. C . .
Ad un livello cronologico leggermente più basso - fme dell'VIII o primi anni del VII sec. ·a. C. - e pertanto coeva all'urna pithekoussana di cui sopra, è un'anfora con collo am· piamente svasato verso l'esterno e anse con sezione circolare, impostate superiormente sul-
.·
la parte bassa della . spalla e inferiormente su.l!a linea di massima espansione della pancia (MC inv. 98161) (Fig. 7, b). Quest'ultima è ampia, leggermente rastremata verso il basso e te r-. mina .con un piede anulare, provvisto di umbone tondeggiante sospeso. Un cordolo a spi-golo vivo separa il collo dalla spalla. Questo recipiente, di derivazione tipicamente geometrica f 4
), è decorato con fasce rosse sull'orlo semicircoJare, sulla spalla, aderente alla rise-
(20) Cint~ Manuel- l, tav. XXIX, 56.
(21) Cf. da ultimo Bartoloni; Cronologilz, pp. 23·24, f~g. 1, 5-7.
(22) R. Saidah, Une tombe de l'age du /età Tambourit (tégion de Sidon): Beytur, 2S (1977), ·
pp. 140, 143-44, fig. 9.
(23) Per la necropoH di Racbgoun cf. Vuillemot, Reconnais~t~~~ce,. pp. 63~7, fJ8. 17, 5,. 5 a; per
la Fenicia e Cipro, cf. P. M. Bikai, TJvt late Phoeniciltn pottery. Complu tmd chronology: BASOR, 229
(1978), p. 51! fig. 2 (seconda fila dal basso), 3, S. . .
(24) Su questo particolare recipiente e su alcum aspetti connessi cf. A. M. Bisi, La cetamiCil pu-nictl. Aspetti e problemi, Napoli 1970, p. 121; da ultimo cf. F. Nioolia, LtJ Sanleg1111 nel mondo classico:
lchnuslltl. ·pp. 443, 470; Butoloni, Olltochoe, pp. 47-50.
26 Studi sulla ceramica fenicia e punica di Sardegna
ga che divide questa dal çoJlo, e sulla parte bassa della pancia. Compresi tra le due ultime fasce rosse citate sono sei gruppi di sette righe nere, delineate a comporre uno schema decorativo di tipo metopale. Sulle anse sono riportate quattro righe nere orizzontali.
Questo tipo di anfora è molto ~oto in Fenicia e a Cipro f 5) e compare neU'ambito
. .
dei centri fenici e in analogia con il nostro esemplare, che costituisce un unicum nella no· stra area, nello strato più arcaico dei tofet di Cartagine e 6) e .di Mozia e 7), e dunque tra gli ultimi decenni dell'VIII sec. a. C. e i primi di quello succe'ssivo.
La brocca che segue (Fig. 7, f) si può collocare attorno alla metà del VII sec. a. C. ed è palesemente la . prima risultante occidentale della tipologia più .sopra citata (Fig. 7, c.d). Caratteristica e fondamentale per l'aspetto cronologico è la più che evidente. strombatura verso l'alto del collo, che spesso è associata, ma non in questo caso specifico, al cospicuo diametro della bocca, come si è accennato più sopra relativamente alla brocca del tofet di Cartagine e come si aggiunge ora per quanto concerne un recipiente ana.ogo apparentemente appena più tardo. Questo vas<> di incerta provenienza, forse· da considerare tharrense in virtù · della consistenza e del colore della pasta, è conservato ed esposto in una vetrina del Museo Nazionale di Cagliari ~ 8 ). L'ampia e diffusa fortuna di questa forma è documentata dalla sua persistenza nei tofet di Mozia e di Tharros ~ 9
), ove il tipo compare, originariamente coevo al . nostro, fin dalla metà del VII sec. a. C. e perdura, con minime ma significative varianti, qua-U la verticalità e il parallelismo delle pareti del collo, conseguiti fin dalla seconda metà del VII sec. a. C., fino agli ultimi decenni di vita di questi due santuari. Nel nostro caso~ come si è detto, il collo è ampio e di fonna cilindrica, con una leggera tendenza ad aprirsi verso l'alto. L'attacco superiore dell'ansa, con sezione ellissoidale, si sovrappone alla risega fortemente marcata, mentre quello inferiore è impostato sulla sp~la. ·La pancia è ampia e nstremata verso il basso. Il piede anulare è provvisto dì umbone tondeggiante. Il particolare del piede posto in risalto tramite anello è, per quanto concerne le fonne fenicie di Sardegna, garanzia di arcaicità e ciò in palese accordo con i recipienti fenici di Oriente che mostrano perennemente, nei casi di comunanza delle forme, questa particolarità e0 ). Nelle forme fenicie.
. . J
·di Sardegna di età più avanzata, cosi come nelle forme di imitazione, il piede ad anello risulta
(25) Cf. Cintas,Manuel-1, pp. 351-53.
(26) Cf. D. B. Harden, 77le pottery from the precillct of Tt11Jit t1t &dtlmmbo. 0Utlrtl8e: Irt~t~. 4 •
(1937), pp. 64-67, fq. 3, t~*b; CSitas, MtmUel-1, pp. 351·53, tav. XXXL
(27) A.Ciaaca.Lo8Ct1JIOdel1912 e 1971: Mozia-JX,p.133, tav. LXXV,4.
(28) Si tratta di uaa brocca panduta con collo carenato e COfPO sddacciato, decomta caa due . .
gruppi di quattro ri&he nere, disposti riSpettivamente aut collo e sulla panda.
(29) Cf. B. Pugtiese, Ltl CS'IImlctz pu11a: Mozltl -l. p. 73; tav. LV; A. Ciasca, Lo ICtlPO del1972 . .
e 1971: Mozia - IX, pp. 129·30, taw. LXXW, 1, ~, 6, LXXIV, 7•8; Ead., Lo 6C11P0 del1914: 7Juv.. 101- l, THT 74/182, p. 107, tav. XXXI; E. Acquaro, Lo zawo del197S: 'IJumol--11. 11IT 75/72, THT
15/82. TIIT 75/83, p. 219, taw. XLVII, S-6, XLVIII, 1; Jll., Lo ICIWO del1977: 'Tiuzn'OI-IY, TIIT 77/57, '
TIIT 77/64, TIIT 77/131, TKf 77/152, p. 68, fiM.U-12; il.,~ BtWPO del1979: Thorro1 :- 111, THP ' . .
144, TifP 478, p. 87, tav. XXXIU; il., Lo 1ct1110 del1980: 7Juzmn - VII, THT -80/9, p. 51, tav. Xlii; . per questo tipo di brocche, nel periodO succ:eslivo aDa IICOilda metà del VI sec. a. C., cf. NOta 17. ·
(30) Cf. Bartoloni, Bitlrla, p. 494.
Capitolo l 27
mancante o viene sostituito dal tipico fondo con umbone piatto sospeso, caratteristico di alcuni tipi ceramici che, comunque, difficilmente scivolano molto oltre la seconda metà del VI sec. a. c. e l).
Anche per quanto attien~ alla decorazione, la nostra brocca ·è abbastanza aderente al coevo tipo moziese: due ampie fasce rosse, delimitate da righe nere, sono disposte rispetti-vamente sul collo e sulla pancia e2). . -
Tra l'anfora di tradizione geometrica e la brocca con collo carenato si pongono due crateri. Questa fonna, come si è già avuto modo di porre in evidenza in altra sede, sembra senza dubbio peculiare del periodo arcaico e non è apparentemente testimoniata nei conte~
. sti dei centri fenici di Occidente oltre gli ultimi decenni del VII sec. a. C., sostituita per tempo dalle anfore munite di collo carenato e .con o senza piede, di uso domestico e precipuamente funerario e3
). I nostri esemplari sono entrambi databili, in base ai confronti, nella prima metà del VII sec. a. C. e hanno forme leggermente differenti, pur convergendo nella medesima tipologia. Il primo cratere (Fig. 8, a) è di modeste dimensioni, con un ampi~ ma breve collo, svasato e privo di risalti sull'orlo. La pancia è tondeggiante e quasi globulare; le anse, con sezione· circolare, sormontano l'orlo sul quale sono impostate, mentre inferionnente sono applicate sulla spalla.· Il piede è privo di risalto anulare, ma presenta il caratteristico umbone.
Particolarmente vistosa è la decorazione che è concentrata ·quasi unicamente sulla pan· eia: due fasce rosse, disposte sulla massima espansione· del corpo, sono delimitate e divise da righe· nere; una ulteriore riga nera occupa, isolata, la parte inferiore della pancia. Sul· le anse sono delineate orizzontalmente quattro righe rosse, alternate a quattro righe nere. Quest'ultimo tipo di decorazione è di gusto tipicamente arcaico ed appare, nei centri fenici di Occidente, fino al VII sec. a. C. e4
) ed è estremamente raro oltre questa data, associato, in quest'ultimo caso, prevalentemente a fonne di gusto arcaistico. Il nostro vaso trova indubbi riscontri sia formali che cronologici con tre recipienti rinvenuti nella necropoli
'
arcaica di M ozia e 5 ) e in uno, sempre afferente a questa tipologia, rinvenuto nella necro-poli arcaica di Bithia e'): In particolare, uno degli esemplari di Mozia, associato nel corredo con una kotyle. protocorinzi~, ci sembra, malgrado sia apparentemente privo di deco-
. -(31) a. _.oloni - Tronchetti~ NOfQ, p. 39. · -(32) A. Ciuca, Lo rctWO·del1972 e 1973: Mozkl-IX, p. 131, tav._LXXXIII. 1, 3.
(53) Bartolonf, Bithill, pp. 49243; au queata forma, parzialmente coeYa ai crateri, si veda ad csem-. -
pio Vuillemot, Reconntlilltzn«s, pp. 6US, fig. 22·23 e, da ·ultimo M. E. Aubet, lA céramiCtZ a tomo de 111 . . .
Ou~ del Neg,o {Oumona, Sevilltl):. 38 40 (1976-78), pp. 267.&7, fia.l-2.
(34) . Per questo tipo di decorazione deDo anae, u.octato a differend forme vascolari, cf. B .. Pu
gtiese, LG cer.mlaz. pcmictz: ·M ozio - l, p. 73, tav. LV; A. M. Bili, L 'inudiluiDne ~em.ittCII· in Sicilitl in bt~-. .
se ai dati ctrrlmtci del centri faiclo-punici dell'iMJIII: Koklllos, 13 (1967), pp. 44, SO, tavv. V, 2, VI, l; ·. .
Ead., Le t:pmpo~~Mtl m«llterrtlllft e k coltmati tipologiche deO. ctUflmicll purdctl: SimpOsio lntmuzcio-. .
1flll de Colonizocione1, Btuceiollll,l971, Barcellona 1974~ p. 17, fta. U, l.
(15) V. Tusa, Lo 1a1J0 dtJI 1910: Mozltl ·- VII~ pp. 46, 59, taw~ :XXXIV, 2, XL; Id., Rdtnio
ne Felimintue degli BCtWi e_,lti t1 Mozitl Mgli an/1972, 1973, 1974: }lozltl - IX, p. 13, tav. VI, 1.
(36) Bartotom. Blthill, pp. 492-93, (J&. l, c.
28 Studi sulla ceramica feniciil e punica di Sardegna·
razione, particolarmente simile al nostro e 7 ).
Il secondo cratere è senza dubbio più aderente ai prototipi fenici e ciprioti e, quindi, cartaginesi (Fig. 8, b). Le ~nse, con sezione circolare doppia, sono impostate superiormen~ te sull'orlo semiconvesso, che non sormontano, e inferiormente sulla spalla. I1 collo è am~ pio e leggermente rastremato verso l'alto; la pancia è ovoide, con rastremazìone verso il bas·. so; il piede è anulare con un forte umbone.
· La decorazione è solo apparentemente più sobria di quella dell'esemplare precedente: sull'orlo è descritta una fascia rossa, mentre, sempre in questa zona, in prossimità delle anse, sono delineati su ciascun lato tre tratti neri, perpendicolari alla bocca. Gli stessi trat-,
ti sono riportati orizzontalmente sulle anse. Al lirriite tra la spalla e la pancia sono traccia-te tre linee nere. La forma di questo cratere richiama senza dubbio quelle dei reperti presentati dal Prausnitz e8 ) e dal Saidah e9 ), nonché gli esemplari' del tofet di Cartagine e, in genere, quelli della costa nord-africana (4 0 ).
Un ulteriore esemplare che, sempre allo stato attuale delle ricerche nel tofet di SulciS. risulta unico nel suo genere è costituito da una piccola anfora di tipo cosiddetto ~tirrenico > (Fig. 8, c}. L'orlo è gonfio e diviso dalla spalla tondeggiante per mezzo di un solco. Le anse con sezione circolare sono applicate verticalmente sulla spalla e sulla pancia, che procede verso il basso rastremandosi, per -terminar:e con una cuspide. Gli attacchi delle anse, nel no~ stro caso, sono leggermente. più bassi della nonna, che li vede impostati molto alti sulla spalla. Il tipo è noto nella sua versione maggiore o commerciale anche a Sulcis, ove sono stati rinvenuti due esemplari integri, citati nel. contributo che segue nell'ambito di questo volume (Fig. 6, b).. La forma di .tipo minore o domestico qui rappresentata trova riseontri puntuali abbastanza diffusi~ come dimostra .Ja loro presenza sia nella necropoli della collina di Byrsa, a Cartagine, sia nel tofet che nella necropoli arcaica di Mozia, ove, in quest'ultimo caso, appare associata anche al tipo maggiore r l).
In Sardegna non sono editi esemplari minori coevi al nostro. Il periodo di diffusione di questa forma in ambiente fenicio di Occidente è collocabile nell'ambito della seconda me-
(37) V. Tusa, Relazione prelimiruzre degli ~CaVi eseguiti a MozitJ negli anni 1972. 1973. 1974: Mo
zia - IX, p. 13, tav. VI, l.
(38) M. W. Prausnitz, A phoenician eNter from Akhzw: OA, 5 (1966),· pp. 177..S8, ra. 2. a·b.
3, 4, a. •
· (39) R. Saidah, Foumes de Khaldé. Rt~ppoTt PTélimint~ire IIU liz premièe et deu.xieme etzmptZgnes
(1961-1962}: BMB, 19 (1966), nn. 7, .17, 20, 47, pp. ~1. 66~7, 69, 74, 77; kl., UM lDmbe de l'tzge
du fer .i Tambourlt (r~ de Sidon), dt .• pp. 141, 144. fil• l Q.
(40) Cintas, MIIIJUel - l, pp. 360~7, tav. XXXV; per la ooata no.rd-afri.cana, cf. G. Vuillemot,
La nécropole punlque du ph~~n dlllls l'ile &chgoun (Oralt): Llbyca, 3 (19SS), tavv. IV, 4, VI, 10; per
la penisola iberica, cf. A. .. Arribu • J. Wilkiìts, La necr6polù /enicill del Corti/o de 1111 Sombru: Pyrenae. • •
S (1969), pp. 228-30 .. 233, i~g.1$ . •
( 41) S. Lancel - J .-P. Thuillier, Rllpport pi'IUmilulin tur liz campagne de 1976 (nWetlux puniques) :
Byrm - I, pp. 191-93, f'~g. •9; A. Ciasca, SctlVi illk muro di Mozitz (ctl11'1Pfl811111978): RSF, 7 (1919), r.,. 17. 2; V. Tusa, Rellzzlone pnlimlluve degli sctlVi ell!gUiti o Mozilz 11egli ~~nni 1972, 1973, 1974: Mozitl...; IX.
j
p. 9, tav. III, S-6.
Capitolo I 29
tà del VII sec. a. C. e -raramente oltre questa data, sostituito fm dalla prima metà del VI sec. a. C. nella sua forma commerciale ·dagli anforoni cosiddetti ~a sacco> (Fig. 6, c) ~2 ). Gli esiti più tardi del tipo domestico non seguono pedissequamente l'evoluzione del tipo commerciale, come è constatabile attraverso gli esemplari, distribuiti in varie epoche, rinvenu-. .
ti sia nel tofet di Thairos (" 3 ) che nelle ·necropoli di Nora, di Monte Sirai (Fig. 3, i) e di Tu-vixeddu (44) e non sembrano proseguire oltre il IV sec. a. C. In base alla sua forma e ai confronti proposti, la nostra arifora è senza dubbio da considerare pertinente alla seconda me-. .
tà del VII sec. a. C. Nel medesimo periodo compaiono le urne globulari con orlo espanso, internamente
obliquo, in tre differenti versioni. La prima è monoansata e risulta di gran lùnga la più nota e diffusa (Fig. 8, d), la seconda è sempre monoansata, ma è provvista, in posizione diametralmente opposta all'ansa, di un falso versatoio .conico (Fig. 8, e), la terza, infine, è biansata (Fig. 8, f).
Nel primo caso, ampiamente attestato in tutto il bacino occidentale del Mediterraneo con una sorprendente identità di forme (45 ), · il tipo compare anche nella prima parte del VI sec. a. C. Evoluzioni tipiche e riscontrabili quasi costantemente sono il progressivo appiattimento dell' orlo, la scomparsa del solco che, negli esemplari più arcaici, divideva in modo netto l'orlo dalla spalla e la creazione di un piano di appoggio tramite una depressione del fondo, all'origine tondeggiante ~6 ).
Nel secondo caso, il tipo, anche nella sua versione minore associata all'ambiente funerario, sembra non proseguire oltre i primi decenni del VI sec. a. C., come sembrano dimqstrare gli esemplari del tofet di Bithia· ~ 7 ) ricordati più sopra, talvolta fomiti di falso versatoio geminato ~ 8
).
Il terzo tipo, biansato e certamente il meno diffuso dei tre, trova riscontri sia formali che cronologici nell'isola di Mozia, ove sembra dividere, almeno nel periodo indicato, la medesima scarsa fortuna et 9).
A partire dalla seconda metà del VI sec. a. C. la tipologia delle urne-contenitore del tofet di Sulcis si restringe quasi esclusivamente àllruma monoansata, con qualche rara attestazione differente. relativa soprattutto alle brocche con collo carenato. Ciò, come si è vi·
(42) Per Ja ferma cf. da ultimo, R. Zucca, R centro fenlci(;.punico· di Othoca: TM"os - VII,
pp. 103-104, fig. 3, l.
(43) Cf. E. Acquaro, Lo ICilPO dell976: '111m'ro1- Hl, THT 76/96, p. 198, tav. Llll, 1; Id., Lo
lariO del1977: T'hmros- IY, TIIT 77/77, pp. 63-68; fJI. 14, l.
(44) Bartoloni - Tronc:hetti, Nora, p. SO, fig. 14, n. 212.32.1; cf. inoltre quando d~tto in propo·
sito nel Capitolo Il di questo contn'buto.
(45) P. Bartoloni, Ceramiche vascoltui nellll necropoli qrcaica di Tharros: Tluzrro1 - VII, p.'96, tav. XXI, 2; d. inoltre quanto detto in proposito nel Capitolo DI di questo contributo.
(46) E. Acquaro, Lo SCIIVO dell977: Tluuros -/J', THT 77/340, pp. 63-68. fJI. 14, J. (47) Cf. Nota 13 . .
· (48) Si tratta di due appendici tronco-coniche afrJ.ancate orizzontalmente e aggettanti obliqua
mente verso l'alto.
(49) A. Ciasca, w icavodd 1966: Mozitl-JII, tav. XXV, l. . .
30 Studi rulla ceramica fenici/l e punica di Sardegna
sto, in accordo con gli esiti contemporanei dei simili santuari di Mozia e di Tharròs, che, del pari e almeno fmo al IV sec. a. C., poco concedono alle fonne che non siano di volta in volta preferenziali.
. . Queste urne sono state presentate unicamente. con lo scopo di avvalorare l'ipotesi che
il livello cronologico dell'identità cittadina a Sulcis e dunque anche nelle più antiche colo· nie fenicie di Sardegna, fosse già raggiunto prima della metà dell'VIII sec. a. C. e, senza dub· bio, ampiamente consolidato nella secol)da metà dell.o stesso secolo.
Di oonverso, allo stato attuale delle ricerche, nessuna testimonianza archeologica nel nostro sito in particolare e ben poche, · generalmente prive di contesto e assai disperse nella stessa Sardegna e nelle regioni di Occidente, in generale, potrebbero far arguire una ~colonizzazione > fenicia dell'isola anteriore alla fme del IX sec. a. C. (50
). Queste testimonian· ze, pur nella loro sporadica esistenza, confermano invece una frequentazione < pre-coloniaJe >, i cui limiti vanno visti non solo nelle motivazioni che la generarono, ma anche nei differenti momenti e moventi che distinsero i primi stanziamenti fenici· da qtjelli greci. Se, infatti, questi ultimi furono oggettivamente richiesti da una prepotente spinta demografica e quindi da una ulteriore necessità di spazi agricoli, e quindi territoriali, quelli furono gene· rati dall'esclusiva ricerca di materie prime, per la necessaria alim.entazione delle botteghe ma-
. '
nifatturiere dell'Oriente fenicio. Ciò per-quanto concerne soprattutto la Sicilia. Del resto, .in Sardegna, 1~ stesso atteggiamento, ahneno apparentemente acquiescente, dell'elemento nuragico, che deteneva le grandi risorse minerarie dell'isola ci dimostra che, fino alla seconda metà del VI sec. a. C., praticamente null'altro se non il commercio e il mutuo scambio . di generi, che dai due contraenti venivano rispettivamente considerati necessari, informò l' attività dei fondaci fenici.
Verso la fnie del VI sec. a. C.·, il Mediterraneo nella sua interezza divenne teatro di gran· di accadimenti che non poterono non riflettersi sulle colonie fenicie di Occidente e· non poterono non influenzare la politica del sorgente imperialismo economico di Cartagine e che, forse, sia pure indirettamente, ne furono la causa. .
La poderosa . spinta verso il . mare delle itmate persiane provocò, accanto a nuovi im· pulsi commerciali sotto tutela, la definitiva perdita dell'autonomia della città della Fenicia
•
e la diaspora in parte forzata degli intraprendenti Focei della Jonia verso le terre e i merca-ti di Occidente (51
). La recente egemonia laziale di Roma, giovane, ma gravida di potenza solo parzialmente espressa, mutò sen·za dubbio il quadrò delle alleanze nell'ambito del Mar . Tirreno. Eloquen.ti testimonianze di questo fervore politico ·sono, storicamente, iJ trattato tra Cartagine e Roma e, archeologicamente, le significative lamine auree rinvenute a Pyrgi.
. .
Al contempo si andavano consolidando sempre maggiormente le tendenze espansionistiche della stirpe dorica di Sicilia, estrinsecate in toto e parzialmente conseguite, più tardi, . con
. la battaglia di Cuma. . . . . .
. Cartagine dunque ·fu senza dubbio spinta ad adattarsi alla nuova situazione e proba· bilmente funse da collettore per la sovrabbondante quantità di · materie prime che i vecchi
.. (50) Si veda ad eaempio il bronutto fenk.:io del pozzo nuragH:o eU S. Cristina di PauHiatino; in
proposito cf. S. Moscati, l Fenici e CaltJzgine, Torino 1972, pp. 439-40; . Baneca, Studeg1111, p. 35. . .
(51) F. Nicosia, Lll Studegntl nel moltdo cllusico: lchnu••· p;. 421-76. . .
Capitolo/ 31
fondaci fenici di Occidente, ormai elevati dalle loro attiVità e di · fatto al rango di città, continuavano a inoltrare sul mercato mediterraneo e verso Oriente.
In ogni caso, lo iato prodotto dal repentino mutamento di indirizzo politico è senza dubbio percepibile attraverso le testimonianze offerteci dalla ceramica vascolare. A partire dalla ftne del VI sec. a. C. e con il trascorrere del tempo, le importazioni di vasellame attico e le frequenti .imitazioni che si hanno di tali forme in Sardeg~, sempre più ampie e co-
. spicue, sia tipologicamente che numericamente (52 ), sostituiscono i materiali etruschi e corinzi trafficati fmo ad allora (53
) e testimoniano egregiamente i contatti commerciali 'tra le due città egemoni e la seriore alleanza politica in funzione anti-dorica.
. Di converso. in Sardegna, nessun altro accadimento storico, tra i pochi noti e i molti pur incogniti, può aver provocato, sia nel mond~ nuragico che in quello fenicio isolano, ta-. li mutamenti e rivolgimenti dì costume e di cultura. In Sardegna, per stroncare tempestiva-menle le velleità poli~iche e commerciali focee e per limitare quello che fino a quel momento era stato il normale atteggiamento autonomo delle popolazioni nuragiche, fino ad allora in parziale simbiosi e in rapporto paritario con .le città fenicie, Cartagine assunse un atteggiamento completamente diverso da quello che era stato tenuto dai centri fenici, sia nei confronti dell'elemento nuragico che di queUo foceo (54) . E, ·m effetti. nell'ambiente indigeno già iniziavano a sorgere, ormai preannunziati dai ritrovamenti dei secoli immediatamente precedenti, i primi spunti di una civiltà in corso di rinnovamento, in parte derivanti dal commercio foceo, senza dubbio concorrenziale i'ispetto a queUo fenicio.
Unicamente in questo q~adro storico. e nell'ambito di un . disegno politicamente unitario vanno viste la battaglia navale ·di AJ~ia e le imprese di Maleo e dei Magonidi in Sicilia e in Sardegna.
Le pur scarse fonti ci attestano, accanto ai ben più cospicui dati archeologici, che gli . eserciti cartaginesi presero piede in Sardegna e, con l'occup~ione di tutta o, almeno, di gran parte dell'isola, soffocarono repentinamente e senza distirizione alcuna, e quindi in modo drastico e brutale, tentativi politici e nuove esperienze culturali, liveUando ben presto tutta l'isola in una koiné che, nei centri maggiori, perqurerà per lungo tempo oltre la successi- · va occupazione romana.
•
(52) Bartoloni - Tronchetti., Nora, pp. 63~; Ba:rtolom, Bithitt, p. 492.
(53) Bartoloni, Oonologia, p. 23_
(54) Sulle finalità dell'intelventq cartaginese, tra l'ahro volte al supporto dei centri fenici deJl'
isola, cf. G. Ultiu, Navicellll di bronzo Protoltll'da d4 Grniset~: GTtiVisCtJ (Tarquinia).· SeDi nella città . etrii&Ctl e romlliJIL Ol1PifNIKIIe 1969 e 1970: NSc, 1971, p.-297; suDa p.resenza di materiali greco-orien
tali e di manufatti di loro imitazione, cf. Bartoloni, Anfore, pp. 323-27; cf. inòltre, da ultimo, R. Zucca,
n centro /enicb-punico di Othoct1: Tluuro1 - Yll, p. 101, nota S; L A. Marru, ·L11 ceramic4 di imituitr
ne ddltt necropoli: Monte SiTtzi 1981.
NOTE SULLA CERAMICA PUNICA DI SULCIS E DI MONTE SIRAI
. Nell'ultimo decennio, in virtù dell' impegno scientifico programmato della Soprintendenza
Archeologica per le Province di Cagliari e Oristano (1 ), in connessione e in accordo, tra gli altri, con l'Istituto per la Civiltà fenicia e punica· del Consiglio Nazionale delle Ricerche, del quale mi onoro di fare parte, sono stati conseguiti, grazie anche alla comune ricerca, alcuni risultati che senza dubbio contribuiscono ad acclarare o a confermare ulteriormente la storia e le vicende umane dell'isola. Ciò si deve anche aU'indagine comparata della ceramica fenicia e ·punica di Sardegna, alla quale partecipa chi scrive; il necessario e imprescindibile riscontro è stato effettuato, e in parte edito, sia tr·a i vari centri. produttori dell'ambito isolano, sia tra la somma di questi, in connessione e in antitesi cori i centri fenici e punici dis-.. seminati lungo le coste del Medi.terraneo occidentale, dei quali esistesse una adeguata o leg-gibile documentazione ~ ). .
L'esame comparato si è anche svolto in modo organico, e cioè sia in aderenza alle mu-tazioni evolutive della ceramica fenicia e punica in generale, sia tenendo conto di queste nel-
•
l ambito regionale di Sardegna. Con ciò si intende affermare che le medesime fonne hanno avuto esiti evolutivi differenti nelle diverse reJ~ioni toccate dall'espansione fenicia e punica. Inoltre, come si vedrà in seguito, ai prodotti conseguiti dall'evoluzione delle forme fenicie di Sardegna, si sovrappongono quelli frutto delle medesime risultanze nell'ambito di Cartagine e del Nord-Africa, dando luogo nelfisola a ibridismi e a fenomeni di arcaismo, tipici deJia Sardegna punica.
AU~origine in Sardegna, almeno fino a tutto il VII sec. a. C., tuttavia, questo proces. so di evoluzione risulta abbastanza omogeneo rispetto ai centri fenici del Mediterraneo occidentale, come si evince . dalle forme contemporanee presenti nei differenti siti. Queste, che sono abbastanza simili tra di loro e sono classificabili, in base a questi parametri, come pro-. . .
dotti fenici e punici deUa koiné ceramica di Sardegna, hanno tuttavia una chiara identità lo-
(1) Ad opera di questa Soprintendenza, oltre alle indagini archeologiche, lODO state attivate nwno·
rose ricerche muaeografidle, rivolte toprattutto a materiali di vecdtia acquisizicme e tese, dunque, a col-.
mare oggettive lacune. ·
(~) Cf. Bartoloni, C>onolog/tl e Bartoloni - Tronchetti, Norll, che costituiscono anche parte del
la ricerca museografica in corso.
• •
36 Studi sulla ceramica fenicia e punica di Sardegna
cale che permette di attribuirle ai differenti siti deiJ'isola. Ciò grazie soprattutto ad alcune
particolarità della forma, del colore e della decorazione. Queste argomentazioni sembrano dunque· dimostrare che se non vi fu con ogni probàbilità un commercio osmotico che riguardasse gran parte della ceramica vascolare, numerosissimi furono, per altri versi, i contatti tra rdifferenti centri produttori di Sardegna e), che indubbiament~ permisero, sia pure in ma- . niera indiretta, questa indiscutibile comunanza delle forme.
La rivisitazione critica delle necropoli fenicie e puniche di Sardegna scavate negli ultimi. cento anni, non disgiunta da una comparazione dei rispettivi corredi, ha portato, tra l'altro,. come conseguenza diretta la separazione temporale dei due principali riti funerari.
Il quadro relativo alla ceramica che se ne ricava è il seguente, tenendo tuttavia presenti alcune possibili anticipazioni o, comunque, immediate ricezioni oppure alcuni normali attardarnenti che, in ogni caso, non dovrebbero _superare in tutti questi possibili eventi come massimo il quarto di secolo. Come inizio. di una frequentazione fenicia non occasionale lungo le coste della Sardegna si propongono f primi anni del IX sec. a. C., periodo che segna la fine o il diradarsi dei commerci micenei e ciprioti.
Periodo fenicio pre-coloniale: dal IX alla metà dell'VIII sec. a. C. ca. Periodo fenicio arcaico: dalla metà dell'VIII alla metà del VII sec. a. C. (750-650 ca.) Periodo fenicio classico: dalla met.à del VII al primo quarto del VI sec. a. C. (650-575 ca.) Periodo fenicio maturo: dal secondo quarto al terzo quarto del VI sec. a. C; (575-525 ca.) Periodo punico arcaico: dall'ultimo quarto del VI alla-metà del V sec. a. C. (525-450 ca.) Periodo punico classico: daUa metà del V a1la metà del IV sec. a. C. (450-350 ca;) Periodo p unico ellenistico 1: dalla metà del IV al primo quarto del III sec. a.C. (350-275).
Periodo punico ellenistico Il: dal primo quarto del III alla fine del II sec. a. C. (275-100)
I riti in questi differenti periodi sono i seguenti:
, a) ~agli inizi dell'epoca coloniale a11a seconda metà·del- VI sec. a. C. (cioè dalla fon-dazìone dei primi centri urbani all'intervento cartaginese) si è praticato esclusivamente il rito dell'incinerazione, con qualch~ inumazione in fossa terragna, estremamente minoritaria rispetto al prec.edente rito;
b) Dalla fine d~ l VI sec. a. C. a un periodo da porsi attorno ana metà del III sec. a. C. (cioè dalla presa di potere di Cartagine in Sardegna all'Ellenismo maturo) si è pra~ ticata· solo l'inumazione, prevalentemente· in camere ipogeiche, ma anche in tombe a fossa o, comunque, in tutte le soluzioni note nell'ambiente e pertinenti a questo rito;
. - . .
c) Dalla seconda metà d~l III sec. a. C. fmo al consolidamento dell'occupazione romana della Sardegna (I sec. d. C.) è prese~te quasi unicamente l'incinerazione in recipienti che vengono deposti all'interno delle fosse o degli ipogei puitìci citati più so~
. . . pra o in fosse terragne, talvolta protette da pietre. ·
(3) Bartoloni- Tronchetti, Nora, pp. 4849,62.
Capitolo II 37
Accanto ai primi due riti e in loro associazione è da segnalare quello dell'enkythrismos, molto raro nel primo periodo e probabilmente connesso con la pratica della scamificazione,
•
come risulta dai rìtrovamenti effettuati nella necropoli fenicia di Bithia e abbastanza frequen-te, invece, nel periodo punico ellenistico·e utilizzato soprattutto per sepolture di bambini.
Nel periodo punico arcaico e nel successivo punico classico, le soluzioni ipogeiche vennero adotta te laddove se ne presentò la possibilità, ciò è ìn quei centri ove erano . reperibili a ragionevole distanza dan·abitato banchi rocciosi adatti allo scopo e di non gravoso impiego di mano d'opera. Pertanto furono privilegiate le falde tufacee, come a Sulcis, Monte Sirai e Paniloriga-, calcaree, come a Cagliari, e di arenaria quatemaria, come a Tharros. Nei centri di pianura, invece, in mancanza di luoghi adatti allo scopo, fu adottata la soluzione del-... le tombe a fossa o a cassone litico, come ad esempio a S. Sperate.
La situazione di cui più sopra è emersa anche per quel che riguarda le necropoli di Sulcis e di Monte Sirai. Infatti, dall'inizio dell'impresa archeologica in quest'ultimo sito, nel 1963, sono stati rinvenuti, neUa valletta ·che separa U tofet dall'acropoli, dodici ipogei certamente di origine punica (4
), uniti ad alcune Domus de Janas ubicate ai piedi del dirupo del tofet .e ampiamente riattate in età punica. Accanto alle prime, nel settore meridionale, fu rinvenuta, sempre nel 1963, una · sacca lenticolare di ceneri e ossa combuste, accompagnata da un modestissimo corredo composto da un piatto certamente arcaico - verosimilmente dunque una tomba a incinerazione - databile latamente attorno alla metà del VI sec. a. C. Il piatto, nella pubblicazione del primo rapporto, fu inserito, data l'indubbia vicinanza e in virtù della sua shnilitudine, in un corredo di tomba ipogeica, assieme ai recipienti analoghi provenienti da questa (MC s.n. inv .) (MSN63/2-s.n.)'(Fig. 1, o) (5 ).
Un ulteriore indizio della presenza a Monte Sirai di una necropoli arcaica a incinerazione era dato, fin dal 1964, dal rinvenimento sporadico di un frammento riferibile a una brocca con orlo cosiddetto <a fungo>. Questo frustulo (MC inv. 98146) (Fig. J, q)è relativo a parte del collo e presenta un solco molto profondo, tipico delle forme originarie e comunque non posteriori alla fine del VII o ai primi anni del VI sec. a. C. (6
). In base a questo ritrovamento, non disgiunto dalla considerazione che talé tipo di recipiente risulta associato in
••• prevalenza .a sepolture . e che è praticamente assente nei coevi contesti abitativi, si ipotizza-va dunque la presenza di una necropoli arcaica a incinerazione, non lontana da quella ipo-
• · getca. Nei primi mesi dell'anno 1981, durante Iò scavo di una canaletta di scolo delle acque
. . .
piovane a ulteriore e maggior protezione delle tombe ipogeiche, venivano poste in h.tce tre· •
deposizioni. A4 "immediato seguito della constatazione che si trattava indubbiamente di tom-be arcaiche; queste venivano nuovamente interrate, previa opportuna protezione, a cura del personale della Soprintendenza Archeologica, in attesa di una esplorazione più approfondi· ta, che è stata effettuata a cura di chi scrive nella tarda estate dello st~sso anno e nella primavera di quello successivo e della quale si darà opportuna notizia nel relativo rapporto di
"
(4) F. Barreca,. Gli JCtZvi: Monte Simi - l, pp. 36--40, 52-SS ; M. G. Amadui - l Brancoli, Lll ne
cropoli: Monte Sirlli -Il. pp. 9.S.l07; Mh. e D. Fantar, Lo n~cropole: Monte Sirai - III. pp. 63-75.
(S) F. Barreca, Gli sCtzvi: Monte Sirlli - l, p. 45, n. 70/98, tav. XXXV. 98; Bartoloni, Recueil. (6) Bartploni, Recueil.
38 Studi sulla ceramica fenicill e punica di Sardegna
scavo('). Come notizia preliminare si può senza dubbio anticipare che si tratta in· grande mag
gioranza di fossette contenenti ossa cremate e céneri, unite a un corredo che è situabile cronologicamente almeno tra la fine del VII. e ·gli ultimi anni del VI sec. a. C. Questa data, oltre a confermare rassunto esposto più sopra riguardante il mutamento di rito funerario, risulta ogge~tivamente più alta di qùella che può vantare il più antico tra i reperti di importazione della necropoli a inumazione, che è, in particolare, una coppa ionica del tipo 8 2 presentata nell'ambito di un contributo edito in precedenza (8 ).
·Le tombe a incinerazione sembrano occupare tutta la parte della yalletta compresa tra l'acropoli e le tombe a camera e, a giudic.are dai frammenti rinvenuti, contengono materiali fenic~, materiali di imitazione e di importazione.· Lo straordinario interesse del ritrovamento è anche dato dal fatto che, in questo settore si presume possano essere rinvenute . ulteriori tombe ipogeiche inesplorate. Ciò permetterà dunque di avere una sequenza crono-logica continua estremamente importante sia per lo studio dei riti che per la cronologia assoluta della ceramica. Lo scavo della necropoli arcaica ha fornito fino ad oggi oltre trenta tombe a fossa, contenenti prevalentemente ossa combuste e un corredo vario sia come numero che come tipologia a seconda delle differenti situazioni.
La presenza nell'acropoli di. frammenti fenici sic_uramente ascrivibili alla seconda metà del VII sec. a. C., uniti a numerosi. frammenti di ~ranùca etrusca e greco-orientale, per-. mettono di ben sperare per quanto riguarda Sia i materiali della necropoli arca.ica a inciDe-razione che le precisazioni cronologiche ad essi connesse.
Inoltre, stante la grande rassomiglianza delle ceramiche di Monte Sirai, relative · alla seconda metà del VI e a tutto il V sec. a. C., con quelle coeve di Sulcis, che sembrano in ·qualche modo confermare la dipendenza della nostra fortezza dal capoluogo sulcitano, i reper· ti della necropoli a incinerazioni testé rinvenuta saranno di grande aiuto per la conoscenza sia pure indiretta di quest'ultimo centro fenicio. In questa città infatti le uniche testimo· nianze arcaiche, collocabili sia topograficamente che stratigraficamente in modo· corretto e ascrivibili alla seconda metà dell'VIII sec. a. C., provengono dal to{et ~), per quanto riguarda sempre la ceramica proveniente da sicuro• contesto o da stratigrafia et 0 ) • . A Sulcis infatti le prove evidenti di una situazione collimante con quella verificatasi a Monte Sirai sono di certo meno consistenti ma non per questo da considerare più labili. Si è potuta acciaia-
' re la presenza di una necropoli ·arcaica, probabilmente a incinerazione, ·grazie al rinvenirnen- . . .
to museografico di alctJni pezzi che, in base aHa loro fonna e, quindi, allo loro cronologia, norrnahitente si accomp~ano a deposizioni di questo tipo.
Allo stato attuale, comunque, null'altro da questa .città emerge, relativo al periodo ar· . caico, compreso tra la metà dell'VIII e la fme del VI sec. a. C. I dati archeologici che sono
(7)· P. Bartotoni, Lo necropoll (CGfii1HliJUll98J): Monte SiNi 1981; P. Bartoloni - L. A. Mar·
ru, Ltl necropoli di Monte Sni, iD preparazione. (8) J.-P. More), L'expt~~~~iolt ph~ne en Occldent: BCH, 99 (1975), p. 863; cf. inoltre, da
ultimo, Bartoloni,An/ol't~ pp. 325-26 e F. Nicolii,IA &udtt~M nel mondo ciGiico: lch181Utl.
(9) Cf. il Capitolo l di questo vohlme. .
(10) Cf. Bartolnni, Crollolot~ pp.ll-24.
;-
•
·Capitolo Il 39
stati ottenuti sono dovuti principalmente alla necropoli ipogeica e 1 ), attiva a partire dal
la fine del VI sec. a. C. In queste tombe polisome, i corredi sono stati rinvenuti per lo più • • l
sconvolti dalle reiterate deposizioni~ che si sono protratte dalla data più sopra indicata fmo al I sec. a. C., o dagli inevitabili allagamenti che stagionalmente hanno investito gli ipogei.
Ma,' tornando all'argomertto più strettamente attinente al tema di questo contributo, mi limiterò a trattare le forme vascolari rinvenute nefie necropoli ipogeiche di Sulcis e di Monte Sirai, con alcuni cenni sommari riguardanti quelle provenienti sia dai saggi che dalla superficie dell'abitato di questo centro. Questi ultimi del resto sono stati già ampiamente trattati in un contributo ad opera di L. A. Marras (11) e costituiscono, allo stato attua-. .
le degli studi del settore, una delle poche valide e preziose testimonianzea di materiali fit-tili d'uso· in un centro fenicio e punico di Sardegna.
Di alcuni materiali delle necropoli ho già avuto modo di fornire alcuni dati nella primavera del 1980 e, al momento attuale, sono in parte editi è in parte in corso. di stampa ne- . gli studi in memor•a del compianto Roger Saidah (13
). Questi dati riguardano soprattutto le necropoli arcaiche a incinerazione, delle . quale ho appunto illustrato brevemente in precedenza alcuni materiali e la cui esistenza, come detto più sopra, avevo giàipotizzato in un ulteriore lavoro. In questa sede dunque · tratterò in modo specifico i1 materiale ceramico relativo alle necropoli a inumazione, messo in luce a Sulcis nél corso degli ultimi decenni e a Monte Sirai durante le campagne di scavi 1963-1965. Ritengo sia necessaria e opportuna la riedizione di questi recipienti, sia alla luce delle ultime risultanze emerse. sia per alcune
'
preci~zioni di carattere cronologico. In ogni caso mi riprometto, ove il tempo e le circo-stanze me lo consentano. di prendere in esanie in un prossimo futuro le miriadi di frammen· ti relativi all' abitato di questi due centri. l frustuli; se pur non appariscenti sott~ l'aspetto estetico·, sono estremamente importanti per quanto riguarda, da un lato, la maggior conoscenza del sito e delle sue vicende cronologiche. Dall'altro, questi framnìenti sono fon· damentali soprattutto per un auspicabile ed ulteriore approfondimento dei modi e degli usi quotidiani di vita e delle imprescindibili correnti commerciali e culturali e 4 ) che influenzarono sotto molti aspetti le comunit~ sia civili che militari della sardegna fenicia e punica,
•• oltre che gli stessi centri di Sulcis e di Monte Sirai. ~
· In ogni caso, ritengo sOmmamente opportuno, per una prima visitazione della problematica esposta più sopra, comunicare alcuni dati preliminari, relativi alla ceramica di stlper· ficie rinvenuta durante diciotto anni di lavori a Monte Sirai, sotto questo aspetto certamen-. . .
te più remunerativa, poichè priva, al contrario di Sulcis, . degli inquinamenti derivanti da ·un . abitato modemò sovrapposto.
Si avverte comunque che queste considerazioni non vanno assunte nella loto valenza
(11) S. S. Antioco. - Sca.o di tombe ~iche pultiche: NSc, 1942, pp.106·lS.
(12) L A. Marraa, sflli;o. pp. 187-209, ove è raècolta un'ampia doçumentazione tipoloaica e cronologica di forme di UIO dotne~tioo .
. (13) Cf. Bartoloni, Rec&~eil. .
(14) Sulle conenti commerdlli e culturali da e P.'r la Satdepa, soprattutto nei secc. VI, V e IV
a. C., d. S. Molcati, Tlt•ro• e. il t:ommt!l'clo Clll'lllgineM In ltdil~ MCNI G~«<tz, 11 (1976). pp. 13·14;
Id., R mondo punlco, Torino 1980, pp. 27-35; Bartolont - Tronc:hetti, Nor11, pp. 57-64.
40 Studi sulla ceramica fenicia ·e punica di Sardegna
assoluta, data la loro natura necessariamente incompleta derivante dalla loro sporadicità, ma vanno lette nell'ambito esclusivo del loro contesto di rinvenimento. Le emergenze di superficie infatti non possono di per sé costituire uri dato statistico probante, ma concorrono unicamente a confermare e corroborare i dati certamente più autorevoli, forniti dai saggi stra t igrafici.
Sono dunque senza alcun dubbio da rigettare e sono da· ritenere assolutamente non validi per la scienza contemporanea tutti gli studi che, assieme alle relative conclusioni, siano fondati e tratti unicamente da ~ontesti superficiali. Ciò poichè non .sono accompagnati dagli opportuni e, anzi, necessari saggi, tes.i ad indagare la reale consistenza dei contesti. La presenza fuori contesto stratigrafico dì qualsiasi frammento ceramico pur estremamente antico, prezioso e di provenienza o fabbrica lontanissime, se è valido come supporto ad una indagine di scavo, di converso nulla può aggiungere ad una corretta ricostruzione del quadro storico d'assieme. Ciò al pari del _ben più noto argumentum ex silentio, ove l'indagine non sia prossima al suo compimento. La menzione di queste trouvailles, che riveste gusti collezionistici e attitudini tipicamente antiquarie e di ~erto non conso'ni ai sistemi· di ricerca attuali e futuri, non reca di per sé nulla e nulla, al contempo, è correttamente in grado di aggiungere, poichè troppe e ·non sempre molto limpide sono le strade attraverso le quali queste ci sono giunte e ci vengono proposte.
Tornando ai nostri siti, ciò che traspare nell'immediato ad un esame anche superficiale, è l'estrema abbondanza di forme onerarie di tutte le epoche, comprese tra la metà del VII e la fine del Il sec. a. C. Intendo affermare, ·confortato in questo dài saggi effettuati soprattutto a Monte Sirai, che ciò si può riscontrare anche solo a giudicare dagli orli di que-
. sta classe di recipienti; essi soli, del resto, costituiscono una testimonianza tipologica e cro-nologica probante, in quanto i frammenti di parete, pur numerosissimi, risultano per loro natura troppo anonimi e atipici. Infatti, per quanto riguarda l'orizzonte culturale trattato in questa sede, le forme commerciali raggiungono una percentuale molto prossima al 25 per cento. Si tratta in prevalenza di anfore dei tipi < tirrenico > e <a sacco >, queste ultime distribuite nelle varie epoche, dalla prima metà del VI sec. a. C. al Il sec. a. C. L'esemplare di tipo <tirrenico > (MC inv. 98144) (Fig. 6~··b) e proveniente da Sulds, è conservato nel Museo Na:zjonate· di Cagliari ed è databile nella seconda metà del VII sec. a. C. e 5 ). l due restanti · ese'ìnplari pertinenti al tipo cosiddetto <a sacco > sono invece rispettivamente databili, il primo (MC s.n. ·inv .) (Fig. 6, c), nella prima .metà del VI sec. a. C. e 6 ) e, iJ secondo (MSA s.n. i~v.) (MSN63/2·c) (Fig .. 6, d), tra la seconda metà del V e i primi decenni del
• • IV sec. a. C. L'esemplare di cui alla Fig. 6, c proviene in realtà dalla necropoli a incinerazio-ne di Bithia (MC ~.n. inv.) (8TH 694) e viene presentato in questa sede come specimen in sostituzione dei recipienti rinvenuti a Monte · Sirai, che, pur identici. sono sempre incompleti. In ogni caso, nelle considerazioni statistiche di cui sopra si è tenuto debito conto, come si è detto, anche del materiale venuto in luce nel corso delle varie campagne di scavo.
Per quanto concern~ il restante 75 per cento, sempre relativo a ·Monte Sirai. occorre
(15) a. V. Tusa, Lo scavo del 1970: Mozitl - YJJ, pp. 75-76, tav. LVII, 4.; cf. inoltre S. Lanool,
!.es nivet~ux funéMires: Byf'lll- Il, pp. 336, 341, fJ18. 546-47, dove il tipo viene defmito <cananéen >. (16) Cf. Tore, Notiziario, pp. 6-8, fJg. 2.
Capitolo Il 41
preventivamente dire che prevalgono in assoluto le forme aperte, come, del resto, mostra il citato contributo di L A. Marras e 7 ). Tra questi tipi sono in percentuale decisamente maggioritaria i piatti, soprattutto ombelicati o da pesce, e le tazze, con pareti dritte o carenate, che occupano una percentuale del 40 per cento circa, equamente distribuita. Seguono le olle più o meno aperte, n~cessarie all'uso domestic() e, in particolare, alla cucina, che occupano il 15 per cento circa. Il restante 20 per cento circa è riferibile all'insieme delle forme chiuse note - soprattutto brocche ·- che, pur .abbastanza numerose, non sembrano investire in modo significativo la vita quotidiana del nostro centro. L 'uso e la distribuzione percentuale dei materiali succitati risulta particolarmente interessante se si. considera che, nella necropoli a inumazione e in quella adiacente a incinerazione e 8 ), al contrarìo, le percentuali sono esattamente ribaltate. In ogni caso le forme chiuse sono riferibili unicamente al versare ·e non al mangiare o al bere, funzioni a cui erano preposti i piatti e le tazze, né al conservare. poichè a ciò erano destinate le grandi anfore di tipo commerciale. In questo
. . caso ci si riferisce ovviamente a derrate di ampia consistenza quantitativa e di grande e pri-. .
mario consumo, quali l'acqua e i cercali~ c non certo a piccole · conserve, alimentari e non, che potevano appunto essere opportunamente riposte in recipienti chiusi di modeste dimensioni.
Quanto aì tempi di appartenenza dei nostri frammenti ceramici., la ·grande maggioranza, come è ovvio •. è pertinente àl periodo finale del nostro centro. Pertanto, sempre per quan· t o attiene ai ritrovamenti ·dì superficie, vi è da registrare, accanto a una presenza del 15 per cc n tò d i frammenti rela.tivi a i secc . V Il e VI a. C. e ad una analoga per quanto riguarda le forme di V sec. a. C., un eclatante 30 per cento per quanto concerne i frammenti del IV sec. a. C. e un 40 per cento riferibile a quelli del III e del Il sec. a. C.
Per quanto attiene, infine, ·sia alla presenza pre-fenicia sia agli apporti commerciali alieni. considerati questi ultimi nella loro totalità dal VII al Il sec. a. C., la quantità di frammenti ceramici riferibili a questi ambiti culturali non su. pera il l O per cento della tota.lità.
Tra i capisaldi per una data finale del centro di Monte Sirai vi è quanto risulta dalle ac· curate indagini di F. Barreca, che pone la fine di una vita urbana stabile neJI'acropoli non oltre la seconda metà dell sec. a. C. (~"9 ), ma già ampiamente in regresso· fin dagli ultimi anni del Il sec. a. C. Bisogna aggiungere che, da indagini stratigrafiche, per il momento incdi· te., svolte in questi ultimi anni, ciò non solo è stato ampiamente riconfennato, ma è stato consolidato alla luce dei risultati ottenuti. Infatti, né la ceramica di superfi.cie, accuratame~-
.
te raccolta e catalogata in relazione .agli -ambienti di provenienza durante lo spietramento del sito, né g!i ·ormai numerosi saggi stratigrafìcì effettuati negli anni scorsi, . han·no mostrato una consistente presenza di ceramica aretina o sud-gallica o, tanto meno; sigillata chiara di produzione nord·africana o delle . loro imitazioni locali. Ciò risulta senz'altro probante poichè, come è noto, la Sardegna e, in particolare1 il meridione dell'isola, in età romana gra-
. vitarono principalmente verso il Nord-Africa, iri evidente prosecuzione di antiche e reitcra-
·-
te consuetudini.
(17) Cf .. Marras, Saggio, f'Jgg. 2·7.
(18) Cf. P. Bartoloni, La necropoli (CtZI'IJfNII'Ull98J): MonteSirai 1981.
(19) ·Cf. F. Barreca, Le /ortifica:zioni: Monk_SJ:ai- II, pp. 73-74. ... . . . . . . ....
42 Studi sulla ceramica fenicia e punica di Sardegna
L'inconsistenza quantitativa di questo tipo di ceramica ci autorizza quindi a supporre la fine di una frequentazione stabile e massiccia di Monte Sirai almeno nel l sec. a. C. In· fatti,. i frammenti di ceramica del tipo sigillata chiara, di fabbrica sia nord-africana sia di sua diretta imitazione, non compaiono nel nostro centro in percentuale maggiore del 3 - 4 per mille, ivi compresi tutti i ritrovamenti di superficie o di scavo stratigrafico.
Appare manifesto dunque -che il centro di Monte Sirai irriziò a spengersi per qualche motivo intuibile ma non meglio precisabile e strettamente connesso con l'occupazione romana della Sardegna e sopravvisse non certo floridamente non più di centocinquanta anni al· la data che segna ufficialmente questo avvenimento storico. Ci si domanda, a questo punto, come sia possibile proporre l'identificazione del centro di Monte Sirai con il sito di Pupulum f 0 ), poichè non risultano assolutamente chiari i motivi che hanno spinto restensore della Tabula Peutingeriana a ritenere fosse · opportuno segnalare sulla stessa un centro abi· tato che era onnai spento da più di duecento anni e che come abitato civile non aveva probabilmente mai fatto parlare di sè a JiveUo sia demografico che produttivo. . .
La fortezza di Monte Sirai era certamente, per sua stessa natura sia geografica che oro-·grafica, estremamente importante sotto l'aspetto strategico, ma lo era certamente divenuta in modo molto minore da un punto di vista civile, per gli stessi motivi. Con questo assunto intendo dire che, per qual)to riguarda l'aspetto agricolo, non solo la c.;>llina su cui sorge-
. . . va non era assolutamente in condizione di nutrire o, comunque, di sostentare un abitato tan-to ampio e consistente, ma, soprattutto, il contado coltivabile era eccessivamente distante e in buona parte già utilizzato da numerosi pagi già noti e altrettanto consistenti in età punico-ellenistica e l). La stessa fine del sito dimostra la sua oggettiva carenza nella possibilità di fornire certe garanzie e i servizi necessari al sostentamento di una comunità civile.
Come si è avuto modo di accennare più sopra, la ceramica della necropoli a inumazio· ne di Monte Sirai non sembra rispecchiare se non in minima parte le forme in ·uso neO' abitato. In ogni caso, poichè sono sia pur in minima parte coincidenti, sarà opportuna una descrizione dei tipi principali presenti sia a Sulcis che a Monte Sirai, suddivisi cronologicamente per periodi.
Prenderemo innanzi tutto in esame, dunqùe, le principali forme p~rtinenti aDa secon.;. da metà· del VI e a buona parte del V sec. a. C. Questo arco di tempo, afferente a queUo che ho indicato come periodo punico arcaico, è a sua volta divisibile,· in base alle risultanze emergenti nei due centri trattati, in due ulteriori periodizzazioni. La prima, che chiameremo periodo punico arcaico l, copre un arco di tempo compreso tra l'ultimo quarto del VI e i primi anni del V s~c·. a. C. e la seconda, che chiameremo ovviamente periodo punico ar-
(20) Cf. S. M. Ceccbini, P• un'identi/iazzlone di Mo,te Slfai: OA, 10 (1971), pp. 183-87; di
diverso avviso è P. Meloni, Lll Studt!g1111 ro11U111111 , Sassari 1980, che propone in moclo certamente più ra
gionevole e plausibile l'iclentificaà.one di Pupulum con l"'attuale ceatro di Matza~ra.
(21) a. F. Barreca, L 'esploruione topogra/ica dell4 rt!Kkme irulcitlliUI: Monte Sil'lli - III. pp. 137-38; si tratta dei centrl di Matzacara e Paringianu. In proaimità di quest'ultimo centro sono ancora
visibili le cave di ca1çue a grana fine che Jwmo contribuito aDa costruzione deU'abitato di Monte Sirai.
A questi centri deve essere qgiunto l'abitato pUDico-romano di Porto SeUlO, che, identificato nel cono
di recenti prospezioni e sopralluoghi ancora inediti, visto.e e iUumiDanti traoc:e deDa sua storia.
Capitolo/l 43
caico Il, che riguarda il restante spazio temporale fino alla metà del V sec. a. C. Comunque, questa ulteriore suddivisione temporale non è percepibile per tutte le forme, poichè non tutte sono rappresentate in modo sufficientemente ampio. Tra queste sono da porre in evidenza i piatti ombelicati. Nel periodo indicato questi recipienti hanno una forma chiaramente arcaizzante (MC s.n. inv.) (MSN65/12-44) (Fig. ), o) che si richiama senza dubbio alle forme simili in auge almeno fin dalla metà del VII sec. a-. C. nei più antichi centri fenici di Sardegna, quali, ad esempio, quello di Bithia, (MC inv. 92887) (BTH 555) (Fig. l, m) attua
le Torre di Chia e2 ). Le varianti, dovute senza dubbio a un processo evolutivo, sono quantificabili in un restringimento progressivo deJI'ombelico e nella paritetica angolazione del~
le pareti f 3 ). In questo periodo il fondo conserva ancora J'umbone piatto sospeso che ca
ratterizZa costantemente le fonne più arcaiche f 4).
Per quanto concerne sia la pasta che il colore e la decorazione, i primi due sono in genere rossastri, mentre l'ultima, quando è presente, sembra peculiare del nostro centro e si presenta con dei gruppi di linee nere e bianche disposte perpendic.olarmente rispetto all'ombelico e 5 ). Due ulteriori tipi di decorazione, comuni ai centri punici contemporanei, sono costituiti, il primo, da due linee, prevalentemente di colore rosso, che seguono rispetti
vamente l'orlo del piatto e del suo ombelico e, il secondo, dalla verniciatura a risparmio in rosso praticata unicamente all'interno del cavo ombelicale.
Per quanto riguarda le tazze, nelle camere ipogeiche non appare nessun esemplare che possa essere apparentato neanche lontanamente ai tipi più arcaici rinvenuti nei saggi dell'acro· poli di Monte Sirai (MC s.n. in v.) (MSA66/III·B) (Fig. l, p). Mi riferisco in particolare a t. le tazze con e senza carenatura (MC inv. 92827) (~TH 179) (Fig. 1 o, j), che possono essere senza dubbio accostate a esemplari simili di Sicilia, ·Sardegna e del Nord-Africa, ma che, in ogni caso; sono afferenti a un periodo anteriore al nostro f 6 ). In· sostituzione di queste, sono presenti, tra l'altro, ·materiali di fabbrica attica o greco-orientale, tra i quali fa spicco la già menzionata coppa di tipo 8 2 della tomba li di Monte Sirai, in posizione notevolmente attardata rispetto alla cronologia tradizionale di questa forma. Non compaiono, in-. oltre, le tazze con pareti leggermente rientranti e piede ad anello, diffuse dalla seconda me-tà del VI sec. a. C. e pre~nti con alcuni 'esemplari nella necropoli di Bithia e con un ~seniplare nella zona del tofet del centro di Monte Sirai fZ 7
).
Passando alle forme chiuse di questo periodo', rivolgerò la mia attenzione alle piccole brocche di tipo vagamente biconico, estremamente ftequenti neUa necropoli di Sulcis (MSA
. s.n. inv.) (Fig. l, h), e quindi, ma in forma minore, nella nostra (MC s.n. inv.) (MSN64/11·398) :.
. .
(Fig. 1 j) - (Mç ·mv. 98147) (MSN64/11•36C) (Fig. l, i). Questi recipienti sono retaggio
(22) Cf. da ultimo Bartoloni, Bithilz, pp. 491·500.
(23) Bartoloni, Bithill, ·p. 497.
(24.) Cf. Bartoloni - Tronchetti, NorQ, p. 39. ' '
(25) Cf. Bartoloni, Rtt.11ell.
(26) Per gli esemplari in qaleatione rinvenuti neD'acropoli di Monte · Sirai, çf. da ultima Marru,
&alo,~ fil· l, 12-16; d.-inoltre, coo la relativa ~ib~ A. Ciuca., Sant 11Dt mru11 di Mozill {Ct1171ptl-/ . .
PtQ 1978): RSF, 7 (1979), pp. 213-14, nota 22, r,. 17, 3.
(27) P. Bartoloni, Lll ceTtJmial VlliCOiiue: Montt SITtli 1980, p. 227. tlg. 2, 9.
44 Studi sulla ceramica fenicia e punica di Sardegna
di epoche precedenti, come parte di quelli che seguiranno, e si richiamano, con ovvie varian
ti evolutive, a esemplari abbastanza simili in uso fin dalla seconda metà del VII sec. a. C., sia nella necropoli di Nora (MC inv. 95043) (NNP/2) (Fig. t, l) che in quella di Bithia (MC inv. 67909) (Fig. l, k) (2 8 ), ove la variante relativa alla fine del VI sec. a. C. (MC inv. 91866) (BTH 446) (fig~ l, g) è indubbiamente molto simile alle nostre.
Continuando sempre con le forme chiuse, possiamo osservare dapprima le brocche con . .
orlo cosiddetto ...: a fungo >. Risulta palese, innanzi tutto che questi recipienti sono la risul-tante evoluta della stessa forma che compare nelle aree cimiteriaJi di Sardegna fin dalla metà del VII sec. a. C. se non in epoca precedente (2 9
). Ma, mentre gli archetipi, prossimi agli esemplari fenici di Oriente, sono piuttosto tozzi e con il collo di tipo tronco-conico, i no-
. .
stri acquistano sveltezza di linea e presentano un collo con due evidentissime strozzature, l'una superiore e l'altra inferiore rispetto al taglio mediano, che è generalmente poco profondo. Si possono distinguere abbastanza agevolme.nte due tipi fondamentali, frutto specifico dell'evoluzione già evocata, che trovano .riscontri. ovviamente al di fuori di Sulcis, in
. altri centri viciniori e o).
Il primo tipo, più arcaico e presente negli ultimi decenni del VI sec. a. C., sia a Sulcis (MSA s. n. inv.) (Fig.· J, a) che a Monte Sirai (MC s.n. inv.) (MSN63/2-sn) (Fig. l, b), ha la pancia di .tipo ellissoidale e, in generale, raggiunge dimensioni superiori a quelle del secondo tipo, compreso nei primi decenni del V sec. a. C., che ha una pancia di tipo ovoidale schiacciato (MC inv. 98145) (MSN64/Il-39) (Fig. 1, c) o è. di tipo tozzo e sub-cilindrico (MC s.n. inv.) (MSN64/I 1~67) (Fig. 1, d), particolarità queste unite ad un col1o molto sagomato. Si confrontino a questo proposito le altre forme dci due centri presentate in altra sede e 1). Anche le dimensioni generali di quest'ultima variante non sono indenni da mutamenti evolutivi e risultano ampiamente ridotte (MSA s.o. inv.) (Fig. l, e) - (MC inv. 98148) (MSN 64/11-33) (Fig. 1, f)rispetto a quelle degli esemplari più arcaici presentati più sopra, quasi per allinearsi, sia pure con un ritardo di circa un cinquantennio, agli aryba/loi corinzi e etrusco-corinzi, dei quali i nostri recipienti avevano le medesime funzioni, sia pure, nel nostro
caso, di ambito esclusivamente funerario e 2 ). Pasta e vernice sono del consueto colore ros-. .
so cupo. con abbondanti inclusi micacei e granilici; la lucidatura è effettuata con il meto-•
do cosiddetto <a stecca >. La decorazione, aUo stato attuale delle scoperte, sembra pecu-liare dei due centri sulcitani: si tratta in questi casi di più gruppi di due, tre o quattro linee, tracciate evidentemente con pennello 'a più punte, che vanno a disporsi sull'orlo, sul. collo, sulla spalla e sulla pancia. La somiglianza -delle brocche con orJo cosiddetto <a fungo > della necropoli di Monte ~irai con .le forme contemporanee rinvenute nella necropoli a inumazione di Sulcis è tale che, questi recipienti, avulsi dal loro contesto originario, potrebbero essere agevolmente ospitati, senza alcuna reale pos8ibilità di distinzione, in qualsiasi corre-
(28) Cf. Bartoloni - Tronchetti, Nora, p. 25; da ultimo cf. P. Bartoloni, Su alcune testimonian-. .
ze di Nora arcaica: Habis, l O ( 198o-1981 ), pp. 3 75.SO.
(29) Cf. Bartoloni, Cronologill; Bartoloni, Bithia, pp. 493~94, fig. l, d.
(30) Cf. P. Bartoloni, Su alcune testimonianze di NortJ arcaica. cit., pp. 376-77.
(31)
(32)
Cf. Bartoloni, Cr,onologia, f~gg. 1,17, 2, 4, 6. '
Cf. Bartoloni, Cronologia, p. 25, nota 74.
Capitolo II 45
do di quest'ultimo centro e3).
U~ altro recipiente, tipico delle aree cimiteriali del periodo arcaico, è la brocca cosid
detta <biconica > o < bil.obata >. Questa forma partecipa generalmente a tutti i corredi delle tombe a incinerazione e4
), assieme alla già citata brocca con orlo cosiddetto < a fungo>.
Nella nostra necropoli, della quale in questa sede si esarni.na un aspetto più tardo, invece, ap·pare costantemente accompagnata anche da altre forme chiuse. La sua forma è palese frutto
di una evoluzione interna e si presenta con corpo fusiforme unito ad un piede espanso, carat
teristiche queste assenti nelle forme arcaiche (Fig. IO, a-c). Anche nel caso di queste brocche si possono riconoscere due varianti , pertinenti rispet
tivamente agli ultimi decenni del VI sec. a. C. e ai primi decenni del V sec. a. C. Il primo
tipo è ovviamente più vicino agli originali, dei quali conserva, ad esempio, l'ansa a doppio
can~ello (MC s.n. inv.) (MSN64/ ll-61) (Fig. 2, a) es) ed è ovviamente molto simile ai coe
vi esemplari sulcitani (MC s.n. in v.) (Fig. :!, b). Inoltre è ricoperto generalmente da verni
ce di colore rosso opaco e -è .decorato con gruppi di tre o quattro linee nere parallele, deli
neate principalmente sulla spa.lla e sulla pancia. La seconda e più tarda variante diviene più
slanciata (MC inv. 98157) (MSN64/11-59) (Fig. 2, e), con il piede espanso sempre più evi
denziato dall'esiguità della parte inferiore della pancia; l'ansa diviene a bastoncello, con se
zione ellissoidale. Anche in questo caso sarà opportuno associare al confronto 1e altre broc~
che presentate altrove e 6 ). In questo periodo. inoltre, si riconoscono ·numerosi esempla
ri con spiccate· tendenze miniaturistiche (MC inv. 98158) (MSN64/ 11-43) (Fig. 2, c) -· (MSA
s.n. iriv.) (Fig. 2, f). La decorazione, in tutti gli ultimi casi, si presenta in modo più articolato, con l'inserimento di fasce di colore bianco (MC s.n. inv.) (MSN64/II-sn) (Fig. 2, d),
che, in qùesto periodo, sembra essere tipico ed esclusivo sia del centro di Monte Sirai che di quello di Sulcis. ·
Sempre a questo periodo appartengono le brocche con bocca 'trìlobata, evidente de-. rivazione· da mode li i greci: l nostri esemplari sono tuttavia più tozzi e pesa n t i degli origi- ·
naH. La vernice è ·del consueto colore rosso. Di particolare interesse è la dècorazione, che
si presenta parzialmente di tipo ornitomotfo: ai lati del lobo anteriore della bocca, subito
sotto l'orlo sono sempre delineati due gr~ndi occhi" in vernice. nera o bianca, a imitazione della testa di anatra (MC inv. 98151) (MSN64/ll-70) (Fig. 2, j) - (MC inv. 98152) (MSN
. . 63/ 10-83) (Fig. 2, h). A completare la decorazione sono, talvolta, sulla spalla una linea di occhielli in vernice bianca o nocciola-chiara e sulla pancia tre gruppi di linee bianche e ne- ..
· re alternate, delineati verticalmente dalla spalla al piede. che ricordano la decorazione dei . . .
piatti più sopra ·citati, o quattro linee dei .medesimi colori disposte in forma stellare. L'e-
semplare sulcitano (MSA s.n. inv.) (Fig. 2, i) è parimenti verniciato in rosso, su tutta la su
perficie~ ma preseòta una decorazione monocroma delineata con vernice nera. Oltre ai ca
ratteristici occhi, sono delineati alcuni tremuli sul collo e alcune righe, due delle quali in
quadrano una fascia, posta sulla massima espansione della pancia. Questa forma, priva dì de-
(33) Cf. Bartoloni, Cronologilz, pp. 22-25.
(34) Cf. Bartoloni, Bithill, p. 495.
(35) Bartoloni, BithifJ, f1g. 2, a-c.
(36) Bartoloni, Bithilz, p. 496, fJg. 2, h.
46 Studi sulla ceramica fenicia e punica di Sardegflll
corazione, è presente, sempre nello stesso periodo, ma frutto di più antiche reminiscenze, nella necropoli a inumazione di Bithia e 7 ).
Ultimo esemplare nell'ambito della tipologia delle brocche, è il recipiente che si pre-. . . senta con bocca circolare, orlo tondeggiante e cordolo in rilievo alla metà del collo . Le due brocche presentate in questa sede sono le uniche presenti nei corredi funebri sia di Sulcis
. -(MSA s.n. inv.) (Fig. 3, h) che di Monte Sirai (MC s.n. inv.) (MSN63/I0-74) (Fig. 2. g). In effetti gli esemplari di questo tipo sono piuttosto rari in questi ambiti, mentre invece ebbero maggiore fortuna nelle aree sacritìcali, soprattutto di Tharros e di Mozia, ma anche, seppure più raramente, in quella di Sulcis, come contenitori delle ceneri derivanti dal sacrificio e 8 ). l nostri esemplari, coerentemente con il periodo al quale appartengono, presen· tano la consueta decorazione a gruppi di due o tre righe nere, disposte sul collo, sulla spalla e sulla pancia.
Tra le anfore, infine, è da citare il tipo con pancia ovoide, diffusissimo nella necropoJi di Monte Sirai (MC s.n. inv.) (MSN64/ ll-1 S) (Fig. 4, a), cosi come in quella su lei tana (MC. inv. 43368) (Fig. 4, b). Peculiare della sua tipologia è il cordolo in rilievo alla metà del collo, sul quale vanno ad appoggiarsi le anse a sezione ellissoidale. Il tipo deriva da esemplari arcaici, presenti tra l'altro anche a Mozia e nella necropoli a incinerazione della stessa Monte Sirai, oltre che, fm dal VII sec. a. C., anche nel tofet di Cartagine e nella necropoli dell' isola Rachgoun. Questa fonna, recepita anche in ambiente iberico, è presente, ·assieme ad alcune varianti di matrice locale, nel sito di .Cruz del ·Negro e9
). · Come ormai è norma, an· che questa forma è dipinta con vernice rossa ed è decorata da più gruppi di tre o quattro ri· ghe nere.
Senza dubbio degna di una menzione particolare è un'anfora proveniente da una tomba sulcitana (MSA s.n. inv.) (Fig. 4, c), che, in questo particolare periodo, costituisce a tutt'oggi un unicum per entrambi i centri trattati in questa sede. La sua forma con spalla carenata è tipica di Cartagine, fin dall'epoca più antica (40
), ma, in Sardegna ebbe grande fortuna, unicamente a partire dal V sec. a. C., quasi solo nei centri posti lungo l'asse del Cam· pidano, sia pure con alcune testimonianze più .arcaiche ubicate sia nella necropoli di Paniloriga che in quella a incinerazione di Monte Sirai (41
). Nel suo aspetto più tardo è presen-. te infatti con numerosissimi esemplari sia nel to[et di Tharros che nella necropoli di Tuvi-
•
(37) cr. Bartoloni, Oinochoe, pp. ~7·50; Bartoloni, Bithltz, p. 496. fig. 2, J. D tipo, sempre for·
nito di lungo collo, ha n corpo più o meno scbiacdato e rutr~rnato verso il bas10. . .
(38) SuUa cronologia e aulla diffusione di questa partiC41are forma si veda quanto OIPOSto al ri·
guardo nel Capitolo l di questo volume.
(39) 0'. V. Tusa, Lo SC(IW) de/ .1970: Mozlil- VII, pp .. 38 40, tavv. XXVII, XXXI, 2; P. Batto
toni, La necropoli: Monte S;Di 1982, in corso di stampa; D. B. Harden, The pottery from the precinct . .
of Tt111lt at &zlllmmbo, Outhage: lr~~q, 4 (1937), pp. 71, 74, r~g. 4. D, p; Vuillemot, Reconntli.wiiCel, pp. . . .
63-65, f~gg. 22·23; M. E. Aubet, . lA cérDniiCil a tomo de la Cruz del Negro (CtumONI, Sntlliz): Ampurill1,
38-40 (1976-78) (= Simpo1i lntemaclonttl: El OrìKen1 dd mlm lbhic,_ &rcelontl - EmpUriel, 1971), pp. . .
267-87. figg. 1·2.
(40) Cf. Cintas, Manuel- /, tav. ,X?(I, 113. . ..
(41) P. Bartoloni, La necro"poli: Monte S;tzi 1982, in corso di stampa.
Capitolo l/ 47
.
xeddu a Cagliari ~2 ). Il nostro pezzo, che è databile neUa prima metà del V sec. a. C., è da
segnalare anche per la vistosa decorazione di tipo arcaizzante che lo accompagna. Sono visibili · fasce di vernice· bianca sul collo e sulla pancia, queste ultime inquadrate da righe nere, mentre lo spazio compreso tra le anse accoglie una fascia decorata con i medesimi colori in stile metopale. Una delle rnetope, composta da du_e righe nere si allarga verso il basso, in modo da formare uno spazio triangolare, che senza dubbio ricorda le decorazioni pre~nti sulle più antiche forme vasco lari di Cartagine (4 3
) oltre che queUe delineate sulle più antiche uova di struzzo c- 4
) . Sulle anse sono delineate sette righe orizzontali, anch'esse di tipico gusto arcaizzante. ,
lnfme sono da menzionare due anfore, rispettivamente d~ Sulcis (MC inv. 98142) (Fig ~
3 d) e da Monte Sirai (MC inv. 98143) (MSN6_4/ 11-sn) (Fig. 4, d), già presentate in altra sed~ e che in questa si citano per completezza di documentazione (4 5 ), che si ispirano evidentemente a modelli greco-orientali, testimoniando con la loro presenza quanto meno una consuetudine delle maestranze puniche con i materiali d'uso ionici, dei quali vi era un palese commerciò (46 ) . l tipi originali a cui si ispirano sono genericamente datati, senza ulteriore precisazione cronologica, al pieno VI sec. a. C. c-'), ma, in ogni caso, la presenza dei nostri esemplari d'imitazione in tombe ipogeiche - associati alla già citata coppa ionica del tipo B 2 - dimostra almeno una indubbia persistenza tipologica reiterata nel tempo ed è da intendersi come probabile frutto di contatti commerciali non certo sporadici tra i due ethnoi, avvenuti prima dell'intervento militare di Cartagine.
La decorazione dell'esemplare di Monte Sirai ripete più o meno fedelmente quelle degli ·originali più correnti, mentre queDa dell'esemplare sulcitano, accoppiata ad una forma senza dubbio più rigorosa di quanto non lo sia quella dell'esemplare precedente, risulta mol-
. to simile .a quella presente sulle forme di matrice punica e di tra(iizione fenicia illustrate più sopra. Si vedano ad esempio le brocche con orlo cosiddetto <a fu'J1go > e le brocche .cosiddette <biconiche >. n particolare della presenza dei tremuli, per di più disposti in stile metopale, richiama invece alla memoria modelli decorativi fenici di Cartagine, ascrivibili a tempi ben più antichi ('8 ).
Rappresentati · in misura minore, ma pur sempre testimoniati, sono i materiali relativi al periodo punico ~lassico, compreso tra là metà del V sec. a. C. e la prima metà del IV sec. a. C. Tra le forme aperte, in apparente non consistente presenza di tazze di produzio-
. (42) Cf. ad esempio E. Acquaro, Lo reno del 1977: Tluno1- IV, p. 68, fig. 10, 1-4; A. Tara·
. meDi, lA Mcropoli punictl di Predio lbb11 t1 S . .Averrdnce, CllglitiTi (lctiVi de/1908) : MAL, 21 (1912), col.
102, r11. 11, 1 . . . (43) Cf. Cintu, M11~el- I, tav. xxv~ 20. 23.
(44) Cf. E. AoqU&I'Q, Uowtdlrtnuzodipi11ted4 Bttlrltl: OA, 20 '(1981), pp. 57-65.
(45) Cf. Bartoloo.L A1t/ol'e, pp. 323·27. l"
(46) Cf. L. A. Marra, Lil ~,.mieti di tmltdione dlzllll necropoli: Monte Sirai l 98 l . .
(47) Cf. P. Rouiflard, Les cl1fl.miquer peintt!l dt! ltl Gr~ce de l'E1t et leur imit11tiom dlln1 111 pénirr-
llllt! ibbique: Reclrel"che1 P'ililffinoirer: Cir~~ntiques grècques de 1•Esr et lftu df/fiufon m Ocddent, Na· poli- Puis 1978, p. 282, tav. CXXIV (V), 2.
(48) Cf.Ontas,MtmUel-1, tav. XXXIV, 103,106.
48 Studi sulla ceramica fenicia e punica di Sardegna .
ne punica, sono da citare i piatti che hanno subito una ulteriore evoluzione rispetto agli esema p lari più arcaici (MC s.n. in v.) (MSN64/11-51) (Fig. 5, a) (4 9 ). lnfatt i, il cavo dell'ombelico è di diametro visibilmente più esiguo e meno profondo, così come le pareti divengono sempre pi~ angolate.. Il piede perde sovente. pur conservandolo in aJcuni rari casi, come in quello presentato, il tipico umbone caratterizzante le forme arcaiche e si presenta inferiormente concavo. La decorazione, non sempre delineata. è abbàstanza elementare e conservativa ed è costituita da due righe, prevalentemente rosse. disposte rispettivamente sull'orlo e attorno al margine dell'ombelièo .
Tra le forme chiuse di questo periodo presenti a Monte Sirai è senza dubbio da segnalare un kernos o candelabro, con corpo cavo e piede passante, che presenta alla sommità una protome di ariete, affiancata lungo tutto il perimetro da sette piccoli contenitori che conservano vistose tracce d i bruciato (MC in v. 98153) (MSN64/J l A 18) (Fig. 3. b). Il nostro recipiente svolgeva pro'babiln~nte una funzione rituale al1'intcrno della tomba, al pari di quello. con parte della decorazione d i stile < ionico >, rinvenuto in una tomba a camera della vicina Sulcis (MC' inv. 98160) (Fig. 3, a) e che è invece da ascrivere al periodo precedente, ma comunque non prima della fine del VI sec. a. C' . (50
). la sua decorazione; particolarmente vistosa, è eseguita con la consueta vernice nera e bianca su fondo ross.o: sulla faccia anteriore di ·ciascuno dei sette piccoli recipienti è impressa a stampo una testa ùmana di profilo. di tipo .greco-orientale .· la cronologia di que-sto ultimo pezzo •. che·. èomo si è già accennato, è da porre nel periodo punico arcaico e dunque non prima degli ultimi ~eccnni del VI . e non dopo i primi an n i del V sec. a. C. , ci è data dalla lucerna. a tazzina, di tipo indubbia-
. . . mente mediato da originali greci c fornita di due becchi passanti, che occupa la sommità del vaso rituale, e ci è confermata dall'appartenenza di questo pezzo a un corredo di tomba ipo-.. .
geica polisoma. A ulteriore conferma della sua cronologia, cosi come di que1Ja indubbiamen-te più tarda del candelabro di Monte .Sirai. sta la forma completamente travisata dei sette piccoli recipienti posti attorno al gambo centrale. Infatti, nei kernoi più arcaici, pertinenti al VII sec. a. C., quali quello della nccropoli di Mozia (51 ) e quello, formalmente identico . e pervenuto ci senza dubbio in migliori . con~izioni, pei il momento in ed i t o, della necropo-Ji di Bithia, i recipienti di contorno sono verosimilmente dei vasi caliciforml. noti· anche come vasi < à chardon >, di dimensioni miniaturistiche. mentre, nei casi presentati più sopra e pertinenti ai si ti trattati in questa sede, ess( hanno evidentemente perso ogni connotazioa
. . ne specifica. Il kernos sulcitano, in conclusione, si inquadra nell'ambito di una simbiosi de-rivante dall'evoluzione di forme tipicamente fenicie ·e dall'imitazione. di forme o di modu-.
•
li decorativi greco-erientali già registrato · per gli altri recipienti derivati dai centri di Sulcis
(49) a. Bartoloni, Rcweil.
(50) Per 1a prima edizione di questo vaso rituale cf. Barreca Studegna, tav. XXX; da ultimo cf. G.
Tore, Elementi culturizli semitici nella Sardegna centro-settentriollllle: Atti della XX/l. R4Jnionc Scientifica . . . . dell'Istituto Italumo di Pr.eistoria e Protostorio neiJD Sardegna centro-settentriolfllle - 2i-27 ottobre /978,
Firenze 1980, p. 277, nota 35, il. quale .Jo ~rive, invece, assieme alla statua egitt~zante incedente rinvenuta . . .
in una tomba ipogeica su lei tana e, quindi, non collocabil~ an eh 'essa prima della fme ·del VI sec. a. t .. <. .. alla . ' . ' .
seconda metà del VII secolo a. C. e agli inizi del VI (forse per la .lampada, anche un poco· più tardi) ... >. . . .
(51) Cf. V .. Tusa; Lo scllPO de/1970: MozÌ/1·- VII, p .. 70, ta.vv. Llll. XCVI.
..
Capitolo/l 49
e di Monte Sirai (52 ).
Sempre al periodo suindicato appartengono alcune brocche con pancia tondeggiant~ o tronco-conica (MC s.n. inv.) (MSN 10-129) (Fig. 3, c). Plasmate con una pasta fme~ depurata e biancastra, presentano molteplici e diversi tipi di decorazione a vernice. Tra tut-
. ti prevalgono quelli. con fasce rosse, marginate da righe rosse o nere, ma sono da registrare anche quelli composti da gruppi di righe nere isolate o da gocce, disposte queste ultime sempre sulla spalla del recipiente. Esemplari siinili, di dimensjoni più o meno cospicue, ma sempre comprese nell'ambito dei piccoli oggetti domestici, sono stati rinvenuti sia a Sulcis che
•
a Nora e a Bithia (53), a testimonianza di una osmosi culturale e commerciale .tra i centri
dell'attuale r~ione sulcitana. _ Proveniente in questo caso dalla necrop0Ji di Sulcis è una brocca che si ispi~ eviden
temente a originali attici della seconda metà del V sec. a. C. (54). Il nostro esemplare (MSA
s.n. inv.) (Fig.· 3, e) è provvisto di bocca circolare con .orlo fortemente espanso e ansa sormontante con sezione circolare. Privo di decorazione, è dcope~o di vernice rossa, tipica del capoluogo sulcitano. In ogni caso, la sveltezza di linee lo accosta senza dubbio anche agli ese~plari metallici presenti nello stesso periodo (5 ~ ) ..
..
Ancora ·tra le brocche si possono indicare quelle con bocca circolare e pancia ovoide (MC s.n. inv.) (MSN63f7-c) (Fig. 5, g) che pur essendo presenti, come ad esempio, se si prescinde dalla_ decorazione, anche nella neeropoli cagliaritana di Tuvixeddu (MC inv. 52970) (Fig. 5, h), non sono per altro testimoniate in numero cospicuo nelle necropoli sarde. Questa forma deriva senza dubbio da prototipi attici ed è assunta in ~pertoriò nei corredi punici di Sardegna fin daU'ultiino quarto. del VI sec. a. C., come testimoniano gli esemplari di Bithia (MC inv. 91811) (F@. 3, g) e quello sulcitano (MSA s.n. inv.) (Fig. 3, f), che è inve- ·
' .
ce ascrivibile aDa metà del V sec. a. C. (56 ). Gli esemplari relativi a Monte Sirai e a Tuvixed-du sono senza dubbio frutto · di una evoluzione interna, ormai avulsa dagli originali, e possono essere collocati verso la fine del V sec. a. C. . . .
Sempre comprese in questo arco di tempo, sono da menzionare, tra l'altro, due piccole anfore .provenienti dai centri di Sulcis (MSA s.n. in v.) (Fig. 5, e) e di Monte Sirai (MC
. 98154) (MSN65/12·16) (Fig.· 5, d). L' e5emplare sulcitano è dec~rato·.con Je consuete righe nere e . bianche alternate, alle quali si· affmnca una fùa di occhielli disposta sulla parte alta ·della spalla, reminiscenta quest'ultima di decorazioni più antiche. Il recipiente di Monte Sirai ripete lo . schema consueto, pur con qualche minima variante. La fonna di queste anfore è abbastanza diffusa e trova confronti significativi sia formali che cronologici con la · ·
(S2) . Cf. Bartoloni, An[on, e quanto detJo nelle PICIM precedenti a pr~to dele anfore di imi
tazione greco-orientale di Sulcis e di Monte Sirai.
(S3) 0'. Bartoloni - Tronchetti, Nora, pp. 47-49.
(54) B. A. Sparkea - L. Talcott, Blllck tllfd pllzin pott~ry of tlr~ 6th, 5tlt tmd 4th cenlrll'k1 b. C . . (-=A thmitm A6o1'11, 12), Prince.ton 1970, n. 275. p . . 78, tav. 13.
(SS) Cl. tra i'aJtro, M . .PoNidJ. TentoÌ8ftCel de l'tlrt p~c D. TlllfKO : BAM, 7 (1967), pp. S9S-96,
tav. 2; rubicaziooe neD'atremo Oociclcllte del Mediterraneo di queato recipiente bronzeo dimostra im-
pUc:itamcmte la 1ua ampia diffusione. · ·
(56) Cf. Bartoloni- Trouchctti, NoN. p. 34; .Bartolont. Ooraologir,-pp. 21-22. fig. 2, 7-8. ·
•
50 Studi sulla ceramica fenicia e punica di Sardegna
vicina Nora (57 ).
Coeva agli esemplari precede·nti è l'anfora acroma con anse a rocchetto e doppio cannello (MC inv. 98156) (MSN64/ 1144) (Fig. 6 , a). La particolare tipologia delle anse inserisce questo r~ipiente tra quelli di gusto arcaiu.ante, ispirati a modeRi del secolo. preceden·
•
te e all'ambiente greco-orientale. ' Sono da citare inoltre le piccole anfore siluriformi senta collo e con orlo leggermen
te gonfio e appena aggettante verso l'interno (MC s.o. inv.) (MSN64/II-sn) (Fig. 3 , i). Le nostre forme, presenti anche in altre necropoli puniche-di Sardegna (58 ), sono talvolta prov
. viste di umbone o di peduncolo terminale e richiamano senza dubbio i coevi esemplari, di ,dimensioni ben maggiori, di uso commerciale o domestico.
· A conclusione della rassegna dei recipienti· pertinenti a questo periodo sono da men-zionare infme le grandi anfore commerciali, cosiddette • a sacco > · (MSA s.n. inv .) (MSN63/2-c) (Fig. 6, d) la cui capienza .è da considerare attorno ai 30 litri e la cui forma ripete quella di esemplari ben più antichi, menzionati più sopra. · La depressione centràJe della pancia, presente costantemente,. ha uno scopo precipuamente funzionale che potrebbe essere individuato nella necessità di assicurare con cordami questi recipienti ai basti degli animali da soma. Le uniche discriminanti· cronologiche tra i tipi delle varie epoche sembrano essere costitui
te dall'orlo, che nei primi esemplari è fortemente ·m rilievo, mentre in. quelli più tardi- si appiattisce fmo a scomparire all'interno del recipiente~ e dalla 5agoma del corpo che da ·tozzo e vistosamente panciuto diviene con pareti rettilinee.
Il periodo successivo, inquadrabile tra la metà del IV e i primi decenni del III sec. a. C.~ è quello che vede, sempre per quel ·che. riguarda la ceramica vascolare~ il progressivo afftevolirsi delle manifestazioni artigianali tipiche del retaggio fenicio a indubbio vantaggio
. . . e sotto l'impulso delle forme più proprie del mondo ellenistico; mediate dall'ambiente gre-
co, e in particolare, attico. Infatti, dalla fme del VI ~c. a. C., accanto a una presenza poco più che sporadica di forme attiche (59 ) , si assiste aDa progressiva e, poi~ subitanea, sparizione di ogni forma di importazione relativa agli ambienti greco.;orientali, ·sostituita da una progressiva e semp~ più massiccia presenza di imp~>rtazioni -attiche, tanto capiUare da·· provocare
~ . nell'ambiente punico di sardegna un più che appariscente fenomeno imitativo. .
Per di più, in oggettivo accordo con lè . altre ·~ del Mediterraneo centro-occidentale, sottoposte o meno aU~influenn .commerciale e politica· di Cartagine~ si assiste ad ùna massiccia assunzione da parte del mondo punico · di Sardegna ·di tutte queUe forme ~e per funzionalità ed· eleganza soddisfacevano i ·mercati del mondo antico. ·che la <grande politica> di Cartagine sia parte. i:f1 causa di questo fenomeno commerciale, ritengo non . sia da dubitare, soprattutto per quanto riguarda la Sardegna, che era considerata c territorio metropo· litano > r 0
).
Scompaiono pertanto tutte o quasi te forme d~uso domestico e funerario che costi-
(57) Cf. Bartoloni - Troncbetti, NON, pp.· ·53-55, f"IJI. 9, 84. 15. 237.
(58) a. Barto!Oni - Tronchetti, Norri,·p~ SO •. nota 107·• fig. 1•. 212~ (59) a. C. Ttoodtetti. ContributO •IJo 11114#0 dd cotnmel'cio tlulflww: MEFRA, 91 (1979),
pp. 6).69; kl., La preu:nza d~IJG ceTIImiCll tlttb III'Clilt:tl ndlll Studtp~~/èlt i~CII: AC3F, pp. 501·507.
(60) 0'. Battoloni - Troncbetti; NON. pp. 51·58. . . .
Capitolo/I 51
tuivano il retaggio della madrepatria orientale e ad esse si sostituiscono con maggiore e oggettivo vantaggio quelle che sono frutto del livellamento ellenistico. Queste ultime, oltre all'aspetto decisamente più gradevole, affiancavano l'indubbio vantaggio tecnico, nel senso di una migliore utilizzazione dell'oggetto contenitore e di una maggiore disponibilità e fruibilità del bene contenuto
Recedono, dunque, quasi defmitivamente i piani apodi, sostituiti da recipienti sem-. .
pre ombelicati~ ma con pareti orizzontali se non addirittura curvilinée, appoggiate ad un pie-de distinto anelliforme (MC s.n. inv.) (MSN64/II..SS) (Fig. 5, b). Del pari scompare la pur esigua decorazione che si era osservata in precedenza, sostituita, qualora si manifesti, da una generica colorazione a vernice rossa, applicata unicamente alla facc.i_a super.,re. Accanto a questa forma, ·tipicamente punica, si affianca, per prevalere nel secolo successivo, il piat .. to cosiddetto -< da pesce>. Questo recipiente, tipico dell'ambiente attico e italiota, finisce per emergere su tutte le forme aperte, nelle sue soluzioni verniciate o acrome. La forma, con ·minime varianti, perdurerà nei nostri centri fino agli anni che videro la fine di Monte . Sirai e, per quanto riguarda Sulcis, fino all'avvento delle forme di ceramica aretina e di si-gillata. Comunque, i tipi di piatti punici succitati, nello stesso periodot compaiono anche tra le deposizioni del tofet di Monte Sirai, con funzione. di coperchi (6 1 ).
Tra le tazze predominano ugualmente le forme imitate da prototipi attici: tra tutte, sono da segnalare le forme 21, 22 e 21/25 della classificazione del Lamboglia (62 ). Le risultanti puniche di questi modelli si adeguano strettamente o interpretano più liberam~n
te gli archetipi, fino a risultare se non diverse, almeno molto lontane dagli originali. Ciò, non solo nell'orizzonte di una produzione stanca, ma anche nell'indubbio tentativo di un miglioramento della funzionalità e di un adeguamento al gusto locale.
Le brocche . di questo periodo assumono dimensioni piuttosto ridotte rispetto a quel· Je del V e della parte iniziale del IV sec. a. C. Si tratta di esemplari prevalentemente apodi,
. .
con bocca circolare o trilobata. In quest'ultimo caso, sotto le convessità dei due lobi late-rali, appaiono delle depressioni verticali, dall'orlo aDa spalla. Alcuni tra questi recipienti so-· no l'evoluzione interna di tipi punici più antichi, mentre altri sono la copia più o meno con-., .
forme di tipi attici con· bocca circolare (MC inv. 98149) (MSN63/l0..53) (Fig. 5, f) e con bocca triJobata (MC inv. 981SS) (MSN63/10-25) (Fig. 5, c) (63).
Con il ritorno del rito dell'incinerazione, dipendente dalla massiccia introduzione in Sardegna di costumi ellenistici, alcuni recipienti di discrete dimensioni, comunque spesso superiori ai cnt. 30 di altezza, e con ampia bocca, vengono inseriti con funzione di urne cine· rarie, all'internò dei loculi delle camere ipogeiche. Tra questi, peraltro non molto numero· si nella necropoli di Monte Sirai, sono da notare una brocca con orlo gonfio e ribattuto e
(61) ·Cf. P. BartoloDi, La ceftlmica VlliCOitzre: M011te SIT11i 1980, pp. 225-21.
(62) Cf. N. Lamboglia, Per UNI cltuli/icszione pnlimÌIIIlre della ce11mica ctunp(llfll: Atti del/
Cblr.trmo IntmrazioNJie di Studi Llgurl, Bord~era 1952, pp. 17~72, 17~75; B. A. Sparkes- L. Talcott, op. dt., IUl. 805-807,.833-35, 882-89; cf. da ultimo J.-P. Morel, Cbamique Cllmpani~ne. La {or·
mes (= Bibliothèque des Ecoles Frtmçailes d'AthèneG et de Rome •. 244)~ Roma 1981. pp. 204-20, tan. 65-70. .
(63) Cf. B. A. Sparkes- L. Talcott, op. dt., nn. 188-89, 1623.
52 . Studi sulla ceramicafenicÌil e pu.nica di Sardegna
un vaso cilindroide con orlo obliquamente espanso e due piccole anse (64). La stessa deco
razione a inci$ione di quest'ultimo recipiente è tipica di questo periodo tardo-punico e ci riporta, trà ·l'altro, al coevo ambiente delle necropolì di Olbia, compreso tra la metà del III sec. a. C. e gran parte del li sec. a. C. (65 )
Siamo evidentemente ormai prossimi alla estinzione del nostro centro. Occorre nota-. re, tra raltro, che troppo esiguo è il numero delle urne contenènti ossa combuste in un pe-riodo - la fme del III e tutto il Il sec. a. C. - che, presumibilmente coincide se non con la massima espansione dell'abitato, almeno con il periodo caratterizzato spesso da restauri e
. .
riattamenti degli edifici dell'acropo-li ~ 6 ). Del resto tale ·situazione demografica si evince in modo inoppugnabile anche dalle risultanze del coevo strato di deposizioni del tofet, che
'
occupa in questo periodo una discreta estensione~ ma non la massima, unita ad una eviden· te concentrazione delle urne r 7).
Pertanto ne consegue che resta anèora da individuare, in un luogo non certamente molto lontano dal cèntro abitato, la necropoH relativa ai secc. III e Il a. C., che deve essere ne
cessariamente a incinerazione, in accordo con quanto avviene nei centri tardo-punici di Sar· degna.
Ma quali conseg~enze possono essere tratte da quanto detto fino ad ora? Ne scaturisce dapprima la considerazione che, in tutte le epoche della sua esistenza, nel centro abita
tivo di Monte Sirai fu in uso un tipo di cerarnic·a ·vascolare Completamente diverso da quel-. lo destinato ai riti funerari. Fatto che, sia detto per inciso, non compare invece per quan-to riguarda il rito dei to{et, ove le urne, almeno· nei sècc. IV e III a. C., sono del tutto simili a quelle utilizzate nell'ambito domestico dell'abitato (6 8
).
Ma, · proseguendo nella trattazione, sempre nell'acropoli abbiamo posto l'accento sulla netta preponderanza dei vasi per bere e per mangiare, uniti a grandi recipienti .atti al tràsporto e alla conservazione. Nella necropoli a inumazione, invece, a probabile conservazione di precedenti riti, sono state rinvenute in prevalenza forme destinate al versare, con una percentuale, rispetto alle fonne aperte, che è dell'87 per cento circa.
In aggiunta a questo, anche alcuni vasi d~signati al versare, in realtà si rivelano del tut-••
to inadeguati a questa funzione. Si tratta in particolare delle brocche con orlo cosiddetto <a fungo > _. Infatti, queste, a causa della forma dell' orlo, m vece di incanalare i liquidi in una direzione ben precisa, come sarebbe conveniente, 1i spargono in ·modo del tutto inadegua·
. . .
to. Ne consegue dunque che, i fluidi .contenuti . in questo tipo di brocche doveVano .essere abbastanza viscosi e che, al pari degli aryballoi greci o di loro imitazione , .l'ampio orlo era
(64) cr. M. G. Amadasi - L Brancoli, Lll necropoli: Monte Sirai -Il-. p. 120, tavv. XLll, 94, XLDI,
97; per quanto concerne Ja brocca, il tiPo è usimiJabile, anche per la funzione di ossuario, all'esemplare . .
edito in Bartoloni - Tronchetti, NON, p. 56~ fig. 6, l.
(65) Cf. D. Levi, Le necropoli punlche di Olbia: SStll', 9 (1950), p .• 41, fsg. 1, d; da ultimo, E.
Acquaro, OlbiD - Il (ctzmpt~g~~~~. 1978): RSF, 8 (1980)? pp. 74·75, ilota 22, tav. XXII, 0878/1'6/2? anche .
per ulteriori attestazioni coeve.
(66) Marras, Saggio. pp. 187-90 . .
(67) F. Barreca- S. F. Bondì,Scoineltofet di Monte St'tzi: RSF. 8 (1980), pp.l43-4S.
(68) P. Bartoloni. Liz cerrzmictz11118C0ltzre: Monte Sirtzi 1980, pp. 22~27.
Capitolo II 53
probabilmente destinato a spargere e a diffondere più che a versare. Si può argomentare pertanto che, data l'estrema carenza di ritroVamenti di questo ti
po di forma nei centri abitati e, al contrario, data la sua costante presenza nei contesti. funerari a incinerazione arcaica e in quelli a inumazione fmo ai primi decenni del V sec. a. C., essa può essere legata a ragione al rito funerario (69 ). Quale fosse la sua funzione non è pos
sibile saperlo con certezza, ma è intuibile che essa fossé strettamente legata ad una probabile unzione rituale del defunto.
Altra constatazione, che risulta abbastanza evidente dalla comparazione della nostra necropoli a inumazione con quelle a incinerazione della Sardegna centro-meridionale, è che i corredi di · accompagnamento dei defunti inumati sono numericamente più consistenti. Nel
le tombe a incinerazione, infatti, SI hanno,. di norma e salvo casi veramente eccezionali, non più di cinque pezzi d~ corredo. Tra questi sempre due brocche, rispettivamente l'una con orlo cosiddetto <a fungo> e l'altra ·con bocca.cosiddetta <bilobatà >, e, talvolta, due piatti, un'urna o una piccola brocca piriforme (' 0 ). Nelle tombe del nostro centro, invecè, al-
• meno a giudicare dalle poche ossa rimaste, che sono peraltro irrecuperabili a causa del for-te tasso di umidità e di acidità del terreno, ad ogni defunto erano attribuiti, fino ai primi decenni del III sec. a. C., otto-dieci pezzi di corredo. A partire da quest' ultima data e fmo al periodo tardo-repubblicano, in coincidenza con il ritorno dell'incinerazione, il corredo praticamente scompare, sostituito talvolta da una mòneta-viatico.
' Inoltre, alla luce delle risultanze che vanno emergendo dalle ricerche in atto, si ritie-
ne necessaria una più che opportuna e attenta considerazione dei dati storici che ne conseguono, che sono portati in superficie e che sono offerti, previa interpretaZione, allo studio comune. Quindi, se ciò che viene dato per certo, ad esempio, dagli studi sulla ceramica di . .
produzione ·etrusca fosse comparato con quanto risulta dall'indagine 'sulla coeva ceramica fenicia di Sardegna, alcuni dubbi più o meno latenti potrebbero forse essere dipanati e, di contro, alcune certezze potrebbero risultare talvolta meno tetragone.
In conclusionè, da quanto è stato messo in evidenza in questa· 5ede, emerge una note
vole involuzione dell'area sulcitana, da intendersi forse anche come conservatorismo. Infat· ••
ti si è potuto agevolmente notare che tutti gli impulsi culturali esterni, recepiti probabilinen-te nel corso del VII e certamente nell'arco di buona parte del VI sec. a. C., sono stati estrinsecati, almeno nell'ambito della ceramica vascolare, nel periodo compreso tra la parte fina·
le di quest'ultimo secolo e la prima metà di quello successivo. Ciò malgrado le non irrilevan- • ti e oggettive testimonianze di contatti esterni, riferibili in particolare all'ambiente grecoorientale, del .quale sono stati citati alcuni prodotti. Ci si riferisce ovviamente sia a manu-. .
fatti originali, sia a quelli interpretati locàlmente, che contribuiscono indubbiamente ad am-pliare il quadro d'assieme.
l sintomi di questa tendenza conservativa si acuiscono quando si osserva che, con le medesime tecniche valide nei secc. VII e VI a. C., anche nel pieno V sec. a. C. vengono interpretati e divengono oggetto di pubblica fruizione, al seguito di una precisa committenza, materiali mediati da ambienti che, per motivi politici e per accadimenti storici conseguen-
(69) Bartoloni, Recueil; Bartoloni. Cronologhz, p. 25. nota 74.
(70) Cf. Bartolo~. Btthill, pp. 491·97.
. 54 Studi sulla ceramica fenicia e punica di SaTdegna
ti, non toccavano più da tempo il mercato sulcitano. Il conservatorismo diviene ancor più palese quando questi materiali divengono frutto di più recenti approcci; ci si riferisce in questo caso alla brocca di tipo metallico che, pur riproducendo quasi specularmente una forma attica di V sec. a. C., è eseguiia con la consueta vernice rossa e con la tipica Iucidatura cosiddetta ~a stecca > che in nulla tecnicamente la discosta dalle· forme più tipicamente fenicie e puniche arcaiche, afferenti ai secoli precedenti. Questa- situazione risalta ancora più evidente al confronto con i coevi materiali ceramici di Tharros e di Cagliari ove è più che percepibile il tentativo di adeguare alla ormai sorgente koinè mediterranea anche i prodotti destinati al mercato interno. Si ricava dunque la concreta sensazione che, così come si è notato altrove per i prodotti ceramici di Nora, la zona del Sulcis fosse non certo un'area . . depressa, ma senza dubbio una regione .periferica e <provinciale ,. rispetto al ben più pri-vilegiato asse campidanese.
· Questi ed 1altri innumerevoli problemi emergono dall'indagine storica e archeologica dei centri di Sulcis e di Monte Sirai e, in generale, deUa civiltà fenicia e punica. Problemi senza dubbio stimolanti che sono spesso legati, ·come in Sardegna, a sostrati di millenarìa civiltà_ Pertanto si auspica, e per quanto attiene. alla parte che mi .compete sono senz.a dub·
. . bio incline a perseguirla, una osmosi disciplinare che chiarisca dal suo interno alcuni tra i
problemi che si sono presentati e che, .certàrnente, si ·presenteranno nè.l futuro.
•
CERAMICA FENICIA E PUNICA DA THARROS
Desidero precisare innanzi tutto che con il tennine di ceramica arcaica di Tharros e quindi, necessariamente, degli ·altri centri fenici di Sardegna, intendo rivolgere l'attenzione a tutte quelle forme vascolari che, dalle origini dell'accessione fenicia in Sardegna, giungono fino al terzo quarto del VI sec. a. C. Con questo assunto intendo dire che le fanne vasco· lari simili, pertinenti a diversi centri fenici della costa libanese, hanno subito, come si è detto più sopra, neiJe diverse regioni · toccate dal commercio e dagli stanziamenti fenici, un dif·
. ferente processo evolutivo. Questo si presenta in misura più o meno conservativa ed è, co-munque, legato sia a cause locali, sia a fenomeni di arcaismo, tipici questi ultimi della ceramica fenicia di Sardegna, sia a influenze allogene, derivate queste principalmente dal com
mercio o, in ogni caso, frutto di contatti, conseguenti a rapporti politici e commerciali in· temazionali.
Alla luce di quanto esposto e a suo corollario, appare manifesto come, in sede pan-mediterranea, siano congrui tra di loro unicamente quei confronti, relativi alle fanne cerami·
che, i quali siano· limitati nel tempo non oltre la fine del VII $ec. a. C. Oltre questa data e per i motivi succitati, tali confronti n~n mi sembrano validi se non ristretti, di necessità, a
• ciascun ambito regionale. AIJ'interno di ciascuna regione, poi, le fonne simili all'origine si evolvono in modo uniforme e, in ogni caso, diverso da quanto accade nelle zone limitrofe,
ma non abbastanza da non permettere di intravedere da quali archetipi esse derivino. Si vedano, a questo proposito e come esempio, te ·spiccate similitudini tra le brocche con orlo cosid
detto <a fungo> più tarde della necropoli a incinerazione di Paniloriga (') e quelle più arcaicliè ~
delle necropoli a inumazione di Sulcis e di Monte Sirai e), pertinenti, le prime, al secondo e ter-zo quarto del VI sec. a. C. e, le seconde, all'ultimo quarto dello stesso secolo. A conferma di quanto detto e in contrasto con la .mutua .Somiglianza delle fanne dei tre centri citati , nulla da . queste è esteriormente condiviso con le coeve ceramiche di Cartagine e), ove queste brocche appaiono certamente più tozze e pesanti.
(l) Cf. Tore, NotlzÌI/Tio, pp. 3-12; Bartoloni, Cronologia, pp. 19-20.
(2) Cf. Bartoloni, Cronologitz_. pp. 22-25 e, inoltre, quanto dotto nel contn'buto relativo al Capitolo
II di questo volume. •
(3) P. Gauctler, Nécropoles puniqan de Outluzge, 11. Paris 1915, tavv. CLIII, CLXXII, CCIX.
58 Studi sulla ceramica fenicia e punica di Sardegna
Inoltre, fin dallo stesso periodo punico arcaico, a questo fenomeno si affianca anche quel· lo della spiccata preferenza, per i medesimi scopi, di una determinata forma a discapito di altre. Mi riferisco in modo particolare ai vasi·contenitore in uso nei tofet, ove si manifesta, fin dalla fine del VI sec. a. C., una palese preferenza e persistenza di questa o quella forma. Queste, pur essendo di uso comune e ampiamente attestate in tutti i siti punici coevi, ven· gono utilizzate in forma maggioritaria o minoritaria per cause e per motivi p~r il momento non meglio precisabili, ma dai quali non può essere certamente disgiunta una volontà di con· servazione e, dunque, un riconoscimento istituzionale di scelte private.
• A maggior conferma di queste risultanti, a partire dagli ultimi decenni del VI sec. a. C., la ceramica fenicia di Sardegna muta radicalmente la sua facies: infatti, in questo perio· do e negli anni successivi, accanto ad aspetti che mostrano, come si è detto, un processo estre· . mamente evolutivo delle forme arcaiche già consolidate, appaiono nuove· sagome, che, pur sempre di matrice chiaramente fenicia, non nascondono, ad un attento esame, una loro ori· gine derivata da mutazioni di marca tipicamente nord·africana, o meglio, cartaginese.
. . . Sono, per l'appunto, ampiamente noti e ben inquadrati storicamente dal Meloni gli
accadirnenti politici e militari relativi alla Sardegna neUa seconda metà. del VI sec. a. ·C. ( 4).
Non sarà pertanto inopportuno ricordare che, prima di questo periodo non sembra traspari· re mai e in ne~un luogo un rapporto. violento tra l'elemento fenicio .e queRo autoctono, al· meno in base a quanto ci. è dato di poter giudicare dalle risultanze arche\) logiche in nostro possesso e dalla tradizione mitica, ma ·non troppo, dell'accessione fenicia in Sardegna, rac· colta e attentamente analizzata daiBondi (5 ).
A questo punto, ·ci piace immaginare, non certo per sensazioni epidermiche, ma per ipotesi concr:ete, una naturale osmosi tra il mondo fenicio e quello nuragico, pur nella conser·
'
vazione delle rispettive identità, osmosi che s.i concretizza evidentemente con il mutuo scam-bio di esperienze, accettate senza dubbio più serenamente e mutuamente .di quanto non lo siano per alcuni aspetti, invece, quelle acquisite in epoche più vicine a noi.
Indizi in questo senso, non certo tenui, ma concretizzanti per alcuni versi U.Q.a quan· to meno parziale simbiosi, più che osmosi, tra i due ethnoi ci vengono indubbiamente for-
-~
niti dalle recentissime scoperte effettuate nella necropoli arcaica a incinerazione dell'anti· · ca Bithia (6 ), ove, strettamente associate a corredi di matrice e ritualità tipicamente fenicie C), sono state rinvenute, tra l'altro, quattro urne certamente di fabbrica nuragica ~), due delle . quali contenenti ossa combuste, munite di orlo internamente gonfio e, in alcuni casi, con anse a gomito rovescio. Tra queste, fa spicco una con antichi e più che evidenti
.
(4) P. Meloni, La cronologitz delle ct~mp~~~ne di Mt~lco: SStzr, 7 (19<47)~ pp. U)7·13; Id., lA &11iJ• '
gna 1'0mana.2 , Sassari 1980, pp. 7·15, ove è sintetizzato m modo estlcmamente convincoftte tutto il perio-
do che qui si osserva.
(S) S. F. Bondi Ouervazioni mlle fonti clalliche per la colonizzt~zione della &udegntl: ≫ Fe
nici- I(= CSF, 6), Roma 1975, pp. 49·72.
(6) Per alcune notizie preliminari su queata neetotoli cf. Bartoloni, Cf01101ogia, pp. 17-19 •
• (7). Cf. Bartoloni, Bith», pp. 491~2.
(8) La pubblicazione di queste quattro ume è affidata a D. Cocco, Jspettrice della Soprin~den-.
za Archeologica di Cagliari.
Capitolo III 59
restauri, effettuati con grappe, rese con piastrine rettangolari di piombo inchiavardate con sottili perni dello stesso materiale. Inoltre, tra le tombe di incinerati di Bithia, tutte rela· tive al periodo fenicio, ne sono state rinvenute quattro coeve contenenti corpi di inumati ('). Due di queste ultime, oltre al normale corredo vascolare, costituito in prevalenza da forme tipicamente fenicie, recavano due anfore. a sacco (Fig. 6, c), databili, in base ai riscontri, nell'ambito della prima metà del VI sec. a. C. Una delle due restanti conservava, posta in prossimità del cranio del defunto, una scapola di equide (cavallo ?) (10), mentre una di quelle con anfora cosiddetta -c a sacco > recava all'interno dell'anfora stessa i resti ossei incornbusti, testimonianti probabilmente il rito della scamificazione, il corredo usuale e una ulte· riore scapola di equide. Alcuni di questi inumati, al pari di molti degli incinerati, erano prov-
. visti di armi offensive in ferro e l), quasi sempre nel medesimo numero e della medesima tipologia e, in ogni caso, numericamente più abbondanti di quanto non lo fossero quelle presenti nelle coeve necropoli di Rachgoun e di Mozia (l 2 ). Queste erano rispettivamente una punta di lancia, provvista di lama a foglia e costolatura medianat simile peraltro a quella ci· tata più sopra e proveniente dalla necropoli di Rachgoun, un tallone, sempre di lancia e da immaginare ovviamente collocato sull'asta in posizione diametralmente opposta alla punta, un corto pugnale, sovente con lama a lingua di bue, e, infine, uno o più piccoli stocchi, verosimilmente da lancio, composti da un evidente pomello e da un'anima in bronzo, ricoper-
. -ta da una camicia in ferro, spessa. circa cinque millimetri (1 3
). Sia la punta di lancia che il relativo tallone sono stati sempre rinvenuti spezzati o piegati ab antiquo; ciò in connessione con evidenti valenze funerarie o magiche. Uno tra i pugnali, rinvenuto peraltro accatastato in una tomba a inumazione, era in bronzo ed era _fuso in un solo pezzo, con elsa a dupli-ci concavità contrapposte e apice mediano, e risulta, pertanto, indiscutibilmente simile ad alcuni di quelli rappresentati sulle faretrine votive di matrice nuragica e 4 ).
Sia il pugnale che i piccoli stocchi sono stati spesso rinv~nuti in posizione non coerente e visibilmente scomposta, verosimilmente a causa del fatto che sia le armi che il corredo erano deposti dopo la combustione del cadavere, ma prima della tumulazione dei resti. Tuttavia, nel caso di uno tra gli inumati cosi.cQme in altri riguardanti alcuni tra gli incinerati,
(9) SuDa presenza grandemente minoritaria di inumati in età arçaica in Sardegna e in alcune necro-
poli nord-africane, eocettuate quelle di Cartagine, cf. T ore, Notizitzrlo, p. 6, nota · Il ; Vuillemot, . .
Recomuds~~mees, pp:6()-63; Bartolo~ Oonologill, pp. 13·15.
(10) · SuUa presenza del cavallo in Sardegna in epoc• fenicia e punica cf. F. Fedele, Antropologitz .
e paleoecologia di Tharroa. Ricerche 1111 tofet (1979} e se.corultl CtllllpfiiNI toriloritlle nel Sinis: Tbfll1'or-
VI. pp. 91-94.
(11) 0'. Tore • Gras, Bithilz, pp. 75·76, 79, 81-82, fig. Cl.C4.
(12) Cf. Vuillemot, ReconMisSDnces, pp. BG-83, fig. 26; V. Tusa, Relllzione prelimiNue degli scavi e1eguiti 11 Mozilz negli mini 1972, 1973, 1974: Mozill- IX, pp. 20, 30, 39-40, 61.
(13) Quest'ultimo particolare non è registrato da Tore • Gras, Bithia poichè lo stocco ivi presenta
to, pur fortemente ossidato, risulta intepo ed emerge unicamente il pomeno bronzeo.
(14) Su queste faretrine cf. G. Lilliu, Sculture deOa SIUdeg114 nuragica, Verona 1966, pp. 456--58,
·nn. 347-49, figg. 636-38; por un'elsa di pugnale identica a queBa del nostro e raffiautata su una di queste
faretre, cf. E. Acquaro, U1111/flTetriu PotlN da A.ntas: OA, 8 (1969), pp. 127-29.
60 Studi ~lkz ceramica fenicia e punica di Sardegna
sono stati ritrovati uniti assieme e in stretta connessione tra di loro, in quella che, con ogni
verosimiglianza, doveva essere una sorta di faretra. Infatti. gli stocchi erano visibilmente af~ fiancati tra di loro e sovrapposti al pugnale, separati da quest'ultimo tramite una esigua in~
tercapedìne. Si può dunque supporre che la guaina che contenev~ le armifosse in materiale
deperibile, forse cuoio, e che fosse del tutto s'imile, come indiscutibilmente testimoniato dal· la stessa posizione delle armi, alle summenziona~e faretrine votive miniaturistiche in bronzo di fabbrica nuragica ( 1 5 ).
In concJusione, sia per la presenza delle urne che delle cosiddette faretre, sia per l'evi· . dente differenza del rituale funerario, si può ragionevolmente supPQrre che gli inumati della necropoli di Bithia fossero di origine nuragica o clie, almeno, fossero legati ·per qualche , verso anche a quel contesto culturale.
Ma, tornando, dopo questa non breve digressione, agli argomenti di cui sopra, si può ritenere che l'elemento nuragico fosse di per sè sufficientemente forte per· contrastare certamente con felice esito eventuali azioni manu militari da p~rte di un evidentemente esiguo nucleo di colonizzatori che, oltre al resto, era palesemente in espansione non certo territoriale, ma, solo e soprattutto commerciale e, quindi, almeno aD'origine, del tutto differente da quella di matrice greca ..
Infatti, come ho già avuto modo di ricordare in altra sede e 6 ), il commercio fenicio, . nella sua prima fase evolutiva, sembra aver assunto· di necessità aspetti e modalità differen-
ti a seconda dei luoghi o delle regioni che andava toccando e nei quali riteneva opportuno fondare un~ stazione commerciale. Ovviamente, in questo caso si prescinde dai noti racconti di Erodoto e 7 ), i quali evidentemente riflettono una fase estremamente arcaica del commercio fenicio e comunque uno dei suoi aspetti meno evoluti. Il noto episodio, degno di.
essere citato come curiosità avulsa da · una realtà ben diversa e ormai consolidata nell'epoca della quali si tratta, è riferito dallo storico probabilmente a regioni dell'estremo Occidente mediterraneo da ubicare forse, poichè si tratta di oro, lungo la costa nord-africana.
Infatti, appare chiaro e palese che, se i commercianti fenici si insediarono in regioni .
ove il concetto di stato nazionale era già radicpto, come ad esempio in Egitto o, per al~ni versi, nella penisola ellenica, essi si limitarono necessariamente a insediare dei semplici uffici . . .
commerciali, con residenti stabili profondamente integrati neii'ethnos locale. . Invece, nei territori ove la compone·nte ·autoctona, pur forte e bellicosa~ non aveva ancora recepito un concetto pJ:ettamente unitario · e nazionale, come in Sardegna e in parte in Sicilia o in .Spagna, i Fenici furono messi in grado di stabilire fondaci .. presto trasfonnati in ·empori e, quindi, in città,
. . --i cui limiti territoriali, per quanto esigui, erano probabilmente sanciti in virtù di possibili accordi e trattative decisi e stipulati a livello locale e tribale.
Premesso tutto ciO~ appare evidente come anche nell'ambito della ceramica vascolare fenicia di fabbrica sarda, ascrivibile al VI sec. a. C., si possa riscontrare un eVidente iato tra quella di produzione e di matrice originaria fenicia orientale, che discende fmo al terzo quarto del
(15)· Cf. da ultima F. Lo Schiavo. Economill t 10cletiz nell'età dei mull8hi: lchnuns, pp. 269, 333,
tavv. 377-78.
(16) Bartoloni- Tronchetti,NOI'Il, p. 57.
(17) Erodoto, IV, 196.
Capitolo III 61
secolo, e quella, sempre di origine orientale, ma di rielaborazione cartaginese o fenicia di ambiente nord-africano, che occupa invece l'ultimo quarto dello stesso secolo e, quindi, quelli successivi. Gli unici motivi plausibili per questo divario possono essere ragionevolmente trovati nel noto e più sopra menzionato intervento militare e politico di Cartagine. La metropoli africana, con il suo intervento in Sardegna, tendeva verosimilmente, tra l'altro, a mutare in modo radicale il poco remunerativo rapporto èommerciale preesistente tra la comunità fenicia e l'ambiente nuragico. Appare manifesta, con ogni evidenza, la sua volontà di impadronirsi delle ricchezze minerarie e agricole dell'isola e di gestire in proprio i proven-. ti derivanti, coagulando al contempo i paniali e forse meno lungimiranti interessi delle an-cora esigue enclavi fenicie.
In ogni caso, anche se si ammette il non strettamente esiguo divario cronologico, .dovuto ·di necessità ai tempi e ai mod'i dell'accessione fenicia in Occidente, la ceramica fenicia pertinente a.Ua seconda metà del VII sec. a. C. è, come si è detto, evidentemente ancora ab-
. . bastanza simile a queiJa di produzione fenicia di Oriente. Ma è certamente necessaria una ulteriore precisazione che, se di per sè potrà apparire non allineata a quanto detto, invece ben si inquadra nell'ambito generale della colonizzazione fenicia dell'Occidente mediterraneo .e nel particolare aspetto rispecchiato dalle fonti storiche a nostra disposizione, riguardanti l'accessione fenicia in Sardegna. Mi riferisco in modo specifico ad alcuni dati emer-
. .
si nel corso dello studio e del generale riesame della ceramica fenicia e punica di Sardegna, conservata nel Museo Nazionale di Cagliari, che conduco da onnai molti anni.
'
Dalla comparazione tipo logica effettuata di recente e 8 ), secondo la sequenza crono· logica offerta dalla stratigrafia della necropoli di Bithia et 9 ), è emerso in effetti che la ceramica fenicia di Sardegna e, comunque, quella che, proveniente da questa regione, in questa sede intendo come arcaica e dunque relativa al VII sec. a. C., ha significative assonanze, se . non addirittura ·consonanze, con le forme vascolari coeve o di poco anteriori dei centri fenici della costa meridionale deUa penisola iberica.
Rimando necessariamente alla parte tipoJogica di questo excursus per quel che riguarda i confronti più puntuali; che, anche. se non risulteranno particolannente illuminanti e de·
•• finitivi, contribuiranno certamente ad acclarare le liaisons tra la Sardegna e la non poi tan-to distante penisola iberica.
A questo punto desidero invece porre l'accento su alcune tra le· purtroppo scarne e certamente partigiane fonti e·o) riguardanti la mitica, ma, come si vedrà, non troppo, accessione · fenicia in Sardegna. Mi riferisco in modo particolare ai' passi di Pausania e di Solin:o. Per quarito conèenie il primo autore, il brano interessato suona come segue: < ... .I Libi per primi si dice vi prendessero terra sotto la guida di Sardo ftglio di Maceride ... Nulla di notevole accadde a Maceride, tranne un viaggio· fatto una volta a Delfi .... Tuttavia quella schiera libica non espulse gli indigeni, ma i nuovi abitanti furono accolti da loro in una nuova alleanza, e questo più per necessità che per ·atteggiamento favorevole ... .Molti anni dopo i Libi, vennero dalla Grecia quelli che avevano seguito Aristeo .;. Dopo Aristeo passarono in Sar-
(18) Bartoloni, Cronologill, pp. 13-29. ·
(19) Bartoloni, Bithill.
(20) F. Nicosia, La SIU'degnt~nel mondo chlhlco : lcltm4w, pp. 423-41.
62 Studi sulla ceramica fenicio e punica di Sardegna
degna gli lberi .... e fu da loro edificata la città di Nora .... > ~ 1 ) • . In se$uito Solino abbrev~a
come segue: <Non importa dunque narrare come Sardo. nato da Eracle, Norace da Mercurio, l'uno dall'Africa e l'altro da Tartesso della Spagna, arr.ivassero fino a quest'isola (/a Sardegna) ... > ~z). A commento di questi due passi, il Moscati aggiunge: < ... si intravede aldilà della leggenda un fondamento di eventi storici: sono chiari i rapporti che legano la Sardegna al mondo africano, iberico e miceneo ... Quanto alla successione· degli avvenimenti. sembra chiaro -che i primi Africani corrispondano in realtà ai Fenici...e la leggenda di Norace in-,
duce a chiedersi se, nella fondazione delle più antiche· città (fenicie di Sardegna) in genere e di Nora in specie, non abbiano avuto qualche parte i Fenici già stanziati in Spagna > ~ 3
) .
La somma di queste due risultanze, l'una archeologica e l'altra storica, non sarà di per sè probante, ma, in ogni caso, potrà essere accettata come ipotesi di lavoro.
Del resto, non debbono stupire intensi e costruttivi rapporti di epoca storica tra i centri della penisola iberica e quelli della Sardegna. Tr~lasciando per il momento sia i dati ar· cheologici più sopra ventilati, sia quelli storici, pur scarni, più compiutamente esposti, vistose tracce, sia pure in parte non contemporanee al periodo arcaico di cui si tratta principalmente · in questa sede, e cospicuj indizi stanno a testimoniare i più che frequenti e, aggiungerei, naturali contatti tra le due regioni. . Ciò per limitarsi ai dati archeologici che più da vicino ci interessano e ci riguatdano, senza toccare, per altro, i già evidenti(,legami di età preisto· rica e protostorica e 4
).
In virtù . della sua particolare posizione geog.-afica, la città di Th~rros è da considerare oggettivamente come partner privilegiato. Citerò a questo proposito quanto ha esposto ancora una volta il Moscati al riguardo: < ... Accertate la cpnsistenza, la n~tura e le proprietà delle botteghe artigiane di Tharros, v'è appena bisogno di aggiungere che ciò non attenua in alcun modo il carattere essenziale di questo centro, che è di ricezione e di trasmi~ione
sulla grande via del commercio fenicio-punico per le Baleari e l'lberia > e 5 ) ..
Questa situazione, almeno in parte, riflette nelle intenzioni dell'A. testè citato un periodo certamente posteriore a quello che qui ci riguarda, in ogni caso, successivo all'asse com· . .
merciale con l'Etruria, e contemporaneo, invecF. al ~ grande fervore commerciale con l'At-tica, conseguente all'intervento cartaginese in Sardegna e, dunque, precedente alla prima età ellenistica, ma è comunque arguibile che questi impulsi costituiscano la naturale risultante di ben più antichi contatti. Questi, in particolare, sembrano documentati dalla ceramica va- .
•
(21) Pausania, X, 17. 2-3, s. (22) Solin9,1V, 2; ll oonivo di questa citazione COli come di quelle che ieguiranno, è dell'A.
(23) · S. Mosca~ R mondo dei FenicP, Milano 1979, p. 247: una p:rezioaa e attenta critica stofi ..
ca delle fonti relative alla Sardepa è, tra l"altro, in F. Nicoàa. lA SllldtJfllll nel mondo cilluico: lchmu
sa, pp. 421·76, nett•ambito del quale contributo, tuttavia, .per ogettive teatimoDilnze archeologiche sem
pre mqgiormente emeqpnti, non si condivide l'esclusione del mondo greco-orientale da rapporti commer
àati diretti con la Sardegna nuragica e fenicia. ·
(24) Sul problema in geaeralè e sulla bibliograf'1a inereote, cf. G. LiDiu, Li1 cwilti dd <di'2 , To
rino 1972, ove sono raccolte, ira l'altro, le indicazioni :relative ai )avori che l'A.. ha ritenuto opportuno svoJ.
gere neu•ambito iberico insulare . .
(2S) S. Moscati,AnecdotQ Tluurllica: Anecdolii'IJJIITI'hica (.-: CSF, 5), Roma 1975, p.l31. ·
Capitolo III 63
scolare fenicia; ciò se non in modo definitivo e inequivocabile, almeno come risUltante di coincidenze non casuali né fortuite.
Prima di affrontare direttamente l'esposizione sulla ceramica arcaica del centro di cui ci si occupa in questa sede, desidero acclarare alcuni problemi inerenti il rito funerario e la conseguente deposizione cui si accompagnava di norma la suppellettile oggetto di questo contributo. In due precedenti lavori, il primo edito nell'ambito della Rivista di Studi Fenici e 6 )
e il secondo in corso di stampa nel Recueilà kl mémoire de Roger Sàilah e 7 ), che qui desidero ricordare ancora una volta, poichè è stato !mmaturamente e dolorosamente strappato alla .sua famiglia e al mondo degli studi, in questi due lavori, dunque, avanzavo l'ipotesi, quasi sempre documentabile e ormai ampiamente attestata, che tutte le necropoli della Sardegna fenicia in uso prima dell'ultimo quarto del VI sec. a. C., e dunque pre-cartaginesi in quanto anteriori alla conquista dell'isola da· parte degli eserciti della metropoli nord-africana, fos-. .
• • • sero a mcmeraz1one. Con ciò, in ogni caso, non si · intende certo affermare che, a· seconda dell'epoca, il ri
to funerario sia stato esclusivamente uno, ma è stato accertato che questo era senza dubbio prevalente. Si veda ad esempio la necropoli arcaica di Bithia, ove, come si è potutò notare, nel periodo compreso tra la metà del VII e la fine del VI sec. a. C., si hanno, allo stato attuale dei lavori, circa centocinquanta tombe a ·incinerazione e unicamente quattrò a inumazione. Altrettanto si può affermare per le necropoli arcaiche di Paniloliga, di Rachgoun, di Mozia e, ora, di Monte Sirai; · nella prima, tra le · numerosissime tombe a incinerazione è stata rinvenuta una sola tomba contenente un inumato; neDa seconda, su centoquattordici tombe, solo nove sono di inumati, tutti bambini e 8 ). Non altrettanto ,si può dire ·per Cartagine, ove i recenti scavi della necropoli arcaica di Byrsa. contemporanea o di poco precedente alle nostre, hanno posto in luce una situazione diametralmente opposta, cioè la prevalenza degli inumati su quella degli incinerati e 9).
In effetti quasi tuttf i centri arc.aici noti della Sardegna presentano questo aspetto particolare. Citerò · tra i centri oggi esplorati · Nora, Bithia. Paniloriga, Monte Sirai e Ot~oca. Gli unici tasselli mancanti al quadro· ·da ~ .proposto più sopra erano costituiti dai centri di Sul-., cis, Karalis e Tharros. Per quel che· rigU•nii Sulcis, la presenza di materiale arcaico di pro-venienza apparentemente sporadiça, unito all'evidente ·assenza di ceramica etrusca (bucche~ ro ), corinzia o etrusco-corinzia all'interno degli ipogei, che invece conservano, per quanto riguarda le importazioni, unicamente ceramica attica. soprattutto di V e di IV sec. a. C., mi hl peimesso di ipotizzare la presenza, in un luogo per il momento non identificato, di una necropoli arcaica ·m cui era in uso un rito non meglio acclarato. Anche per quel che concerne il centro di Karalis ho ritenuto valido l'argumentum ex silentio poichè la grande necropoli di Tuvixeddu, apparentemente t•unica in funzione in questo centro tra la fine del VI
. (26) Cf. Bartoloni, CrortDIOgltz, pp. 28w29.
(27) Bartoloni, Recuell.
(28) Tore, Nottzltl1'1o. pp. 3-12; VuiUemot. ReconnDirsmrces, pp.S9-63; Bartoloni, CronoiOKitz, p. 29 . ..
(29) S. ùncel, Ler nlvetiU:X et .attrer puniques de 14 colline de Byrrt~: Historique det recherche1:
ByTIII .;..: I, pp. 17·22; S. Lancel - 1.- P. Thuillier, Rllpport pnliminlllre 8Ur /Q et~mptJgM de 1976 (ni-,etzUX pu
niqlles): Byr111- I. pp. 256-68; S. Lancel, Ln·nhetlllX /ultbiÙTeJ: Byflll- H. panim . .
64 Studi sulla ceramica fenicia e punica di Sardegna
e i primi decenni del III sec . a. C., al pari di quella sulcitana citata, non ha mai restituito, . .
all'interno delle camere sepolcrali, materiali databili prima degli ultimi anni del VI sec. a.C. Per quanto riguarda, infine, Tharros, la mancanza pressochè assoluta di sicuri corre
di completi e di contesti omogenei, nonchè la necessaria garanzia data da scavi controllabili tramite rapporti esaurienti che non 'era offerta a tutt'oggi per quanto concerne le grandi necropoli, impediva un qualsiasi giudi:::io, anche basato su argomenti esnemamente labili.
Oggi, dopo un attento riesame e una rJvisitazione critica sia dei materiali conservati presso i Musei e gli Antiquarill dell'isola, sia deUe relazioni e dei resoconti, relativi agli scavi e ai materiali, depositati presso gli archivi della Soprintendenza Archeologica per le Province di Cagliari e Oristano, sia degli spesso lacunosi rapporti di scavo editi negli ultimi decenni del secolo scorso, sono in grado di affermare che anche nel centro di Tharros, fino alla fine del VI sec. a. C., era in auge prevalentemente il rito funerario dell'incinerazione, nello stesso periodo, dunque, in cui esso era praticato nei centri succitati e, probabilmente, fin dall'epoca del primo impianto urbano, che, allo .stato . attuale delle scoperte~ è presumibilmente da porre non dopo gli ultimi decenni dell'VIII sec. a. C.
Lungi dal ritenere che i dati che andrò esponendo possano e·ssere del tutto convincen- · ti e probanti, quantunque io creda nella loro veridicità, mi limiterò a fornirli corroborati da tutte quelle corrispondenze e analogie. talvolta stringenti, che non possono non essere constatate.
Nelle Notizie degli Scavi di Antichità del 1884 si può leggere quanto segue, a cura di -
E. Pais, .-a firma del Fiorelli, all'epoca Direttore Generale delle antichità, ma in quasi assolu-ta conformità con quanto scritto in precedenza neUa relazione depositata nell'archivio · delIa Soprìntendenza da F. Nissardi, autore materia l~ degli scavi: ~ .•. ad oriente della piccola torre (oggi nota con il nome di Torre Vecchia) ... aiJa profondità di m. 1,50 si scopri una lastra di pietra di m. 0,39 x 0,75. Sotto di essa giacevano delle pietre scomposte, le quali però in origine dovevano essere collocate· in modo da sostenere il detto -lastrone. In mezzo ad esse si trovò una terra nerastra mista a pezzi di carbone, tra i quali si rinvennero i seguenti oggetti: - Un orecchino di argento in forma di ~mplice anello, del diametro di mm. 14. Due
•• gJobettj dello stesSo metallo fo~ti, appartenenti ad . una collana ... Un vasetto fittile, ·cilindri-
• co, rossastro, rastremato al fondo, alto mm. 55, largo alla bocca mm. 65, al piede mm. 45 . Vari cocci insignificanti ... Lo scavo continuato fino a sera, offri anche l'esempio di un'altra sepoltura in terra nuda. Di fatti gli scavatori trovarono una massa di terra nera, formata dalla decomposizione dei cadavefi, cir~ondata da un recinto di pietre, dentro cui si rinvennero frammenti di ossa umane e vasi, dei quali uno simile a quello descritto nel catalogo della coHezione Chessa, tav. E, fig. 12, tipo di vasi che si trova nelle tombe dell'età cartagine· se in Sardegna > e 0 ) •
• A commento di questo brano, estremamente eloquente di per sè stesso possono esse-
re certamente aggiunte alcune considerazioni Innanzi tutto, appare verosimile che, nel caso della prima sepoltur~ citata dal Nissardi, si trattasse di . una tomba a incinerazione conte~ nuta evidentemente in una cista litica. Questo tipa di tomba, presente nell'isola, in ambito fenicio e puDico, esclusivamente nel periodo che qui ci interessa, cioè tra la metà del VII e
(30) E. Pais, OrutlllJO: NSc, 1884, pp. 199~200.
•
Capitolo III 65
la f"me del VI sec. a. C .• è riscontrabile non solo nelle necropoli di Nora e 1 ) e di Bithia e 2 ).
ma, al di fuori delta stessa Sardegna, anche, ad esempio, a M ozia e 3 ), ove, sia detto per in-
. .
ciso, si verifica il medesimo cambiamento di rito, nello stesso momento e, presumibilmente, ·per le stes~ cause più sopra esposte. ·
Inoltre; la <terra nerastra mista a pezzi di carbone > è ~a ritenere probabilmente la risultante della deposizione all'interno della cista dei resti derivanti dalla combustione del cadavere, avvenuta in un ustrinum, ·posto in luogo adiacente a quello ove, in un momento successivo, era ~ato collocata la stessa cista litica.
Anche la fosSa terragna, presumìbilmente di incinerato, vista la presenza di <una masdi terra nera > mista a <frammenti" di ossa umane e vasi > che è descritta nella seconda par-
. .
te del brano, non può· risuJtare certamente estranea a necropoli di questo tipo. Infatti, ciò è manifesto ove si pensi alla necropoli della stessa ·Bithia, oltre a quelle di Monte Sirai e di Paniloriga, in Sardegna e4
), e, ad esempio nel Nord-Africa, a quelle di Rachgoun e di Tipa-. .
sa e$), tanto per citarne alcune, cho. a quanto risulta dai rapporti editi, si presentano con . . . .
deposizioni in veste del tutto analoga. . .
Per quel che riguarda i pezzi di corredo della prima tomba tharrense esplorata dal Nis· sardi, dovendo prescindere purtroppo dai <vari cocci insignificanti >, la cui dispersione tanto ancor oggi pesa e- non solo per l'indagine retrospettiva, si può tentare l'identificazione di qualche pezzo. Il recipiente <cilindrico ... rastremato al fondo >, tanto accuratamente. misurato, sembrerebbe essere, in modo abbastanza manifesto, una delle piccole tazze a pare-. .
ti verticali è pancia carenata, molto frequenti. tra l'altro,. nella necropoli arcaica di Mozia e, pertanto, considerate prodotto locale {'6 ), ma presenti, seppure in minor misura, anche nelle deposizioni della necropoli arcaica di Bithia (MC inv .. 92827) (BTH 179) (Fig. l O, j) e 7 )
nonchè nell'acropoH di. Monte Sirai e !l), negli ultimi decenni del VII sec. a. C. e,, co.n leggere
(31) Bartoloni - Tronchetti, Nora, pp~ 23-25.
(32) Bartoloni, Bi'thitl, p. 491.
. .
(33) V. Tusa, Lo SCIIVO del 1970: Mozùz- YII. p. 35; Bartoloni, Cronologill, p. 29, nota 96 • . (34) Bartoloni, Bithill, p. 491; P. Bartoloni, Ltl necropoli {ct~mpQgNZ 1981): Monte SiTai 1981;
. .
Tore, Notiziario, p. S.
(35) S. Lancel, Tipasitana 1: li'ouilles dÌznsla nécropole occidentale de Tipasa: BAA, l (1962-65};
pp. 48-54; per unà valutazione dei dati proposti dal Lancel, cf. da ultimo Bartoloni, Crt;~nologill-, pp. 14--15,
nota 9; G. VuiJlemot, La nécTojJole punique du phare diUis 17le Rachgoun (Oron}: 'Libyca, 3 (1955), pp.
7-45; Vuillemot, Recon,.,aissonces, pp. 60, 62.
(36) · 0'. ad esempio V. Tusa, Lo scavo dell970: Mozitl- VII, p. 49, tav. XXXVI, 1; cf. inoltre, . . .
da ultimo, A. Ciasca, Smvi alle mura: Moz/41978: RSF, 7 (1979), pp. 213-14, nota 22, ove, come si è
detto, non si esclude una origine locale del recipiente. . .
(l7) Un . ulteriore esemplare è stato rinvenuto dal Taramelli negli scavi effettuati nella necropoli . . .
di Bithia nel 1933; dei materiali risultanti da questo scavo dà notizia G. Pesce, Chùz (Caglitlri). - SCIIVi . .
nel territorio: . NSc, 1968,_ pp. 309-45, che tuttavia non fa menzione di questa ciotola, quantunque essa .· - .
sia conservata ed_ eSposta accanto agli altri. materiali della medesima provenienza nel Museo Nazionale di Cagliari.
(38) Cf. Marras. Saggio, p. 192, fig. 2, 12-16.
66 Studi sulla ceramica fenicill e punica di Sardegna
varianti, anche nella prima metà del VI sec. a. C. Quanto al vaso della seconda fossa, fortunatamente riconoscibile tramite l'iJiustrazio·
ne offertaci dal Crespi, esso costituisce un dato ancor. più probante, poichè non solo proviene sicuramente da una semplice fossa a incinerazione, ma perchè, tramite una interpretazio· ne quanto meno coerente e corretta del disegno, effettuato evidentemente con molta libertà e9 ), esso' appare manifestamente una brocca de) tipo cosiddetto <biconico> o <biloba·
. to > , di derivazione da prototipi vicino--orientali e, nel caso citato, in un aspetto tipicamente stanco o di routine, pertinente alla prima metà del VI sec. a. C. e, dunque, molto simile agli esemplari coevi presenti nei contesti delle necropoli a incinerazione di Paniloriga e di Monte Sirai (4 0
).
Sempre a cura del Pais, a firma del Fiorelli e sulla base della relazione del Nissardi, nel volume dell'anno 1886 delle Notizie degli Scavi di Antichità, si può leggere: < ... A ·nord d; Torre vecchill, ed a poca distanza da questo sito, si aprirono tre. trincee, cominciando dalle rocce che· stanno sulla sponda del mare, nelle quali si . notavano traccie di antichi loculi ... Si continuarono le trincee nella parte bassa della necropoli, colla sPeranza di trovare altre sepolture non violate; ed alla profondità di m. l, 60, si incontrò uno strato di carbone sopra uno strato di argilla e sabbia, fusa per azione del calore intenso; e poco lungi una grossa urna in terracotta a quattro anse, coperta da un piatto fittile, in forma di patera, simile a quel·
. le che si scoprono d'ordinario nelle tombe cartaginesi. Dentro l'urna si trovarono solo le ossa combuste; e poichè l'urna medesima. qua~do venne adoperata per contenere i resti 4el rogo, era guasta nel fondo, venne questo supplito con un piatti.no in terracotta, simile in tut· to a quello che servi di coperchio .
Internamente, nell'urna, niente altro si trovò che Je ossa: esternamente poi si trovò un altro piattino, simile agli accennati, più un pentolino ed (sic!) un'ansa ... > (" ~ ).
Per ovvi mo.tivi di brevità nòn ho ritenuto né utile né ·opportuno riportare il brano nella sua interezza; ·comunque, le considerazioni che si possono trarre dalla relazione riportata più sopra sono numerose e possono senza dubbio corroborare quanto desidero sostenere. Occorre ~otare innanzi tutto che gli ·~Vi governativi condotti négli anni ·1884-86 dal Soprastante· Nissardi si sono sempre svolti nelle imrrtedi~te ~icinanze dell'edificio noto con iJ nome di Torre Vecchia, men,zionata da G. F. Fara e, dunque, già in funzione attorno al 1550, in evidente antitesi con la torre di S. Giovanni· (" 2 ), edificata · al centro della peniso· la dopo· il 1600; dunque in epo~ certamente posteriore. La nostra torre è ubicata nella par.-. te nord-orientale di. Capo S. Marco ed è situata su uno sperone arenaceo, misto a enormi ma-cigni basaltici, eh~ . si protende nel cosiddetto Mare Morto, corrispondente quest'ultimo· al·
(39) V. Crespi, Catalogo ddla f'flccolt• di t~~ttièhittÌ IllUde del Sjgnor R•imortdo CM§fl, Cagliari
1868, p. 76 ~v. E, 12. . .
(40) P. BartoloDi, Llz necropoli (atmfN18M 1981) : Monte Sil'fli 1981; Bartolonf. CroM/ogill, pp. . . .
19--20. fig. l, 16; per qileata fonna della necropoli di Puilloriga, da ultiln<> cf. S. Moscati. n mondQ pu-
nko, Torino 1980, p. 202, fis. l (al qcmtro).
(41) . Fiorelli. Thflnor: NSc, 1886, pp. 27-30.
(42) G . F. Fara, Gfe!Ullf'rtl.deU. Saldeìn4, (~ad. a cura di P. Secchi), Suwi 1975, p. 47; E. PlDosu, . .
Le tcit71ll101'11nee in San:ICM, c.,Jiarl1~7. pp; 7~1f.
Capitolo III 67
l'ampio specchio di mare abbracciato dal Golfo di Oristano. La torre sorge su un leggero declivio ed è posta a meno di venti metri daDa costa; la base rocciosa su cui si insedia è separata dalla superficie· del terreno da una spessa coltre di deposito terroso misto a sabbia.
La grande necropoli ipogeica meridionale, che non deve essere confusa con quella in . . . parte coeva, sempre a inumazione,- che · si ·estende a occidente dell'attuale abitato di S. Gio-vanni di Sinis, è, invece, ubicata sul versante opposto del Capo, a una distanza di circa duecento metri. Questa distanza è misUrata tra l'edificio della Torre Vecchia e le prime falde di arenaria occupate da tombe, emergenti all'altezza della stessa torre. Le due grandi ·necropoIi ipageiche furono verosimilmente depredate durante la famiger.ata <corsa all'oro> degli anni 18S J -52 (4 3
); questi segnarono verosimilmente la irreparabile e definitiva perdita, se · non. per quanto concerne alcuni miseri lembi assai poco signifiCativi, dei dati archeologici contestuali relativi al periodo tra Ja fine del VI e la metà del III sec. a. C., per quanto concerne la civiltà punica.
Pertanto, gli scavi effettuati da Filippo Nissardi, come del resto risulta ampiamente dalla sua · corrispondenza e dalle sue relazioiii, non hanno assolutamente interessato le necropoli a camere ipogeiche, delle quali, peraltro, quella meridionale fu accuratamente rilevata
. . . dallo .stesso Nissardi, bensì un cospicuo numero di tombe a cista, a fossa, a cassone e alla cap-. puccina. La maggior pa_rte delle sepolture esplorate Sembra pertinente, in ogni caso, ai pri-mi due tipi e conteneva unicamente corpi di incinerati. -I due restanti tipi ton:Jbali menzionati, oltre ad esse.re strutturalmente· più tardi, come nel caso delle tombe a cassone, o, addirittùra quasi sconosciuti alla civiltà fenicia e punica, nel caso delle tombe alla cappuecir:ta ~4 ) e presenti in misura assolutamente minoritaria. erano ubicati a una quota molto più al~a e
. . contenevano.sovente, oltre al restante corredo, monete romane di età imperiale.
Ma, restando più adere~ti al brano proposto più sopra, si possono innanzi tutto confrontare le indubbie similitudini risultanti dalla presenza di sabbia fusa, che indubbiamente apparentano le deposizioni tharrensi a quelle di Bithia. In quest'uJtima necropoli, infat· ti, in base al reperimento di numerose travi di ginepro parzialmente combuste all'interno di alcune fosse, si ·è potuto ragioncvoiQlente dedurre che, in taluni casi, jl rogo del cadavere veniva effettuato sullo stesso luogo del seppellimento. In base a queste risultanze diviene immediatamente comprensibile lo strato di carbone presente nelle succitate tombe a fossa d i Tharros (" 5 ).
(43) Per alcune notizie sugli scavi ufficiali e sulle depredazioni, autorizZate e non, alle quali fu-
rono sottoposte nel corso dei secoli le necropoli tharrensi, cf. G. Quattrocclli Pisano, l Kloi~lli t~nici di
Tluuros n~l Museo Nazio1Jille di Cagliari(= CSF, 3), Roma 1974, pp. 13·14; cf., inoltre, da ultimo S. Mo
scati • Jocalla ThiiTI'hica: Thturos - Y Il, pp. 11 5·19. . .
(44) Come è noto, le tombe a · cassone litico sono comunemente usate in San:Jesoa a partire dal-
la rme del VI sec. a. .C., ma. conoscono U massimo utilizzo attorno al IV sec. a. C.; le tombe cosiddette
< aUa cappuccina > sono inveee, c:Ome è parimenti noto, utilizzate in Sardegna principalmente dal U sec.
d. c., con qualche sporadica presenza rm dallll sec. a. c. (4S) GH · ustrina .lélativi aDe deposizioni in cista litica, come si evince dai riJUltati offerti sempre
. . .
dalla necropoli di Bithia, avvenivano invece al margine della stessa cista, come appare daUe ampie cbiaZ· . . .
ze di bruciato e sabbia fusa.
l l
. 68 Studi sulla ceramica fenicia e pùnica di Sardegna
Per quanto riguarda l'urna tetransata, ben poco vi è da aggiungere alla descrizione del . . . . . Nissardi;. se non che verosimilmente si tràtta, in base alla pr~senza delle quattro anse, di una olla · stamnoide fenicià, imitata indubbiamente da modelli · italo-geometrici e presente in di· screto numero anche nella necropoli coeva di Bithia f' 6 ). Quello che rende del tutto par-. . . ticolare il nostro recipiente è, senzà dubbio, l'antico restauro che rende questa urna ùn og-getto praticamente unico: A dispetto degli eventi c~e hanno causato la quasi totale disper
. sione dei materiali tharrensi, il pezzo descritto è infatti ricon~scìbiJe in un'urna oggi conset. vata ~d esposta al Museo Arçheologico Nazionale <.G. A. Sanna > di Sassari. La descriz.ione
. . . . . . fattane a · suo tempo dai ·Nissardi ristdta in effetti abbastanza generica, ma l'ecc~zionale pre-senza ·sul (ondo del nostro recipiente cinerario di un piatto ·arcaico, det'tipo apodo con um-. . . .
bone piatto sospeso sul. fondo, simile ai recipienti della necropoli di Bithia (MC inv. 92887) . . '
(BTH 555) (Fig. l, n) e, dunque, .cronologicamente affme all'urna, induce· a identificare il . nostro esemplare nel recipiente conservato ed esposto nel Museo Archeologico di.Sas5arL . ·
. . . . ~
Una ulteriore ·.considerazione d a porre alla comune attenzione è il fatto che, ne Da f os-sa descritta nel brano, la parte preponderante del corredo è costituita' da' piatti: la c~rcost~n· za ci . riporta, con significativi · paralleli, àncora u~a volta alle necropoli di Bithia e di M o~ te · Sirai (4 7 ). Quarito al sliécitato pentolino . monoansato, se si. ~uole intendere come· refuso
. Ia .·parola .<ed~, tu.tto in9uce · a ri~enere che si tratti con ogni verosimiglianza ~i un'urna di modeste dimensioni-, con orlo leggermente inclinato verso l'interno e, in genere, di cottura
. . . . .
men che mediocre.·. Recipienti di questo tipo sono pressochè costanti sia nel tofet che nei ' .
corredi · della .neèropoli arcaica· di Mozia, sono molto frequenti, a partire dalla· seconda me-tà dèl VII sec. a. C.~ nel tofet di Sulcis (MSA s.n . irtv·.) (Fig: 8, ~), e compaiono in qualche caso nei contesti arcaici di Bithia (4
· 8 ), nel periodo compr~so tra gli ultimi anni· del VII e i . .
primi decenni del VI sec. a. C. Continuando nell'ambito delia rassegna: · dei rapporti editi dalle Notizie degli Scavi di '
Antichità, nel volume dell'anno· 188 7, si legge come segue: < .... Un sepolcro però tra. i mol· tì mostrava· di essere intatto ... In quel giorno fu ritirata dalla: tomba ... la .suppellettile seguen· te: - · Gro~so. anello. d'argento, 'àvente la gemina in forma di cartello. Diversi frammenti ap· partenenti ad Ornamento, COStituito <Ìa· lamina d'argento .... Va$0 a bocca larga, Seilza mani-Ci, di forma globosa ... > (49)~ ·
Anche in quest'ultimo ca·so sem.ora trattarsi di una tomba a· cista, della q,uale, per brevità, ho omesso volutamente la lunga descriZione . fattane dal Nissa~di, che, comunque; po~
. . . .
(46} Tore- GrU, Bithla, pp. 55-56, 76-77, fig. A l, ove è, inoltre, ~dita, pur senza alcuna menzio-. .
ne riguardante questa particolarità, l'uma tharrense- con antico restauro menzionata dal Nissardi: Tore -. .
Gr~, Bithia, p. 58; tav. l, l. Jter alcuni materiali fenici imitati da modelli italo-pometrici, cf. BartotOni, .
Olnochoe, pp. 47·~~· ' . . '
(47) - Cf. Bartoloni, Bithia, p. 49.7; ·P. Bartoloni, JA. necropoli (azmptZKifll 1981): MonteSirai 1981.
· (48) · Per la trattazionè· ..relativa a q \leste urne e alla loro presenza e ·di (fusione sia .a Mozia che a Sul- . . . . cis, cosi carne in molti altri ~tri fenici del _t.Jediterraneo occidontat,, si rimanda al Capitolo· l di questo
· volUme; ~ quantò ~da alcuni tra sJi esemplari di B~ cf. G .. Pesce, CIUil (Caglilui). - Stmi. nel
tmttol'lo, cit., p. 326, f-.g. t9. · · . . . .
(49') F. Vivanet, Tharros: . NSct 1887, pp. 46-47.
CapitokJ DI 69
trà essere controllata in baSI; al rifeFimento fornito~ La tomba conteneva evidentemente alcuni gioielli d'arg~to, oltre· alla suppellettile c~rami~a. non · chiaramente identificabile in base alia de~criz~o~e ed.ita·; tranl)e quello eh~ p~trebbe forse .. essere rièonosciut~ · come. un . . . . vaso-del tipo noto con ,il nome di <chardon >; Ciò, per quanto riguarda il materiale dei mo-nili, in assoluta analogia·· con quanto era stato rmv.enuto nella tomba con urna -più ·sopra men· zionatà dallo stesso Nissardi. · ·
. .· . . In effetti, da quanto risulta dai · rapporti manoscritti inediti del Nissardi, la stragran-
de maggioranz~ degli ornamenti preziosi e dei gioi~IJi da-lui rinven'uti in ·quella che, ve.rosi-. .
milmente, può essere considerata . la n:ec.ropoli meridionale arcaica . a incineraziol)e .erano in . . .
argento. _Questi reperti ·erano depositati e, in buona .parte, esposti ~elle vetrine dell'Anti-quarium Arborense di Oristano ·e oggi n~n sono purtroppo più ·visibili a causa di un 'furto avvenuto negli scorsi anÌii. In conclusione, ·lungi dal considerarla probante in senso assolu- . . . . . . . . .
to, fitengo che si possa avanzare a qu~sto punto l'ipotesi del doppio binomio <tomba areai-. . . ca = ·tomba a .incinerazione > e <tomba a incinerazione = gioielli· d'argento>, con l'avvertenza che questo parallelismo è, ovviamente, da pre·sumere valido quasi unicamente per quel che ·. ~iguarct'a il periodo arcaico dell'aé~essione feniCia in . Sardegna, in corrispondenza cioè . con l'arco di ·tempo tra la metà del · V Il e la fine del VI sec. a .. C., che in questa Sede viene considerato fenicio ·. e, . quìndi, pre-cartaginese. Ovviamente, la . presenza dei 'gioielli d~ argento . non . è da considerare esclusiva dellà fase {enicià, poichè l'uso dell'oro a questo scopo e . . .
in questo stesso periodo è parimenti. attest~to, seppure in forma éstremamente minoritaria. Del ·pari, Io' stesso . argento-fu. utilizzato . e· viene talvolta rinvenuto ·negli 'ipogei qi epoca· puni· ca.·. In · def~itiva, con l'ipotesi sopra esposta si vuole unicamente affermare che, nella fase . .
storica indicata, l'attestaz~ne di questo tipo di moniti, seppure non in forma èsclusiva, è tuttavia percentuaJmente maggioritaria e ampiamente prepond~rante.
. . . . . ·lnfmti, se osserviamo ad esempio i corred.i delle -tombe arcaiche di Bithia, tra i quali
quello. presentato più sopra_, ·e quelli-delle necropoli. di' Monte Sirai e di Paniloriga ( 5'0 ), quel-. . . li della prima compresi tra la metà d~l VII e la _fme· del VI· sec. a. C. e :quelli dellé due resta~· ti jnseriti tra i primi anni .e la fme del VI sec. a. C;, si _potrà notare come. in· quest~ compaia· : no .pres~chè esclusivamente gioielli'in .. àrgento. Tra .i numerosi reperti· della· necropoÙ· areai· . . . . . ca dell'antica· Bithia, ad eSempio, su un. numero superiore al centinaio tra bracciali·, collari. anelli, orecchini,' fibùle .e pendenti, u~camente due tra i ·pi~{ piccoli e_. mèno significat_IVì so~ . ilo in oro. Quest'ultim~ . doveva necessariamente e'ssere imPòrtato nell~ _ nòst~a isola, sopra t· tutto dal Nord•Africa .o . anche dalla .Spagna, poichè~ rrièntre~ 'se-~prattutto nella regione del . . ,. . . . . Sulcis-lglesiente· ~no ampiamente att~stati grandi giacimenti · di piombo: argentifero, in Sar-degna l'oro è praticamente assente. · · . .
L'improvviso_ fiorire della· gioielleria aurea, come si è· detto non ·esclusiva ma certamen-. te maggioritaria e posta verosimilmente a corn;do delle sole tombe a inumazione, ·è da collo· eare, in . conseguenza delle ipotesi proposté, oltre ·Che,' naturabne~te, dei dati forniti, dopo
. )'avvento di .Cartagine e quindi dopo ~ sue_ campagne militari In Sardegna, ·avvenu1e negli ultimi_ decenni del· Vl'sec. a. C . . La presenza .· tanto .massiccia di monili aurei posta ·in conco-
. (50) Cf. P. Bartoloni, La necro,;oli (étlmpag,u,J981); Monte Srai 1981; .. . Tore, ..... Notizillfio, pp.
5~, note 8, 13.
70 Studi fU/la ceramica fenicia e punica di Sardegna ·
mitanza con il mutamento del rito funerario potrebbe mostrare in definitiva non solo l'apertura di nuovi mercati, ma anche un più stretto rapporto con l'Africa settentrionale, conseguente alla politica espansionistica ,di Car~agine e/o, in posizione collaterale e subordinata, !'accessione di una nuova classe mercantile e di un ethnos dr medesima stirpe ma di differente acculturazione.
· In conclusione di questo aperçu storico e archeologico, ·mi sembra che, alla luce dei dati concomitanti più sopra esposti, anche per il centro di Tharros si possa sostenere l'ipotesi di lavoro già proposta e in gran parte verificata per i coevi centri. Si hanno 9unque motivi abbastanza fondati per ritenere che neiJa Tharros arcaica, nel periodo compreso tra le sue origini e la fine del VI sec. a. C., fosse in auge il rito della cremazione, soppiantato in modo abbastanza repentino d~ll'inumazione. Quest'ultima pratica funeraria nel nostro cen-
·tro, cosi come in tutti quelli della Sardegna punica, si svolse, dalla fine del VI ai primi anni del III sec. a. C., soprattutto, ma non esclusivamente, in ipogei.
A margine della situazione prodotta più sopra~ è da segnalare la presenza, nell'ambito delle collezione del Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, di un corredo visibilmente arcaico (Figg. 9, d, f, IO, c, g) che, in base a quanto riportato da una· indicazione scritta su un cartellino, oggi smarrito, oltre che. da relazioni orali · chi tuttavia· non ebbe parte alcuna nella scoperta, e da una sua parziale edizione, sareb stato rinvenuto al margine della grande necropoli settentrionale tharrense, alla quale ·si è accennato più sopra. Il ma.teriale,. che verrà presentato· in modo più compiuto in seguito, sembra fuor di dubbio appartenere tipologicarnente a una tomba a incinerazione ed è databile trà gli ultimi anni del VII sec. a. C. e i primi del secolo successivo. Questa tomba, dunque, avrebbe dovuto essere ubicata lungo il versante occidentale dell'attuale .abitato di S. Giovanni di Sinis, concretizzando con la sua presenza l'ipotesi dell'esistenza di una seconda necropoli a incinerazione.
Sarà utile a questo punto un breve excur:~Us geografico relativo alla penisola del Ca-. .
po S. Marco e alla sua topografia nell'epoca di cui si tratta in questa sede. · L'antico abitato era posto a Oriente della torre di S. Giovanni, affacciato alla costa del Mare Morto ed era protetto a Occidente dall'altura della torre suddetta, a nord dall'altura di Muru Mannu, ove è ubicato il tofet, e a sud dal rilievo del Capo s~··Marco, che ospita la grande necropoli ipogei-
. ca meridionale. A nord dell'altura di Muru Mannu, occupata, oltre che dal tofet, a~he dalle imponenti fortificazioni di epoca . punica (51
). il livello del terrerto digrada repentinamente da quota .32 a quota 2, Per for~are una SDrta di depressione che ai affaccia sul Mare Morto ed è compresa . tra l'attuale abitato, i banchi di arenaria- quatemaria della costa occidentale e la suddetta altura fortificata. L'ampiezza di questa depressione, oggi parzialmente col-
•
mata da apporti eoliQ, è valutabile nell'ordine di circa cinque ettari (52 ). · Una SDttile taenia separava, dunque, ad Occidente questo bacino dal mare aperto e congiungeva ·la penisola con l'entroterra.
l risultati conseguiti dalla prospezione archeologica subacquea, condotta lungo le co-
(5 l) Sulla situazione geologica del Capo S. Marco cf. F. De Horatiis, Note geo-morfologiche: Tluu· . . .
ros - V, pp. 61-65: suDa topografla generale del sito e sul suo imponente impianto fortificato, cf. F. Bar·
reca, Le forti/ktaloni ~nentriontlli di Tluno1: 'I'Iulrr01 -III, pp. 215-23.
(52) E. Acquaro, Lo IC.ZJO dell918: 71wros - Y, pp. 49-59, fig. l.
çapitolo III 71
ste della penisola del Capo S. Marco (53), non disgiunti da considerazioni di carattere urbaniStico e topografico,. hanno portato _a conCludere che la succitata depressione poteva costituire anticamente un i~pianto portuale, forse non l'unico del nostro centro, colmato con il trascorrere dei secoli, dagli apporti fluviali del Tirso.
Pertanto, poichè il porto dista dall'estremo limite settentrionale dell'abitato più di un chilometro e poichè l'esiguo istmo che divideva il bacino portuale dal mare aperto non era probabilmente in grado di ospitare, per ovvi motivi di viabilità, costruzioni di tipo privato, ne consegue che lungo la sponda settentrionale della depressione doveva sorgere un ulterio· re quartiere, forse di tipo commerciale o industriale~ ben distinto e separato dalla città e ubi-
• • • cato nella zona ove sorge ancor oggi la chiesetta paleocristiana di S. Giovanni. E' altrettan-
•
to ovvio, ·dunque, che questo agglomerato urbano, sia pure secondario rispeho alla città, fos-se provvisto, in tutto il periodo della sua esistenza, . di una sua necropoli, in antitesi con quell~ meridionàle. Se la presenza di queUa ipogeica settentrionale era nota da lungo tempo, ora a quest'ultima si affianca quella arcaica a incinerazione (54
).
Iniziando finalmente la trattazione specifica sulla ceramica arcaica tharrense, desidero precisare dapprima che i1 discorso che: seguirà sarà necessariamente limitato solo ad alcuni tipi. Ciò. poichè i reperti conservati nella· collezione del Museo Archeologico Nazionale
'
di Cagliari, provenienti con certezza da questo sito, sono in numero molto esiguo e, pertan-. to, rispondono ad una tipologia che non comprende certo tutta la gamma delle forme del . .
periodo arcaico esaminato in questa sede. A prescindere . infatti dalla fonata diaspora con destinazione prevalentemente privata alla quale sono stati sottoposti gli smembrati corredi delle necropoli . thar.rensi, in relazione soprattutto agli scavi occasionali Q clandestini del-. la prima metà del seco1o scorso, ~ da constatare il fatto che osgi il Museo Archeologico Na-zionale di Cagliari conserva pochissime, ma fortunatamente significative, vestigia delle nostre necropoli.
La grande maggioranza dei reperti conservati nei Musei e negli Antiquaria isalani è so-- .
prattutto di natura e di materiale prezioso oppure rispecchia con oggettiva evidenza, il ti· pico gusto antiquario, destinato in p~valenza agli oggetti strani e inusitati, . che caratteriz-
•• zò, fino a non molti decenni orsono, le ricerche archeologiche e gli aspetti museografici del-. . l'area ~be qui ci interessa e che furono svolte in prevalenza negli ultimi decenni del secolo passato. In defmitiva, la ceramica vascolare di fabbrica fenicia, non rivestendO all'epoca al· cun carattere di preziosità né di curiosità, fu relegata ad un ruolo minore e, pertanto; desti~
. . nata ·a quelli che, all'epoca delle seoperte, . erano i depositi, i Musei o gli Antiquaria perife-. rici e decentrati: Vi è .da aggiungere che, per di più, non veniva effettuata la raccola del ma-teriale rinv~nuto in frammenti e che 1a tecnica del · restauro, ancora per certi versi agli albori, non veniva certamente applicata a reperti tanto umili e comuni.
·(53) Cf. L. Fozzati, Archeologia .,.,inlt di 11tarro1. Rlcerchtt e riadtllti dellll prlntll Ctl11fiNI61Ul
(1979): Thtmtn - VI, pp. 99-110; seu~pre Mll'unbito di queaa prospezione è stata coastatata la totale
aaeitza delle strutture IOJIUDel.te indiCate da G. Pace~ 1Juuro1~ ·Cagliari 1966 e da G. Schmiedt.. Antkhi
portid1talf4: L'Uftivmo, 45 (1965), PP• 2~6-51. •
(54) Per la prima meoàolle eli questa noaopoli e per akune ~derazioni sulle tombe di cui so-~ d . Tore, Cippi, pp. 29, 123-24. ·
. .
72 Studi sulla ceramica fenicia e punica d t Sa m~
Oggi, in · effetti,· n Museo Archeologico Nazionale dì Cagliari è costretto ad avvalersi, come unica documentazione riguard~te 1~ cer~mica arcaica tharrense, di alc\lni corredi non sicuramente completi, frutto .di scavi di recupero, rinvenuti in pr~valenza attorno aUa. IJletà di questo secolo e, pe-rtanto, resti spor.adici, completamente avulsi dalle grandi campagne di scavo effettuate negli ultimi decenni del XIX sec., che, assiem~ e a seguito degli scavi <:tan .. destini, hanno depauperato e praticamente quas·i esaurito le grandi necropoU tharren.at ·
Iniziando la descrizione tipologica da quelle forme che, di m~ssima, partetipàtìo qua· si costantementè ai corredi arcaici, rivolgerò innanzi ·tutto la mia attén!lUfiè alte brocçhe con .
• orlo cosiddetto <a fungo>.. Nel Museo Nazionale di Cagliari queste ultime sono presenti
. t . .
con quattro esemplari, dei ·.·quali. uno purtroppo rnonco alla sommità· e, dunque, .privo del . caratteristico. orJo. Le nostre brocche •. così come la grande maggioranza delle fonne che verranno descri.tte più. sotto, erano ricoperte, all'atto del loro rinvenimento, da uno spesso stra· . to calcareo grigiastro, dovuto alla prolungata permanenza in terreno sabbfp•o ftlrtèttU!ntè basico. Questa coltre calcarea, se. talora perriaetteva di · intravederè la pa~ta ntH punti di fra t- .
. tura, escludeva assolutamente un esame· diretto delle superfi~i è deiìe eventuali decorazioni. Grazie alla puntuale organizzazione della Soprintendenza Archeologica, dalla quale di·
. .
pende il Museo, che su mia richiesta ha prontamente disposto e fatto eseguire tramìte il pro· prio gabinettQ di restauro l'asportazione della coltre calcarea dei recipienti (~ 5 ), si ~ potuto non solo distinguere il colore deUa superficie, che in generè è nocciol• tgn tfUmature tos• sastre, ma anche constatare la presenza 'di .·alcuni tipi di decorazloné. htf'atti, a èausa <~:elle . . precarie condizioni in cui versavano i nostri pezzi, il colore della !Uperficie di uno di essi (Fig .
. 9, d), peraltro edito di recente· (56 )~ era. stato d'efinito <grigi~tro>, mentre non veniva fatta· . . alcu~a menziont dèllfl decorazione particolarmente vistosa e bicroma,· anch'essa ovviatnen· tè fit:Operta dalle concrezioni.
Ma, dando inizio alle descrizioni più precise proprio da questo pezzo~ si potrà set:tza . . dubbio notare come esso risulti cenllmetlte lfèa1co in base alla· sùa f~rrna . Il recipiente in quest~one è anche parte dell'utdèfi cor~tlo, pitl sopra indicato col,lle prb\ietii~_ritè dàlla ttecro• poli arcaici settet\trlòftaté. ìi ~assiccio e lungo··collo, UtiitartUHtte atì'atripièiza àeihJtiti èspanso~ denun~rebbero senza dubbio la sua appartenenza alla secprida metà del VII sec. a. é; e ciò evidentemente in ·acc01:do con i timiii esemplaJ:i della -.neéropoli di Bithia (57
). Tuttavia, la decorazione. ~iilffiente cromatica, ·parte a immersione (5-1) e· p~e descritta a pennellò Wft fasce e linee, e il doppio taglio post9 all'altezza della carenatura del collo, deiiun· ziano immediatamente . alcune innovukuil :~ UtUl èèrtà trasandatezza ·Q · routine rispetto ai sobri canoni formali e. decoratiVI dt!lt+@ptlc~ e, di conseguenza, concedono di presumere per .
. . (55) . Sono arato ai responsabW del suddetto laboratorio, 58. E. Putzu e F. Tidu, che hanno èse--. . . .
guito Je oPer~ioni di restauro con la OOilsUeta perizia. . .
(56) Cf. Tore, Cippi, ·P.,. 123-24, tav. ·xxrx, 2; su questo i'artiéOlAN problema cf. dà ultimo, P . .
Bartoloni, Cl!l'lmiche Wllcollir:i nelllz necropoli til'ctiiCf! di Thllrto1: Tluvfe>i- Y/1, p. 9!, tav. XX, 3. (57) Pèr le brocch~ con odo ·cosiddetto ~a fungo > et, iar.tolonl~ OonoloKitl, pp .. 17-20, ftg. l, .
2; cf. inoltre Bartoloili. Bithkz, pp. 493·95 . . (58)
. . . Che la verniciatura sia fatta per ilbmersione parziale del pezt.o rovèlciato, li evince dai fat·
. .
to che le pareti in teme SOli o vernicJate in minor ~~ a cauaa deDa pt'èss.icme interna del recipiente.
Capitolo III 73
.
il nostro recipiente un sia pure esiguo ma indubbio att~roarnento , analogo a quello. di un coe-. .
vo · esemplare della necropoli di Bithia, abbastanza simile sia come fonna che come decora-. . . zione (MC inv. 91516) (8TH 332) (Fig. 9~ e). Per questi motivi ritengo che il recipiente in . .
questione sia da collocare non prima degli ultimi anni del VII o, al più tardi , nei primi .del VI sec. a. C.
Un confronto, a mio avviso assai probante, ci viene fornito da un recipiente analogo, attualmente conservato nelJ'ambiio· di una coiJezione privata di Olbia e recentemente edito a cura. di G. Tore (59
) . ·Infatti, questa brocca che ritengo pr~babìlmente pertinente a un corredo tombale tharrense, non solo gode di una cronologia affine aU'esemplare presentato più sopra, ma è fornita di ·un doppio taglio praticato.sulla parte mediana del. collo che la apparel)ta immediatamente .al nostro pezzo. In effetti, è difficilmente sostenibile una pro-. '
'
venienza certa per la brocca di Olbia, ascritta alla fase arcaica di questo centro. dal suo pri-mo editore e da .ine attribuita .invece· aJI'area tharrense, ma la succitata particolarità del dop- .
•
pio taglio sul collo, come già notato altrove dal suo editore (60 ), indurrebbe a indicare ·nel centro di fharros il suo luogo di produzione:
Il secondo (MC inv. 27658) (Fig. 9, a) e il terzo eSémplare (MC ~7659) (Fig. 9, b).(61 )
di quésto tipo sono di dimensioni certamente più cospicue del precedente e quindi, più antichi di quello descritto, se sono validi anche per il cent.ro. di Tharros i canoni generali che sembrano governare la ceram'ica fenicia di Sardegna (6?). Una loro appartenenza aiJa secon-. . da metà del VII sec. a. C. sembrerebbe confennata da ·due particolari distintivi. Il primo si . rJferl~e all'orlo abnorme del secondo esemplare, che ~icorda fuor di ogni dubbio sia quel-H di alcune · brocche coeve della necropoli arcaica di. M ozia· (63 ) , sia queJio di un vaso deUa stessa claSSè tipo logica, · sempre proveniente da M ozia, ma, ·contrariamente al · nostro; ascri-
. vibile alla seco~da ~età del VI sec. a: C. (64 ), sia quello di due, piatti pertinenti ·alla. seconda inetà del VU sec. a. C., provenienti .dalle necropòli arcaiche di · Bithia (MC inV'. 91498) (BTH · I69) (Fig.· IO~ e) (65
) e di Rachgoun (66). Inoltre, piatti con questo tipo di orlo so-. '
' . (59) G. Tore, Elementi cultul'tlli .emitici nell4 SIUdegrJll centro-lettentritiMle: Atti dellll XXII . . .
Riunione ScientifiCfl deQ'lstituto ltalf!lno di Preistorill e Protostorill nella &rd~IIQ c~tro~settenli'ioNZ· · . . .
~ - 21-27 qttobre 19.78, Fa-enze 1980, pp. 498--99, 501; fig. 2,1. . .
(60) Cf. T ore, Cippi, p. 27, ove =queno .spocifico particolare è menzionato come < riscontrabilo • •
in altri tipi thartOnsi ,. • . . '
(61) Cf. da ultimo+ P. Barto1oni, C~~iche vtUCOUzrl nelltz n~li tVCIIictl di Thluro1: . Tlulr-
ros- VII, p. 95, tav. XX, 1·2.
(62) . Cf. Bartoloni, CronolOfÌ/I, pp. 19-20; Bartoloni, BithÌil, p. 494.
(63) cr. V. Tusa, Lo scavo del 197_0: Mozill - YII. pp. 36-37, 47, tavv~ . XXIV~XXV, xXXV, l; . . Id., Rellizione preliminm'e degli. scavi. eseguiti 11 Mozùt negli 11nni 1972, 1973, 1914: Mozitl - IX; pp. 11.
'
l l, 52, 56, tavv. V, l, Xli, 3, XXXVII, 3, XLIII, 2. · •
. (64) A~ M; Bisi~ L 'in'oditlzlone semitica in Sicilia in base ai dati ceramici d~i ceniri fenic/0-puni-. .
ci dell'ùolll: Koklilol, 13' (1967), p: 42, tav. VI, 2. -
74 Studi sulla ceramica fenicitz e punica di Sardegna
no anche attestati, in un periodo leggermente anteriore al nostro, nella penisola iberica (6 7 )
e, ovviamente, tra i reperti fittili delle città fenicie deJJa costa Iibanese (68).
Il secondo particolare è costituito dalla decorazione che, come di norma per l'epoca, è a parziale immersione dell'orlo e del collo in una vert)ice di colore rossastro e presenta, ol~ tre a due righe in vernice nera disposte sulla parte superiore del collo·, tra l'orlo e il t_aglio
mediano, tre righe delineate con il medesiino colore nerastro, pe·rchè panialmente evanido, raggruppate immediatamente sotto l'ansa. La particolare sintassi di questa decorazione, costituita da un unico gruppo di tre righe associate e descritte in vernice nera, appare particolarmente probante, poichè le forme simili della necropoli di ~ithia (MC inv. 91824) (BTH 94) (Fig. 9, c), ascrivibili tra le più arcaiche di questo ultimo centro (69 ), riportano con estrema frequenza il medesimo tipo di decorazione. Questa ultima, negli esemplari immediatamente più tardi, collocabili verso gli ultimi anni del Vll o i primj del VI, si evolve, oltre che in fasce più o meno ampie di colore sia nerastro che rossastro~ come si è visto più s~pra e come mostrano, tra l'altro,. alcune forme simili e contemporanee della necropoli. arcaica di .. Paniloriga C0
), anche e soprattutto in reiterati gruppi di tre o più linee disposti lungo tut-ta la sagoma, a distanze presso~hè regolari tra di loro.
Per inciso, questo ultimo aspetto decorativo ebbe in seguito una più che · ampia fortu- . na soprattutto in ambiente sulcitano, come si evince dalle forme simili relative ai cemri di . Sulcis e di Monte Sirai, che ho avuto modo di illustrare più sopra. e in altra sede (' 1 ). In
.
questo caso si può concludere, pertanto, che, in mancanza di testimonianze più arcaiche, relative al capoluogo suls;itano, e a seguito della constatazione che le forme simili fino ad oggi note, pertinenti a questo centro e delle sue dipendenze e provenie.nti da necropoli a . inumazione, non possono essere collocate più in alto dell'ultimo quarto del VI sec. a. C., il modulo decorativo composto da un singolo gruppo. di tre linee, nel suo· aspetto iterato, costi·
'
tuisca in questo caso una evidente fossilizzazione e un palese gusto arcaistico. Proseguendo la rassegna sul materiale · tharrense, si può dire che sul terzo esemplare
di questa categorie ben poco vi è da aggiungere ed esso stesso in realtà non è in grado, a cau· sa del suo· precario stato di conservazione, di .f.ornire ulteriori indizi. Infatti, pur ripetendo genericamente la forma dell'esemplare citato più sopra, risulta privo dell'orlo e di parte del collo ed .è tuttora ricoperto dalla spessa patina calcarea che preclude un esame anche superficiale della pasta e della. eventuale decorazione. Queste ultime, tuttavia, non dovrebbero discostarsi di molto da quelle osservate nel recipiente di cui sopra. ·
Con il dichiarato ed evidente proposito di mostrare un eloquente esempio del gusto . . .
arcaistico, che investe· alcune forme ceram.iche di fabbrica punica dj" Sardegna, viene· presen-- . tato il quarto ed ultimo esemplare, pertinente sempre a questa classe tipologica (MC s.n. inv.)
(67) Cf. H. G. Niemeyer - H. Schubart, TrqytnMr (= Madrider Beitrege. 4), Mainz 1975. pp. 76,
92, 96, tavv. 14, 18, 22; cf. inoltre H. Sch~bart. Westpho11izilche TeUer; RSF, 6 (1978), pp. 81-96. . .
(68) Cf. da ultimo, anche per la b.ibliograf'a attinente. P. ~ Bikai, The Phoenicitln lmports: · 71re
non~ypriote pottery (= ExCIWtltion tlt Kitiolt, 4), Nieo&ia 1981, pp. 25, 30..31, tavv. XX·l. 16, xxv. 26.
(69) Cf. Bartoloni. Bithit1.. r,.. 1, d.
(70) Cf. S. Moscati, n mondo ptmico, cit., p. 202. fig. l.
(71) Cf. BartoloDi. CronoloKUz. pp. 22·25;ra. l, 11, 2. 4. 6.
Capitolo III 75
(Fig. IO, n). Si tratta abbastanza chiaramente di una brocca con orlo cosiddetto -ca fungo>, collocabile non prima degli inizi del V sec. a. C. e che, dunque, dimostra più che ampiamente come questa forma · sopravviva, sia pure nell'aspetto evoluto, ben oltre la fine del VII sec. a. C. e non si arresti a questa data, come invece è 'stato altrove afferm~to C 2 ).
Questo pezzo, avulso com'è da un contesto cronologicamente ·ben qualificato, diffi. cilmente potrebbe essere attribuito in modo oggettivamèrite motivato al periodo più sopra proposto. Tuttavia, oggi è possibile collocare il pezzo in questione nell'ambito di una data
· presumibilmente corretta. Ciò grazie alla sequenza cronologica fornita dai materiali della necropoli di Bithia, che, · soprattutto per quanto riguarda questa forma e quella della brocca di tipo. cosiddetto .c biconico> o .c bilobato > sua inscindibile paredra, ci mostrano in circa centocinquanta anni non solo tipi strettamente affini agli archetipi e, dunque, aderenti ai prototipi orientali, ma addirittura ben cinque varianti formali disposte cronologicamente lungo l'arco di tempo indicato, dalla seconda metà del VII agli inizi del V se~. a. C. (' 3
).
Inoltre, le indicazioni museografiche che accompagnano il nostro recipiente, di antica accessione alle collezioni del nostro Museo, lo registrano come proveniente dall'area urbana e non specificano in modo più puntuale la località del rinvenimento. A questo proposito mi limiterò a obiettare che il nostro pezzo non solo è assolutamente integro e privo di abrasioni o scheggiature, ma che è ricoperto, come i precedenti più antichi esemplari, dal· la nota patina calcarea e che, pertanto, tale origine è da considerare quanto meno dubbia e improbabile. Ciò soprattutto in un centro quale quello di Tharros, che, in virtù della sua posizione geografica, ha ricevuto almeno dal VII sec. a. C. in· poi l'impatto delle molteplici sovrapposizioni ediJizie, susseguitesi a partire dal parziale smantellamento, probabilmente incruento, del villaggio'nuragico preesistente ('4 ) al basso impero e oltre (' 5 ).
Desidero ~gnalare questa situazione, che considero aberrante, anche per il fatto che alcune urne del locale tofet recano parimenti l'improponibile indicazione di provenienza del· l'area urbana (76 ), testimoniando in tal modo alcuni interventi privi ·di controllo ai quali è stata sottoposta in tempi anche recenti l'area sacrifica le della città (' 7 ). Riferisco tutto ciò poichè ho fondati motivi per ritenere ch.e, nel caso della brocca con orlo cosiddetto ~a fun-
. '• 89 > , si tratti d i un vaso d i uso prec ipu amen te funerario.
, .
A quanto mi è noto, · infatti, la . precentuale di frammenti pertinenti a questa particola-re forma rinvenuti nell'ambito delle aree urbane è assolutamente minoritaria e irrilevante
(72) Cf. Tore, Cippi, p. 146.
(73 > cr. Bartotoni, Bitlrflz, pp. 495-96 . . . (74) Cf. da ultimo V. Santoni, n vlllauiO mu~~gico di Tluur01. Cllmpii61Ull977: Tluuro1 ~ IY,
pp. 81-96.
(75) Per alcune interessanti notizie .sulle vicende storiche di questo oentro, cf. Moscati, ltlllitl, pp.
253-S S; per alcune testimonianze archeologiche relative, cf. E. Acquaro, Lo lctlVO del 1981 : 1'1uuro1 -
VIU, pp. SO.S l.
(7~) lUtti questi materiali proftD~ono, ~e~tza ulteriori indicazioni, dqli scavi effettuati nell'abi-. .
tato tra p anni c:blquanta e asanta, fino al 1967, da G. Pesce: cf. in proposito, G. Pesce, Thtzrror, Ca-. gliari 1966.
(17) Su quata situazione, d. E. Acquaro~ Lo ICilPO de/1981: Thturol - VIII, p. 42.
76 Studi sulla ceramica fenicia e punica di Sardegna .
.
rispetto a queiJa de.i frustuli o delle . formè integre scoperti nelle aree. cimiteriali. Per di più, . . . il ri.trovainento di parti di queste forme in zone abitat_e riveste . molto spesso carattere di as· so Iuta sporadicità, come si evince dal noto . frammento pertinente . alla ·necropoli arcaica di" Monte Sirai e rinvenuto nel settore dell'opera avanzata ('8
). In ogni caso, ad ulteriore .conferina della cronologia proposta per il nostro vaso, che iri realtà dovrebbe eiuttosto provenire da una delle due necropoli ipogeich~ a inumazione, propongo alla comune attenzione due recipienti molto simili sia come forma che come dimensioni. provenienti, il primo, dal· la necropoli- di Tuvixeddu, a· Cagliari, ·(MC inv. -43447) (Fig. lO, m) ('9
) che; come è noto 1
non ospita· all' interno d~i suoi ipogei alcun pezzo Ghe sia anteriore aua··fine del VI o ai pri· mi anni del V sec. a. C. (80 ), e, il secondo, dalla necropoli ipogeica del Puig des Molins, a lbiza (81
), anch'essa del tutto priva di materiali anteriori alle date più·sopra indicate. Lasciando da parte finalmente le forme .suc~itate , rivolgerò ora. l'attenzione all'unico . .
esemplare di doppia patera :(MC inv. 34529) (Fig. 9, h) attribuibile con qualche certezza a)-le necr-opoli ~rcaiche dr Tharros (82
), che, pur essendo inserito nella c~llezione Gouin, ac-. '
quisita e conservata nel ·Museo Nazionale di Cagliari, -è. stato registrato, fin daUa sua prima accessione presso il privàto, come _proveniente dalle tombe tharrensi. La sua · forma e la sua decorazione .sono pratjca~ente identiche ·a quelle di un reperto analogo provenieniente dal-. . la necropoli .di Bithia (MC inv. 91547) {8TH 257).(Fig. 9, g), il quale. in base ·al .corredo che lo affinaca, è da porre nell'ultimo· quarto. del VII sec. a . . C. Per quanto attiene alla form~
·dell'esempJa·re tharrense, le due patere sovrapposte, distanziate d.a un robusto gambo, risultano di dimensioni pressochè ·identiche, con una leggera prevalenza di quella inferiore. · Le
. . . .
coppe, inoltre, presentano un orlo aggettante con sezione triangqlare e labbro _appena con-. . . . vesso, anche questa sicura garanzia di arcaicità, come è . del resto ampiamente dimostrato dal-l'analogo recipien~ rinvenuto a Trayamar (83 ) ~ · Quanto alla decorazione, anche questa si attiene ai ·canoni in voga in età arcaica ed è del tipo cosiddetto ·<a risparmio>' poichè sulla superficie esterna, dì colore brunastro, è applicata, dai rispettivi orli fino aUe carenature delle coppe, una vernice di colo·re necciola tendente .aJ rossastro, anch'essa· tipica -e in armo-
. . . . nia con gli esemplari citati più sopra come confronto. . .
Seguono in questa trattazion·e tre broccHe del tipo menzionato più sopra e cosiddetto -c biconico >. o < biìobato >: Come si è già avuto modo di sottolineare, questi recipieQti sì accompagnano di nonna . alle già citate br~èche cori orlo . cosiddetto <a fung.o >, stabilendo in tal modo una costante tipica dei corredi funerari arcaici in .gran parte . del Mediterra-
(78)
(79)
Cf. Bartoloni, .Recueil; P. Bartoloni, La necropoli (campogna198N: MonteSirlli 1981 • . • o • • • . .
Cf. S.· Puglisi,. Sct~Vi nellil necropoli punictlll inurnllZion~ di s: A vendnzce: NSc, 1942, p. 99. .
(8.0) Sui limiti temporali di questa necropoli cf. Bartoloni, Cronologitl. pp. 21-22. . .
(81) Cf. A . . Rodero Riaza, CoUeccion de certnntca punicll de Ibiz11 (= Ctltlllogos del MuseiJ Arqueo-
logicoNilciona~ Serie 80, S), p. 46; f".tg. 9, S; . . .
(82) · La doppia patem tharreDJe reca ancora n carteDino originale applicatO a suo tempo dal col- ·
.lezionista; da questa collezione provengono altri materiali di epoca · fenitia e 'probabilmente di fabbrica . . . . .
tharrense, ma J)rivi di qualsiasi indicazione, tra j quali .una piccola fiaSCa da ·-c pellegrino> munita di quat
tro bugne passanti. · . . . .
·(83) Cf .. H. G. Niemeyer- H. Schubart, Trllyllnwr, cit., p.1S, tav. f2. . .
Capitolo III . 77
neo occidentale (84). In effetti.almeno UQO (MC s. n. inv.) (Fig. IO, b) dei tre esemplari che ~ . .
· verranno presentati appartiene all'unico corredo superstite citato · più sopra. La sua forma, pur rientrando nei c~oni generali della tipologia di questo periodo, è con pancia allungàta~ . .
che la discosta dai prototipi metallici iberici. dai quali probabilmente deriva (8 ~ ). La sobria decorazione è appare()temente limitata ad upa parte della bocca, del collo e dell'ansa geminata · ed è ottenuta,. come di consueto, per . parziale immersione. Manca dunque il caratteri-.. .
stico gruppo di tre o ·quattro linee nere, tracciate à pennello, ·che norritalmerlte. è posto su-. . bito sotto. l'ansa e, · dunque," sotto la carenatura, e delimita, quindi, la spalla .ribassata dalla .
' .
·pancia (8 6 ). L'esemplare più .prossimo, coevo al nostro che è collocabile a1la fine del VII sec. a." C.; è reperibile tra i recipieriU tipologicamente affini d·eua nectopoli di Bithia, tra i quali se ne produce uno tra i più vicini (MC inv. 91436)-(BTH 537) (Fig. lO, c). ·
L'esemplare th.arrense successivo, assai più panciuto del precedente, presenta la ·medesima d·ecorazione per immersione e sembra esser~ privo di tratti di vernice a pennello· (MC . . .
·s. n. inv .) (Fig. l O, .a) . . Pur noli ·avendo per H momento potuto reperire confronti estrema-. .
mente puntuali si~ nell'ambito dei· corredi che in q"'esti ultimi anni vanno emergendo, sia tra gli esemplari tipo logicamente simili delJa ceramica fenicia · conservata nei Musei di Sar-
• • • l
degna, sarei propenso, in virtù della· fomia e. deUe motivazioni che seguiranno, ad attribui-. . . . .
rè a questo recipiente una datazione affine a quella proposta per l'esemplare menzionato . .
in precedenza. Al di fuori dell'ambiente fenicio di ·Sardegna, l'unico confronto edito tra i non pochi esistenti, dunque Il solo a tutt'oggi citabile, è localizzato nella necropoli occiden-. . . tale di Tipasa (8 7 )~ contrariamente alla datazione- proposta dal su_o editore, che lo situa nel . . V sec. a. C., ritengo che, in virtù si~ della forma che de)Ia· decorazione, la nostra brocca sia . . .
pertinente a un perio.do non poSterio~e all'ultimo quarto :del VII ·sec. a. C. o, al più . tardi; .· . al primo quarto di quello successivo.
Il terzo esemp.lare (MC s. n. inv.) (Fig. 10, d), pur appartenendo chiaramente in pecto~ · . .
re a questa classe tipologica, è da collocate cronologicamente iil un periodo leggermente po- · . .
steriore .a quello assegnato ai due pr~cedenti. .Ciò poiché, plJr conservando alcune caratteri-stiche. specifiche della . sua tipologia. qua W-ad esempio la marcata carenatura tra . spal1a e pan-. . . .
eia, r.isente palesemente di afflati ·esterni •. ma.nife.stati, tra. (;altro, in m·o~o inequivocabile dal-la sagoma della bocca." che ricorda le oinochoai corinzie o itala-geometriche (88 ). Il .suo sta-
. . . .
to di conservazione è abbastanza prec~rio poichè la superficie è quasi completamente abra-sa e :Je parti risparmiate da questo proç~sso, conseguen~e a malcottura, sono tuttora ricoper• te ·da ·una spessa patina calcarea. In defiriitiv~. la perdita della caratteristica ansa a doppio
.
(84) Cf. ad esempio, V. Tusa, Relazione prelimiiuzre degli ICtJIIi eseguiti a Mozia negli anni 1972,
1973, "1974: Mozilz- IX~ pp. 36-37, tavv. XXIV-XXV; P. Bartoloni. Lll necropoli (cafnptJgluz 1981): Mon
teSinzi 1981. . .
(8S) et. da ultimo .J. P. Garrido Roiz ... E. M. Orta Garcia, Excavaciones en la necropoli de 14U
Joya" Hu~/va. II (3.·, 4. y 5. bzmpàlfas) (= EAE, 96), Madrid 1978, pp. 171-75, fJg; 105, ove è segnalata . .
-uiche la imprescindibile bibliografia p~cedente . .
(86) Cf. da ultimo P. Bartoloni, lA necropoli (càmpagna 1981): Monte SiTai 1981. . . .
(87) Cf. S. LaliceJ. TfPasltlllltl Hl: .BAA, 3 (1968),.p. 127. f~g. 93.
· (88) Cf. &rtoloni, Oinochoe, pp. 4 7-50.
78 Studi sulla ceramica fenicia e punica di Sardegna
cannello e la summenzionata trasformazione della bocca, che, come si è detto, la avvicina alle oinòchoai trilobate, permettono di collocare la nostra brocca neiJ'ambito della prima metà del VI sec. a. C. Un confronto non paritetico, ma sufficientemente aderente, è reperibile nella necropoli di Bithia.
Sempre al medesimo corredo di cui sopra appartiene una piccola olia panciuta con orlo piatto, verosimilmente del tutto simile al tipo rinvenuto in una fossa a incinerazione durante i lavori del 1886 dal Nissardi e descritto più sopra. Il tipo, prevaientemente a pasta grigia derivante da cattiva .. cotrura e con abbonda.nti inclusi granitici e micacei, è ampiamen-
• •
te noto e diffuso sia in Sardegna che nelle restanti aree del Mediterraneo occidentale e vie-ne sempre rinvenuto, nella fonna presentata in questa sede, tra la metà del VII e la metà del VI sec. a. C. La sua pressochè costante presenza sia nei contesti abitativi che funerari o sacrificali (89
) pennette ce~amente di classificare questa . fonna nell'ambito della ceramica domestica o cosiddetta <comune >, in contrapposizione a quella di uso specificamente funerario o a quella di uso esclusivamente domestico.
Questo tipo di urna, Jeggennente mutato nell'aspetto esteriore, soprattutto per quanto concerne l'orlo, ma sempre mal cotto ò, addirittura, ad impasto. si rinviene quasi costan· temente in contesti funerari di V e di IV sec. a. C .. , soprattutto nella necropoli di Tuvixeddu {' 0
). La sua presenza. in associazione a materiali che mostrano le indubbie capacità tec· niche raggiunte dai figuli fenici e punici, deve probabilmente costituire parte di un rituale funerario non meglio , specificabile, ma forse connesso con · il desiderio di ·ptocrastinare il ricordo della vita quotidiana.
In ogni caso, il nostro recipiente (MC s. n~ inv.) (Fig. 9, f). leggermente schiacciato, .
munito di orlo piatto e di piede indistinto concavo, ·contrariamente ai prototipi che mostra· no una tendenza verticale, l'orlo inclinato verso l'interno e sono con fondo tondeggiante,
è da porre cronologicamente in un periodo attorno al600 a. C. ('1) e, dunque, in connes
sione con la restante parte del corredo. Da citare ancora l'unico piatto, che appartiene anch'esso al più volte menzionato cor
redo .. L'esemplare tharrense (MC s. n. inv.) (F.ig. lO, g) è molt<> rovinato e presenta, certa· • •
mente dovute a scarsa cottura. una vistosa degradazione ·della superficié, oltre ad ampie abra-sioni. Queste, tra .l'altro, hanno fatto praticamente scomparire il piede. che doveva mostrare. come di consueto, il tipico umbone piatto sospeso. Quesfultimo appare invece nei recipien·
' . . . ti simili, che ·si producono a confronto e che provengono rispettivamente dalla necropoli di
. (~9) q. ad esempio, M. H. Fantar, Une tombe punique 111r le Ferlllllt est de la colline dite de Junon:
AAfr, 6 (1972), pp . . 23-24; V. Tusa, Lo SCDO dd 1910: MoziiJ - Vll, pp. 36--40~ 42, 45-46. 48-Sl, 59, . . . 63, 6S, 67-69,71-73,75. 78, tavv. XXIV-XVV, XXVII, XXXI, XXXII14 XXXVIL XXXIX, XLVI-L, LIII-LIV, LIX; V. Tusa, Relazione prelimintue degli seDi eseguiti Q Mozia negli llnm 1972, 1973, 1914: Mozitz-/X,
pp. lo-62, tavv. V·X, XII-XV, XVIII-XXVII, XXJX. XXX~·XXXIX. Per la diffusione del tipo si veda inol·
tre quanto detto più sopra, nel Clpitolo l, relativo alle. urne del to/et di Suk:is. ·
(90) A. Taflll)eDi, La necropoli puirict1 di Pr~lo /bba Q S. A.vmdra«, Coglilui (ICtlvi de/1908):
MAL, 21 (1912). coD. 102-103, fig. 20, 2-3. 8.
(91) Per la seriazione tipologica e cronologica di questa forma, cf. da ultinio, A. Ciaic:a, Note mo-
ziesi: ACSF, pp. 61'9-24.
Capitolo III 79
Bithia (MC inv. 91500) (BTH 388) (Fig. 10, f) e di Mo"te Sirai (MC s. n. inv.) (MSN 65/12-44) (Fjg, I, n) (1 2 ) . Ulteriori confronti abbastanza aderenti, sempre attinenti alla ceramica fenicia di Sardegna, sono reperibili sia nella necropoli di Paniloriga (' 3 ) che in quella arcaica di Monte Sirai ('4 ); gli esemplari pertinenti a queste due necropoli sono databili nei primi decen-ni del VI sec. a. C. -
.
Oltre ai piatti citati, è senza dubbio da. segnalare un recipiente molto simile. rinvenuto anch'esso a Tipasa e attribuito dal suo scopritore ai primi anni del IV sec. a. C.(' 5
), contrariamente a quanto da me proposto più sopra. In ogni caso, il nostro piatto è certamente da por· re cronologicamente in concomitanza con la parte restante del corredo,. dato che le sue pareti non sono rettilinee come quelle degli esemplari più arcaici, tra i quali si propone l'esemplare proveniente dalla necropoli di Bithia (MC 91498) (BTH 169) (Fig. 10, e) ~6) che è senza dubbio ascrivibile alla seconda metà del VII sec. a. C.
Restano, a chiusura della t.rattazione sulla ceramica tharreose. due tazze. La loro forma è nota e· diffusa nell'Occidente mediterraneo, soprattutto a Cartagine, dove si accompa· gna in genere a corredi visibilmente pertinenti alla prima metà del VI sec. a. C., come egregiamente può mostrare la brocca· cosiddetta ~biconica~ della tomba n. 294 della necropoli di Dermech ~ 7 ) e ancor più J'aryballos , probabilmente etrusco-corinzio, della tomba n. 291 della stessa necropo.li (98 ) . · Un ulteriore esemplare cartaginese è localizzato in una ·tomba della necropoli di Junon, ma si accompagna a un corredo poco significativo e visibilmente inquinato da uno scarabeo reale collocabile tra la fine del IX e i primi anni deU'VIH sec. a_ C. (' 9
). In ogni caso, per ulteriori attestazioni bibliografiche sia nord-africane che di .Sici· lia e di Sardegna, si rimanda a un recente catalogo (1 00), ove, tuttavia. le considerazioni at· torno alla tipologia risultano troppo generiche cosi come la cronologia proposta è da considerare troppo ampia.
IJ primo esemplare, in pasta buccheroide grigiastra derivante da cattiva cottura~ (MC s. n. inv.) (fig. 10, i) è certamente queiJo più strettamente aderente ai confronti citati, ai quali ~no da-aggiungere due tazze proveflienti dalla necropolf di Bithia, Ja prima delle qua-
•• li è praticamente identica alla nostra (MC inv. 91510) (BTH 16) (Fig. IO. h), mentre la se·
. conda mostra un versatoio posticcio (MC inv. 91483) (BTH 107) (Fig. 10. k). Il secondo
(92) Su questo caratteristico tipo di fondo, peculiare soprattutto deUe forme aperte arcaiche e,
quindi, anche dei piatti, et. Bartoloni - Tronchetti, Nortt, p. 39.
.
(93) Cf. Tore - Gras, Bithill, J)lJ· 63-65, tav. Il. (94)
(95)
. (96)
. . Cf. P. Bartoloni, lA necTopoli (ct17n{HlgM 1981) : Monte Sr11i 1981 .
Cf. S. Llncel, TipasittUIIllll, cit .• p. 136, fig. 116.
Sulla tipologia e suDa cronologia dei piatti ombelicati si veda qumto esposto più 10pra, nel . . . ·Capitolo Il~ relativo alla Ceramica di SulciJ e di Monte Sirai.
. '
(97) ' Cf. Cintas, Mtmuel.-1, tav. XXI, 11 O. . ~
(98) Cf. <lntaa, Maìwel - l. tav. XXD. 116. . .
(99) Cf. P. Cintu, M11nuel d'ATchioliJ8le punique - O(= Collectiom des ~111Wel6 d'Archiologie
etd'Histolrede I'ATt), Paris 1976. p. 295, tav. XCIV, 3 • •
(100) Cf • . G. Quattrocdù Pilano, La collezione GtUowzglio. Antichità fmickrpuniche al Museo
di Como: RSF. 9 (1981), supplemento, pp. 90-91, ~. 3, D 17. · .
80 Studi sulla ceramica fenicia e punica di Sardegna.
esemplare (MC s. n. inv.) (Fig. lO, 1), di pasta nocciola, sembra essere la ·risultante di un pro-. ... . ~
cesso evolutivo interno. Pertanto, la cronologia della prima tazza è da porre nella prima· me-. .
tà del VI sec. a. C., mentre queJla della seconda è da sit~are probabilmente a cavallo della metà _dello .stesso secolo. Le nostre tazze, comunque, se si prescinde dall'orlo gonfio che in
dubbiamente richiama _quello deiJ'urna citata più sopra (Fig. 9, f), sembrano discendere da . .
quelle senza dubbio più arcaiche, qual~~ ad esempio una rinvenuta nella neoropoli di Bithia (MC inv. '92827) (BTH 179) (Fig. 10, j), che si unisce a quelle niènzionate in precedenza,
. relative alle ricerche effettuate dal Nissardi. ·
La- più che -evidente carenza di ampi parametri di giudizio, dovuta soprattutto all'esi-.
guo numero degli esemplari conservati nel Museo Nazionale di Cagliari e, quindi, alla incom-. ' . . . . .
pleta tipologia, non· permette allo stato; attuale .considerazioni ·definitive. I dati raccolti -in · questa sede posson<? essere comunque di qualch~ aiuto per comprendere in modo più completo i primi sec91i di vha de) centro ur~ano di Tharros e i rapporti_ commerciali che in questo arco di tempo furono tenuti dai suoi abitanti con le diverse civiltà che si affacciano sul~ le sponde del Mediterraneo centrale e occ.identale ( 1 0 1 ). ·
Innanzi· tutto è stata accertata la indubbia presenza di due necropoli . .a incinerazione. che, come per i maggi.Qri e più noti 1;entri urbani della Sardegna fenicia, contenevano sup-
. .
pellettili arcaiche e 02 ). Queste ultime, a_l contrario, non sembrano provenire. dagli ipogéi contenenti inurnati dei due restanti grandi· impianti cimiteriali tra .loro parzialmente coevi, come risulta dalle so_mrnarie ·relazioni e dai rapporti citatL Si è potuto accertare inoltre che
. .
nei corredi di ~ccompagnamento· delle fosse e delle ciste a incinerazione erano presenti qua-si unicamente oggetti preziosi in argento. Ciò ·certamente non perchè l'oro fosse ignoto. o
. . . . . . .
non incontrasse .il gradimento dei fruitori,- ma per oggettiva carenza di questo metallo nei giacimenti di Sardegna e 03
). La repentina quanto a Tharros particolarmente cospicua apparizione di monili aurei,. associati ai corredi delle tombe ipogeiche, che ovviamente impli-· cano una mutazione nel rito funerario, può essere spiegata, come si è detto più sopra, da un
. .
maggior interesse e da una compartecipazione diretta di Cartagine nei confronti dei merca~ . : . . . .
ti di Sardegna che si pone a partire d.alla fine dei..VI sec. a. C. _ La ceramica vascolare arcaica del centro di Tharios si affianca- palesemente a quelJa
. ' . . .
dei siti noH in ·precedenza, pur con queiJe minime· varianti che certamente ,preludono a svj. . .
luppi regionali e a· sc~lte in autongmia. Le similitudinj riscontrate in questo ambito, soprat~ tutto con_ il centro di Bithia, inducono a ipotizzare rapporti, già acclarati per quanto riguar· da il sito sulcitano -(10~). abbastanza stretti con _la penisola iberica, in questo caso avvalo-
. . .
rati e resi quasi ovvi dalla posizione geografica di Tharros e, soprattutto, in accordo con quan·
(101) Per alctmi aspetti del commercio tharrenso. si veda M. Gru, Les tmportatidns du Y.I siècle . . .
avant J. C. ti Thtll'ros · (&udaigne). Musée .de Caglitui, AntiqiUUium Arborense d 'Oristano:. .ME FRA, 86 -
(1974), pp. 79-139; per una sintesi più completa cf: da ultimo S. Moscati, 11uuros e il commercio ciuta-. . -ginese in Italia: Magna Graecia, 11 (1976)~ pp. 13-14. ·
.
(102) Cf. Bartoloni, Cronologia, pp. 13-29. .· ·
(103) E.· Billows, l minerali della Sardegna e i loro giacimenti: San:legna Min~arill, Ca&Jiari 1941, pp. 50.:52.
(104) Cf. ,Bartoloni. Bithill, p. 497.
Capitolo III 81
-to ci è tramandato dalle fonti storiche.
Tutte queste considerazioni, che devono essere assunte come ipotesi di lavoro, dovranno comunque essere ulteriormente vagliate c approfondite con un attento riesame dci materiali ceramici conservati nei Musei c negli Antiquaria della Sardegna e, uve ciò sia ancora possibile, con opportune c coordinate indagini sul terreno.
Questo lavoro, in ogni caso, vuole essere un contributo agli sforzi congiunti di differenti discipline e05)~ che si stanno applicando a questo antico centro c vanno ormai formando un panorama che da diverso tempo e sotto molteplici aspetti si delinea in modo sempre meno oscuro c più illuminante.
(l 05) SuU'articolato e pJuridisciplinare impegno archeologico e storico nel sito di Tharros e nel
suo circondario cf. E. Acquaro, Lo scavo dell981: Tharros- VIII, pp. 79-87, in cui è contenuta anche
la bibliografia precedente.
ELENCO DELLE FIGURE
Fig. 1. a (MSA s.n. inv.); b (MC s.n . inv.) (MSN63/2-s.o.); c (MC iov. 98145)
(MSN 64/ 11-39)~ d (MC s.n. inv.) (MSN64/II-67); e (MSA s.n. inv:); f (MC inv. 98148) (MSN 64/1 1-33); g (MC inv. 91866) (8TH 446); h (MSA s.o. inv.); i (MC inv. 98147)
(MSN 64/II-36C): j (MC s.o. inv .) (MSN64/ 11-39B); k (MC 67909); l (MC inv. 95~3)
(NNP/.:!): m (MC inv. 92&87) (8TH S.S.S): n (MC s.n. inv.) (MSN65/1244): o (MC s.n.
inv.) (MSN 63/.:!-s.n.); p (MS s.n. inv.) (MSA 66/111-B): q (MC inv. 98146) .
.
Fig. ::! . a (MC s.n. inv.) (MSN64/11-61); b (MC s.n. inv.): c (MC inv. 981 58) . (MSN64/11-43): d (MC s.n. inv.) (MSN64/ll·s.n.); e (MC inv. 98157) (MSN.64/II-59); .
f (MSA s.n .. inv.); g (MC s.n. inv.) (MSN43/10-74); h (MC inv. 98151) (MSN63/I0-83):
i (MSA s.n . inv .): j (MC inv. 98151)(MSN64/ ll-70). .
Fig. 3. · a (MC inv. 98160): b (MC inv. 98153) (MSN64/11·-18): c (MC s.n. inv.)
(MSN63/I0-129); d (MC inv. 98142); e · (M~A s.n .. ·inv.); f (MSA s.n. inv): g (MC inv.
91811); h (MSA s.n. inv.); i (MC s.n. inv.)(MSN64/ ll-s.n.).
.
Fig. 4. a (MC s.n. inv.) (MSN64/11-J5): b (M(' inv. 43368): c (.MSA s~n. inv.);
· d (MC inv. 98143)(MSN64/ II-s.n.) .
Fig. 5. a (MC s.n. inv.) (MSN64/ll-51): b (MC s.n. inv.) (MSN64/ ll-85); c (MC
inv. 98155) (MSN63/10-25); d (MC inv. 98154) (MSN65!J 2-16); e (MSA s.n. inv.): f (MC inv. 98 149) (MSN63/ L0-53) ; g (MC s.n. inv.) (MSN63/7-c) ; h (MC inv. 5.2970).
Fig. 6. a (MC inv. 98Ì56) ·(MSN64/ II-44); b (MC98144): c (MC s.n. inv.)(BTH . .
694); d (MSA s.n. inv.) (MSN 63/2-c). .
Fig. 7. a (MC s.n. inv.); b (MC inv. 98161); c (MSA s.n. inv.);. d (MSA,s.n.
inv.); e (Tambourit); f (MSA s.n. inv.).
84 Elenco delle figure
Fig. 8. a (MSA s.n. inv.): b (MSA s.n. inv.): c (MSA s.n. inv.) ; d (MSA s.n.
inv.); e (MSA s.n. inv.); f (MSA s.n. ìnv .).
Fig. 9. . a (MC inv. 2765H): b (MC inv . 17659): c (MC inv .. 91824) (BTH 94);
d (MC s.n. inv.): e (M( inv. 91516) (8TH 332)~ f (MC s.n. ìnv.): g (MC inv. 91547)(BTH
· 257); h (MC inv. 34529).
Fig. IO. a (MC s.n. inv .) : b (MC' s.n. inv . )~ c (MC' inv. 91436) (BTH 537): d (MC
s.n. inv . ) ~ e (MC inv. 91498) (BTH 169); f (M{' inv. 91500) (8TH 38X): g (MC s.n. inv .):
h (MC inv . . 91510) (BTH 16): i (MC s.n. inv .): j (MC inv. 928~7) (8TH 179); k (MC' inv .
91483) (8TH 107): l (MC s.n. inv.); m (MC' inv. 43447): n (MC' s.n. inv.).
\' -- o 'l l "4 o
.
' g b
' h
~ \ 1-.. o
o '
a
• • l t
+-+0 ++O
/"' 1- d y •
J
--- ·- ---- -- --- --- la 1
'
o o
-- --- -- --- -. . . ...
f 4
O 10 cm 1 , , , • . • Fia. 1