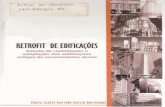\"Pantheon e culto a Biblo\", in E. Acquaro et alii, Biblo. Una città e la sua cultura, Collezione...
Transcript of \"Pantheon e culto a Biblo\", in E. Acquaro et alii, Biblo. Una città e la sua cultura, Collezione...
COLLEZIONE DI STUDI FENICI, 34
BIBLO ' UNA CITTA E LA SUA CULTURA
Atti del Colloquio Internazionale (Roma, 5-7 dicembre 1990)
1994 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
ROMA
ISTITUTO PER LA CIVILTÀ FENICIA E PUNICA
BIBLO '
UNA CITTA E LA SUA CULTURA
a cura di ENRICO ACQUARO -FEDERICO MAZZA - SERGIO RIBICHINI
GABRIELLA SCANDONE - PAOLO XELLA
1994 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
ROMA
PANTHEON E CULTO A BIBLO. ASPETTI E PROBLEMI
pAOLO XELLA - Roma
Alla memoria di Anna Maria Bisi
l. Obiettivo della presente relazione è fare il punto sull'apporto che le testimonianze scritte, in particolare le fonti epigrafiche, possono fornire allo studio della religione gublita: menzioni di divinità, allusioni di carattere cultuale, tipologia e caratteristiche dei nomi teofori ed altri elementi di interesse storico-religioso desumibili dai testi delle iscrizioni saranno al centro della nostra attenzione. Premessa indispensabile a tale riesame è però un riepilogo delle nostre attuali conoscenze in base a fonti extra-fenicie e per epoche diverse (generalmente più antiche), che serviranno da necessario sfondo alla rassegna del materiale epigrafico propriamente gublita.
Come nel caso di tutte le altre città fenicie d'Oriente, anche Biblo presenta purtroppo una situazione documentaria assai problematica sia in generale, sia per quanto riguarda più specificamente le fonti scritte. Il numero abbastanza ristretto di iscrizioni gublite giunte fino a noi e) e la loro particolare tipologia limitano enormemente le informazioni storicoreligiose e storiche tout court da esse desumibili. Per lo studio del pantheon e del culto cittadino, quindi, analogamente a quanto accade per altri aspetti della cultura gublita, si deve cercare di attingere a fonti esterne ed indirette, anch'esse, però, tutt'altro che abbondanti, in genere poco eloquenti e spesso di impiego assai delicato: dai risultati dell'esplorazione archeologica da tempo conclusasi (non di rado di complessa lettura e di limitata utilizzazione), a fonti esterne e disparate come alcuni documenti egiziani, dei testi sumerici e accadici CZ) o una serie di notizie di autori classici, tra cui le informazioni risalenti a Filone di Biblo/Sanchuniaton. Quest'ultimo complesso di fonti riveste un ruolo particolarmente importante per quanto riguarda aspetti della tradizione mitico-rituale locale, altrimenti ignota.
In tali condizioni, ben si comprende come la possibilità di un discorso storico continuo ed organico sulla religione gublita sia, almeno per il momento, un vera e propria utopia. Avvalendosi di informazioni ed indizi desunti da ogni tipo di documento, ivi compresi quelli archeologici e numismatici, lo storico può certo formarsi un'idea sulla struttura del pantheon, sui suoi esponenti più significativi, su taluni attributi divini, su qualche aspetto specifico del culto (sempre per epoche ben delimitate). Egli dovrà tuttavia limitarsi a formulare, al massimo, valutazioni provvisorie ed ipotesi di lavoro, nell'attesa di nuovi ritrovamenti che consentano di ampliare i parametri dell'indagine. Tale situazione spiega sufficientemente il carattere asistematico e generalmente problematico della presente relazione, da cui non ci si potrà attendere alcuna scoperta sensazionale, ma soltanto un riepilogo ed una messa a punto delle attuali conoscenze sulle manifestazioni religiose della Biblo pre-classica.
e) Cf. infra, Appendice I.
CZ) Cf. in generale B. HROUDA-W. RòLLIG, s.v. Gubla: R!A III, 673 ss.
196 P. Xella
2. Rimaste tuttora pressoché indecifrate le iscnz10ni locali dette pseudogeroglifiche e), se si mettono momentaneamente da parte i documenti epigrafici fenici, ciò che ci è noto della religione gublita consiste essenzialmente nei seguenti dati: elementi della topografia religiosa urbana; alcune informazioni concernenti soprattutto Hathor «Signora di Biblo», desumibili da documenti egiziani (4
); qualche altro dato sempre desumibile da testi egiziani, di particolare interesse perché redatti da «principi» locali e). che apportano qualche informazione diretta sul pantheon cittadino nell'età del Bronzo; alcune allusioni alla vita religiosa contenute nella corrispondenza amarniana tra Rib-Addi di Biblo e la cancelleria faraonica; le tradizioni- in ipotesi proiettabili in epoche assai antiche- contenute nei frammenti di Filone di Biblo; altre informazioni tramandateci da vari autori greci e latini, che ci ragguagliano su peculiari aspetti della religione gublita in epoche più tarde.
A parte il caso di Filone di Biblo, giuntoci attraverso quella complicata tradizione che sappiamo, le fonti classiche ci forniscono rilevanti informazioni, ma d'epoca più tarda, circa il complesso di tradizioni incentrate sulla figura di Adonis e le sue vicende mitico-rituali, anch'esse proiettabili in gran parte sullo sfondo della religiosità gublita. Si tratta di materiali assai importanti, che devono però essere utilizzati previa un'attenta e consapevole «decodifica» ideologica, metodologicamente bene orientata.
Per quanto riguarda in particolare Adonis e le tradizioni su di lui incentrate, studi recenti hanno sufficientemente chiarito portata e limiti dei problemi connessi a tale personaggio, nonché al contesto culturale in cui si radica. Si tratta sostanzialmente della proiezione greca di un «Baal» fenicio ideale, la cui denominazione era desunta dal suo epiteto abituale ('DN), assunto e rielaborato nella visione classica a nome proprio di un personaggio tipico ed «esemplare», di cui quello gublita poteva costituire certo una delle più significative formulazioni storiche (6
).
Quanto a Filone di Biblo, a parte altri dati e personaggi connessi alle tradizioni mitologiche gublite dettagliatamente evocati da altri in questo Colloquio C), mi limiterò soltanto a ricordare che Kronos (=El), padre della generazione divina «attuale», fondò tale città- la prima e più antica- e ne fece signora Baaltis, in cui è trasparentemente individuabile (anche dall'iconografia «hathorica» attribuita da Filone ad Astarte) (8
) quella Baalat Gebal, la «Signora di Biblo» (nbt kblpn nei testi egiziani), che costituisce indubbiamente il personaggio divino di maggior spicco nella storia religiosa cittadina. Si tratta della più tarda 'Acpgoòl'rn
e) Il recente tentativo di G. E. MENDENHALL, The Syllabic Inscriptions from Byblos. Beirut 1985, non ha certamente risolto il problema (cf., tra le varie recensioni, quelle di A. CAQUOT: Syria, 64 [1987], pp. 344-45; di G. GARBINI: RSF, 16 (1988], pp. 129-31; di W. R6LLIG: OLZ, 83 [1988], coli. 573-76).
(4
) G. SCANDONE MATTHIAE, Hathor Signora di Biblo e la Baalat Gebal: ACFP l, pp. 401-406.
e) Riepilogo dei dati in w. HELCK, Byblos: LA, 889-91. Cf. anche il sempre valido studio di K. KITCHEN, Byblos, Egypt and Mari in the Early Second Millennium B. C.: OrNS, 36 (1967), pp. 39-54. Come è noto, nei testi egizi sovrani di Biblo sono detti 1}3tj-' (qualcosa come <<sindaco»), e non ~~~3-b3swt, definizione corrente dei re delle altre città siriane. Da tempo è stato rilevato che tale circostanza riflette un rapporto privilegiato - di solidarietà ma anche di dipendenza o «Sudditanza>> - tra Biblo e la Terra del Nilo. Cf. in generale HELCK, Beziehungen, p. 64.
(6
) Cf. in generale S. RIBICHINI, Adonis. Aspetti «Orientali» di un mito greco, Roma 1981.
C) Cf. in questi stessi Atti la relazione di S. Ribichini.
(8
) P.E. I 10, 30-31. In Filone di Biblo, Baaltis è distinta da Astarte, il che testimonia indubbiamente una peculiare caratterizzazione della Signora gublita; tuttavia il particolare della «testa taurina» emblema di Astarte che, con Demarous/Adodos (= un tipico «Baal» poliade) regna sulla Fenicia col consenso di Kronos-El, è certamente connesso all'iconografia «hathorica» tipica della Baalat. Qui, come altrove, le antiche tradizioni confluite in Eusebio hanno subito un riadattamento, che lascia comunque cogliere la loro sostanziale veridicità. Sui problemi connessi con Astarte, tra cui quello in questione, rinvio alla monografia di imminente pubblicazione consacrata alla dea da parte di C. Bonnet.
Pantheon e culto a Biblo 197
Bv~ÀLYJ dello pseudo-Luciano C), cioè una particolare e complessa formulazione di Astarte, in cui essa va senz'altro identificata: ciò è stato recentemente dimostrato al di là di ogni dubbio da un'iscrizione bilingue fenicio-greca del IV secolo a. C., incisa su un trono in terracotta, che menziona appunto la Baalat Gebal e ALTAPTH 8EA MEriLTH e0
).
Sulla morfologia della «Signora di Biblo», come ha mostrato G. Scandone Matthiae (11),
dovette influire in una prima fase storica Hathor, Signora di Dendera, quindi- nel corso del I millennio a.C. -la dea Iside, che si sostituisce progressivamente all'antica madre di Horus. È inoltre probabile che - alla luce degli intensissimi rapporti storici e culturali che unirono Biblo alla Terra del Nilo già da epoche remote e2
) - anche Osiride e la mitologia su questi incentrata dovesse giocare un ruolo nelle tradizioni di Biblo attraverso assimilazioni, riadattamenti e riformulazioni locali testimoniate dalle vicende di Adonis e da altri indizi ancora. Non è mia intenzione soffermarmi qui su tale documentazione, che è stata recentemente al centro di intensi studi e sulla quale si è avuto in questa sede il complemento fornito da S. Ribichini (13
).
I resti dei templi di Biblo ci fanno bene intravvedere la ricchezza, la complessità, l'antichità delle installazioni religiose cittadine attraverso i molti secoli della loro esistenza ed utilizzazione, ma non lasciano trasparire che pochi ed incerti dati sugli dèi e sulla vita cultuale ad esse connessa. Se la presenza preminente della Baalat Gebal, cui è dedicato il complesso templare più antico, ne esce nuovamente confermata, si intravvede la presenza di un dio poliade, il cui santuario va probabilmente individuato nel tempio dell'Antico Bronzo (il «Tempie en L» di M. Dunand), posto nei pressi di quello della Baalat, poi parzialmente incorporato nel successivo «Tempio degli Obelischi» (risalente al Medio Bronzo).
L'identificazione con Rasa p ( «Reshef») del personaggio titolare di questi o tempio e, in ipotesi, dio poliade paredro della Baalat, proposta già nei primi studi, è in realtà probabilmente infondata. Essa si basa sostanzialmente su due argomenti: a) il rinvenimento di alcune statuette del tipo «Smiting God» nell'area del santuario; b) l'iscrizione incisa su uno degli obelischi del tempio, una dedica effettuata da una gublita al dio-ariete di Herakleopolis, I:Ierishef e4
). Ora, quest'ultimo teonimo non ha in comune col dio siriano Rasa p (erroneamente vocalizzato «Reshef» secondo l'uso biblico) che un'apparente assonanza (in realtà, a quest'epoca, il nome del dio semitico doveva essere quasi certamente *Ras[a]pu). Va ancora aggiunto che, fino al momento attuale, non si conoscono indizi che possano caratterizzare Rasap come dio poliade in nessun centro semitico-occidentale a noi noto. Si tratta di una complessa figura divina dalle molteplici caratterizzazioni, che manca però di quella «polivalenza» funzionale che sconfina in una indeterminatezza di attribuzioni, che è tipica dei «Baal» fenici, a loro volta diretti continuatori delle divinità poliadi dell'età del Bronzo es).
C) Dea Syria, 6.
C0) P. BORDREUIL-E. GUBEL, BAALIM II: Syria, 62 (1985), pp. 182-83. Gli stessi autori hanno pubblicato
nello stesso anno una statuetta in calcare raffigurante la dea in questione, recante l'iscrizione B'LT GBL, datata alla seconda metà del V secolo a.C. (Semitica, 35 [1985], pp. 5-11).
(11
) G. ScANDONE MATTHIAE, Hathor Signora di Biblo e la Baalat Gebal, cit. (nota 4).
C2) Cf. K. PRAG, Byblos and Egypt in the Fourth Millennium B. C.: Levant, 18 (1986), pp. 59-74; per il III
millennio, si veda M. SAGHIEH, Byblos in the Third Millennium B. C., Warminster 1983.
(13
) Si vedano supra le note 5-6 ed inoltre AA.VV., Adonis. Relazioni del Colloquio di Roma, Maggio 1981, Roma 1984.
C4) Dati in W. J. FuLco, The God Resep, New Haven 1976, p. 55, cui si aggiunga l'importante messa a
punto di G. ScANDONE MATTHIAE, Il problema delle influenze egiziane sulla religione fenicia: AA.VV., La religione fenicia. Matrici orientali e sviluppi occidentali, Roma 1981, pp. 67 ss.
C5) Cf. da ultimo P. XELLA, D'Ugarit à la Phénicie: sur !es traces de Rashap, Horon, Eshmun: WO, 19
(1988), pp. 45-64, cui si rinvia per gli studi anteriori.
198 P. Xella
Per quanto concerne poi il personaggio rappresentato dalle statuette, la denominazione «Reshef» risponde, come è ben noto, ad una pura convenzione, ma la sua vera identità è in realtà tutta da dimostrare e6
). Alla luce dei dati in nostro possesso appare comunque probabile che nello «Smiting God» si debba riconoscere semplicemente un «Baal», cioè una figura poliade del tipo di Haddu, Baal di Ugarit nel II millennio. Che, nel caso specifico, il personaggio delle statuette corrispondesse ad un «Baal di Biblo» è poi molto verosimile: non va dimenticato che quest'ultimo teonimo (sia più anticamente nella forma «Haddu», che come «Baal» nel I millennio), è bene attestato nell'antroponimia gublita, ivi compreso nel nome di qualche antico sovrano locale, evidentemente devoto a questa divinità.
3. Per quanto riguarda le epoche più antiche, alcune informazioni isolate ci vengono, come già accennato, da documenti extra-fenici, non privi di interesse, ma certo insufficienti a darci un'idea chiara della religione gublita nel II millennio.
Oltre alle lettere di El-Amarna, su cui tornerò tra breve, si ha il famoso resoconto egiziano del viaggio a Biblo di Unamon, sacerdote del dio Amon (17
). Il testo, qualunque ne sia stata l'orientazione ideologica, apre comunque un piccolo squarcio sulla Biblo dell'XI secolo a.C. con l'accenno ai sacrifici del re locale Zakarbaal, all'innegabile deferenza di questi per il dio Amon e con l'episodio, interessante ma purtroppo senza altri confronti, dell'estasi notturna e relativa «possessione» divina di un giovane (sacerdote?) alla corte gublita.
Una messa a punto dettagliata delle nostre conoscenze sulla religione gublita anteriormente all'età del Ferro, specie in relazione agli influssi egiziani, è stata fatta esaurientemente da G. Scandone Matthiae in molteplici contributi es), e ciò mi esime dal riprendere la questione. Ricorderò solo brevemente due aspetti, che mi sembrano di particolare interesse e che sono suscettibili di un approfondimento.
In primo luogo la circostanza che, su un'iscrizione geroglifica da Biblo, un antico «principe» locale menzioni la dea Nut nell'ambito di una serie di divinità. Dal testo emerge altresì che la dea in questione possedeva un tempio a Biblo durante l'età del Bronzo C9
). La notizia desta sorpresa, sia dal punto di vista egittologico (la dea da sola non ha praticamente culto in Egitto), sia da quello gublita: è possibile che si tratti di un'altra denominazione della Baalat Gebal, una volta tanto non identificata con Hathor? Non lo ritengo credibile. Se un teorico accostamento tra la «Signora di Biblo» e l'egiziana dea-vacca celeste potrebbe forse avere un
C6) Cf. in generale H. SEEDEN, The Standing Armed Figurines in the Levant, Miinchen 1980; particolarmen
te incisiva è la messa a punto della compianta A. M. Brsr, Le «Smiting God>> dans les milieux phéniciens: un réexamen de la question: C. BoNNET-E. LIPINSKI-P. MARCHETII (edd.). Studia Phoenicia-IV. Religio Phoenicia. Namur 1986, pp. 170-87.
C7) Cf. il classico lavoro di H. GoEDICKE, The Report ofWenamun, Baltimore-London 1975. Cf. anche E.
BRESCIANI, Letteratura e poesia dell'antico Egitto, Torino 19752, pp. 508-15. Gli eventi, come è noto, si proietta
no negli ultimi anni di regno del faraone Ramesse XI (XXI dinastia), cioè nel corso dell'XI secolo a.C. La più recente riconsiderazione del testo, nell'ambito più generale dei rapporti tra Egitto e Fenicia. si deve a 1. LECLANT, Lcs Phéniciens et l'Égypte: ACFP 2, pp. 7-17. cui si rinvia per tutti gli studi antecedenti. Cf. adesso lo studio di A. ScHEEPERS, Anthroponymes et toponymes du récit de Ounamon: E. LIPINSKI (ed.), Studia PhoeniciaXl. Phoenicia and the Bible (= OLA, 44), Leuven 1991, pp. 17-83.
C8) Vedi soprattutto G. SCANDONE MATIHIAE, Il problema delle influenze egiziane sulla religione fenicia,
cit .. pp. 61-80; EAD .. Una statuetta del Museo Egizio di Torino con dedica ad Hathor Signora di Biblo: RSF, 15 (1987), pp. 115-25; EAD., Hathor Signora di Biblo e la Baalat Gebal, cit. (nota 4). Sulla documentazione egiziana a Biblo, e in generale in Fenicia, cf. EAD., Testimonianze egiziane in Fenicia dal XII al IV sec. a. C.: RSF. 12 (1984), pp. 133-63.
C9) K. A. KncHEN, An Unusual Egyptian Text from Byblos: BMB. 20 (1967), pp. 149-53, con ulteriori
rinvii bibliografici (tra cui all'edizione del documento da parte di P. Montet).
Pantheon e culto a Biblo 199
vago fondamento morfologico e funzionale, sembra tuttavia più ragionevole tenere conto della concreta possibilità che Nut sia qui l'interpretatio aegyptiaca di un'altra importante e a noi sconosciuta dea locale. Il nome di 'Anat, avanzato ipoteticamente da W. F. Albright CZ0
),
potrebbe essere un candidato attendibile, specie alla luce delle connotazioni celesti (b'lt smm rmm) CZ1
) e alla sua possibile rappresentazione come vacca, testimoniate dai testi di Ugarit CZ2
). Il dato deve comunque far riflettere sul carattere composito ed articolato del pantheon gublita, cui i laconici documenti a noi noti non rendono certo giustizia.
Il secondo punto concerne il problema del ruolo a Biblo del dio Khai-tau (lj'yt3w), che è menzionato in tre passi dei «Testi delle Piramidi», una volta in connessione con il «paese di Ng3», cioè il territorio circostante la nostra città CZ3
). Il nesso con Biblo è ulteriormente provato dal fatto che Khai-tau è una delle divinità invocate da un «principe» locale nell'iscrizione sul celebre «Cylindre Monte t» CZ4
): ci si deve allora chiedere se è possibile che si abbia qui addirittura a che fare col dio poliade di Biblo, il paredro della Baalat. A tale quesito occorre, a mio avviso, dare una risposta negativa.
Mentre va osservato che dai passi dei «Testi delle Piramidi» sopra citati emergono indizi che ci indirizzano verso un tipo assai specifico di divinità CZ5
)' dai caratteri molto peculiari e non generici (come ci si aspetterebbe invece da un Ba al poliade), v'è da tenere conto globalmente dell'iscrizione sul «Cylindre Montet» che, come è stato giustamente osservato CZ6),
riflette in un certo senso uno spaccato del pantheon gublita a quest'epoca. Qui, infatti, il «principe» di Biblo autore dell'iscrizione geroglifica, dopo aver menzionato il proprio padre, sembra volersi porre sotto la protezione di alcune divinità: nell'ordine, un «Ra dei Paesi stranieri», la Baalat di Biblo e lo stesso Khai-tau CZ7
). Con la prudenza che impone ogni interpretazione di questo difficile testo, si può tuttavia supporre che i primi due siano i membri della «coppia» poliade (diciamo, il «Baal Gebal» e la «Baalat Gebal»), mentre il terzo, se si tiene conto di quanto emerge dai «Testi delle Piramidi», dovrebbe essere una figura diversa, dagli aspetti ctonii e dalle speciali funzioni (forse psicopompo), ma non la divinità poliade (W. Helck pensava ad una sorta di Tammuz-Gestalt) CZ8
).
La proposta di vedere in Khai-tau un personaggio divino analogo a Rasap, avanzata qualche anno fa da G. Scandone Matthiae e da chi scrive CZ9
), mi sembra tuttora sostenibile, senza però che di tale dio si pretenda di fare a tutti i costi il capo del pantheon locale. Siamo piuttosto di fronte, ancora una volta, ad un indizio della complessità dell'universo religioso gublita visto attraverso l'ottica egizia: una problematica di studio ancora insufficientemente
eo) W. F. ALBRIGHL Further Light 011 the History on Middle-Bronze Byblos: BASOR, 179 (1965), p. 40.
e1) KTU 1.108:7. Si noti anche il suo epiteto <<signora della regalità>> (b'/t mlk) nello stesso passaggio, linee
6-7. e2 ) Cf. ad esempio KTU 1.6 II 28, col parallelismo 'gli/ ari!. Si veda in generale O. LORETZ, Ugarit und die
Bible. Kanaaniiische Gotter und Religion im Alten Testament, Darmstadt 1990, pp. 79 ss.
e3) §§242, 423 (ripetizione del precedente) e 518 (menzione di Ng3). Cf. P. MONTET, Le pays de Negaou
près de Byblos et san dieu: Syria, 4 (1923), pp. 181-92.
e4) Dati e bibliografia in R. STADELMANN, Chaitau: LA, 902.
es) Cf. in particolare G. ScANDONE MATTHIAE-P. XELLA, I:;I'yt3w di Biblo = Rasap?: RSF, 9 (1981), pp. 149 ss.
CZ6) HELCK, Beziehungen, cit.' p.22.
CZ7) La lettura e la traduzione del testo sono assai controverse, a causa dello stato di conservazione del
documento. Prescindendo qui da studi specifici, si cf. in generale HELCK, Beziehungen, pp. 21 ss.: R. STADELMANN, Syrisch-paliistinensische Gottheiten in Agypten, Leiden 1967, pp. 8 ss. Più recentemente, si veda H. GoEDICKE, Another Remark about the Byblos Cylinder Seal: GM, 29 (1978), pp. 23-24.
CZ8) HELCK, Beziehungen, p. 22.
CZ9) Cf. G. SCANDONE MATIHIAE-P. XELLA: RSF, 9 (1981), pp. 147-53.
200 P. Xella
esplorata dai semitisti, che potrebbe e dovrebbe affiancarsi a quella, già ben nota, dell'interpretatio classica delle divinità fenicio-puniche.
4. Prima di venire alle iscrizioni gublite, mi è sembrata infine utile una breve puntualizzazione della situazione per l'epoca ad esse immediatamente precedente, cioè attraverso le scarse e non trascurabili notizie desumibili dalla corrispondenza di El-Amarna concernente Rib-Addi e la cancelleria faraonica.
Nelle lettere di provenienza gublita e0), oltre a qualche altra allusione, sembrano men
zionati direttamente quattro teonimi: la Baalat Gebal, «Tammuz», Ninurta e il «dio della tempesta» (Haddu/Baal).
La prima è indubbiamente la più importante ed autorevole; «Tammuz» è stato generalmente ritenuto essere la designazione della divinità maschile di Biblo (l' «Adonis» delle fonti classiche), ma la menzione è in realtà assai dubbia. Tale lettura e interpretazione di AN.DA. MV-ia in EA 84, 33, proposta in origine da O. Schròder e1
), non si basano su alcun dato obiettivo e sono in buona parte influenzate da quanto ci è noto dalle tradizioni posteriori. Al riguardo, si è recentemente proposto che possa trattarsi ancora una volta della menzione della Baalat locale, anche se la spiegazione di AN.DA.MV-ia come DINGIR-da-mu-ia non è priva di difficoltà e2
). Per quanto riguarda la menzione di Haddu/Baal, essa potrebbe avere carattere incidentale e non concernere direttamente il pantheon gublita. Quanto a Ninurta, o meglio, al suo tempio di cui sembra esser questione in EA 74, 31, dal contesto si evince che, se non è un toponimo e3
), difficilmente tale eventuale santuario può però essere localizzato a Biblo.
Nelle formule di saluto indirizzate da Rib-Addi al Faraone, la Baalat di Biblo (Beltu sa Gubla) e4
) riveste un ruolo assolutamente predominante, venendo menzionata quasi sistematicamente nell'augurio di potenza al sovrano egiziano e5
). Il carattere indubbiamente in buona parte stereotipo e «formulare» di questi indirizzi contribuisce a confermare il prestigio tradizionale ed indiscusso di cui godeva la dea in questione, che è per Rib-Addi anche,
eu) Oltre all'edizione di J. A. Knudtzon, no 68 e ss., cf. R. F. YOUNGBLOOD, The Amarna Correspondence of Rib-Haddi, Prince of Byblos (EA 68-96), Ph. D. Diss., Dropsie Univ., Ann Arbor 1961; W. L. MoRAN, Les lettres d'El-Amarna, Paris 1987, nn. 68 ss., alle quali vanno aggiunte altre due lettere (EA 139 e 140) di provenienza gublita, scritte da un certo Ili-rapil]. Sugli aspetti storici e ideologici, cf. E. F. CAMPBELL, The Chronology ofthe Amarna Letters, Baltimore 1964 e M. LrvERANI, Three Amarna Essays, Malibu 1979. Non apporta gran che di nuovo P. SwrGGERS, Byblos dans les lettres d'El Amarna: lumières sur des relations obscures: Studia PhoeniciaIII. Phoenicia and lts Neighbours, Leuven 1985, pp. 45-58.
e1) O. SCHRODER, Uber den N amen des Tamllz von Byblos in der Amarnazeit: OLZ, 18 (1915), coli. 291-93.
e2) Cf. N. NA'AMAN, On Gods and Scribal Traditions in the Amarna Letters: UF, 22 (1990), pp. 247-55, in
particolare pp. 248-50, che propone come traduzione «The Goddess, my vitality», o qualcosa del genere. Si noti come W. L. MORAN, Les lettres d'El-Amarna, cit., pp. 267-68, legga qui DINGIR MES, di contro al DA.MU-ia di R. S. HEss: UF, 18 (1986), p. 154, che segue invece Knudtzon (I, 406).
e3) Ipotesi respinta da W. L. MORAN, Les lettres d'El-Amarna, cit.' p. 252, nota 10, in base all'assenza di
URU o KI. Di un toponimo sembra trattarsi però in EA 290: cf. N. NA'AMAN: UF, 22 (1990), pp. 252-54. Quest'ultimo propone che Ninurta vada inteso come un teonimo femminile(!) riferito a 'Anat, anche in base alle analogie funzionali tra le due divinità (guerra, caccia), un'ipotesi inverosimile, contraddetta chiaramente anche dalle liste divine ugaritiche (pure citate dall'A.), secondo le quali a N in urta corrisponde il dio semitico occidentale gsr l gasaru.
e4) Nelle grafie ctNIN sa URU gu-ub-la/gub-la(kiJ!gu-ub-la, ovvero semplicemente come NIN-nu (EA 74,
56) o dNIN (EA 83, 57; 85, 86; 86, 29; 132, 55). Sui teonimi a El-Amarna cf. R. S. HEss, Divine Names in the Amarna Texts: UF, 18 (1986), pp. 149-68, che tuttavia non si occupa né dei teofori né dei toponimi contenenti teonimi.
es) EA 68; 74-76; 78; 79; 81; 83; 85; 89; 92; 105; 107; 108; 109; 112; 114; 116-119; 121-125; 130; 132.
Pantheon e culto a Biblo 201
semplicemente, «la nostra Signora» e6). Sempre nelle formule di saluto, allorché non ci si
rivolge direttamente al Faraone, si invoca la dea affinché garantisca l'onore dell'interlocutore davanti al sovrano stesso e7
), funzione condivisa da Amon da solo e8) o insieme alla stessa
Baalat di Biblo e9). La dea, del resto, è colei che, insieme agli altri dèi ed al Sole (Samas),
hanno concesso che il Faraone sieda sul trono (40). La Baalat è chiamata a testimone di ciò
che si scrive (41); è su di lei e su tutti gli dèi di Biblo che Rib-Addi giura (42
); la dea (qui, certo, il suo tempio) possedeva dei beni (43
), mentre qualche altra lettera fa menzione di una certa Ummal]nu (e di suo marito Milkuru), definita «serva della Signora di Biblo», che deve pregare la dea per il Faraone (si tratta certamente di una sacerdotessa) (44
). Secondo N. Na'aman, che ha tentato una ricostruzione storica basata sulle quattro menzioni del personaggio, la donna e suo marito avrebbero trascorso un certo periodo di tempo in Egitto per un servizio cultuale (alla dea Hathor?), ma il re di Biblo avrebbe poi preteso il loro ritorno perché partecipassero ad una «festa del vino» (EZEN ye-ni in EA 84, 44), sulla quale non abbiamo finora altre notizie (45
).
Tra le altre poche informazioni sparse desumibili, si deve ancora ricordare una attestazione di Haddu/Baal (ctiM) cui è paragonato il Faraone, di cui si dice «che sta nel cielo come Baal e come Samas» (46
). Non vi sono elementi certi per dimostrare che questo «dio della tempesta» sia una divinità gublita e la menzione potrebbe essere semplicemente «di circostanza» (47
).
C'è ancora da annoverare qualche allusione agli «dèi di Biblo» nel loro complesso da parte di Rib-Addi (48
). In una lettera (49) si dice che egli abbandonerà la città insieme con i
suoi dèi, mentre questi stessi dèi di Biblo, secondo un'altra lettera (50), saranno costretti a
lasciare la città e ad essere consegnati ad Aziru (sembra che essi siano usciti e non possano rientrare). In un altro caso, infine, si allude a peccati connessi davanti ai sacri dèi cittadini ('1
).
Di una divinità maschile, definita «dio (personale?) di Rib-Addi», che veglia sul benessere di questi e della sua casa, si fa menzione in un'altra lettera, questa volta proveniente dalla cancelleria egiziana ( 2
). Qui tale figura divina, più che con un Baal poliade, sembra piuttosto identificabile con un dio dinastico ignoto, a somiglianza dell'ilib di Ugarit o delle
C6) EA 74, 56. Cf. del resto l'iscrizione di Sipitbaal (KAI 9 B: 5), dove la dea è menzionata semplicemente
come B'LT.
C7) EA 69; 73; 102.
C8) EA 71; 77; 86.
C9) EA 77; 87; 95.
(40
) EA 116.
(41
) EA 77.
C2) EA 109.
(43
) EA 132.
(44
) EA 83, 52-57; 84, 42-44; 85, 84-87; 86, 23-30.
(45
) N. NA'AMAN: UF, 22 (1990), pp. 247-48.
(46
) EA 108, 9.
(47
) Cf. tuttavia il nome stesso di Rib-Addi, nonché, tra l'altro, quello di Ibdati/di attestato a Ur III (E. SOLLBERGER, Byblos sous le roi d'Ur: AfO, 19 [1959-60), pp. 120-22).
(48
) Come già in EA 109.
(49
) EA 77.
CS0) EA 134.
CS 1) EA 137.
CS2) EA 96.
202 P. Xella
divinità connesse con la famiglia del sovrano menzionate ad esempio nell'iscrizione di Kilamuwa di Zincirli CS3). Enigmatica, ma ipoteticamente riferibile sia al Baal poliade, sia ad una divinità dinastica, sembra infine la menzione del «(mio) dio vivente» in un'altra lettera CS4
).
Per quanto questi dati siano obiettivamente scarni, se ne può comunque dedurre il ruolo leader della Baalat di Biblo, di cui si ricorda una sacerdotessa dal carisma e dai poteri probabilmente assai famosi. Le formule di saluto e gli altri accenni rendono evidente che la Signora gublita era al primo posto nella devozione di Rib-Addi. Accanto a lei, è deducibile la presenza di un Haddu/Baal poliade, probabilmente diverso dal dio dinastico menzionato in EA 96, mentre sullo sfondo si trovano «gli dèi» di Biblo (DINGIRme~ [ilani], menzionati collettivamente) CS5), che richiamano immediatamente «(l'assemblea degli) dèi santi di Bibio» (MPI:fRT 'L GBL QDSM), ben noti dalle iscrizioni reali fenicie di età posteriore. In definitiva, si tratta di un quadro d'insieme che non sembra presentare elementi significativi di dissonanza rispetto a quello che si delinea in base alle epigrafi gublite dell'età del Ferro, per quanto i secoli immediatamente seguenti dovettero essere forieri di non pochi rivolgimenti storico-politici e culturali.
5. Venendo dunque alle fonti dirette, procederò ad una rapida analisi panoramica del materiale epigrafico fenicio di Biblo, al fine di desumerne elementi utili alla conoscenza del suo pantheon ed eventualmente di altri aspetti della vita religiosa gublita. Una sintetica valutazione dell'onomastica personale, alla ricerca dei teofori che vi compaiono, costituirà un aspetto collaterale ma non trascurabile di questa relazione. In appendice, mi è sembrato non privo di interesse ed utilità redigere un elenco - che spero completo - di tutte le iscrizioni finora note provenienti dal sito in questione. Ai testi già conosciuti e riportati dalle più autorevoli raccolte epigrafiche sono state aggiunte iscrizioni pubblicate più di recente e qualche altro documento (per lo più assai breve) poco noto o addirittura sconosciuto, individuato attraverso uno spoglio sistematico dei volumi di Fouilles de Byblos. Si tratta di testi che, pur senza apportare novità sensazionali, contribuiscono ad arricchire il corpus epigrafico gublita ed a fornire qualche altro piccolo elemento di valore soprattutto paleografico.
Va da sé che la natura ed i limiti delle fonti non consentono che valutazioni parziali ed assai limitate, e la natura stessa del corpus- consistente in una cinquantina di iscrizioni- è in parte artificiosa e disseminata nell'arco di molti secoli. Pur con questi limiti, tenterò di procedere nel modo sopra indicato, con l'implicita e costante avvertenza che si tratta di valutazioni provvisorie, soggette alla massima cautela.
* * *
Le mie osservazioni sparse non possono non prendere le mosse dall'iscrizione di AQ.irom, che ha fatto versare fiumi d'inchiostro per gli svariati problemi interpretativi e cronologici che il testo ed il suo supporto presentano.
Non è mia intenzione affrontare qui in dettaglio il controverso problema della datazione dell'epigrafe, connessa a quella del sarcofago, non necessariamente coincidenti a seguito di
CS 3) KAI 24.
CS4) EA 129 (cf. 84, 35). Si aggiunga per completezza di informazione la menzione di offerte funerarie in EA
131.
(55
) Cf. tuttavia le argomentazioni di N. NA'AMAN: UF, 22 (1990), p. 255, sulla necessità di stabilire caso per caso se si tratti di un plurale o di un singolare.
Pantheon e culto a Biblo 203
un'eventuale riutilizzazione (e/o rilavorazione) del medesimo. È però evidente che la questione non è irrilevante dal punto di vista storico-religioso. Le implicazioni ideologiche (specie di carattere funerario) presupposte dal documento potrebbero essere più adeguatamente valutate se se ne potesse precisare al meglio il contesto storico-cronologico.
Conscio delle difficoltà d'ogni tipo che si frappongono ai tentativi d'interpretazione complessiva, mi limiterò qui a ricordare come i ritrovamenti ceramici della Tomba V della necropoli gublita indicano un arco cronologico che va da Ramesse II fino all'incirca all'XI-X secolo, epoca presunta cui risalgono i frammenti del cratere di «White Painted W are» trovati nella camera funeraria. A questi ultimi dovrebbe naturalmente ancorarsi la datazione, a meno che non si riesca a trovare una spiegazione plausibile per un loro posteriore arrivo in loco. Confesso che, finora, non ne ho trovate di convincenti e spero d'altra parte che gli specialisti di ceramica possano riuscire a meglio precisare la datazione dei frammenti in questione.
È noto d'altra parte che, dal punto di vista storico-artistico, un'autorità in materia come E. Porada CS6) ha pubblicato un esame dettagliato del sarcofago e dei rilievi, giungendo a proporre - come aveva fatto del resto anni prima (ed indipendentemente) N. AiméGiron CS7
) - una data intorno al 1000. Le deduzioni d'ordine stilistico fatte dall'eminente studiosa americana hanno il loro peso e devono costituire un punto di riferimento, anche se relativo: mi riesce infatti difficile credere che i confronti con materiali leggermente posteriori non permettano di oscillare di qualche decennio verso l'alto e8
), e consentire di alzare leggermente la datazione del sarcofago (di una cinquantina d'anni) rispetto al 1000 o «slightly late» proposto da E. Porada.
Dal punto di vista paleografico, poi, mi pare assai convincente l'analisi effettuata qualche anno fa da W. Rollig CS9
) il quale, in una riconsiderazione del problema, notava la possibile leggera anteriorità delle iscrizioni sui coni d'argilla rispetto all'iscrizione di A~irom e la relativa omogeneità paleografica di quest'ultima con le più arcaiche iscrizioni reali della serie gublita (60
). Tra l'altro, un alef simile a quello di A~irom è ora attestato sia nell'iscrizione «champlevée» pubblicata da P. Bordreuil (61
) (datata al 950-925), che a Creta nella coppa di Tekke, pubblicata da M. Sznycer (62
) e assegnata anch'essa all'XI-X secolo. Quanto agli aspetti contenutistici e linguistici di colore innegabilmente arcaico, c'è però
da tenere conto anche del carattere stereotipo della maledizione, che certo continua una tradizione risalente almeno al Tardo Bronzo. Dato il conservatorismo in questo ambito, infatti, essa non prova necessariamente l'appartenenza del testo all'identico milieu culturale
CS6) E. PORADA, Notes on the Sarcophagus of Ahiram: JANES, 5 (1973) (The Gaster Festschrift), pp. 355-72.
CS7) N. AIMÉ-GIRON, Adversaria semitica-IV. Essai sur l'age et la succession des rois de Byblos d'après leurs
inscriptions: ASAE, 42 (1943), pp. 284-338.
CS8) Come sembra invece credere G. GARBINI, I Fenici. Storia e religione, Napoli 1980, pp. 31 ss.' per il
quale i materiali di confronto (IX-VIII secolo) dovrebbero automaticamente implicare una stessa datazione per il sarcofago. Mi pare che datazioni scaturite da analisi artistiche di questo tipo non siano da prendersi in senso troppo rigido e consentano un certo margine di oscillazione verso l'alto o il basso, purché ragionevolmente motivate e limitate.
C9) W. RoLLIG, Die Al}lrom-Inschrift. Bemerkungen eines Epigraphikers zu einem kontroversen Thema:
Praestant Interna. Festschrift fiir Ulrich Haussmann, Tiibingen 1982, pp. 367-73.
(60
) Nella questione della datazione si deve tenere altresì conto delle osservazioni di M. Martin sulla possibilità che il testo di Al,lirom (come altri gubliti) sia un palinsesto, con precedenti iscrizioni in pseudo-geroglifico (anche se non tutte le sue proposte sono da accettare): cf. M. MARTIN, A Preliminary Report after the ReExamination of the Byblian Inscriptions: OrNS, 30 (1961), pp. 46-78.
(61
) P. BORDREUIL, Une inscription champlevée des environs de Byblos: Semitica, 27 (1977), pp. 23-27.
(62
) M. SzNYCER, L'inscription phénicienne de Tekke près de Knossos: Kadmos, 18 (1979), pp. 89-93.
204 P. Xella
riflesso dai testi di U garit: dovevano certo esistere formulari tradizionali e consolidati, un vero e proprio «genere» di cui si hanno molteplici esempi anche in testi non epigrafici. Quanto alla lingua, l'assenza o quasi di testi fenici coevi, provenienti da Biblo o da altrove, suggerisce la più grande prudenza ed impone che, al massimo, si formulino caute ipotesi di lavoro sulle peculiarità, reali o apparenti, che sembrano individuarsi in questa breve iscrizione.
In definitiva, tenendo conto di tutti gli elementi del problema (paleografico e linguistico, archeologico e stilistico ), e con un occhio attento al contesto storico, una datazione intorno al 1000 o appena prima mi sembra al momento la più ragionevole. L'iscrizione è certo posteriore ai drammatici eventi riflessi dalle lettere amarniane, cui seguì un'epoca imprecisabile di caos e di disordine; d'altra parte, il re gublita Zakarbaal menzionato nel testo di Unamon dovrebbe situarsi non lontano, ma probabilmente appena prima del binomio Al)iromIttobaal.
Considerate dal punto di vista storico-religioso, le scene del cordoglio ed i riti funebri sul sarcofago alludono non sorprendentemente ad un'ideologia e una prassi cultuale che affonda le sue radici nelle tradizioni siriane dell'Età del Bronzo, da Ebla ad Ugarit (63
). Si vedano ad esempio le préfiche menzionate dal testo di Keret (64
), il tema del banchetto funerario (65) o
il ruolo dei figli del re nei riti di lutto (66): il rapporto padre-figlio costituisce, com'è noto, il
motivo decorativo del coperchio del sarcofago, ed è troppo conosciuto per meritare commenti. Il re è posto «nell'eternità» dal suo erede: questi deve assicurargli una forma di sopravvivenza nella tomba (preservando il suo nome) e nell'aldilà (67
), dove il defunto certo eserciterà un'azione benefica- se opportunamente onorato- come è il caso dei Rapiuma (antichi sovrani ed eroi tradizionali) nei testi ugaritici.
La maledizione sopra menzionata occupa la maggior parte del testo ed elenca tre eventuali possibili violatori, un re, un SKN, un comandante militare. Ma cosa e chi temeva realmente Ittobaal? In base alla frase relativa al venir meno della pace a Biblo (WNI:JT. TBRI:J. 'L.GBL), è stato ipotizzato (68
) che si doveva trattare di un nemico «interno», poiché di pace non doveva già esser più questione all'atto dell'eventuale attacco o conquista esterna, seguita dalla violazione del sepolcro.
L'espressione «Un re tra i re» (in generale, «un X tra i varii X») pare tuttavia riflettere una casistica più generica, che naturalmente include anche potenziali nemici esterni. A questa interpretazione non si oppone il fatto che Biblo resti «senza pace», poiché l'allusione sembra rivolta piuttosto al destino dell'eventuale violatore/invasore, che non dovrà più avere pace se compirà l'abominio di profanare la tomba di A}:lirom. L'obiezione interpretativa sopra ricordata non sembra aver più ragione di sussistere, da quando S. M. Cecchini ha mostrato che 'L indica «sopra», come ci si attenderebbe regolarmente, attribuendo convincentemente al verbo BRI:J il senso di «cessare, venir meno» (69
).
Cade perciò la proposta di distinguere un 'L «da» rispetto a 'L Y «Sopra» C0). 'L Y non andrà inteso
dunque col senso di «prendere il potere su» ma, esattamente come ci si attenderebbe, «salire a Biblo»,
( 63 ) Cf. da ultimo TH. PaDELLA, Ein mediterraner Trauerritus: UF. 18 (1986). pp. 263-69.
(64
) KTU 1.16 I l ss. e paralleli.
( 65) P. es. in KTU l. 161.
( 66) Cf. lo studio citato supra (nota 63) e, in particolare, i testi discussi da O. LoRETZ, Ugarit und die Bibel, cit.' pp. 125 ss.
( 67) Sulla dualità tomba/aldilà, aspetti di una stessa dimensione ultra terrena, cf. P. XELLA, Imago martis nella Siria antica: In. (ed.), Archeologia dell'inferno. L'aldilà del mondo antico vicino-orientale e classico, Verona 1987, pp. 117-45. Si noti come il graffito sulla parte della tomba di Al,lirom menzioni Tl:JT, <<sotterraneo>>, che è forse attestato a Ugarit: S. M. CECCHINI, TlfT in KAI 2, 3 e in KTU 1.161:22 ss.: UF. 13 (1981), pp. 27-31.
( 68) G. GARBINI, I Fenici, cit., pp. 59 ss.
(69) S. M. CECCHINI. La pace di Biblo. Ancora a proposito dell'iscrizione di A!Jiram: Studi orientali e linguistici, 3 (1986), pp. 53-56.
(0
) G. GARBINI, I Fenici, cit.' p. 61.
Pantheon e culto a Biblo 205
non necessariamente in senso militare, senza però che questa sfumatura possa venire completamente esclusa ( 1
) o
Quanto ai tre potenziali violatori (MLK. SKN e TM' MJ:INT), ben difficilmente essi possono venire intesi come le tre cariche più alte di Biblo, dal momento che abbiamo probabilmente a che fare con un'enumerazione stereotipa. Mentre non si dispone di alcun parallelo storico che possa suffragare tale ipotesi, andrà osservato che il SKN potrebbe anche essere un «governatore» per conto del re che opera al di fuori dello stato (72
). Quanto alle prerogative del re, niente nel testo allude alla limitatezza dei suoi poteri o suggerisce che egli avesse al contempo la carica di sommo sacerdote, fatto teoricamente possibile. ma che a Biblo non è attestato neanche negli altri documenti. Si veda in proposito l'iscrizione di BTN'M, dove infatti PLfB 'L, qualificato come «sacerdote della B 'L T» non è esplicitamente detto re.
Per quanto riguarda infine le ultime parole della maledizione. è sicuramente questione di cancellare l'iscrizione (YMJ:I SPRH), ma le difficoltà di lettura hanno finora impedito interpretazioni più dettagliate. Mentre l'ipotesi di vedere nell'ipotetico SBL una sorta di «raschietto» appare piuttosto remota ( 3
), ugualmente poco convincente appare la resa proposta da M. Dahood: «dall'inizio alla fine», basata su problematici confronti biblici C4
). Un recente riesame dovuto a J. Teixidor lo ha indotto a leggere LPN GBL ed a tradurre di conseguenza «davanti a Biblo», soluzione possibile, anche se non definitiva C5
).
Se nessuna divinità è menzionata nell'iscrizione di Al)irom, le altre epigrafi reali di Biblo ci lasciano in qualche modo verificare il rapporto tra i sovrani e mondo divino, confermandoci innanzitutto la preminenza della Baalat poliade, invocata o menzionata da Yel).imilk, Abibaal, Elibaal, Sipitbaal, dal «figlio di Sipitbaal», da Yel).awmilk, oltre a figurare sulla statua che la rappresenta C6
), sul modellino di trono con iscrizione bilingue greco-fenicia già ricordata (77) e su un frammento di coppa, che allude forse a riti di libagione effettuati nell'ambito del suo culto con questo stesso oggetto C8
).
È vero che Yel).imilk - sospetto usurpatore (non menziona la propria genealogia ed insiste sulla propria giustizia e rettitudine)- si rivolge nell'ordine a Baal Samem, alla Baalat di Biblo e all'«assemblea degli dèi santi di Biblo», ma quest'unica attestazione del «dio celeste» non è sufficiente a fare di lui l'esponente principe del pantheon cittadino. Il culto di questo dio dovette certo essere assai diffuso, in Fenicia come nel mondo punico posteriore, ma la sua presenza nel documento può spiegarsi variamente: da una preferenza devozionale
(1) Cf. già S. GEVIRTZ, West Semitic Curses and the Problem ofthe Origin of Hebrew Law: VT, 11 (1961),
pp. 137-58, in particolare p. 147.
C2) Cf. ad esempio il caso del SKN di ORTf:IDST, dipendente dal re di Sidone. menzionato nell'iscrizione
da Limassol KAI 31 (VIII secolo a. C.), o anche quello del SKN SR attestato a Kition in un 'iscrizione del IV-III sec. a.C. incisa su un sarcofago oggi perduto (IK F 6).
(3
) Cf. KAI II, p. 4 («ein Werkzeug»).
e4) M. DAHOOD, Phoenician-Hebrew Philology: Études sémitiques. Actes du XX!Xe Congrès international
des Orientalistes (Section organisée parA. Caquot). Paris 1975, pp. 5-8, in particolare pp. 5-6. Egli traduce l'espressione WH' YMf:l SPRH LPP SBL (senza preoccupazioni paleografiche) con <<And as for him, may a vagabond efface his inscription from beginning to end>>, analizzando LPP come LP «from end>> più P <<to end>> (rinviando a peh lapeh di 2 Re 10,21) ed attribuendo a SBL il senso ipotetico di <<vagabondo>>, con la presunzione che il termine afferisca alla stessa radice dell'ebr. sebfl <<Sentiero>>. L'assoluta ipoteticità della proposta è del tutto manifesta.
es) J. TEIXIDOR, L'inscription d'A~iram à nouveau: Syria, 64 (1987), pp. 137-40. In base alla fotografia a p. 139, sembra potersi accettare N di LPN. ma non vi sono chiari indizi in favore di un S per la terzultima lettera.
(6
) E. GUBEL-P. BORDREUIL: Semitica, 35 (1985). pp. 5-11.
(77
) Cf. supra, nota 10.
es) M. DUNAND, Fouilles, Il, Paris 1958, n. 19.047, p. 1055. su cui vedasi G. GARBINI. Note su alcune iscrizioni fenicie minori: RSF, 10 (1982), pp. 164-65.
206 P. Xella
di Yel)imilk stesso (forse proprio perché re non legittimo?), alla sua connessione con gli edifici restaurati dal re.
Nella lacunosa epigrafe del «figlio di Sipitbaal» compare una volta il nome di B'L 'DR, ma la presenza del teonimo va piuttosto spiegata col contesto di maledizione, in cui questa divinità ctonia era particolarmente adatta ad essere invocata.
Gli altri sovrani mostrano una devozione compatta ed esclusiva che difficilmente non riflette il ruolo di divinità poliade e dinastica della Signora di Biblo, cui tutti i re si affidano per ottenere lunga vita e protezione e le offrono statue, edifici o parti di essi.
All'ultimo secolo a. C. o agli inizi dell'era cristiana si data un'iscrizione gublita su altare, con dedica al «nostro signore» e all' «immagine di Baal» di due oggetti, che potrebbero essere dei brucia-incenso connessi con l'altare stesso ( 9
). Chi ne sono i destinatari? C'è chi ha pensato addirittura all'imperatore romano, ma SML B'L non può non richiamare immediatamente gli epiteti SM B'L e PN B'L, attribuiti rispettivamente ad Astarte (Ugarit, Sidone) e a Tinnit (nel mondo punico ). Sembra trattarsi di una divinità femminile, paredra del Baal in questione, così chiamata in virtù delle sue funzioni mediatrici, particolarmente efficaci perché le è consuetudinario il contatto col «Signore». Quanto a 'DN, va sottolineato che questa è l'unica volta che compare a Biblo (inclusi i teofori!), e non esistono ragioni né indizi per considerarlo un teonimo a sé stante. Come nel caso di SML B'L, si tratta di un epiteto che deve appunto riferirsi a B'L, in cui si potrebbe ravvisare la divinità poliade, quel particolare Baal di Biblo che i Greci caratterizzarono come Adonis.
Qualche ulteriore indizio sulle concezioni e gli usi funerari emerge inoltre dal corpus epigrafico gublita: oltre a ciò che si è detto di Al)irom, va menzionata l'iscrizione di Batnoam, con particolari sul tipo di deposizione funebre (80
), e l'iscrizione di età persiana in cui J. Starcky ha voluto riconoscere la presenza del mitico Og, re di Basan (81
). Il testo è molto frammentario e problematico, ma da esso risulta che il cadavere del personaggio era avvolto in mirra e bdellio e forse rivestito di un tessuto o veste ornata da lapislazzuli. Da un altro passo mutilo si può ancora dedurre che il personaggio va a raggiungere i suoi padri. Altre allusioni ad eventi personali e storici sono troppo frammentarie per venire prese in considerazione. Infine, semplici testimonianze mute di devozione sono altre brevi iscrizioni come quelle sui coni d'argilla o su altri frammenti ceramici che recano incisi nomi di persona (non tutti questi documenti, naturalmente, devono essere però considerati di carattere votivo).
* * *
Nell'ambito della nostra messa a punto, un'attenzione particolare merita l'iscrizione del re Yel)awmilk (V-IV secolo a.C.) (82
), la più lunga e la più dettagliata, che consente di farsi un'idea dell'architettura religiosa gublita.
Il testo, come è noto, è inciso su una stele calcarea che reca nella parte superiore una scena cultuale: sotto un sole alato il re di Biblo manifesta la propria adorazione verso la Baalat Gebal, assisa in trono e benedicente (83
). Parte della stele è stata ritrovata nel cortile
(9
) KAI 12. Cf. in seguito E. PuECH, Remarques sur quelques inscriptions phéniciennes de Byblos: RSF, 9 (1981), p. 163.
(80
) KAI 11. Cf. anche TSSI III, pp. 99-100.
(81
) J. STARCKY, Une inscriptionphénicienne de Byblos: MUSJ, 45 (1969), pp. 259-73. Cf. da ultimo TUAT II, 4 (1988), pp. 585-86. con bibliografia.
(82
) KAI 10. Cf. altresì TSSI III, pp. 93 ss.
( 83) Cf. E. GuBEL, Studia Phoenicia-Vll. Phoenician Furniture, Leuven 1987, pp.134-35 e passim (con esauriente bibliografia anteriore).
Pantheon e culto a Biblo 207
del santuario della Baalat Gebal e tale circostanza rende probabile la restituzione, alla linea 4, BJ:I[~R Z]N, «in questo cortile», a suo tempo proposta da A. Dupont-Sommer (84
).
Tutto il testo è imperniato sul rapporto, stretto e particolarissimo, che unisce il re e la Baalat poliade. È la dea, infatti, che ha fatto divenire re Yel)awmilk, che a lei si è rivolto ed è stato ascoltato (85). Il sovrano, pertanto, le dedica una serie di importanti opere nell'ambito del suo santuario in ringraziamento dei benefici ricevuti. La dea lo benedirà ulteriormente e gli concederà una lunga vita (lunga vita =benedizione divina), giacché Yel)awmilk è un re giusto (giustizia = virtù ricompensata dagli dèi). Da questa iscrizione, anche al di là dei rapporti tra il re e la Baalat, si può dedurre l'esistenza di una serie di valori etici: un retto comportamento viene ricompensato dall'alto.
La Baalat Gebal assicura al re, suo devoto, una protezione che si può definire «tridimensionale»: gli garantisce infatti, verso l'alto, la benevolenza degli dèi (ruolo di mediatrice), mentre, verso il basso, sarà presso il popolo, i suoi sudditi, che assicurerà a Yel)awmilk il favore; il terzo tipo di protezione divina si esplica, per così dire, orizzontalmente, cioè garantendo al sovrano anche il favore degli altri re.
Da questo testo emerge una sorta di «etica di governo» che, al di là dei sicuri intenti propagandistici, pare essere realmente stata alla base della monarchia gublita in quest'epoca. Un re diventa tale solo se assistito dal favore della divinità poliade; egli deve possedere e mettere in atto doti di giustizia e devozione; con l'aiuto della Baalat dovrà essere il baricentro di un equilibrio delicato che lo vede mediatore tra gli dèi - di cui deve godere i favori - ed il suo popolo, il cui atteggiamento viene implicitamente dichiarato importante per la regalità (nella realtà, forse, esso doveva contare assai meno). Il «buon governo» deve infine tenere conto dei rapporti con gli altri sovrani, che dovranno stimare e rispettare il re di Biblo.
Oltre a questi aspetti etico-politici e religiosi concernenti la regalità, l'iscrizione di Yel)awmilk apre un interessante squarcio sull'architettura religiosa urbana.
Si è già detto che ci si trova nel cortile del tempio della patrona cittadina. In esso si trova un portico a colonne, ricoperto da una sorta di tettoia; la stele iscritta (probabilmente è questo il senso di PTJ:I) si trova di fronte ad una costruzione (PTJ:I J:IR~) che ha in alto un architrave in pietra con un disco solare alato in oro. L'altare in bronzo doveva probabilmente trovarsi dentro tale costruzione o nelle sue immediate vicinanze (forse era prospiciente). G. Garbini (86
) ha proposto di riconoscere nel PTJ:I J:IR~ l'edicola, il sacello tipico dell'architettura religiosa fenicia. L'ipotesi è plausibile, anche se conviene qui pensare forse ad una cella o stanza incorporata nel complesso templare. Quanto al porticato ed alle colonne, l'iscrizione
o o v
menziona alla linea 6 WH'RPT Z' W'MDH WHK[x] RM 'S 'LHM WMSPNTH, cioè «que-sto portico e le sue colonne e i ( .. ? .. ) che sono sopra di essi e il suo tetto». Il termine lacunoso viene di solito restituito K[T]RM, col senso di «capitelli» (87
) o «appliques e n me tal» (88).
Tuttavia c'è da osservare che esiste un'altra possibile soluzione. In tempi recenti E. Gubel ha pubblicato una plaquette rettangolare in terracotta recante
una scena del tutto simile a quella rappresentata nella stele di Yel)awmilk. Il re rende omaggio alla Baalat, che si trova all'interno di un «bàtiment religieux», di cui riportiamo qui in sintesi la descrizione datane dall'A.: «Le bàtiment est posé sur une krépis à deux gradins; les deux colonnes, reposant sur le stylobate, sont tripartites. Leurs fùts ( ... ) s'épanouissent vers
(84
) A. DuPONT-SOMMER: Semitica. 3 (1950), pp. 35-44.
( 85) E. PuEcH: RSF, 9 (1981), p. 167, ha addirittura ipotizzato che l'iscrizione sia da porsi all'inizio del suo regno, «comme action de griìces à la divinité pour les bienfaits accordés>>.
( 86) G. GARBINI, Analisi di iscrizioni fenicie: AION, 37 (1977), pp. 403-408.
(87
) KAI, p. 14.
CS8) E. PUECH: RSF, 9 (1981), pp. 158 ss.
208 P. Xella
leurs bases, en forme de tambours troncoconiques d'inspiration néo-syrienne. En haut, ils s'amortissent dans des chapiteaux d'ordre ionique ( ... ).Il est possible qu'une couronne feuilletée assurait la transition entre ces éléments et les piliers. Dans le deux cas, l'abaque semble manquer ( ... ). De bas en haut, l'entablement comprend les éléments suivants: un dentelet, suivi de la frise de l'architrave décorée d'un disque ailé flanqué d'une paire d'uraei, la téte de chaque serpent étant munie d'un disque solaire de petite taille ( ... ). Au-dessus de l'architrave figurent un geison non décoré et une cyma ionique décorée d'ovicules. Deux lions couchés et adossés constituent les imposants acrotères du toit; entre ces animaux, on aperçoit les traces d'une puissante palmette à sépales bi e n étalées» (89
).
Lo studioso belga ricorda come, nei pressi della stele reale ed eseguite nel medesimo tipo di calcare, furono rinvenute a Biblo due statue di leoni, con una fenditura sul bordo, particolare che ne fa supporre con buone ragioni la loro antica utilizzazione come acroteri di un edificio, che potrebbe accostarsi a quello della placchetta sopra descritta. Se, nel testo dell'iscrizione, anziché K[T]RM si integra K[P]RM - restituzione che non incontra gravi ostacoli filologici (90
) - si avrebbe un ulteriore elemento in favore dell'interpretazione proposta.
In altri termini, si delinea una serie di elementi che convergono nell'indicare che l'edificio cultuale della placchetta e il PTJ:I J:IR~ dell'iscrizione siano la stessa cosa. Si tratterebbe dunque di un caso davvero eccezionale in cui dati testuali, archeologici (91 ) ed iconografici verrebbero a convergere, rivelandoci importanti particolari dell'architettura religiosa gublita . . m epoca persiana.
6. Un ultimo sguardo all'antroponimia (92), alla ricerca di elementi teoforici, conclude
questa rassegna. Il repertorio degli antroponimi attestati nei documenti gubliti - fenici e non -non va al di là di una cinquantina di formazioni nominali. Di queste, una dozzina compare su testi non fenici che risalgono ad epoche anteriori all'età del Ferro (si va dal *Ba'alat-rum del 2350 fino al Rib-Addi delle lettere di El-Amarna).
Anche per i nomi di persona attestati nelle iscrizioni fenicie si ha un ampio arco cronologico, che va dalla prima età del Ferro (nomi dei più antichi dinasti e quelli iscritti sui coni d'argilla) fino al 'BD'SMN del I sec. a.C./I d.C. che offre l'altare agli dèi, menzionando i due enigmatici oggetti detti J:INWTM C3
).
Pur nella consapevolezza della compressione cronologica e dell'appiattimento storico cui viene sottoposto tale repertorio (la cui costituzione è soggetta in buona parte alla casualità dei ritrovamenti), che ha una rappresentatività dai precisi limiti, vale forse la pena di operare una messa a punto senza eccessive pretese.
Per l'epoca antecedente all'età del Ferro, i non molti teofori (non registrati da fonti
(89
) E. GUBEL, Une nouvelle représentation du culte de la Baalat Gebal?: Studia Phoenicia-IV. Religio Phoenicia, cit. pp. 263-76, in particolare p. 273. Cf. altresì Io .. Studia Phoenicia-VII. Phoenician Furniture, cit., p. 110.
eo) Il termine «leone>> è in fenicio 'RW, mentre KPR ( «ieoncello>>) è attestato in Yaudico ed in Aramaico antico (DISO, s. v. kpru, p. 126). L'integrazione proposta non è priva di plausibilità, anche perché nell'onomastica fenicia è attestato un nome proprio KPR (F. L. BENZ, Personal Names in the Phoenician and Punic Inscriptions, Roma 1972, p. 334), sigillo da Tiro dell'VIII secolo con inciso LKPR: cf. P. BoRDREUIL, Catalogue des sceaux ouest-sémitiques inscrits de la Bibliothèque Nationale. du Musée du Lou1>re et du Musée Biblique de Bible et Terre Sainte, Paris 1986. pp. 35-35, no 24).
e1) Cf. P. WAGNER, Der iigyptische Einfluss auf die phonizische Architektur, Bonn 1980, pp. 16 ss.
(92
) Oltre ai repertori specifici, cf. in particolare F. IsRAEL, Osservazioni formali all' onomastica fenicia della madrepatria: ACFP l, pp. 663-72.
(93
) Cf. supra, nota 82.
Pantheon e culto a Biblo 209
fenicie) a noi noti attestano i nomi della Baalat e di Haddu, verosimilmente la coppia che si trovava al vertice del pantheon gublita durante l'età del Bronzo. Nel paredro della Signora deve certamente riconoscersi un Baal del II millennio, in ipotesi non molto dissimile dal Haddu di Aleppo o dal Baal di Ugarit. I confronti nell'area siriana, grazie soprattutto ai testi di Mari, Emar e Ugarit, non fanno difetto. Gli antroponimi documentano ancora Ilu(m)/El (se non si tratta del termine comune), dato che non sorprende, visto il ruolo assegnato a El-Kronos nella mitologia locale da Filone di Biblo. Figura ancora l'elemento 'B, {<padre», che tuttavia non è molto significativo.
Se si passa alla documentazione propriamente fenicia, con quasi 40 diverse formazioni nominali, si deve immediatamente rilevare l'assenza della Baalat. Tale circostanza però non deve assolutamente venir interpretata come un declino della dea, bensì si può spiegare con varie ragioni: l) inadeguatezza intrinseca del teonimo a figurare in un nome di persona; 2) possibilità concreta che si preferisse Astarte (rappresentata comunque a Biblo in un paio di antroponimi); 3) possibilità che la Ba ala t fosse soprattutto una divinità dinastica, legata alla casa regnante ed alla città nel suo complesso, sentita perciò come meno vicina nella devozione popolare.
Dal punto di vista quantitativo, predomina comunque nettamente Baal (una dozzina di attestazioni), certo il dio poliade, seguito da MLK (suo epiteto?: una mezza dozzina); una volta è attestato N'M, probabile epiclesi dello stesso Baal gublita (recepito dalla tradizione greca su Adonis). In epoca arcaica figura una volta l'elemento I:IMN (che ci riconduce alla tradizione posteriore concernente Ba al Hammon) e4
). Tre volte c'è El (di nuovo richiamo al ruolo del dio attestato nelle fonti più tarde e certo attendibili, a questo riguardo). In epoche tarde appaiono una volta Eshmun, Melqart e Iside. Altri nomi propri o non sono veri teofori, o sono ipocoristici generici.
Andrà notata en passant l'assenza di Rasap, presunto titolare di un antico tempio urbano (cf. supra), ed insieme dell'elemento 'DN: circostanza, quest'ultima, che suona come un'ulteriore conferma del suo carattere di {<epiteto» del Baal poliade.
Questo quadro, pur con i limiti più volte sottolineati, si accorda con quanto sembra fosse la realtà cultuale di Biblo, che è possibile così sintetizzare schematicamente:
l) supremazia della coppia Baalat (divinità dinastica)/ Baal poliade (erede dei Baal del II millennio);
2) discreto ruolo di El, probabilmente dio-creatore e padre delle «attuali» generazioni divine;
3) presenza di altre figure divine, che rivelano un pantheon articolato, certo non del tutto dissimile da quello delle altre città fenicie, ma avente peculiarità proprie notevoli, con un forte e persistente influsso egiziano.
7. Le conclusioni di questo riesame possono sembrare, e di fatto sono, minimali e poco soddisfacenti, ma è assai più saggio ammettere i limiti obiettivi delle proprie conoscenze, che dare libero sfogo a fantasie pericolose, cui devono tra l'altro ascriversi ipotesi infondate ma tuttora popolari come quelle delle <{triadi» cittadine, inesistenti storicamente e naturalmente assenti anche a Biblo. Se tuttavia si pensa ai progressi che, negli ultimi decenni, hanno contrassegnato gli studi fenicio-punici ed in particolare quelli sulla religione, non si può non esprimere, tendenzialmente, un moderato ottimismo sul futuro delle nostre ricerche. Ciò, si spera, varrà anche per una città come Biblo, un po' dimenticata dai moderni rispetto a Tiro e Sidone, vero e proprio {{crocevia» di civiltà, la cui cultura ed i cui resti archeologici meritano ben più che la rovina e l'oblio.
e4) Cf. P. XELLA, Baal Hammon. Recherches sur l'identité et thistoire d'un dieu phénico-punique, Roma 1991.
APPENDICE
l. IL CORPUS EPIGRAFICO DI BIBLO
Si dà qui di seguito un elenco dei materiali epigrafici fenici di Biblo, indicando innanzitutto le iscrizioni comprese in KAI; le altre saranno menzionate in base all'anno dell'editio princeps, cui si aggiungerà il rinvio ad altre raccolte o, secondo i casi, si segnalerà qualche studio importante o recente. Tra le abbreviazioni usate si notino in particolare le seguenti:
FB I e II = M. DuNAND, Fouilles de Byblos, 1-11, Paris 1939-1954; PECKHAM = B. PECKHAM, The Development ofthe Late Phoenician Scripts, Cambridge (Mass.), 1968; VATTIONI, SF: F. VATTIONI, I sigilli fenici: AION, 41 (1981), pp. 177-93.
l. KAI l: iscrizione del re Al)irom es); 2. KAI 2: graffito della tomba di Al)irom e6
);
3. KAI 3: spatola di bronzo e7);
4. KAI 4: iscrizione del re Y el)imilk es); 5. KAI 5: iscrizione del re Abibaal (figlio di Yel)imilk?) e9
);
6. KAI 6: iscrizione del re Elibaal (figlio di Yel)imilk) e00);
7. KAI 7: iscrizione del re Sipitbaal I (figlio di Elibaal) e01);
8. KAI 8: iscrizione di 'Abdo e02);
9. KAI 9: iscrizione del re figlio di Sipitbaal e03);
10. KAI 10: iscrizione del re Yel)awmilk (104);
11. KAI 11: iscrizione di Batno'am e05);
12. KAI 12: iscrizione di 'Abdesmun su altare (106);
13. Bollo su ansa d'anfora CH. VIROLLEAUD: Syria, 5 (1924), p. 119 (107);
14. Iscrizione su frammento di zoccolo in serpentina FB I, no 1111, pp. 25-26; 15. Iscrizione su frammento di vaso in marmo FB l, no 1112, p. 26; 16. Iscrizione su frammento di stele in calcare FB I, no 1144, p. 33;
e5) TSS/ III, n° 4, pp. 12-16; CHR. BurrERWECK: TUAT Il, 4, 1988, pp. 582-83.
( 96) TSS/ III, n° 5, p. 17; S. M. CECCHINI: UF, 13 (1981), pp. 27-31; CHR. BUTTERWECK: TUAT Il, 4, 1988, pp. 582-83.
(97
) TSSI III, no l, pp. 9-11.
es) TSSI III, no 6, pp. 17-19; H.-P. MDLLER: TUAT Il, 4, 1988, p. 584.
C9) TSSI III, n° 7, pp. 19-21.
e00) TSSI III, no 8, pp. 21-22.
C01) TSS/ III, no 9, pp. 23-24; CHR. BurrERWECK: TUAT Il, 4, 1988, pp. 584-85.
C02) TSSI III, no 10, p. 24.
C03) E. PuEcH: RSF, 9 (1981), pp. 153-58.
( 104) TSS/III, no 25, pp. 93-99; E. PUECH: RSF, 9 (1981), pp. 158-62; CHR. BuTTERWECK: TUA T II, 4, 1988, pp. 586-87.
C05) TSS/ III, no 26, pp. 99-100; CHR. BuTTERWECK: TUAT Il, 4, 1988, pp. 588-89.
C06) E. PUECH: RSF, 9 (1981), p. 163.
( 107) PECKHAM, pp. 50-51, nota 23.
Pantheon e culto a Biblo
17. «Cachet scarabéoi'de» in ematite FB I, no 1291, p. 48 e08);
18. Ansa di recipiente FB I, no 1331, p. 91; 19. Frammento di recipiente in terracotta FB I, n° 1450, p. 95 (109
);
20. Iscrizione su placca in calcare FB I, no 1452, pp. 95-96 e10);
21. Sigillo FB I, no 1610, p. 107 e11);
22. Sigillo FB I, no 1708, p. 113 (112);
23. Frammento di «tuyau» FB l, no 2927, pp. 186-87 e13);
24. Frammento d'ansa FB l, no 3317, p. 226 (114);
25. Fondo di coppa FB I, no 8237, p. 182; 26. Sigillo FB II, no 6915, p. 123 (115
);
27. Cono FB II, no 7765, p. 144 (116).
28. Sigillo FB II, no 8472, p. 194 e17);
29. Frammento di cono FB II, no 9400, p. 280; 30. Bollo su giara FB II, no 10193, p. 345; 31. «Tronco di piramide» FB II, no 1:469, p. 368; 32. Frammento di cono FB II, no 10470, p. 368; 33. Cono FB II, no 11.671, p. 466-67; 34. Cono FB II, no 11.687, p. 468 (118
);
35. Coccio FB II, no 13872, p. 631; 36. Statuetta metallica FB II, no 15477, pl. CX; 37. Iscrizione su frammento di piatto in terracotta FB II, no 15683, p. 792. 38. Frammento di stele FB II, no 18026, p. 977; 39. Coccio FB II, no 18690, p. 1024; 40. Frammento di giara FB II, no 18813, p. 1034; 41. Iscrizione su piatto in terracotta FB II, no 18989, p. 1049. 42. Frammento di coppa a vernice nera FB Il, no 19083, p. 1059 (119
);
43. Coppa a vernice nera FB II, 1958, no 19047, p. 1055 e20);
44. Coccio FB II, no 19082, p. 1059; 45. Frammento di piatto d'alabastro FB II, no 19.197, p. 1070; 46. Iscrizione su frammento di sarcofago ( «Byblos 13») (121
);
47. Inscrizione «Champlevée» e22).
e08) VATIIONI, SF no 59, p. 187; PECKHAM, pp. 50-51, nota 23.
(109
) PECKHAM, p. 51, nota 23.
e10) PECKHAM, p. 51, nota 22.
(lll) VATIIONI, SF no 60, p. 187.
(112
) VATIIONI, SFn° 61, p. 187.
e13) Cf. PECKHAM, pp. 50-51 (nota 22); A. LEMAIRE: Syria, 62 (1985), pp. 31-32.
(114
) PECKHAM, p. 51, nota 22.
(115
) V ATIIONI, SF no 62, p. 188.
(116
) Cf. F. M. CRoss-P. K. McCARTER: RSF, l (1973). pp. 3-8; TSSJ III, no 2, p. 12. ( 117) VATIIONI SF no 63, p. 88.
( 118) F. M. CRoss-P. K. McCARTER: RSF, l (1973), pp. 3-8; TSSI III, no 3, p. 12.
(119
) Cf. G. GARBINI: OrNS, 29 (1960), p. 322.
(120
) Cf. G. GARBINI: RSF, 10 (1982), pp. 164-65.
211
(121
) J. STARCKY: MUSI, 45 (1969), pp. 257-73; cf. da ultimo CHR. BUTIERWECK: TUAT Il, 4, 1988 pp. 585~6. '
(122
) P. BORDREUIL: Semitica, 27 (1977), pp. 23-27.
212 P. Xella
48. Iscrizione sulla statua della Baalat Gebal e23);
49. Iscrizione (bilingue fenicio-greca) sul trono della Baalat Gebal e24);
INCERTE
- Ansa FB I, no 1446, pl. CXXXII; - Bollo su piatto FB I, no 2324, p. 157; - Placchetta in calcare FB I, no 6033, p. 399 (??); - Anfora dipinta di rosso FB II, l, n° 17872, p. 965.
Leggende monetali e25)
'LP' L 'ZB'L (figlio di PLTB'L e BTN'M) 'DRMLK 'YN'L
Il. NOMI ED ELEMENTI DIVINI NELL'ONOMASTICA DI BIBLO
Baal 'BB'L 'LB'L 'RSTB'L 'TB'L HRB'L *ZKRB'L YJ:IRB'L 'ZB'L 'ZRB'L PLTB'L SPTB 'L/Sipittibi'li *'gl.: 'Aglu/'Eglija ('kr/'k3i) e26
)
Ilu/El 'LP'L 'LRS['?) 'YN'L Iakin-ilum
( 123) E. GUBEL-P. BORDREUJL: Semitica, 35 (1985), pp. 5-11.
C24) P. BORDREUIL-E. GUBEL: Syria, 62 (1985), pp. 182-83.
(125
) FB I, nn. 6091-6210; 6226-6256; FB Il, nn. 6292-6307; 16409-16467. Cf. in generale J. ELAYI, Le monnayage de Byblos avant Alexandre: problèmes et perspectives: Transeuphratène, l (1989), pp. 9-20.
C26) Questo NP semitico («il vitello») può riferirsi a Baal. Esso richiama anche il toponimo egiziano 'gny,
nel III Nomo dell'Alto Egitto, territorio sacro ad Hathor, assonanza che potrebbe aver giocato un ruolo secondo P. MONTET, Quatre nouvelles inscriptions hiéroglyphiques trouvées à Byblos: Kemi, 17 (1964), p. 63.
Iblulum e27) ( = Abilulum ?)
Ili-rapil} e28)
MLK 'DRMLK *'RMLK (Urumilki) YI:IWMLK YI:IMLK *MLK'SP (Milkiasapa)
'B Abi-semu Iapi-semu-abi
'1;1 'I:I'M (o 'I:I'S) 'I:IRM
Astarte 'STR<T?>HN ['STR ?]TYTN
Iside 'S"
Es hm un 'BD'SMN
Baalat Ba'alat-nlm e29
)
DD Ibdati (130
)
Haddu Rib-Addi
I;IMN 'BDHMN
Mel q art GRMLQRT
Pantheon e culto a Biblo 213
(127
) Titolare del sigillo che lo menziona, dove si definisce ~~3-bswt di Biblo, amato dal <<Ra dei paesi stranieri e da KhaitaU>>. Sui problemi di traduzione del testo, cf. supra.
e28) È incerto se qui sia da riconoscere il teonimo <<El>>.
e29) Padre del titolare del sigillo.
(130
) Cf. Amar-Suena 4/V/6' e 4/V/9: ib-da-ti énsi ku-ub-lak\ D. OwEN-R. WEENKER, MeGum, the First Ur III Ensi of Ebla: L. CAGNI (ed.), Ebla 1975-1985, Napoli 1987, pp. 179-80 (dove si troveranno i riferimenti relativi). Anche questo epiteto potrebbe riferirsi, come n'm, al Baal poliade.




























![E]E!DH - RERO DOC](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63233b14f3cd44b80906ba12/eedh-rero-doc.jpg)