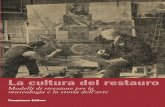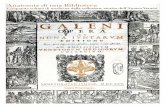MATERIALI LIBARNESI E TORTONESI DELLA COLLEZIONE SANTO VARNI AL MUSEO CIVICO DI ARCHEOLOGIA LIGURE
La necropoli di Monte Sirai - I (= Collezione di Studi Fenici, 41), Roma 2000.
Transcript of La necropoli di Monte Sirai - I (= Collezione di Studi Fenici, 41), Roma 2000.
ISTITUTO PER LA CIVILTÀ FENICIA E PUNICA "SABATINO MOSCAIT'
•
•
•
•
••
•
113
82
LA
• • •
•
•
• •
•
•
•
ConsiJ?lio Nazionale delle Ricerche
• •
o o o o 8 g
Q
• • •
PIERO BARTOLONI
1-1 l
.. •
•
COLLEZIONE DI STUDI FENICI, 41
LA NECROPOLI DI MONTE SIRAI - I
2000 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
ROMA
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA PER LE PROVINCE DI CAGLIARI E ORISTANO
ISTITUTO PER LA CIVILTÀ FENICIA E PUNICA
«SABATINO MOSCATI»
LA NECROPOLI DI MONTE SI I - I
di PIERO BARTOLONI
Con il contributo di
Sandro Filippo Bondì - Lorenza Campanella - Debora Martini Emanuela Solinas - Carlo Tronchetti
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
ISTfl'UTO PER LA CIVILTÀ FENICIA E P UNICA
«SABATINO MOSCATI»
SOMMARIO
ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI ••••• l l ••• •• l •••••• • ••••••••••••••••••••••••• • l ••••• •••• • •• •• •••• ••••• ••••• •
INTRODUZIONE •••••••••••••••• l •••••• l ••••••• •••• l l •••• •• •••••• ••••••• l.' •••••••••••••••••• ' •• ••••••••••••••••••••••••••••••
PARTE PRIMA
IL NOME E LA POSIZIONE GEOGRAFICA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Il topo n imo ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
La struttura geologica •••• ~ ••••••••••••• l l •••• ••• ••••••••• •• l • ••• •••••••••••••• •• • ' •••• •• ••••• •••••••••••••• • •••••••
STORIA DELL'INSEDIAMENTO ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• ••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••• l' ••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• • ~ ••••••••••••• l ••••••• •• •••••••••••••••••• •• l •••••••••• La preistoria L'età nuragica L'età fenicia L'età p unica
••••••••••••••••••••• l ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• t' ••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••• l ••••• l • •••••••••••••• l' • •• •••••••••••••• l' •• ••• ~ •••••••••• l l.' • ••••• • ••••••••••• l t l •••••• • • l •••••• ••• •
•••••••••••••• ••• •.•••••••• •• ••••••• • ••..•• •••• •••••••••••.•• ••••••• • ••• •• t.' ••••••••••••••••••••••••••••••••••
L'età neo-punica o romana •••• ' •••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••• ••• •••••••••••••••• l ••• ~ •••••••••••• • ••••••
STORIA DEGLI SCAVI E DEGLI STUDI •••• l •••••••••••••••••• l ••••••••••••••••• l. l •••• ••• l •••••• •• •••
IL CENTRO ABITATO ••••••••••• l •••••••••••••••••••••••• ••••• ••••••••••••••••••• t''' .•••••••••••••••••••••••••••••••
Le vze di accesso t'.' ••••••••••••••• t •• ' •••••••• •• •••• •• • ' .' ••••••• ••• • •••• l. ' .....•••••....•••••.•...••.•..•..••.•..•.
L'Opera avanzata ·······························································••t•••·································· L'Acropoli Il Mastio
••••••••• t ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
.......................................................................... ,,, ...................................... .. L'abitato •••••••••••• t ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ' l' •• ••••••••••••• ' ••••• ••••••• • ••••••• l •••••••••••••••••••••••••••
PARTE SECONDA
LE NECROPOLI . . . . . . . . . . . . . . . . . l t . . . . . . . . . . . . . . . . . l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . • . t • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
La necropoli fenicia • ••••• •••••••••••••••••••••••••••• l' ••• • •• t ••••••• l l l.'.' • •••••••• ••• ••• l l' •••••••••••••••••• l ••••
Il rito dell 'incinerazione ' Il rito dell'inumazione zn
' m età fenicia età fenicia
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • t • • • • • • • • • • • • • • • • • • t • • ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•• ' ••••••• l •••••••••• ' ••••••••••••••••••••••••• •••• •••••••••••••••••••
La necropoli punica ···················································••ttlt••······································· La struttura delle tombe ipogee •••••••••••••••••••••••••••• ' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• t •••
La necropoli dei bambini ····························· ··············· ·············•••t ••· ····· ···················· Il • rtto de Il' inumazione ' zn ' ' eta pumca ...................................... ... ..............................
La necropoli neo-punica ••••••••• l •• •••• •••••• ••• •••••• ••• ••••••• ••• ••••••••••••••• ' •••••••••••••••••••••••••••••••
IL TOFET ··················································································1·················1·················
PARTE TERZA
LE TOMBE ...................•........•............•................ , ...................................... 111111•••··········
l • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • l • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • t • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • La tipo/o g ia cronologia La ····························································································l···············
I CORREDI ···························································································•l•t•••···· ············· LA TIPOLOGIA •••••••••• •••• •••• •••••••••••••••• ••• ••••• •••••• ••• •••••••••••••••• ' •••••••••••••••••••••••••••••••••• l •••••
Pag. 9
» 25
» 31 » 31 » 32 » 35 » 35 » 36 » 39 » 41 » 44 » 47 » 53 » 53 >> 55 » 56 » 57 » 60
» 67 » 67 » 68 » 70 » 72 » 73 » 75 » 76 » 77 >> 79
83 » 83
86
» 89 » 93
LE FORME APERTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 97 LE FORME CHIUSE . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. >> l 07 LA CERAMICA DI IMPORTAZIONE (di Carlo Tronchetti) .................................. » 117 I GIOIELLI (di Lorenza Campanella) ....... ................... ................................... ..... .. .. .. » 1 19 GLI AMULETI (di Debora Martin i) . .. .. .. . .. .. . .. . . . . .. . .. .. .. .. . . . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . . . .. . .. . . .. . . .. .. . . . . » 127 GLI SCARABEI (di San dro Filippo Bondì) ........... .. .................... ....... ...................... » 131
CONCLUSIONI ................................. ..................... .... ..................... ................................ >> 133
TABELLA CRONOLOGICA I . . . . . . .................. .. ...... ....... ....... .... .................. .. ... .... ....... » 135 TABELLA CRONOLOGICA II ................................................. .......... ...................... . » 137
ELENCO DELLE CONCORDANZE •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• » 139
PARTE QUARTA
CATALOGO (di Emanuela Solinas) • • • • • • t • • • • • • • • • • • • l • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' • • • • • • • ' » 143
ELENCO DELLE FIGURE • • •••••••••••• •• •••••• • •••••••••••• •• •••••• • • ••• •• ' •••• ••• •••••••• ••• •••• • l • •••• •• ' •••••• >> 195
ELENCO DELLE TAVOLE ... . . . .................. .. ................... . .......... .......... .. .. ....... .. ....... ... » 197
ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI
Riviste, Collezioni, Raccolte e Congressi
A
ACFP l
ACFP 2
ACFP 3
AEA AHA ALUB ASKW
ASSa AUC AVO BAA BAAL BArch BArte
BEFAR BiAr CAFP Carbonia 1995
CdB Chronology
CIS
CMO CRHA
CSF
----
--
--
--
------------
--
---
--------
Archaeolo gica.
Atti del I Congresso Internazionale di Studi Fenici e Punici, Roma, 5-10 novembre 1979, Roma 1983.
Atti del II Congresso Internazionale di Studi Fenici e Punici, Roma, 9-14 novembre 1987, Roma 1991.
, Actes du IIr Congrès International d'Etudes phéniciennes et pu-niques, Tunis 11-16 novembre 1991, Tunis 1995. Archivo Espafiol de Arqueologfa.
Anna/es d'Histoire et d'Archéologie. Anna/es Littéraires de l'Université de Besançon. R. RoLLE-K. S c HMIDT (edd.), Archiiologische Studien in Kontaktzonen der antiken Welts (= Veroffentlichung der Joachim JungiusGesellschaft der Wissenschaften Hamburg, 87), Gottingen 1998. Archivio Storico Sardo. Anales de la Universidad de Cadiz. Altertumskunde des Vorderen Orients. Bulletin d'Archéologie Algérienne. Bulletin d 'Archéologie et d 'A rchitecture Libanaises.
Bollettino di Archeologia. Bollettino d'Arte.
, Bibliothèques des Eco/es Françaises d'Athènes et de Rome. Biblioteca di Archeologia. Corpus delle Antichità Fenici e e Punì che. AA.VV., Carbonia e il Sulcis. Archeologia e territorio, Oristano 1995. Cahiers de Byrsa. M. S. BALMUTH-R. H. TYKOT (edd.), Sardinian and Aegean Chronology Towards the Resolution of Relative and Absolute Dating in the Mediterranean (= Proceedings ofthe International Coloquium «Sardinian Stratigraphy and Mediterranean Chronology», Tufts University, Medford, Massachusetts, March 17-19, 1995), Oxford 1998. Corpus Inscriptionum Semiticarum.
Collection de la Maison de l'Orient Méditerranéen. Centre de Recherches d ' Histoire Ancienne.
Collezione di Studi Fenici.
lO
Cuccureddus
DCPP
EPRO
EVO
Fenici 1995
KTU
MAL
MANL
MDAI(R)
ME FRA
MF
MM
MMNT
Monte Sirai - I
Monte Sirai - II
Monte Sirai - Il/
Monte Sirai - IV
Monte Sirai 1992
NBAS
ND
NSc
OrA n
P!W
Phoinikes
QuadCagliari
PCFP
RAMadrid
RANL
REPPAL
--
--
--
----
--
------
--
--------
--
--
--
--------
----
--
--
-
------
Elenco delle abbreviazioni
L. A. MARRAs-P. B ARTOLONI-S. M oscATI, Cuccureddus: RANL, 42 (1987), pp. 225-48.
Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, Bruxelles 1992. ,.
Etudes préliminaires aux religions orientales dans l'Empire Romain.
Egitto e Vicino Oriente.
I Fenici: ieri oggi domani. Ricerche, scoperte, progetti, Roma, 3-
5 marzo 1994, Roma 1995. M. DIETRICH-0. L o RETz-J. SANMARTIN, Die keilalphabetischen Te
xte aus Ugarit (AOAT 2411), Neukirchen-Vluyn 1976. Monumenti Antichi dell'Accademia Nazionale dei Lincei.
Memorie dell 'Accademia Nazionale dei Lincei.
Mitteilungen des Deutschen Archiiologischen Institut Romische Abteilung.
Melanges d'Archéologie
Rome ( Antiquité).
Madrider Forschungen.
.1'
et d 'Histoire de l 'Ecole Française de
Madrider Mitteilungen.
Materiali del Museo Nazionale di Tarquina.
Monte Sirai - l. Rapporto preliminare della campagna di scavi 1963 ( = StSem, Il), Roma 1964.
Monte Sirai - Il. Rapporto preliminare della campagna di scavi
1964 (= StSem, 14), Roma 1965. Monte Sirai - III. Rapporto preliminare della campagna di scavi
l 965 ( = StSem, 20), Roma 1966.
Monte Sirai - IV. Rapporto preliminare della campagna di scavi l 966 ( = StSem, 25), Roma 1967.
Monte Sirai ( = Itinerari, 9), Roma 1992.
Nuovo Bullettino Archeologico Sardo.
Notes et Documents.
Atti dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Notizie degli Scavi di
Antichità.
Oriens Antiquus.
H. G. NIEMEYER (ed.), Phonizier im Westen (= MB, 8) Mainz
1982. P. BERNARDINJ-R. D'ORlANo-P. G. SPANu (edd.), Phoinikes b Shrdn.
l Fenici in Sardegna. Nuove acquisizioni, Catalogo della Mostra,
Oristano 1997. Quaderni della Soprintendenza Archeologica per le Province di
Cagliari e Oristano.
Pubblicazioni del Centro di Studio per la Civiltà f enicia e • punzca.
Revista de Arqueologia.
Rendiconti dell'Accademia Nazionale dei Lincei.
Revue du Centre d' Etudes de la Civilisation Phénicienne-punique
et des Antiquités Libyques.
RPARA
RSO
RScPr
RStAn
RStFen
SEAP
SeAr
Sardinia
Studi Moscati 1996
StPu
StSem
TAA
Tharros 1987
Tell Keisan
T MAl
Trans
Libri e articoli
AcQUARO 197 5
AcQUARO 1977
AcQUARO 1982
AcQUARO 1988
ACQUARO 1989
AcQUARO 1992
AMADASl 1966
AMADASI 1967
AMADASI- BRANCOLI 1965
AMIRAN 1970
--
--------------
--
------
--
----
--
--
--
--
--
--------
--
Elenco delle abbreviazioni ll
Rendiconti della Pontificia Accademia Romana di Archeolo-• gza.
Rivista degli Studi Orientali.
Rivista di Scienze Preistoriche.
Rivista Storica dell'Antichità.
Rivista di Studi Fenici.
Studi di egittologia e antichità puniche.
Serie Archeologica.
R. H. T YKOT-T. K. ANDREWS (edd.), Sardinia in the Mediterranean: A Footprint in the Sea. Studies in Sardinian Archaeology Presented to Miriam S. Balmuth, Sheffield 1992.
Alle soglie della classicità. Il Mediterraneo tra tradizione e innovazione. Studi in onore di Sabatino Moscati, 1-111, Pisa-Roma 1996.
Studia Punica.
Studi Semitici.
The Athenian Agora.
R. D. BARNETT-C. MENDLESON (edd.), Tharros. A Catalogue of Materia! in the British Museum from Phoenician and Other Tombs at Tharros, Sardinia, London 1987.
J. BRIEND-J.-B. HuMBERT (edd.), Tell Keisan ( 1971-1976). Une cité phénicienne en Galilée, Paris 1980. Trabajos del Museo Arqueologico de /biza.
Transeuphratène.
E. A cQUARO, Gli amuleti: E. AcQuARo -S. MoscATI-M. L. UBERTI,
Anecdota Tharrhica (= CSF, 5), Roma 1975, pp. 73-93.
lo., Amuleti egiziani ed egittizzanti del Museo Nazionale di Cagliari (= CSF, 10), Roma 1977.
Io., lA collezione punica del Museo Nazionale «Giovanni Antonio Sanna» di Sassari. Gli amuleti (= RStFen, IO [1982], suppl.).
ID., Gli insediamenti fenici e p unici in Italia ( = Itinerari, 1 ), Ro
ma 1988, pp. 66-70.
ID., Scavi al tofet di Tharros. Le urne dello scavo Pesce - I (= CSF, 29), Roma 1989.
Io., I gioielli punici di Tharros: Sardinia, pp. 424-28.
M. G. AMADASI , L'abitato: Monte Sirai - 111, pp. 83-103.
EAo., La zona C: Monte Sirai - IV, pp. 55-93.
M. G. AMAOASI-1. BRANCOLI, La necropoli: Monte Sirai - Il, pp. 95-121.
R. AMIRAN, Ancient Pottery of the Holy Land from its Beginnings in the Neolithic Period to the End of lron Age, New Brunswick 1970.
12
ANDERSON 1988
AUBET 1994
BADRE 1997
BARRECA 1964
BARRECA 1965 a
BARRECA 1965 b BARRECA 1965 c BARRECA 1966 a BARRECA 1966 b
BARRECA 1967
BARRECA 1970
B ARRECA 197 4
BARRECA 1978
BARRECA 1979
BARRECA 1981
BARRECA 1982
BARRECA I 983
BARRECA 1983-1984
BARRECA 1984 a
B ARRECA 1984 b
B ARRECA 1985 a
B ARRECA 1985 b
B ARRECA 1986
BARRECA-BONDÌ 1980
BARTOLONI 1965
B Ain'OLONl 1971
--
--
--
----------------
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
----
----
Elenco delle abbreviazioni
W. P. ANDERSON, Sarepta l. The Late Bronze and /ron Age Strata of Area II, Y, Beyrouth 1988.
M. E. AusET, Tiro y las colonias fenicias de Occidente, Barcelona
1994.
L. B AORE, Bey 003 Preliminary Report. Excavation of the American University of Beirut Museum: BAAL, 2 (1997), pp. 6-94.
F. BARRECA, Gli scavi: Monte Sirai - /, pp. 11-63.
Io., Descrizione generale: Monte Sirai - Il, pp. 13-17.
Io., L 'acropoli: Monte Sirai - /1, pp. 19-62.
Io., Confronti e conclusioni: Monte Sirai - Il, pp. 63-78.
lo., Il mastio: Monte Sirai - l/1, pp. 9-48.
Io., Topografia dell'acropoli: Monte Sirai - III, pp. 49-54.
Io., Il mastio: Monte Sirai - IV, pp. 7-25.
Io., Ricerche puniche in Sardegna: Ricerche puniche nel Mediterraneo centrale (= StSem, 36; PCFP, 6), Roma 1970, pp.
21-37.
Io., La Sardegna fenicia e punica (= Storia della Sardegna antica
e moderna, 2), Sassari 1974.
Io., Le fortificazioni fenicio-puniche in Sardegna: Atti del 1° Con
vegno Italiano sul Vicino Oriente antico, Roma 22-24 aprile
1976, Roma 1978, pp. 115-28.
Io., La Sardegna f enicia e p unica ( = Storia della Sardegna antica e moderna, 2), Sassari 19792•
Io., La Sardegna e i Fenici: Ichnussa. La Sardegna dalle origini all'età classica, Milano 1981 , pp. 350-417.
lo., Stato attuale della ricerca sulla Sardegna fenicio -punica: Stato attuale della ricerca storica sulla Sardegna (= ASSa, 33), Ca
gliari 1982, pp. 57-71.
Io., L'archeologia fenicio -punica in Sardegna. Un decennio di at
tività: ACFP l, pp. 291-310.
Io., Gli eserciti annibalici: RStAn, 13-14 (1983-84), pp. 43-
68.
Io., Carbonia (Cagliari), loc. Monte Sirai: E. ANATI (ed.), l Sardi.
La Sardegna dal paleolitico alt' età romana, Milano 1984, pp.
46-49.
Io., Venti anni di scavi a Monte Sirai: NBAS, l (1984), pp.
143-57.
Io., Fenici e Cartaginesi in Italia. L 'archeologiafenicio-punica in Sardegna: BArte, 31-32 (1985), pp. 57-95.
Io., Recenti scoperte in Sardegna: RStFen, 13 (1985), pp.
265-67.
Io., La civiltà fenicio-punica in Sardegna, Sassari 1986.
F. BARRECA-S. F. B o Noì, Scavi nel tofet di Monte Sirai, campagna 1979: RStFen, 8 (1980), pp. 143-45.
P. BARTOLONI, Il villaggio: Monte Sirai - II, pp. 135-37.
Io., Fortificazioni puniche nel Mediterraneo: Cultura e Scuola, 37
(1971), pp. 193-98.
BARTOLONI 1973 a
BARTOLONI 1973 b
BARTOLONI 1979
BARTOLONI 1981 a
BARTOLONI 1981 b
BAirn)LONI 1982 a
BARTOLONI 1982 b
BARTOLONJ 1982 c
BARTOLONt 1983 a
B ARTOLONI 1983 b
BARTOLONI 1985 a
BARTOLONI 1985 b
BARTOLONr 1987 a
B ARTOLONI 1987 b
BARTOLONI 1987 c
B ARTOLONI 1987 d
BARTOLONI 1988 a
BARTOLONI 1988 b
BARTOLONI 1988 c
B ARTOLONI 1988 d
BARTOLONI 1989 a
B ARTOLONI 1989 b
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
----
Elenco delle abbreviazioni 13
Io., Gli amuleti punici del tofet di Sulcis: RStFen, l (1973), pp. 181-203.
Io., Necropoli puniche della costa nord-orientale del Capo Bon: AA.VV., Prospezione archeologica al Capo Bon - I(= CSF, 2), Roma 1973, pp. 9-68.
lo., Due anfore greco-orientali di imitazione fenicia dal Sulcis: OrAn, 18 (1979), pp. 323-27.
Io., Contributo alla cronologia delle necropoli f enicie e puniche di Sardegna: RStFen, 9 (1981), suppl., pp. 13-29.
Io., Monte Sirai 1980: La ceramica vasco/are: RStFen, 9 (1981), pp. 223-30.
Io., Contributo alla cronologia della fortezza fenicia e punica di Monte Sirai: Archéologie au Levant. Recueil à la mémoire de Roger Saidah (= CMO, 12), Lyon 1982, pp. 265-70.
lo., Monte Sirai 1981. La ceramica del tofet: RStFen, IO (1982), pp. 283-90.
Io., Monte Sirai 1981. La necropoli (campagna 1981): ibid., pp. 291-94.
Io., Studi sulla ceramica f enicia e punica di Sardegna (= CSF, 15), Roma 1983.
Io., Monte Sirai 1982. La necropoli (campagna 1982): RStFen, 11 (1983), pp. 205-17.
Io., Monte Sirai 1984. La necropoli (campagne 1983 e 1984): RStFen, 13 (1985), pp. 247-63. ID., Nuove testimonianze arcaiche da Sulcis: NBAS, 2 ( 1985), pp. 167-92.
Io., La tomba 54 della necropoli arcaica di Monte Sirai: QuadCagliari, 411 (1987), pp. 153-59.
Io., Le relazioni tra Cartagine e la Sardegna nei secoli VII e VI a.C. : EVO, lO (1987), pp. 79-86. Io., La tomba 2 AR della necropoli di Sulcis: RStFen, 15 (1987),
pp. 57-73. Io., La ceramica f enicia: Cuccureddus, pp. 237-44.
Io., Tracce di coltura della vite nella Sardegna fenicia: Stato Economia Lavoro nel Vicino Oriente antico, Milano 1988, pp. 410-13.
lo., La necropoli di Monte Sirai (Carbonia): L 'Antiquarium arborense e i civici musei archeologici della Sardegna, Sassari 1988, pp. 224-31.
ID.~ Urne cinerarie arcaiche a Sulcis: RStFen, 16 (1988), pp. 165-79. ID., Le anfore f enicie e puniche di Sardegna (= StPu, 4), Roma
1988.
Io., Sulcis (= Itinerari, 3), Roma 1989.
Io., La civiltà fenicia e p unica. La cultura materiale e l 'epigrafia: Il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, Sassari 1989, pp.
155-78.
14
BARTOLONI 1989 c
BARTOLONI 1989 d
BARTOLONI 1990 a
BARTOLONI 1990 b
B ARTOLONI 1991
BARTOLONI 1992 a
BARTOLONI 1992 b BARTOLONT 1992 C
BARTOLONI 1992 d
BARTOLONI I 992 e BARI'OLONI 1992 f
BARTOLONI 1992 g
BARTOLONI 1992 h BARTOLONI 1994 a
BARTOLONJ 1994 b
BARTOLONI 1995 a
BARTOLONI 1995 b
BARTOLONI 1995 c
BARTOLONI 1996
BARTOLONI 1997 a
BARTOLONI 1997 b
BARTOLONI 1998
BARTOLONI c.d.s. a
BARTOLONI c.d.s. b
BARTOLONI-GARBINI 1999
BARTOLONl-MOSCATI 1995
--
----
--
----
----------
--
----
--
--
--
--
----
----
--
--
--
--
Elenco delle abbreviazioni
Io., Riti funerari fenici e punici nel Sulcis: Riti funerari e di olocausto nella Sardegna fenicia e punica (= QuadCagliari, 6 [ 1989], suppl. ), pp. 67-81.
Io., Monte Sirai (= Guide e itinerari, 10), Sassari 1989. Io., Monte Sirai: genesi di un insediamento: Incontro «I Fenici», Cagliari 1990, pp. 31-33.
Io., S. Antioco: area del Cronicario (campagne di scavo 1983-86). I recipienti chiusi d'uso domestico e commerciale: RStFen, 18 (1990), pp. 37-80.
Io., Nell'acropoli di Monte Sirai: Archeo, 72 (1991), p. 19.
Io., L'insediamento fenicio e punico di Monte Sirai: Sardegna antica, 2 (1992), pp. 20-21. Io., Itinerario: Monte Sirai 1992, pp. 9-12.
Io., L'insediamento: ibid., pp. 27-35.
Io., L'acropoli: ibid., pp. 37-45.
Io., Le necropoli: ibid., pp. 47-54.
Io., Recipienti rituali fenici e p unici dalla Sardegna: RStF e n, 20 ( 1992), pp. 123-42. Io., Nora l. Nota su due frammenti di bacino di tipo fenicio-cipriota: QuadCagliari, 9 (1992), pp. 99-I 03.
IQ., Lucerne arcaiche da Sulcis: Sardinia, pp. 419-23. Io., L'impianto urbanistico di Monte Sirai nell'età repubblicana: <<L'Africa romana>>, Atti del X Convegno di studio, Oristano 11-13 dicembre 1992, Sassari 1994, pp. 817-29.
Io., Monte Sirai l. Gli scavi del 1990-92: RStFen, 22 (1994), pp. 75-82. Io., L'insediamento di Monte Sirai nel quadro della Sardegna fenicia e punica: ACFP 3, pp. 99-108.
Io., Le linee commerciali all'alba del primo millennio: Fenici 1995, pp. 245-59.
Io., L'insediamento fortificato di Monte Sirai: Carbonia 1995, pp. 203-21.
Io., La necropoli di Bitia - I ( = CSF, 38), Roma 1996.
Io., L'insediamento fenicio -punico di Bitia: Phoinikes, pp. 81-84, 254-63.
Io., Monte Sirai: ibid., pp. 85-89, 264-65.
Io., La tomba 88 della necropoli arcaica di Monte Sirai: ASKW, pp. 353-58. Io., Il santuario di Su Campu 'e sa domu: Studi in memoria di Luigi Cagni, c.d.s.
Io., La ceramica punica della necropoli di Tuvixeddu: tipologia e cronologia: Studi in memoria di Giovanni T ore, Cagliari, c.d.s.
P. BARTOLONI-G. GARBINI, Una coppa d 'argento con iscrizione punica da Sulcis: RStFen, 27 ( 1999), pp. 79-91.
P. BARTOLONr- S. 'MoscATI, La ceramica e la storia: RStFen, 23 (1995), pp. 37-45.
BARTOLONI- TRONCHEITI
1981
B ARTOLONI-B oNoì-MoscATI
1997
BENICHOU-SAFAR 1982
BENICHOU-SAFAR 1995
BENICHOU- SAFAR 1996
BEN Y OUNES I<RANDEL
1995
B ERNARDINI 1988 a
B ERNARDINI 1988 b
B ERNARDINI 1989 a
BERNARDJNI 1989 b
BERNARDU\"1 1990
BERNARDINI 199 1 B ERNARDlNI 1996
BERNARDINI 1997
BrKAI 1978
BIKAI 1987
BISl 1970
Brsr 1971
BIST 1977
BtSI 1986-1987
BONDÌ 1970
BONDÌ 1972
BoNoì 1975 a
BoNoì 1975 b
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
----
--
--
--
--
--
--
--
Elenco delle abbreviazioni 15
P. BARTOLONI-C. TRONCHEITI, La necropoli di Nora (= CSF, 12),
Roma 1981.
P. B ARTOLONI-S. F. B oNDì-S. M oscATI, La penetrazione fenicia e punica in Sardegna. Trent'anni dopo (= MANL, IX, 9).
H. B ENICHOU-SAFAR, Les tombes puniques de Carthage, Paris
1982.
EAo., Les phénico-puniques et la mort: mise en perspective des recherches: Fenici 1995, pp. 95-105.
EAD., De la fonction des bijoux phénico-puniques: Studi Moscati 1996, pp. 523-34.
A. BEN Y ouNES KRANDEL, Le thème du banquet funéraire sur une hachette rasoir punique: REPPAL, 9 (1995), pp. 109-13.
P. B ERNAROINI, L'insediamento fenicio-punico di Monte Sirai (Carbonia-CA): Museo Villa Sulcis, Cagliari 1988, pp. 45-55.
lo., S. Antioco: area del Cronicario (campagne di scavo 1983-86). L'insediamento fenicio: RStFen, 16 (1988), pp. 73-89.
Io., Le origini di Sulcis e Monte Sirai: SEAP, 4 ( 1989), pp.
45-66.
Io., Sant'Antioco (Cagliari), Abitato fenicio e necropoli punica di Sulcis: BArch, 3 (1 989}, pp. 149-52.
Io., S. Antioco: area del Cronicario (campagne di scavo l 983-86). La ceramica f enicia: forme aperte: RStFen, 18 (1990), pp.
81-89.
In., l gioielli di Sulci: QuadCagliari, 8 (1991), pp. 191-206.
Io., Le origini della presenza fenicia in Sardegna: tipologie di insediamento e cronologia: Studi Moscati 1996, pp. 535-47.
Io. , La necropoli fenicia di San Giorgio di Portoscuso: Phoinikes, pp. 55-58.
P. M. BIKAI, The Pottery of Tyre, Wanninster 1978.
EAo., The Phoenician Pottery of Cyprus, Nicosia 1987.
A. M. BISI, La ceramica punica. Aspetti e problemi, Napoli
1970.
EAD, Lilibeo (Marsala).- Nuovi scavi nella necropoli punica ( 1969-1970 ): NSc, 1971, pp. 662-762.
EAD., La collezione di vasi cartaginesi del Museo di Bruxelles: RStFen, 5 (1977}, pp. 23-50.
EAo., Le origini della statuaria nel mondo coloniale f enicio. Per una riconsiderazione della «Astarte» di Monte Sirai: AUC, 3-4 (1986- 1987), pp. 107-21.
S. F. BoNoì, Una stele inedita da Monte Sirai: OrAn, 9 (1970), pp.
355-58.
Io., Le stele di Monte Sirai (= StSem, 43; PCFP, 12), Roma
1972.
lo., Gli scarabei di Monte Sirai: Saggi Fenici - l (= CSF, 6), Roma 1975, pp. 73-98.
Io., L'espansione cartaginese in Italia: Cultura e Scuola, 56
(1975), pp. 66-74.
16
BoNoì 1975 c
BoNoì 1975 d
BoNOÌ 1978
BoNol 1980 a
BoNol 1980 b
BoNoì 1981
BONDÌ 1982
BoNDl 1983
BONOÌ 1984
BoNol 1985
BoNoì 1987
BoNol 1988 a
BoNol 1988 b
BONDÌ 1989
BoNot 1992 a
BoNDl 1992 b BoNot 1992 c BoNoì 1995 Borro 1993
BoTro 1994
Borro 1996 BRIESE-DOCTER 1992
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--------
--
---
Elenco delle abbreviazioni
lo., Ricerche fenicie a Roma. 1963-1975: Bibbia e Oriente, 17
(1975), pp. 173-85. Io., Osservazioni sulle fonti classiche per la colonizzazione della
Sardegna: Saggi Fenici - I (= CSF, 6), Roma 1975, pp.
49-66. Io., Monte Sirai: un caposaldo fenicio nell'entroterra sardo: Anti
qua, 9 (1978), pp. 22-28.
lo., Nuove stele da Monte Sirai: RStFen, 8 (1980), pp. 51-
70. In., Monte Sirai, un insediamento punico nell'entroterra sardo:
RPARA, 51-52 (1978-79, 1979-80), pp. 171-94. Io., Monte Sirai 1980. Lo scavo nel tofet: RStFen, 9 (1981), pp.
217-22. In., Monte Sirai 1981. Lo scavo nel tofet: RStFen, 10 (1982), pp.
273-81. In., Monte Sirai 1982. Lo scavo nel tofet: RStFen, Il (1983), pp.
193-203. lo., Monte Sirai 1983. Lo scavo nel tofet: RStFen, 12 (1984), pp.
185-98. Io., Monte Sirai nel quadro della cultura fenicio-punica di Sarde
gna: EVO, 8 (1985), pp. 73-89. ID., Monte Sirai 1985. Lo scavo nel tofet (campagne 1984 e
1985): RStF e n, 15 (1987), pp. 179-90.
Io., Il tofet di Monte Sirai-Carbonia: L'Antiquarium arborense e i
civici musei archeologici della Sardegna, Sassari 1988, pp.
231-34. lo., La frequentazione precoloniale fenicia. La colonizzazione fe
nicia. La dominazione cartaginese. Le sopravvivenze puniche nel
la Sardegna romana: Storia dei Sardi e della Sardegna, l. Dalle
origini alla fine dell'età bizantina, Milano 1988, pp. 129-211,
436-49. Io., Nuovi dati sul tofet di Monte Sirai: Riti funerari e di olocausto
nella Sardegna fenicia e punica (= QuadCagliari, 6 [1989], sup
pl.), pp. 23-43. lo., Storia degli scavi e degli studi: Monte Sirai 1992, pp.
13-18. Io., La storia: ibid., pp. 19-26. Io., Il tofet: ibid., pp. 55-60. ID., Il tofet di Monte Sirai: Carbonia 1995, pp. 223-38. M. Borro, Anfore fenicie dai contesti indigeni del Latium Vetus nel periodo orientalizzante: RStFen, 21 (1993), suppl., pp.
15-27. In., Monte Sirai l. Analisi del materiale anforico relativo alle
campagne di scavo 1990 e 1991: RStFen, 22 (1994), pp.
83-115. Io., Le armi: BARTOLONI 1996, pp. 137-44. C. BRIESE-R. DocTER, Der Phonizische Skyphos: Adaption einer
Griechischen Trinkschale: MM, 33 (1992), pp. 25-69.
BucHNER-RIDGWAY 1993
CAMPANELLA 1999
CAMPANELLA c.d.s.
CASALIS 1833-1856
CECCHINI 1965 CECCHINI 1971
CECCHINI 197 6
CECCHINI 1991
CHAMBON 1980 CIASCA 1991 CINTAS 1951
CINTAS 1954
CINTAS 1970 Cocco 1991
CuucAN 1980
DI STEFANO 1993 DoTHAN-PORATH 1982
DouMET-BoRDREUIL 1982
EL AziFI 1995
FADDA 1998
FANTAR 1986
FANTAR 1993
FANTAR 1966 FANTAR 1967 FERNANDEZ-PADR6 1986
--
--
--
--
----
--
--
------
--
----
--
----
--
--
--
--
--
------
Elenco delle abbreviazioni 17
G. BucHNER-D. RmawAY, Pithekoussai l. La necropoli: Tombe 1-723 scavate dal 1952 al 1961 ( = MAL, 55), Roma 1993. L. CAMPANELLA, Ceramica punica di età ellenistica da Monte Sirai (== CSF, 39), Roma 1999. EAD., Necropoli fenicia di Monte Sirai. Il contesto della tomba 90: Atti del Primo Congresso Internazionale Sulcitano «La ceramica fenicia di Sardegna. Dati, problematiche, confronti», Sant'Antioco, 19-21 settembre 1997 (== CSF, 40), Roma c.d.s. G. CAsAus, Dizionario geografico, storico, statistico, commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino 1833-1856, p. 349. S. M. CECCHINI, Il «tophet»: Monte Sirai - Il, pp. 123-33. EAD., Per un 'identificazione di Monte Sirai: Or An, l O (1971), pp.
183-87. EAD., Una sfinge in osso da Monte Sirai: RStFen, 4 (1976), pp.
41-48. EAD., La statua dell'acropoli di Monte Sirai: ACFP 2, pp.
683-89. A. CHAMBON, Le niveau 5: Tell Keisan, pp. 157-79. A. CIASCA, Note moziesi: ACFP l, pp. 617-22. P. CINTAS, Deux campagnes de fouille à Utique: Karthago, 2 (1951), pp. 5-88. ID., Nouvelles recherches à Utique: Karthago, 5 (1954), pp. 89-154. ID., Manuel d'archéologie punique - /, Paris 1970. D. Cocco, Museo« Villa Sulcis»: Guida alla visita dei Musei locali e regionali della Sardegna, Cagliari 1991, pp. 132-35. W. CuucAN, Phoenician lncense Stands: Orientai Studies: Essays Presented to B. S. J. lsserlin, Leiden 1980, pp. 85-101. C. A. DI STEFANO, Li/i beo p unica, Marsala 1993. M. DoTHAN-Y. PoRATH, Ashdod IV. Excavation of Area M ( = 'Atiqot, 15), Jerusalem 1982. C. DouMET-P. BoRDREUIL, Les tombes IV et V de Rachidieh. Deux épigraphes phéniciennes de Tell Rachidieh: AHA, l ( 1982), pp. 89-148. M. R. EL AztFI, Les nécropoles de la région de Tanger sont-elles phéniciennes: ACFP 3, pp. 417-21. M. A. FADDA, Nuovi elementi di datazione dell'Età del Bronzo Medio: Lo scavo del Nuraghe Talei di Sorgono e della tomba di giganti Sa Pattada di Macomer: Chronology, pp. 179-93. M. FANTAR, Kerkouane. Cité punique du Cap Bon (Tunisie ), III, Tunis 1986.
' In., A propos d'un livre sur Carthage: RStFen, 21 (1993), suppl., pp. 75-86. M. e D. FANTAR, La nécropole: Monte Sirai - III, pp. 63-81. lm., La zone B: Monte Sirai - IV, pp. 27-54. J. H. FERNANDEz-J. PADR6, Amuletos de tipo egipcio del Museo Arqueologico de lbiza (= TMAI, 16), Eivissa 1986.
18
FERRARI 1994
FRAU-MONTICOLO 1990
FRus JoHANSEN 1957
GALLET DE SANfERRE-SLIM
1983 GARBINI 1964 a
GARBINI 1964 b
GARBINI 1965 GARBINI 1966
GARBINI 1992 GAUCKLER 1915 GHARBI 1995
GJERSTAD 1948
GoRTON 1996
GRAS 1974
GRAS 1985
GRAS 1993
Guzzo AMADASI 1967
HARDEN 1937
HoLBL 1986 a
HùLBL 1986 b
HouRs-MIÉDAN 1951
J OHANSSON 1994
KARAGEORGHIS 1977
--
--
--
--
----
----
------
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Elenco delle abbreviazioni
D. FERRARI, Gli amuleti del tofet: SEAP, 13 (1994), pp. 8~-
115. M. FRAU-R. MoNTICOLO, Sulcis. Guida archeologica, Firenze
1990. K. FRns JoHANSEN, Exochi. Ein Friihrhodisches Griiberfeld: Acta Archaeologica, 28 (1957), pp. 1-192. H. GALLEr DE SANTERRE-L. SLIM, Recherches sur les nécropoles puniques de Kerkouane, Tunis 1983. G. GARBINI, I monumenti figurati: Monte Sirai - I, pp. 65-99. Io., Sul toponimo sardo «Sirài»: Archivio Glottologico Italiano, 49 (1964), pp. 77-79. Io., L'iscrizione punica: Monte Sirai - Il, pp. 79-92. Io., Documenti artistici a Monte Sirai: Monte Sirai - III, pp. 107-26. Io., Magomadas: RStFen, 20 (1992), pp. 181-87. P. GAUCKLER, Nécropoles puniques, I-II, Paris 1915. M. GHARBI, Laforteresse punique et son territoire: réjlexion sur la présence punique en Sardaigne et en Tunisie: ACFP 3, pp. 71-82. E. GJERSTAO, The Cypro-geometric, Cypro-archaic and Cyproclassical Periods (= The Swedish Cyprus Expedition, 4), Stoc
kholm 1948. A. F. GoRTON, Egyptian and Egyptianizing Scarabs. A Typology of Steatite, Faience and Paste Scarabs from Punic and other Mediterranean Sites (= Monograph, 44), Oxford 1996. M. GRAS, Les importations du vr siècle avant J.-C. à Tharros (Sardaigne). Musée de Cagliari, Antiquarium Arborense d'Oristano: MEFRA, 86 (1974), pp. 79-139. Io., Trafics tyrrhéniens archai·ques ( = BE FAR, 258), Roma
1985. Io., Monte Sirai: G. NENCI-G. VALLET (edd.), Bibliografia topografica della colonizzazione greca in Italia e nelle isole tirreniche, 12, Pisa-Roma 1993, pp. 37-40. M. G. Guzzo AMADASI, Le iscrizioni fenicie e p uniche delle colonie in Occidente (= StSem, 28), Roma 1967, pp. 122-23. D. B. HAROEN, The Pottery from the precinct of Tanit at Salammbo, Carthage: Iraq, 4 (1937), pp. 59-89. G. HoLBL, Agyptisches Kulturgut im Phonikischen und Punischen Sardinien (= EPRO, 102), Leiden 1986. lo., Egyptian fertility magie within Phoenician and Punic culture: A. BoNANNO (ed.), Archeology and Fertility Cult in the Ancient Mediterranean, Amsterdam 1986, pp. 197-205. M. HouRs-MIÉDAN, Les représentations figurées sur les stèles de Carthage: CdB, l (1951), pp. 15-76. L. JoHANSON, Fenicier och kartager pa berget Monte Sirai: Medusa, 3 (1994), pp. 22-28. V. l<.ARAGEORGHIS, Two Cypriote Sanctuaries of the End of the Cypro-Archaic Period (= PCFP, 17; SeAr, 22), Roma 1977.
Elenco delle abbreviazioni 19
KBIRI ALAOUI-L6PEZ PARDO = M . KBIRI A LAOUI-F. L6PEZ PARDO, La factorfa fenicia de Mogador
1998 (Essaouira, Marruecos). Las ceramicas pintadas: AEA, 71 (1998), pp. 5-25.
KuRTZ-BoARDMAN 1971
LANCEL 1987
LANCEL 1992
LEHMANN 1996
LrLLIU 1993
LILLIU 1995
MAASS-LINDEMANN 1982
MARRAS 1981
MARRAS 1982
MARRAS 1991
MARRAS 1992 a
MARRAS 1992 b
MARRAS 1992 c
MARRAS 1993
MARRAS 1995
MARRAS 1998
MAR1iN Rmz 1995
MAITHIAE SCANDONE 197 5
MELONI 1988
MELONI 1990
MENDLESON 1987
--
--
----
--
--
-
--
--
--
--
--
--
--
----
D. C. KuRrZ-1. BoARDMAN, Greek Burial Custom, London
1971.
S. LANCEL, La céramique punique d'époque hellénistique: P. L É
v~QUE-1. P. MoREL (edd.), Céramiques hellénistiques et romaines
Il (=ALUB, 331; CRHA, 70), Paris 1987, pp. 99-137.
Io., Carthage, Paris 1992.
G. LEHMANN, Untersuchungen zur spiiten Eisenzeit in Syrien und Libanon (=AVO, 5), Mtinster 1996.
C. LILLIU, Un culto di età Punico-Romana al nuraghe Genna Ma
ria di Villanovaforru: Genna Maria, II, l . Il deposito votivo del
mastio e del cortile, Cagliari 1993, pp. 11-39.
G. LILLIU, Preistoria e protostoria del Sulcis: Carbonia 1995, pp. 11-50.
G. MAAss-LINDEMANN, Toscanos. Die westphonikische Niederlassung an der Mundung des Rfo de Vélez. Lieferung 3: Grabun
gskampagne 1971 und die importdatierte westphOnikische Grab
keramik des VII.- VIli. Jhs. v. C h r. ( = M F, 6), Berlin 1982.
L. A. MARRAS, Saggio di esplorazione stratigrafica nell'acropoli
di Monte Sirai: RStFen, 9 (1981), pp. 187-209.
EAo., Monte Sirai 1981. La ceramica di imitazione dalla necropoli: RStFen, l O (1982), pp. 295-96.
EAo., Nota su un frammento di matrice fittile da Monte Sirai:
QuadCag li ari, 8 (1991 ), pp. 171-7 4. EAo., Il Museo Archeologico «Villa Sulcis» di Carbonia: Monte
Sirai 1992, Roma 1992, pp. 97-100.
EAo., l materiali di Monte Sirai nel Museo Nazionale di Cagliari:
ibid.' pp. 75-78.
EAo., Nota su una tazza carenata dalla necropoli ad incinerazione
di Monte Sirai: RStFen, 20 (1992), pp. 179-80.
EAo., Una mano fittile da Monte Sirai: QuadCagliari, 10 (1993),
pp. 97-100.
EAo., La Collezione Pispisa: Carbonia 1995, pp. 439-54.
EAo., Il museo archeologico di Carbonia ( = Guide e Itinerari, 24), Sassari 1998.
1. A. MARrtN Rurz, Catalogo documentai de los Fenicios en Anda
lucia, Sevilla 1995.
G. MAITHIAE ScANDONE, Scarabei e scaraboidi egiziani ed egittiz
zanti del Museo Nazionale di Cagliari ( = CSF, 7), Roma 1975.
P. MELONI, La Sardegna e la repubblica romana: L'età imperiale.
La romanizzazione: Storia dei Sardi e della Sardegna, I. Dalle
origini alla fine dell'età bizantina, Milano 1988, pp. 213-95.
lo., La Sardegna romana, Sassari 19902•
C. MENDLESON, Amulets: Tharros 1987, pp. 108-17.
20
MERLIN-DRAPPIER 1909
MoREL 1981
MoscATI 1964
MoscATI 1966 MoscATI 1967
MoscATI 1968 MoscATI 1971 a
MoscATI 1971 b
MoscATI 1972 a
MoscATI 1972 b
MoscATI 1972-1973
MoscATI 1973 a
MoscATI 1973 b
MoscATI 197 4
MoscATI 197 5
MoscATI 1976
MoscATI 1977
MoscATI 1979 a
MoscATI 1979 b
MoscATI 1980
MoscATI 1981
MoscATI 1982
MoscATI 1983 a
MoscATI 1983 b
MoscATI 1986
--
--
--
----
------
--
--
--
-
--
--
--
--
--
----
----
--
--
--
--
Elenco delle abbreviazioni
A. M ERLIN-L. DRAPPIER, La nécropole punique d'Ard el-Kheraib. à Carthage (= ND, 3), Paris 1909. J.-P. MoREL, Céramique campanienne. Les formes (= BEFAR, 244), Roma 1981.
S. M oscATI, Il simbolo di Tanit a Monte Sirai: RSO, 39 (1964), pp. 1-5. lo., Il mondo dei Fenici, Milano 1966. Io., Quattro anni di scavi a Monte Sirai: Monte Sirai - IV, pp. 95-100. Io., Fenici e Cartaginesi in Sardegna, Milano 1968. Io., M onte Sirai: Italia sconosciuta, Milano 1971, pp. l 02-11. Io., La via dei Fenici: Civiltà sul Mediterraneo, Novara 1971. ID., l Fenici e Cartagine (= Società e costume, 8), Torino
1972. Io., Fenici e Cartaginesi in Italia: Magna Graecia, 7 (1972), pp. 1-4. Io., Figurine puniche nei paesi mediterranei: RPARA, 45 (1972-
1973), pp. 13-28.
Io., Centri artigianali fenici in Italia: RStFen, l (1973), pp. 37-52. Io., Civiltà punica: Italia Archeologica, I, Novara 1973, pp. 150-221. Io., Monte Sirai: una fortezza cartaginese in Sardegna: Le Scienze, 67 (1974), pp. 76-82. Io., Les Phéniciens en Occident: A. PARROT-M. H. CHÉHAB-S. Mo
SCATI, Les Phéniciens. L' expansion phénicienne. Carthage (= L'univers des formes, 23), Paris 1975, pp. 145-257.
lo., L'expansion phénico-punique dans la Méditerranée occidentale: Proceedings of the 2nd International Congress of Studies on Cultures of the Western Mediterranean, I, Algiers 1976, pp. 9-33. Io., I Cartaginesi in Italia (= Saggi, 89), Milano 1977, pp. 228-45.
ID., Il Bes di Monte Sirai: RANL, 34 (1979), pp. 233-39. lo., Le basi militari di Cartagine: <PtÀtaç xaQtV, Miscellanea di studi classici in onore di Eugenio Manni, V, Roma 1979, pp. 1593-1601. In., Il mondo punico, Torino 1980. lo., Una figurina fittile da Monte Sirai: RStFen, 9 (1981), pp. 19-20. Io., Monte Sirai 1981. Una testa a rilievo in pietra da Monte Sirai: RStFen, 10 (1982), pp. 297-99. Io., Monte Sirai 1982. Un secondo quadriennio di scavi a Monte Sirai: RStFen, 11 (1983), pp. 183-91.
Io., Monte Sirai 1982. Un rilievo su pilastro a Monte Sirai: RStFen, 11 (1983), pp. 219-22. ID., Italia punica, Milano 1986.
MoscATI 1988 a
MoscATI 1988 b
MoscATI 1993
MoscATI 1995
MoscATI 1996
MoscATI-PEscE 1964
MoscATI-PESCE 1965
MuREoou 1998
NAJIM 1996
NEWBERRY 1907
PAORO PARCERISA 1981
PAULIS 1986
PERRA 1998
PESERJCO l 994
PESERICO 1996
PICARO 1976
PICARD 1978
PIERRO 1984
PISANO 1985
PISANO 1987
PISANO 1988
PISANO 1994
'
--
--
----
--------
--
--
--
--
--
--
--
--
------
Elenco delle abbreviazioni 21
lo., La scoperta di Monte Sirai: RANLl 43 (1988), pp. 167-72.
Io., I gioielli di Tharros. Origini, caratteri, confronti (= CSF, 26), Roma 1988.
lo., Il tramonto di Cartagine, Torino 1993.
lo., Fenici e Cartaginesi nel Sulcis-Iglesiente: Carbonia 1995, pp. 187-90. lo., Artigianato a Monte Sirai (= StPu, 10), Roma 1996.
S. MoscATI-G. PESCE, Introduzione: Monte Sirai - I, pp. 7-10.
IID., Introduzione: Monte Sirai - II, pp. 7-9.
A. MuREoou, La geologia di Monte Sirai. Considerazioni evolutive e paleoambientali: RStFen, 26 (1998), pp. 21-29.
A. NAJIM, Tharros XXIII. Les brule-paifums à coupelles superpo
sées de Carthage et de Tharros: essai de comparaison: RStFen,
24 (1996), suppl., pp. 61-73.
P. E. NEWBERRY, Scarab-shaped Seals (= Catalogue général des " Antiquités Egyptiennes du Musée du Caire, nn. 36001-37521),
London 1907.
J. PADRO PARCERISA, Las divinidades egipcias en la Hispania Romana y sus precedentes: La religion romana en Hispania, Madrid 1981, pp. 335-51. G. PAuus, Osservazioni toponomastiche sul sostrato preromano
della Sardegna: Società e cultura in Sardegna nei periodi orienta
lizzante ed arcaico (fine VIII sec. a. C. - 480 a. C.). Rapporti fra Sardegna, Fenici, Etruschi e Greci:· Atti del 1° Convegno di studi
«Un millennio di relazioni fra la Sardegna e i Paesi del Mediterraneo~>, Selargius-Cagliari, 29-30 novembre 1985, 1° dicembre
1985, Cagliari 1986, pp. 17-21.
C. PERRA, L'architettura templare fenicia e punica di Sardegna: il problema delle origini orientali, Oristano 1998.
A. PESERICO, Monte Sirai l. La ceramica fenicia: le forme aperte:
RStF en, 22 (1994 ), pp. 117-44. EAo., Le brocche «a fungo» fenicie nel Mediterraneo: Tipologia e
cronologia ( = CSF, 36), Roma 1996.
C. PICARO, Les représentations de sacrifice molk sur les ex-voto de
Carthage: Karthago, 17 (1976), pp. 67-138.
EAo., Les représentations de sacrifice molk sur les stèles de Car
thage: Karthago, 18 (1978), pp. 5-116.
E. PIERRO, Ceramica 'ionica' non figurata e coppe attiche a figure
nere (= MMNT, 6; A, 33), Roma 1984. G. PISANO, Nuovi studi sull'oreficeria tharrense: RStFen, 13 (1985), pp. 189-210.
EAo., Jewellery: Tharros 1987, pp .. 78-95.
EAo., I gioielli fenici e punici in Italia, Roma 1988.
EAo., L'art orfèvrerie: V. KRINGS, La civilisation phénicienne et
punique: manuel de recherche, Leiden - New York - Kolri 1994, pp. 494-500.
22
PoNSICH 1967 _ --
QuATIROCCHI PISANO 1974 --
QUILLARD 1979 --
QUILLARD 1987 --
RAMON ToRRES 1995 --
REDISSI 1991 --
RIBICHINI-XELLA 1994 --
RoDERO RIAZA 1980 --
RomLLARD 1990 --
RoVERI 1963 --
RuANO Rmz 1995 --
RuANO Rmz 1996 --
RuANo Rmz 1997 --
RuANO Rmz-HoFFMAN-RIN- = C6N 1995
SANDER HANSEN 1956
SANTONI 1986
SAPIN 1998
SEQUI 1985 SoRDA 1966
SPARKES-TALCOTI 1970
--
--
--
----
--
Elenco delle abbreviazioni
M. PoNSICH, Nécropoles phéniciennes de la région de Tanger, Tanger 1967. G. QuATIRoccHI PISANO, I gioielli fenici di Tharros nel Museo Nazionale di Cagliari (= CSF, 3), Roma 1974. B. QmtLARD, Bijoux carthaginois. I. Les colliers, Louvain-la-Neu
ve 1979.
EAo., Bijoux carthaginois. Il. Porte amulettes, sceaux-pendentifs, pendants, boucles, anneaux et bagues, Louvain-la-Neuve
1987. J. RAMON ToRRES, Las anforas fenicio-punicas del Mediterraneo centrai y occidental, Barcelona 1995.
~
T. REorssi, Etude de quelques amulettes puniques de type egypti-sant: REPPAL, 6 (1991), pp. 95-139. S. RIBICHINI-P. XELLA, La religione fenicia e punica in Italia(= Itinerari, 14), Roma 1994.
A. RoDERO RIAZA, Colecci6n de ceramica punica de lbiza en el Museo Arqueol6gico Nacional, Madrid 1980.
P. RomLLARD, Phéniciens et Grecs à Toscanos. Note sur quelques vases d'inspiration Gréco-géométrique de Toscanos ( 1967): MM, 31 (1990), pp. 178-85.
M. A. RovERI, Nut: Enciclopedia dell'Arte Antica, V, Roma 1963, p. 610.
E. RuANO Rmz, Cuentas policromas prerromanas decoradas con «ojos»: Espacio, Tiempo y Forma. Serie Il, Historia Antigua, 8 (1995)~ pp. 255-84. EAo., Las cuentas de vidrio prerromç~.nas del Museo Arqueol6gico de Ibiza y Formentera (= TMAI, 36), Ibiza 1996. EAD., Las cuentas de c oliar: Vidrios del Puig des Molins ( Eivissa). La colecci6n de D. José Costa «Picarol>> (= TMAI, 37), lbiza
1997. E. RuANO Rmz-P. HoFFMAN-J. Ma. RINCON, Aproximaci6n al es tudio del vidrio prerromano: los materiales procedentes de la necropolis ibérica de El Cigarralejo (Mula, Murcia). Composici6n qu{mica de varias cuentas decollar: Trabajos de Prehistoria, 52 (1995), pp. 189-206.
C. E. SANDER HANSEN, Die Texte der Metternichstele, Copenhague
1956. V. SANTONI, Ceramica fenicia dal nuraghe Sirai di Carbonia (CA): RStFen, 14 (1986), pp. 181-84.
J. SAPIN, Mortaria. Un lot inédit de Tell Keisan. Essai d'interprétation fonctionnelle: Trans, 16 (1998) (= Mélanges Jacques Briend, 3), pp. 87-120.
M. SEQui, Nuraghi, Milano 1985, pp. 94-95. S. SoRDA, Catalogo delle monete rinvenute ne/1964: Monte Sirai - III, pp. 127-32. B. A. SPARKES-L. TALCOTI, Black and Plain Pottery of the 6th, 5th and 4th centuries b.C. (= TAA, 12), Princeton 1970.
T ARAMELLI 191 o
TARAMELLI 1912
ToRE 1983
ToRE 1986
ToRE 1989
ToRE 1992 ToRE 1995
TRONCHETTI 1988
TRONCHETII 1989 a
TRONCHETII 1989 b
TRONCHETI'I 1996
TusA 1972
TusA 1974
TusA 1978
U BEIITI 1971
UBERTI 1975
UBEIITI 1977
UBERTI 1978
UBERTI 1985
UBERTJ 1993
UGAS-LUCIA 1987
--
--
--
--
--
----
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Elenco delle abbreviazioni 23
A. TARAMELLI, Il nuraghe Lugherras presso Paulilatino: MAL, 20
(1910), coll. 153-234. Io., La necropoli punica di Predio lbba a S. Avendrace, Cagliari (scavi del 1908): MAL, 21 (1912), coll. 45-223. G. T oRE, I bronzi figurati fenicio-punici in Sardegna: ACFP l, pp.
449-61.
Io., Osservazioni sulle fortificazioni puniche in Sardegna: La fortification dans l' histoire du monde grec, Paris 1986, pp. 221-
27. Io., La civiltà fenicia e punica. Categorie artistiche e artigianali: Il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, Sassari 1989, pp. 155-78. Io., Monte Sirai: DCPP, pp. 298-99. Io., L'insediamento fenicio-punico di Paniloriga di Santadi (Cagliari): Carbonia 1995, pp. 239-52. C. TRONCHETII, I Sardi. Traffici, relazioni, ideologie nella Sardegna arcaica (= BiAr, 9), Milano 1988.
Io., La tomba 6A della necropoli punica di Sulcis: BArch, 3
(1989), p. 152. Io., Nuove testimonianze etrusche da Monte Sirai: SEAP, 4 (1989), pp. 67-71. Io., La ceramica di importazione: BARTOLONT 1996, pp. 119-
28. V. TusA, Lo scavo del 1970: Mozia VII(= StSem, 40; PCFP, 10,
Roma 1972, pp. 7-81. lo., La civiltà punica: Popoli e Civiltà dell'Italia antica, III, Ro
ma 1974, p. 78.
Io., Relazione preliminare degli scavi eseguiti a Mozia negli anni 1972, 1973, 1974: Mozia IX (= StSem, 50; PCFP, 18), Roma
1978, pp. 7-98. M. L. UBERTI, La collezione punica don Armeni (Sulcis): OrAn, 10 (1971), pp. 277-312. EAo., I vetri: E. AcQUARo-S. MoscATI-M. L. UBERTI, Anecdota Tharrhica, Roma 1975, pp. 109-21. EAD., I gioielli: AA. VV., La Collezione Biggio. Antichità puniche a Sant'Antioco (= CSF, 9), Roma 1977, pp. 51-55. EAo., Le stele puniche di Sardegna e le coltri litiche locali: Antiqua, 10 (1978), pp. 50-53.
EAo., Le stele di Monte Sirai e l'artigianato lapideo votivo della Sardegna punica: Studi in onore di Edda Bresciani, Pisa 1985, pp. 529-45. EAD., I vetri preromani del Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, Roma 1993. G. UGAs-G. LuciA, Primi scavi nel sepolcreto nuragico di Antas: La Sardegna nel Mediterraneo tra il Secondo e il Primo Millennio a.C.: Atti del II Convegno di Studi «Un millennio di relazioni fra la Sardegna e i Paesi del Mediterraneo», Selargius-Cagliari, 27-30 novembre 1986. Cagliari 1987, pp. 255-70.
24
USAI 1995 --
UsAI 1993 --
VEGAS 1989 --
VEGAS 1990 --
VERCOUTIER 1945 --
VERGA 1986 --
VICH 1990 --
ZuccA 1997 --
Elenco delle abbreviazioni
E. UsAI, Monte Sirai prima dei Fenici: Carbonia 1995, pp. 83-93. L. UsAI, Carbonia, loc. Monte Sirai (Prov. di Cagliari): RScPr, 45 (1993), p. 314. M. VEGAS, Archaische und mittelpunische Keramik aus Karthago: MDAI(R), 96 (1989), pp. 209-65. EAD., Archaische Topferofen in Karthago: MDAI(R), 97 (1990), pp. 33-56. J. VERCOUITER, Les objets égyptiens et égyptisants du mobilier funéraire carthaginois, Paris 1945. S. VERGA, Scarabei in pietra dura nel Museo Archeologico Regionale di Palermo: RStFen, 14 (1986), pp. 153-80. S. VIcH, Amuletos en la Antiguedad: proteccion contra espiritus, encantamientos y hechicerias: RAMadrid, 111 (1990), pp. 32-
9. R. ZuccA, La necropoli settentrionale di Tharros: Phoinikes, pp. 95-97.
INTRODUZIONE
Invidia rtanpuntur aves neque noctua curat
La città di Monte Sirai, ancorché durante la sua esistenza non sia mai stata un insediamento di cosiddetta primaria importanza, si pone come strumento fondamentale ai fini di una maggiore conoscenza della civiltà fenicia e punica, poiché il centro abitato, completo in ogni sua componente urbana, è privo di sovrapposizioni più tarde e, comunque, posteriori all'età romana repubblicana. Dopo il suo abbandono, avvenuto, per motivi attualmente solo intuibili e non facilmente spiegabili, attorno al Il O a.C., nu11a è venuto a sconvolgere o a mutare in modo sia pure minimo la struttura del luogo.
L'insediamento di Monte Sirai è formato da tre grandi settori. Il principale è costituito dali' abitato (Fig. 3, A), che occupa una cresta rocciosa nella parte meridionale della collina. Nella parte settentrionale della collina è invece situato il tofet: è questo il luogo sacro nel quale erano sepolti con particolari riti i corpi bruciati dei bambini nati morti o defunti in tenera età (Fig. 3, C). L'ultimo settore è costituito dalle due necropoli (Fig. 3, B), collocate nella valle che separa l'abitato dal tofet. Si tratta di una necropoli fenicia ad incinerazione, della quale onnai sono visibili unicamente le fossette scavate nel piano di tufo (Tav. I, a), e una necropoli punica ad inumazione, formata da tombe ipogee, quasi tutte in buono stato di conservazione.
Il centro di Monte Sirai nasce come abitato civile attorno al 750 a.C. e risulta particolarmente importante perché è situato lungo la via costiera, alla confluenza con la valle del Cixerri che conduce al Campidano (Fig. l). La sua fondazione come città si deve probabilmente ai Fenici di Sul cis o forse a quelli di un insediamento anonimo presso l'attuale Portoscuso. In ogni caso, da ciò scaturisce più che evidente la necessità, e anzi l'obbligo, di un'analisi globale del territorio che tenga conto di tutte le componenti storiche che parteciparono alla nascita, alla crescita e alle vicende della civiltà urbana nella regione sulcitana. Pertanto, questa deve essere sempre considerata nella sua interezza, da Chia a Monte Sirai, da Sant' Antioco a San Pantaleo. Quindi, non è possibile né corretto lo studio di un solo insediamento che_ non tenga in debito conto anche la storia e la vita di quelli più o meno vicini, poiché sia la storia sia la vita li accomunarono e li accomunano tuttora.
Attorno al 540 a.C. Cartagine decise di impadronirsi dell'isola, ma probabilmente una coalizione di città fenicie, tra le quali certamente Sulcis e Monte Sirai, si oppose con successo alle sue mire espansionistiche. Pochi anni dopo Cartagine inviò in Sardegna un secondo esercito che questa volta ebbe ragione delle resistenze delle città fenicie e dei loro alleati. Monte Sirai fu rasa quasi completamente al suolo e fu spopolata dalla strage dei suoi cittadini. In questo periodo l'abitato fu ridotto ad un piccolo insediamento, abitato da non più di una dozzina di famiglie e la vita sul monte da quel momento continuò grama e senza particolari sussulti fino al 370/360 a.C. circa, periodo in
... cui Cartagine decise di fortificare numerosi centri deUa Sardegna tra i quali appunto Monte Sirai. E in quest'occasione che fu impiantato il tofet.
Verso il 260 a.C. la struttura urbanistica dell'abitato fu radicalmente modificata, probabilmente in seguito ad eventi storici considerevoli, dei quali tuttavia non è rimasta eco nelle fonti scritte. La fortificazione costruita nel 370/360 a.C. fu demolita completamente, l'impianto urbanistico fu . ridisegnato e furono costruiti quattro grandi complessi di case a schiera.
Il 238 a.C., anno del passaggio della Sardegna dalla signoda di Cartagine al dominio di Roma, ' non sembra creare notevoli mutamenti alla struttura dell'abitato. Nel periodo che chiameremo neo-
punico, attorno al 110 a.C., la città fu abbandonata e non più frequentata nei secoli successivi se non in modo sporadico.
26 Introduzione
Monte Sirai ha iniziato a vivere una seconda età aurea quando nel 1963 sono iniziate le ricerche concepite e volute da Sabatino Moscati nel quadro delle molteplici attività svolte sotto l'egida del suo insegnamento.
Questo lavoro dunque è uno dei molteplici frutti di tanti anni di scavi a Monte Sirai. L' impegno e la dedizione di molti studiosi e di numerose maestranze hanno contribuito in modo determinante a creare il quadro storico e di vita quotidiana pieno di fascino che oggi si dipana e rivive sotto i nostri occhi come un libro di storia .
... E grazie agli accordi p l uri decennali tra l'Istituto per la Civiltà fenicia e punica «Sabatino Mo-
scati» del Consiglio Nazionale delle Ricerche, del quale mi onoro di fare parte e che attualmente ho il privilegio di dirigere, e la Soprintendenza Archeologica per le Province di Cagliari e Oristano, che ha luogo l'impresa della quale le due Istituzioni mi hanno affidato la direzione scientifica sul campo e alle quali sono e sarò riconoscente nella misura dell'appoggio ricevuto.
Sono grato alla cara memoria del mio Maestro, Sabatino Moscati, che ha consentito la rinascita di questo insediamento, concependo, volendo e realizzando l'impresa che lo ha riproposto alla storia e al pubblico.
Mentre ricordo con tanto affetto e molto rimpianto il caro Ferruccio Barreca, cui Monte Sirai deve la sua riscoperta e la sua fortuna, un grato pensiero va anche alla memoria dei cari Giuseppe «Peppino» Lai e Vittorio Pispisa, pionieri delle ricerche a Monte Sirai e compagni indimenticabili di mille imprese in terra sulcitana.
Un ringraziamento particolare al caro amico e collega, Sandra Filippo Bondì, anch'egli a suo tempo impegnato nei lavori sulla collina di Monte Sirai dai quali ha tratto lusinghieri e fondamentali risultati e che in questa sede mi onora della sua presenza con un prezioso contributo.
Sono grato a Vincenzo Santoni, Soprintendente Archeologo, a Carlo Tronchetti, al quale esprimo la mia gratitudine per la sua presenza in questo volume, e a Paolo Bemardini, ad Antonio Zara e al Personale della Soprintendenza di Cagliari e Oristano, distaccato presso la sede di Monte Sirai - Carbonia, e alle maestranze della GEPI operanti sul luogo, consapevole che senza il loro aiuto l'impresa archeologica sul monte non avrebbe potuto giungere agli attuali risultati. Altrettanto detenninante risulta l'impegno della Cooperativa «Vittorio Pispisa», che attualmente opera per la custodia e per la valorizzazione turistica dell'insediamento sia sul monte sia presso il Civico Museo Archeologico «Villa Sulcis».
La mia gratitudine va anche alla Regione Autonoma della Sardegna, e in particolare ali' Assessorato al Lavoro e all'Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Infonnazione, Spettacolo e Sport, senza il cui contributo gli scavi a Monte Sirai avrebbero avuto almeno per i primi anni una vita assai stentata. Inoltre, ricordo con piacere il costante appoggio datomi nel corso degli anni dali' Amministrazione Comunale di Carbonia e, in particolare, dal Sindaco, nonché caro amico, Antonangelo Casula, e dagli Assessori alla Cultura e Pubblica Istruzione che si sono succeduti in questi ultimi anni, Paolo Costa, Romano Morittu, Elio Fadda e Giovanni Tocco.
Ringrazio i miei allievi, alcuni dei quali peraltro sono onnai laureati, dell'Università di Urbino e i giovani studiosi e studenti provenienti dalle Università italiane di Cagliari, Catania, Genova, Napoli, Padova, Pisa, Roma e Viterbo, e straniere di Boston, Chicago, Medford (USA), Sevilla (Spagna), Uppsala (Svezia), Valencia (Spagna), che da molti anni seguono gli scavi assieme a numerosi giovani di Carbonia e di Sant' Antioco.
Ma desidero rivolgere un particolare ringraziamento a sette giovani studiosi senza il cui aiuto non avrei potuto realizzare i lavori programmati e realizzati in questi anni: è solo grazie alla loro abnegazione e al loro sacrificio che una parte considerevole dell'insediamento di Monte Sirai ha rivisto la luce ed ha potuto essere indagata. Ricordo dunque, in rigoroso elenco alfabetico, Lorenza Campanella, Stefano Esu, Laura lmpagliazzo, Debora Martini, Sara Muscuso, Carla Perra e, da ultima, Emanuela Solinas, alcuni dei quali, del resto, hanno avuto la bontà di partecipare a questo lavor:o .. Non posso che augurare loro un successo più che ampio, poiché sono questi i giovani studiosi che hanno affrontato con correttezza
Introduzione 27
e con entusiasmo il mondo degli studi e che, quindi, costituiscono la base delle nostre speranze per il futuro.
I rilievi, così come alcuni disegni, sono di Sandro D'Achille e di Claudio Pisu, ai quali vanno la mia gratitudine e la mia stima per la loro professionalità. Alcune piante e le rielaborazioni grafiche sono mie. Una buona parte delle fotografie sono dovute a Gesualdo Petruccioli.
Ed è infine, proprio agli abitanti di Carbonia che volgo un grato ricordo poiché hanno seguito e seguono sempre con immutato e grande interesse il continuo divenire dei lavori.
PIERO BAIITOLONI
Roma, 18 gennaio 2000
IL NOME E LA POSIZIONE GEOGRAFICA
Il toponimo
Dell'antico nome dell'abitato di Monte Sirai non è rimasta alcuna traccia nella memoria degli abitanti del circondario, nessun'antica fonte scritta lo ricorda e, in definitiva, non sappiamo neppure con certezza se il non1e attuale abbia un'antica origine. Tuttavia, ciò è possibile e quindi, tra l'altro, in un primo momento si era pensato che il nome di Sirai potesse essere accostato alla radice semitica SR, il cui significato è roccia o scoglio, e che, ad esempio, compare in modo sintomatico nel toponimo fenicio Sur che indica la città fenicia di Tiroct ), che, come è noto, è stata edificato su alcuni scogli ali' epoca distanti circa seicento metri dall'antica linea di costa.
Inoltre, a corollario e sempre partendo dal toponirno Sirai e da questo dilittero, si è ipotizzato che la lettera finale di Sirai - (-i) - fosse la parte residua del suffisso -im di antica origine fenicia, che indicava un sostantivo duale. Pertanto si è pensato che, pur con la caduta della consonante m, l 'antico toponimo si fosse conservato fino ai giorni nostri e che quindi, ad esempio, il nome potesse significare il Monte con due cime o il Doppio montee). Ma, come la precedente, anche quest'ipotesi è stata presto abbandonata perché non corretta per quanto riguarda l'aspetto glotto logico e per di più linguisticamente insostenibile. Infatti nel dilittero SR la prima consonante è una ~ade, mentre nel caso del nome Sirai, si tratta palesemente di una samek. Né, del resto, sussiste una giustificazione geografica poiché la sommità del monte è pianeggiante e le due supposte cime, l'una a quota 194 e l'altra a quota 191, in realtà risultano assai poco eminenti rispetto al pianoro, che risulta in massima parte attorno alla quota 180, e non sono percepibili se non dal versante settentrionale.
Anche l'ipotesi che il nome di Monte Sirai, a prescindere dal suo significato, avesse comunque un'origine fenicia o punica è stata abbandonata di recente a favore di una sua più probabile provenienza da lingue mediterranee anteriori ali' arrivo sulle coste sarde dei popoli provenienti dal Vicino OrienteC). In un primo momento, infatti, era stato anche proposto che il nome Sirai avesse una origine berbera e cioè che il monte fosse stato indicato con questo nome da coloni nord-africani di stirpe indigena, venuti in Sardegna come agricoltori al seguito degli eserciti cartaginesi dopo il 520 a.C.
Si è ritenuto inoltre che l'insediamento di Monte Sirai fosse da identificare con l'antica Pupulum. Il nome di questo centro abitato, per altro non ancora identificato sul terreno, è conosciuto unicamente attraverso la Tabula Peutingeriana, che notoriamente riproduce la collocazione dei centri romani del mondo conosciuto nel IV secolo d.C.(4
). Ma poiché, come si vedrà più sotto, il centro abitato di Monte Sirai è stato abbandonato definitivamente verso la fine del II secolo a.C., e la succitata carta geografica riporta una situazione insediativa decisamente più tarda, è poco probabile che l'abitato di Monte Sirai abbia inciso a tal punto nella storia della Sardegna e sia stato talmente importante da perpetuare il suo ricordo per circa cinquecento anni, tanto cioè da essere inserito nella riproduzione geografica del mondo allora noto.
C) GARBINI 1964 b, pp. 77-79; P AULIS 1986, pp. 20-21; BARTOLONI 1992 c, pp. 29-30.
e) cf. BARRECA 1986, p. 289.
e) GARBINI 1992, pp. 186-87, nota 15.
(4
) Cf. CECCHINI 1971, pp. 183-87.
32 Parte Prima
' E invece più probabile che il toponimo di Pupu}um vada riferito ad uno degli insediamenti ro-mani, originati forse da villae rusticae, a loro volta impiantate su precedenti latifondi di età punica(5),. divenuti particolarmente consistenti in età imperiale, quali ad esempio quelli di Matzacara o Paringianu, collocati a poca distanza da Monte Sirai - circa sei chilometri in linea d'aria - nella pianura lungo la costa antistante le isole di Sant' Antioco e di San Pietro(6) .
Attualmente- come è autorevolmente sostenuto da Giovanni Garbini- è da ritenere più pro-. .
babile che l' origine del toponimo Sirai, il cui significato, ancorché. sconosciuto, è comunque da . · considerare legato ali' aspra natura del luogo e dunque alla roccia, sia sempre da collocare in am-
biente nord-africano berbero, ma da porre nel sostrato linguistico panmedìterraneo di epoca neolitica e quindi, come detto, in un periodo ben precedente all'arrivo di popolazioni vicino-orientali in SardegnaC).
La struttura geologica
L' altura di Monte Sirai trae la sua origine da vasti movimenti tettonici che hanno suddiviso la regione del Sulcis in alcune ampie zolle. Alcune di queste sono rimaste in rilievo e tra di loro vi è per l'appunto la collina di Monte Sirai, accanto ai monti Essu, Narcao, Corona Arrubia e Sinni. L'area di Monte Sirai in particolare è costituita da arenarie e conglomerati appartenenti alla cosiddetta «Fonnazione del Cixerri» (Eocene-Oligocene medio) e in un secondo momento, al termine del Cenozoico (Oligocene-Miocene), fu ricoperta da rocce vulcaniche effusive (Ignimbriti).
Non sono noti i centri di emissione di queste vulcaniti, poiché sf tratta in prevalenza di prodotti ignimbritici (nubi ardenti), provenienti da diverse direzioni ed emessi da fratture della crosta terrestre onnai richiuse da lungo tempo. Attualmente l'attività vulcanica nella zona prosegue in mare in un apparato vulcanico chiamato Quirino, situato 30 chilometri a sud di Capo Sperone(8), che è la punta meridionale dell ' isola di Sant' Antioco.
L'altura di Monte Sirai si eleva ad una quota massima di 194 metri sul livello del mare (Figg. 2-3). La struttura è costituita da un paleosuolo originario, conservatosi al livello attuale grazie ad un «cappello» la vico che ne ha impedito 1' erosione. Infatti la parte sommi tale del rilievo è costituita da vulcaniti acide appartenenti alla cosiddetta «Serie Ignimbritica Sulcitana». Questa particolare serie è presente sul monte con due ignimbriti compatte, comunemente anche in seguito chiamate trachiti, separate da una piroclastite cineritico-pomicea tenera, comunemente denominata tufo. Nell ' area di Monte Sirai sono presenti anche prodotti vulcanici di natura andesitica, sia in cupole sia in facies esplosiva.
Il progressivo lento disfacimento delle vulcaniti acide ha dato origine ad un terreno ovviamente acido, le cui proprietà si riverberano anche sui manufatti di terracotta che di norma vengono rinvenuti con le superfici completamente spatinate.
La particolare struttura morfologica di Monte Sirai trae origine dalla differente natura e dal diverso grado di erodibilità delle rocce presenti. A questa situazione morfologica ha concorso anche I' assetto detenninato dalle forze tettoniche che hanno sollevato l'altura provocandone lo sbandamento verso sud-ovest. Come accennato, il basamento della collina, che è di natura sedimentaria, ha una fonna troncoconica, mentre gli episodi vulcanici che formano il «cappello» del rilievo e che costituiscono il pianoro sommitale, caratterizzano il paesaggio con le tipiche rotture del pendio (gradonate). Le necropoli sono state realizzate scavando l'unità piroclastica tenera, cioè il tufo,
(5) P. MELONI, L 'età dei Romani: La Sardegna, 1, Cagliari 1982, pp. 20-22; M ELONI 1990, pp. 107-11.
(6
) P. MELONI, La costa sulcitana in Tolomeo (Geogr. 111; 3, 3): Carbonia 1995, pp. 307-14.
C) Cf. Nota 3.
(8) Cf. B ARTOLONI 1989 d, p. 9; BAJITOLONI 1992 C, pp. 27-28 .
Il nome e la posizione geografica 33
mentre l'abitato è stato edificato sulle ignimbriti compatte, che hanno forn1ato la fondazione naturale.
Quindi, Monte Sirai ha l'aspetto tipico dei pianori ignimbritici della regione sulcitana e, con la sommità piatta e i fianchi scoscesi, ricorda le giare, i caratteristici tavolati basaltici della Sardegna centrale. Tra le più famose e di maggiore estensione è la giara di Gesturi. Anche Monte Sirai è specificamente nota per la sua posizione particolarmente isolata nella piana costiera ed è quindi ben visibile lungo la costa anche da grande distanza(9). Per chi giunga dal mare, invece, il rilievo di Monte Sirai è assai poco distinguibile, poiché risulta appiattito sulle alture retrostanti, appena . ' . . ptu emtnentt.
La caratteristica morfologia del rilievo, con le pendici oblique e la sommità verticale, pone in evidenza le difese naturali collocate al culmine della collina. Queste peculiarità, del resto, sembrano casualmente riprodotte in modo artificiale già dalle fortificazioni del medio e tardo bronzo dei centri della costa palestinese. Si vedano ad esempio i glacis inclinati di Berytus(10) e di Byblos( 11},
quest'ultimo perpetuato morfologicamente anche nella fortezza di età persianae2), con il terrapieno inclinato e il parapetto verticale costruiti con blocchi squadrati in opera pseudoisodoma(13).
(9) Sulla geologia della zona di Monte Sirai e del Sulcis, cf. AA.VV., Il bacino carbotlifero del Sulcis. Geologia,
idrogeologia, miniere, Cagliari 1994, e quindi, da ultimo, cf. MuREoou 1998, pp. 21-29.
(10
) Cf. da ultimo, BADRE 1997, pp. 60-66, fig. 31 a.
(11
) Cf. A. PARROT-M. H. CHÉHAB-S. MoscATI, Les Phéniciens, Paris 1975, pp. 30-31, fig. 19.
(12
) Cf. da ultimo, anche per la bibliografia, P. BAirn>LONI, Un leone su/citano a Roma: RStFen, 27 (1999), pp. 115-26.
(13
) A. PARROT-M. H. CHÉHAB-S. MoscATI, op. cit., p. ~06, fig. 110: la protome leonina visibile nelrillustrazione attualmente non è reperibile in situ.
STORIA DELL'INSEDIAMENTO
L'antica storia della Sardegna, e quindi anche quella di Monte Sirai, è legata agli antichi racconti, come del resto lo è quella di tutte le altre regioni del Mediterraneo antico. Purtroppo, per quanto riguarda in modo specifico l'isola, le opere degli antichi scrittori greci e latini risultano particolarmente avare di notizie e queste ultime per di più sono spesso legate ad avvenimenti mitici e quindi fantasiose e imprecisee ). Ciò perché con ogni probabilità gran parte del mondo greco non aveva una diretta conoscenza della Sardegna e quindi vedeva l'isola come una lontana terra misteriosa e felicee).
Altrettanto scarse sono generalmente le fonti dirette, derivanti dalla tradizione fenicia e punìca, poiché rare sono le iscrizioni rimaste e le poche sopravvissute sono prevalentemente di argomento religioso o votivo. Si consideri ad esempio che l'unica iscrizione con più parole di senso compiuto rinvenuta fino ad oggi a Monte Sirai riguarda la dedica di un altare ad una non meglio identificata divinitàe). Pertanto, la ricostruzione dell'antica storia dell'isola risulta particolarmente difficoltosa e ancor più lo è quella di Monte Sirai, il cui antico nome risulta ancora oggi sconosciuto. Comunque, un indispensabile aiuto è dato dalle indagini archeologiche che sono state effettuate in Sardegna nel corso dell'ultimo secolo e che sopperiscono almeno in parte al desolante quadro suesposto.
La preistoria
Le prime tracce di vita sulle falde e sul pianoro di Monte Sirai sono da collocare in epoca neolitica, anche se la morfologia e la struttura del monte ne fanno dft sempre una fortezza naturale e quindi consentono di ritenere che il rilievo abbia costituito un rifugio eccellente per l'uomo fin dalle epoche più remote. Del resto, evidenti tracce di popolazioni stanziate nella regione fin dal periodo Paleolitico medio o superiore sono state rinvenute da Egidio Capuzzi, cultore della materia di Carbonia, nella non lontana località di Porto Pinetto, ubicata sulla costa circa trenta chilometri a sud di Monte Sirai, e sono costituite da due officine litiche a cielo aperto nelle quali fanno spicco alcuni raschiatoi trapezoidali in granito di origine non locale(4)'.~ •
Comunque, le prime tracce di stanziamenti umani a Monte Sirai sono rappresentate da piccoli anfratti naturali - i cosiddetti ripari sotto roccia - che costituivano le abitazioni per i vivi e i luoghi di sepoltura per i morti. Questi ripari sono disseminati soprattutto lungo le pendi ci e le creste rocciose del monte, dove l'azione del vento e della pioggia
e) Cf. BaNDÌ 1975 d, pp. 49-66.
e) Cf. TRONCHETTI 1988.
e) Cf. per la lectio princeps, GARBINI 1965, pp. 79-92; per il resto si tratta unicamente di alcune ràre lettere stam-. . .
pigliate prima della cottura o incise su frammenti di terracotta: cf. Guzzo AMADASI 1967, p. 124, riferibile ad una iscri-zione mutila di tre lettere tracciata su un frammento di tabouna. ; ; ·
(4) Sulle prime testimonianze d~l Paleolitko in Sardegna, cf. ad esempio F. Lo ScHIAVO, 'La preistoria: Il museo Sanna)n Sassari, Sassari 1986, pp. 19-28. ;
36 Parte Prima
nel corso dei millenni hanno creato nella pur durissima trachite delle cavità talvolta assai ampie, comunemente denominate tafoni(5).
Più consistenti testimonianze di vita a Monte Sirai sono da collocare sempre in epoca neolitica, in questo caso attorno al 2500 a.C. I resti più concreti sono rappresentati da alcune Domus de Janas(6
), qui costituite da non più di due celle successive. Si tratta di almeno quattro camere ipogee scavate nel tufo, nelle quali si entrava percorrendo un breve corridoio. Due tombe sono accanto alla necropoli di età punica e, riutilizzate appunto in questo periodo, sono ubicate ai piedi dell ' altura del tofet. Altre due sono situate al centro della valle, ma ad una quota più bassa rispetto alle necropoli fenicia e punica. La posizione delle prime due sepolture, i cui portelli di accesso sono affacciati sulla valle, ricorda in qualche modo e sia pure in misura assai minore la disposizione decisamente scenografica della grande necropoli neolitica di Montessu, presso Villaperuccio.
Che sul monte vi fosse un luogo di culto attivo in questo periodo è dimostrato dalla presenza di almeno due grandi menhirs, che, sia pure ritagliati e riutilizzati nelle strutture murarie di età neo-punicaC), mostrano su una delle facce alcune cavità che sono da interpretare come coppelle, caratteristiche di questo tipo di monumenti. In particolare, le stele appaiono riutilizzate nella cosiddetta torre cava, eretta tra l'altro con i materiali edilizi appartenenti alle fortificazioni costruite attorno al 370/360 a.C. e demolite probabilmente nel secondo quarto del III secolo a.C. Quindi risulta probabile che originariamente questi menhirs fossero collocati in posizione non molto distante dal luogo del loro riutilizzo, confermando una continuità di culto millenaria che, dal presumibile luogo sacro di età neolitica, giunge fino al tempio neo-punico, passando in successione attraverso il luogo di culto ali ' interno del nuraghe e il tempio di età punica.
Il villaggio corrispondente alle Domus de Janas non dovrebbe essere situato in un luogo molto distante, anche perché la valle delle necropoli ha costituito in ogni tempo l'unico luogo realmente coltivabile di tutto il monte e per di più nella sua parte occidentale era ubicata l 'unica sorgente perenne di tutto il circondario. Inoltre, le pendici della terrazza su cui sorge il tofet, a nord della valle, costituivano una egregia difesa naturale contro lo spirare del Maestrale.
In effetti, durante gli scavi della necropoli fenicia sono stati individuati alcuni massi che avrebbero potuto anche fare parte di strutture murarie attribuibili forse a quel periodo. In ogni caso, in questo settore del monte non sono stati mai individuati i fondi di capanne che sono caratteristici dei centri abitati di epoca neolitica. Occorre poi notare che, di nonna, i villaggi di riferimento delle necropoli di questo periodo -le tombe ipogee dette Domus de Janas - sono ubicati nella vallata e dunque l'abitato relativo a questa pur numericamente modesta necropoli potrebbe aver trovato collocazione in un punto qualsiasi dell'ampia pianura costiera che si apre tra Monte Sirai e il mare.
In ogni caso, tracce di vita attribuibili con certezza alla Cultura di S. Michele, rese concrete da strutture e da alcuni frammenti di ceramica coevi alle tombe descritte, sono state recentemente rinvenute nell'area tra le vecchie batterie antiaeree, oggi riattate come luoghi di ristoro e di ricezione turistica, e l' attuale zona destinata al parcheggio, durante la realizzazione delle aree di servizio(8). · ·
L'età nuragica
Anche in epoca protostorica e quindi fin dalla prima metà del secondo millennio a.C. Monte Sirai fu frequentato in modo significativo e certamente anche stabile dalle popolazioni nuragiche che abitavano la zona centrale del Sulcis-Iglesiente.
CS) SuUe emergenze preistoriche dell 'area, cf., da ultimo, G. Lru.m, Preistoria e protostoria del Su/cis: Carbonia 1995, pp. 11-50.
(6
) Cf. B ARRECA 1964, p. 12; BARTOLONI 1992 c, p. 29 e da, ultimo, UsAI 1995, pp. 83-94.
C) Cf. BARRECA 1966 a, pp .. 34-35, tav. XXII; BARTOLONI 1989 d, p. 17, fig. 6.
(8
) Cf. U s AI 1993, p. 514.
Storia dell'insediamento 37
Come detto, il monte, con i suoi fianchi scoscesi e con la sommità pianeggiante, in età nuragica costituiva un luogo naturalmente difeso e dunque probabilmente ideale soprattutto per l'allevamento del bestiame. Le testimonianze più dirette della presenza d'età nuragica sono costituite da alcune torri erette sia alla sommità sia lungo le pendici dell'altura (Fig. 3). Di quella alla sommità, cuore e fulcro dell'abitato anche in ogni suo momento storico (Fig. 4, k), si avrà modo di parlare ampiamente più avanti. Per quanto riguarda invece quelle lungo le pendici del monte, si tratta in ogni caso di monumenti di esigue dimensioni, la cui funzione era probabilmente solo quella di garitte di guardia e non anche quella di abitazioni(9).
Il nuraghe più imponente e di maggiore importanza del circondario è quello denominato Sirai(10) che non è situato sul monte bensì nella pianura che si apre a sud-est della collina (Fig. 2). Si tratta di un nuraghe di tipo complesso, formato cioè da una torre centrale - forse ma non necessariamente la più antica dell'edificio - circondata da altre quattro torri collegate tra loro da un muro che racchiude un cortile, antistante la prima torre.
Il nuraghe Sirai, probabilmente attivo nella sua funzione primaria tra il 1600 e il 1200 a.C., fu certamente abitato fino ai primi anni dell'VIII secolo a.C., con tracce di frequentazione negli edifici adiacenti l'antemurale che perdurano fino alla seconda metà del VI secolo a.C. Tra i materiali riferibili a matrice di età fenicia è da segnalare un frammento di brocca con orlo espanso, relativo al collo e databile probabilmente non oltre la prima metà del VII secolo a.C.(11 ) e alcuni frammenti di anfore onerarie fenicie della seconda metà del VI secolo a.C.
L'edificio era quasi attorniato da un grande villaggio, formato dalle consuete capanne circolari, ed era adibito alla protezione e al controllo della strada costiera che percorreva il fianco occidentale di Monte Sirai, tra la collina e il mare. La torre centrale è ben visibile e in uno stato di conservazione apparentemente non troppo degradato, anche se non sono mancate le incursioni di operatori clandestini, mentre le altre quattro sono sommerse dall'abbondante vegetazione. Il crollo coinvolge tutta la struttura, ma ciò non impedisce di scorgere almeno gli ultimi filari della torre principale, che dovrebbe avere un'altezza di poco inferiore ai quindici metri. Inoltre, la torre sembra composta da almeno due camere ogivali sovrapposte. Le torri minori sono raccordate da possenti strutture rettilinee, che racchiudono il già citato cortile. Un antemurale, lungo almeno quattrocento metri, racchiude un vasto villaggio, addossato, come è consuetudine, soprattutto al versante meridionale del nuraghe. Il villaggio sembra composto dalle caratteristiche abitazioni di età nuragica, ma, come accennato più sopra, non mancano strutture rettilinee addossate ali' antemurale che potrebbero sottintendere utilizzi di epoca posteriore.
Lo stato attuale di questo nuraghe ricorda indubbiamente le condizioni nelle quali fu rinvenuto l'antico abitato di Monte Sirai, completamente coperto dai crolli e dalla macchia mediterranea. Attualmente il nuraghe Sirai è visitabile staccandosi dalla strada statale 126 all'altezza del chilometro 17, percorrendo la strada asfaltata fino al Medau Rubiu e da qui passando per un breve tratturo in terra battuta.
Altre torri nuragiche sorgono sia a sud sia a sud-ovest del monte (Figg. 2-3). Si tratta dei nuraghi Nuraxeddu e Piliu, le cui funzioni erano sempre quelle di controllare sia la strada costiera che transitava lungo il versante occidentale del monte e quindi dalla parte opposta rispetto a quella at-
(9
) Cf. BARRECA 1964, p. 12.
(10
) Cf. BARRECA 1964, p. 12; SEQUI 1985, p. 95; SANTONI 1986, pp. 181-84; BAIITOLONI 1992 b, pp. 9-12.
(11
) Cf. SANTONI 1986, pp. 182-84, tav. XXVIII; per quanto riguarda questo frammento, la cronologia proposta da PESERico 1996, p. 94 suscita, in relazione alla forma del collo, qualche perplessità poiché appare troppo ampia, posta com'è dalla nostra autrice tra la fine dell'VIII e tutto il VII secolo a.C. (= PEsERico 1996, p. 93); del resto, è ampiamente riconosciuto che, per quanto riguarda la colonizzazione fenicia in Sardegna, sono percepibili due periodi ben separati tra di ]oro: come è ampiamente noto, il primo si colloca tra Ja metà detrVIll e il primo quarto del VII secolo a.C., mentre il secondo è da porre tra l'ultimo quarto del VII e l'ultimo quarto del VI secolo a.C.: cf. in proposito BAIITOLONI-BONDl
MoscATI 1997, pp. 33-37.
38 Parte Prima
tuale, sia il monte stesso, del quale custodivano gli accessi, e infine di fiancheggiare il nuraghe Sirai. Infatti, mentre il nuraghe Piliu era situato allo sbocco sud-occidentale della valle delle necropoli e controllava da ovest la via costiera, il nuraghe Nuraxeddu custodiva il passo Arcu de Ulmus a sud-ovest del monte e l'origine della strada carraia che si staccava dall'arteria principale e si inerpicava lungo il fianco orientale della collina( 12
).
Come già accennato, altri piccoli nuraghi - almeno due - sorgono sulle pendici del monte o sull'orlo del pianoro sommitale (Fig. 3). In questo caso si tratta di ripari fortificati utilizzati per il diretto controllo del monte e della pianura circostante, nei versanti non direttamente visibili dal nuraghe Sirai e dai suoi immediati satelliti. Per quanto riguarda quello più occidentale, posto su una terrazza trachitica che domina la valle costiera, si tratta probabilmente di un nuraghe cosiddetto a tancato. Com'è noto, le torri di questo tipo di nonna erano singole, ma erano sempre accompagnate da un cortile circolare, costruito in apparecchio robusto, che si addossava allo stesso nuraghe e ne proteggeva l'accesso.
Anche il pianoro di Monte Sirai era difeso da un nuraghe, ma la sua struttura semplice, costituita cioè da una sola torre, porta a ritenere che la sua funzione principale fosse più quella di torre d'avvistamento e di segnalazione che quella di specifico luogo di residenza stabile e di difesa. Ciò non esclude tuttavia che l'edificio costituisse anche il fulcro e il principale luogo di riferimento degli antichi frequentatori della collina.
Come detto, si tratta di una torre nuragica singola il cui diametro di base è di circa quattordici metri e la cui altezza originale, che si calcola dovesse essere analoga, permetteva di superare con la vista il crinale del monte. Quindi, dalla terrazza sommi tale dell'edificio era possibile vedere il sottostante nuraghe Sirai e più in distanza quelli del versante settentrionale. Dunque, attraverso il nuraghe posto sul pianoro, gli eventuali abitanti del nuraghe Sirai potevano superare il dislivello del monte e, tramite i loro segnali, entrare in collegamento con tutte le principali torri circostanti, quali ad esempio, per l'appunto a nord, quella di Seruci( 13
), presso l'attuale abitato di Gonnesa. Oltre alla torre nuragica che sorge sulla sommità di Monte Sirai, altre sono le tracce relative a
monumenti appartenuti a questa civiltà. Infatti, sparsi sul pianoro e riutilizzati nelle strutture di età fenicia e punica, sono numerosi frammenti architettonici relativi sia allo stesso nuraghe sia a una Tomba di Giganti. Per quanto riguarda il nuraghe, un concio in trachite appartenente al terrazzo sommitale della torre è stato rinvenuto riutilizzato nei muri perimetrali del cosiddetto lv/astio, e più precisamente nell'angolo orientale della cinta del cortile. Sempre appartenenti allo stesso edificio sono presenti altri conci minori, realizzati in pietra calcarea e reimpiegati nella scalinata di accesso al cortile del tempio di età punico-romana.
Quanto alla Tomba di Giganti, in questo caso si trattava di una grande sepoltura di tipo collet-·.
tivo, oggi scomparsa, che era formata da una sorta di lungo corridoio coperto da grandi lastre di pietrae4
). Tra i resti architettonici appartenenti a questo edificio, utilizzati in seguito dalle maestranze puniche, è da segnalare un architrave a dentelli in pietra calcarea, reimpiegato come stipite in un edificio di età tarda, relativo alla ristrutturazione del secondo quarto del terzo secolo a.C., ubicato nel versante meridionale dell'abitato. Inoltre, una lastra calcarea sagomata in forma curvilinea- verosimilmente un frammento di como taurino falcato realizzato dunque nello stesso tipo di materiale dell'architrave a dentelli- è inserita in una muratura del medesimo periodo, distante pochi metri dallo stesso architrave.
e2> cr. BARRECA 1964, p. 12.
( 13) Cf. A. TARAMELLI, Gonnesa. Indagini nella cittadella nuragica di Serrucci (Cagliari): MAL, 24 (1917), con. 633-96; da ultimo, V. SANTONI-G. BAcco, L'isolato A del villaggio nuragico di Serucci- Gonnesa. Lo scavo dei vani 3 e 6: QuadCaglìari, 5 (1988), pp. 39-64.
(14
) Per questa tipologia di monumenti, cf., da ultimo, A. MoRAVETTI, Serra Orrios e i monumenti archeologici di Dorgali, Sassari 1998.
Storia dell 'insediamento 39
Sul monte invece non sono visibili capanne e non ne è stata trovata traccia durante gli scavi, come del resto era da attendersi, visto che la torre non era di tipo complesso e il villaggio era ubicato attorno al grande nuraghe ai piedi del rilievo. Inoltre, la probabile presenza della Tomba di Giganti porta ad escludere per ovvi motivi la vicinanza di luoghi abitativi. Tuttavia, sparse sul monte, sono visibili alcune grandi macine di forma ellissoidale cosiddette da coscia, realizzate in pietra trachitica, che certamente sono attribuibili ad un periodo anteriore all'edificazione dell'abitato fenicio e forse anche alla presenza di età nuragica.
L'età fenicia
Le prime tracce di una presenza stabile dei Fenici, ultimi a giungere in Sardegna dopo i naviganti micenei, vicino-orientali e ciprioti, sono databili attorno al 750 a.C. e anche a Monte Sirai se ne notano chiari indizi, anch'essi attribuibili a questo periodo. Infatti gli oggetti più antichi - alcuni frammenti di vasi in terracotta, tra i quali non poche· coppe carenate e delle forme chiuse, tra le quali alcune brocche biconiche, queste ultime assai simili a quelle rinvenute nella vicina necropoli di San Giorgio - sono databili non dopo il 750/740 a.C.
Come già accennato, la fondazione di Monte Sirai si deve probabilmente ai Fenici stanziati fin dalla prima metà dell'VIII secolo a.C. a Sulcis, nell'isola di Sant' Antioco, o forse agli abitanti che nello stesso periodo occupavano la zona di Portoscuso, ove è stata rinvenuta di recente la succitata necropoli fenicia( 15
). In quest' ultimo caso, tuttavia, più che di una vera e propria città, si tratta più probabilmente di un piccolo fondaco commerciale attivo già nel secondo terzo dell ' VIII secolo a.C. e del quale in seguito si perdono completamente le tracce. È dunque possibile che, nel caso dell'insediamento fenicio di Portoscuso, siamo di fronte a uno di quei centri abitati di tipo cosiddetto «precoloniale». Come è noto, questi luoghi, talvolta abitati solo temporaneamente o gestiti da popolazioni locali .e attivi soprattutto tra il XII e la prima metà de li 'VIII secolo a.C., erano adibiti principalmente al commercio con gli abitati circonvicini ed erano utilizzati per la sosta o per il ricovero temporaneo delle navi in transito e non ospitavano mai consistenti nuclei di abitanti. Dopo il 750 a.C. circa, una parte degli insediamenti di questo tipo, all'infuori di quelli costieri ubicati a nord di Tharros e della foce del Flumendosa che scomparvero o furono fortemente ridimensionati
' entro la prima metà del VII secolo a.C. , se erano dotati di un porto sufficientemente ampio e di un retroterra coltivabile, si trasformarono in colonie di popolarnento, mentre gli altri, sostanzialmente privi di collegamenti terrestri, scomparvero rapidamente.
Non è neppure lontanamente immaginabile che tutti gli abitanti di cultura fenicia che occupavano Monte Sirai così come tutte le altre città della costa sarda fossero di origine orientale. Si deve pensare piuttosto ad una popolazione mista e composta da una minoranza di Fenici di Oriente e da una maggioranza di stirpe nuragica. La presenza di forti nuclei di abitanti di origine autoctona fin dai primi anni della fondazione delle città è suggerita ad esempio da alcune testimonianze legate alle pratiche funerarie più antiche e da alcuni oggetti di uso quotidiano, come tra l'altro le pentole, che, come forma esteriore, erano senza dubbio di tipo nuragico, ma erano fabbricati con l'uso ~el tornio e, dunque, con una tecnologia di tipo fenicioct 6
).
Dunque, i Fenici si insediarono stabilmente a Monte Sirai attorno al 750 a.C. costruendo un centro abitato di notevoli dimensioni che si distendeva attorno alla vecchia torre nuragica ed occupava una superficie praticamente di pari estensione a quella relativa al centro abitato visibile attualmente, che, sia detto per inciso, ben poco conserva in vista delle strutture fenicie. L' insediamento fu impiantato su una dorsale fonnata da rocce ignimbritiche, ubicata nella parte sud-orienta-
('5
) BERNAROINI 1997, pp. 55-57.
e6) Cf. anche per la bibliografia precedente BARTOLONI 1998 c, pp. 165-79.
40 Parte Prima
le della collina, che emergeva seppure di poco rispetto al pianoro antistante, costituendo una ulteriore difesa naturale.
In un primo momento si era pensato che i Fenici, ali' atto del loro stanziamento sul monte, proposto a suo tempo nel corso del VII secolo a.C., avessero distrutto il nuraghee 7
), ma negli strati più antichi non vi sono tracce di una occupazione violenta né di distruzioni. Era stata anche formulata 1' ipotesi che il nuraghe fosse crollato unicamente per cause naturali, quali ad esempio un terremoto, ma anche in questo caso durante le indagini non sono emerse testimonianze dirette, né i nuraghi vicini conservano tracce di simili eventi. Invece, come si vedrà in seguito, la torre sommitale era ancora eretta ed agibile fino agli ultimi anni del VI secolo a.C.
L'abitato di epoca fenicia era costruito attorno al nuraghe, trasformato in luogo sacro, che è stato chiamato Mastio, poiché in un primo momento si era pensato che il suo uso fosse stato soprattutto difensivo e specificamente di carattere militaree8
). Questo edificio, che in realtà è soprattutto un luogo di culto, ha subito durante i secoli numerose ristrutturazioni e, nel suo aspetto più recente, sorge in parte sul circuito di base del nuraghe.
Negli ultimi anni, nel corso di indagini archeologiche mirate, è stato possibile constatare che in età fenicia la torre nuragica era in buono stato di conservazione e quindi era ancora accessibile e in uso. Ciò poiché in realtà si è potuto osservare che nessuna struttura relativa a quel periodo si sovrappone ai ruderi del nuraghe e che almeno due edifici gli erano adiacenti, l'uno sul versante orientale e l'altro su quello nord-occidentale. Inoltre, si è potuto osservare che i frammenti fittili inseriti nel piano di calpestio dell'ingresso della torre sono databili non oltre gli inizi dell'ultimo quarto del VI secolo a.C. e che quindi l'accesso era in uso fino a quella data. Pertanto, si è supposto che il luogo di culto fenicio fosse ospitato ali' interno della cella del nuraghe, in probabile sostituzione o integrazione di un precedente luogo di culto di età nuragica, collocato ovviamente all'interno della torre stessaC9
).
Dunque, è verosimile che i Fenici avessero probabilmente sistemato ali' interno della tholos del nuraghe la statua di culto che rappresentava la dea Ashtart. La statua, attualmente conservata nel Museo Nazionale di Cagliari, è stata rinvenuta nel 1964 all'interno di una delle celle centrali del cosiddetto Mastio, che si aprono sul fondo dei due cortili dell'edificio relativo alla fase neo-punica. Ma, sulla base dello stile e dei confronti storico-artistici, è stato possibile appurare che la statua era stata scolpita almeno nel VII secolo a.C., se non addirittura nel secolo precedente, in concomitanza con la prima occupazione fenicia di Monte Sirai. In ogni caso è certo che la statua sia di produzione locale, poiché la pietra nella quale è stata scolpita proviene dalle vicine cave di Paringianu, poste tra Monte Sirai e la costa. Come si vedrà in seguito, all'interno della cella di età tardopunica erano conservati anche gli arredi di culto e le offerte votive deposte dai fedeli nel corso dei decenni, tra i quali tre statuette in bronzo del VII secolo a.C., numerose placchette di osso databili nel secolo successivo, alcune maschere in terracotta collocabili nel V secolo a.C. e alcune statuette, lucerne e stoviglie databili tra il III e il II secolo a.C.
La statua ha subito alcuni forti rimaneggiamenti verso la fine del VI secolo a.C., dopo l'invasione cartaginese. Date le dimensioni della pietra, probabilmente in origine si doveva trattare di una statua che rappresentava la dea Astarte nella sua interezza, forse seduta in tronoe0). Attualmente invece la statua accanto alla testa finemente lavorata presenta un corpo rozzo, appena sbozzato e apparentemente privo di gambe, elaborato sommariamente secondo lo schema iconografico del cosiddetto personaggio con stola, raffigurato su alcune stele del tofet di Monte Sirai e assai di
(17
) Cf. BARRECA 1986, pp. 24-26, 29.
(18
) Cf. BARRECA 1967, pp. 23-25.
e9) Si vedano ad esempio TARAMELLI 1910, coli. 166-74; da ultimo, L ILLIU 1993, pp. 13-39.
eo) Sull'argomento cf., da ultimo, CECCHINI 1991, pp. 683-89, ma su una più plausibile ricostruzione della statua originale, cf. Bist 1986-1987, pp. 107-21.
Storia dell'insediamento 41
frequente in quelle di Sulcise1). Questo rimaneggiamento apparentemente sacrilego, assieme alla
distruzioni di altri luoghi di culto fenici ad opera di Cartagine, come suggerito altrove, potrebbe forse alludere ad ulteriori motivazioni nell'aggressione cartaginese, in questo caso di ordine religiosoe2
) .
Il ricordo della presenza di un tempio e quindi di un luogo di culto esistente sulla sommità di Monte Sirai si è tramandato fin dalla più remota antichità e fin dali' abbandono dell'antico abitato, avvenuto a partire dagli anni attorno al 100 a.C., quindi da ben più di 2000 anni, per giungere fino ai giorni nostri. Infatti, nella memoria degli abitanti dell'attuale piccolo centro di Sirai, frazione del Comune di Carbonia ai piedi del versante orientale della collina, ancor prima dell'inizio degli scavi e ovviamente prima della scoperta della statua, il luogo era conosciuto per tradizione orale come una chiesa in rovina dedicata originariamente a Santa Maria di Sirai. In realtà, come è logico, la chiesa non è mai esistita poiché l'antico abitato sul monte è stato definitivamente abbandonato prima dell 'era cristiana e quindi la memoria del luogo di culto è da legare piuttosto al tempio della dea Astarte.
Le case di abitazione di età fenicia si appoggiavano sulla dorsale rocciosa che si estende dal Mastio verso sud-ovest e che oggi è interamente occupata dall'abitato della tarda età punica. Non ci è nota la struttura urbanistica dell ' insediamento o la rete viaria originale né conosciamo le piante di questi edifici più antichi, ma solo una parte delle strutture murarie che le componevano emergono tra le rovine del periodo successivo. Si può ipotizzare comunque che anche le abitazioni di epoca fenicia fossero del tipo consueto e cioè fossero formate da più ambienti raccolti attorno ad un cortile centrale.
L'età p unica
La comunità fenicia trascorse nell'abitato di Monte Sirai circa duecento anni di tranquilla attività commerciale, agricola e domestica fino a quando - attorno al 540 a.C. - Cartagine decise di porre piede in Sardegna per conquistarla ed inserirla nel suo territorio metropolitano. Già da tempo la città nord-africana sembrava aver manifestato le sue miree3
), ma solo nella seconda metà del VI secolo a.C. queste prendono realmente corpo. Infatti, con due successive invasioni, l'una avvenuta
' appunto attorno al 540 e l' altra verso il 520 a.C., Cartagine invase l' isola. E ampiamente noto come dapprima giungesse un esercito al comando del generale Maleo, che, vittorioso in Siciliae4
), dopo alterne vicende fu duramente sconfitto, probabilmente da una coalizione di città fenicie, e costretto a reimbarcarsi verso Cartagine.
In seguito- attorno al 520 a.C. -le armate cartaginesi passarono sotto il comando di Asdrubale e Amilcare figli di Magone e questa volta ebbero ragione della resistenza opposta dagli abitanti delle città fenicie di Sardegna. Infatti, le ostilità della città nord-africana erano rivolte soprattutto nei confronti di questi centri e pertanto anche verso Monte Sirai. Quindi, dopo aspri combattimenti, grandi stragi degli abitanti, queste solo intuibili, e radicali distruzioni, queste ultime invece facilmente constatabili sia a Monte Sirai che altrovee5), Cartagine se ne impadronl saldamente.
Dopo la conquista di tutta la Sardegna, Cartagine trasportò n eli' isola un notevole numero di
e1) Cf. S. MOSCATI, Le stele di Sulcis. Caratteri e Confronti (= CSF, 23), Roma 1986.
e2) cf. B ARTOLONI 1995 b, p. 257.
CZ3) cf. BARTOLONI 1995 b, pp. 257-58.
e4) S. F. BoNoì, Siciliae partem domuerant Maleo e la politica siciliana di Cartagine nel VI secolo a.C.: Studi
Moscati 1996, pp. 21-28.
f 5) Cf. ad esempio, BARTOLONI 1994 a, pp. 825-27; Cuccureddus, pp. 225-48; L. A. MARRAS, La stipe votiva di
Cuccureddus (= CAFP, 5), Roma 1999, in stampa.
42 Parte Prima
funzionari necessari all'amministrazione del territorio e di indigeni berberi nord-africani, destinati alla coltivazione intensiva dei cereali nei Campidani. Molte zone dell'isola, soprattutto quelle collinari, furono abbandonate poiché inadatte all'agricoltura di tipo latifondista, mentre numerosi nuovi insediamenti sorsero nelle-pianure. Dunque, mentre nei secoli precedenti l'isola aveva costituito . un fondamentale nodo di scambio tra Oriente e Occidente e tra il Settentrione e il Meridione del Mediterraneo, l'intera Sardegna fu accomunata al territorio metropolitano di Cartagine e fu rigorosamente chiusa ai commerci esterni. In particolare, cessarono praticamente tutte le importazioni dall'Etruria, mentre si instaurarono quelle con Atene, ma unicamente attraverso la mediazione di Cartagine e sotto il rigido controllo dei suoi funzionari.
A questo scopo la metropoli nord-africana stipulò con Roma e verosimilmente con molte altre città, soprattutto etruschee6
), alcuni trattati che di fatto imponevano una rigorosa limitazione ai traffici commerciali da e per la Sardegna, sempre e comunque sottoposti alla ferrea ispezione di Cartagine.
Negli anni scorsi si è pensato che l'intervento di Cartagine in Sardegna fosse motivato dalla necessità di difendere gli interessi delle città fenicie da una improvvisa rivolta delle popolazioni nuragiche e dalla crescente ingerenza greca nell'isola. In effetti però dapprima occorre sottolineare che tra le città fenicie di Oriente o quelle di Occidente non vi è mai stata una unità politica. Inoltre, tutti questi centri erano gelosi de11a propria indipendenza e al pari di quelli greci, erano tutti ordinati politicamente come città-stato. Infine, attualmente si ritiene non più ipotizzabile una rivolta delle tribù nuragiche, poiché sarebbe stata tardiva e immotivatae 7
). Infatti, per prima cosa non risulta che le popolazioni autoctone in qualche momento della loro storia siano state soggette a quelle di stirpe fenicia. Per di più, bisogna considerare che gli stanziamenti fenici lungo le coste sarde erano presenti da oltre due secoli e le popolazioni nuragiche, almeno per quanto riguarda quelle costiere, erano ormai saldamente inserite nella cultura e nel contesto urbano e civile fenicio. Quindi, ammesso che avessero voluto scrollarsi di dosso un supposto quanto improbabile giogo fenicio, avrebbero potuto farlo con maggiore successo nei secoli precedentie 8) .
In ogni caso, come gran parte delle città fenicie di Sardegna, anche Monte Sirai uscì completamente distrutta dalla conquista cartaginese. La metropoli africana, che aveva conquistato la Sardegna per impadronirsi soprattutto delle immense risorse agricole dell'isola, inserì anche a Monte Sirai dei coloni trasportati dalle coste del Nord-Africa.
I nuovi abitanti, forse anche di origine berbera e quindi portatori di una nuova cultura e di nuove usanze, trovarono una sistemazione attorno al nuovo luogo di culto del Mastio e quindi ripristinarono solo una parte degli edifici circostanti questo tempio, anch'esso devastato dagli eserciti cartaginesi. In particolare, si ricorda che è probabilmente proprio in questa occasione che venne totalmente rasa al suolo la torre nuragica che ospitava il tempio fenicio.
Dopo la sua conquista, il centro di Monte Sirai, o meglio quel poco che ne restava, fu abitato da non più di tredici famiglie di stirpe nord-africana. Ciò si deduce dalla presenza nella necropoli punica, re lati va appunto a questo periodo, di tredici sepolture di tipo p unico a camera sotterranea, che evidentemente, almeno in un primo momento, rappresentavano altrettante tombe di famiglia.
Infatti, mentre in epoca fenicia, a Monte Sirai come nei restanti insediamenti fenici di Sardegna e in genere del Mediterraneo occidentale, era in uso soprattutto il rito dell ' incinerazione del corpo in piccole fosse, in età p unica, vale a dire dopo la conquista
e6) M. CRISTOFANI, Gli Etruschi e i Fenici nel Mediterraneo: ACFP 2, pp. 7 1-75.
f 7) B AJm>LONI 1987 b, pp. 79-86.
es) G. L ILLilJ, Ancora una riflessione sulle guerre cartaginesi per la conquista della Sardegna: RANL, 3 (1992), pp. 17-35.
Storia dell'insediamento 43
cartaginese, divenne prevalente il rituale de11'inumazione dei defunti, che venivano sistemati all'interno di tombe a camera ipogeae9).
Nella prima età punica i pochi abitanti di Monte Sirai, divenuta zona marginale ed economicamente depressa, si dedicarono soprattutto all'agricoltura e la vita sul monte trascorse presumibilmente più o meno pacifica, ma certamente senza troppi soprassalti e con scarsi collegamenti commerciali se non con la vicina Sulcis, fino al terzo quarto del IV secolo a.C. circa, presumibilmente il 370/360 a.C. Attorno a questa data Cartagine decise di ristrutturare, ampliare e fortificare alcune tra le città più importanti della Sardegna e tra queste inserl anche il centro abitato di Monte Siraie0). In questo disegno fu compresa, oltre al Nord-Africa, anche la Sicilia. A questo scopo, probabilmente furono introdotti n eli' isola gruppi di coloni comprendenti soprattutto maestranze atte all'esecuzione delle opere. Le motivazioni sono certamente da ricercare nella politica espansionistica di Cartagine, forse anche in relazione con i moti insurrezionali che infiammarono i possedimenti cartaginesi del Nord-Africa e della Sardegnae 1
), sia forse in connessione con i potenziali pericoli derivanti dalla nascita e dalla veloce crescita della repubblica romanae2
), e quindi con la conseguente necessità di irrobustire i punti nevralgici dell'isola. Tra gli altri centri dell'isola furono cinte di mura le città di Karalis, Nora, Olbia, Sulcis, Tharros e furono fortificati ad esempio gli insediamenti extraurbani, forse da interpretare come castra, di Santu Antine di Genoni, di San Simeone di Bonorva, di Su Palattu di Padria e di Rassetto di Sant' Antiocoe3
) .
Quindi anche Monte Sirai fu fortificata e, grazie anche alla sua felice posizione naturale, fu resa praticamente inespugnabile. Le mura, tipologicamente e strutturalmente identiche a quelle di tutti gli altri centri citati, erano composte da più filari in pietra lavorata ed erano fonnate da blocchi di pietra da taglio in trachite rossa squadrati e con la faccia a vista decorata da un bugnato rustico con listello risparmiato. Dopo la costruzione della cinta muraria, l'insediamento di Monte Sirai iniziò rapidamente a crescere di dimensioni e di importanza. Fu forse insediata una piccola guarnigione e certamente nuovi e più numerosi coloni si aggiunsero ai precedenti. Il centro abitato si ampliò e, come estensione, si sovrappose almeno in buona parte alle rovine delle antiche abitazioni di epo-
, ca fenicia. E appunto relativo a questo periodo il primo impianto dell'area sacra del tofet, che testi-monia il sopraggiungere a Monte Sirai di ulteriori abitanti portatori di nuove e diverse usanzee4
).
In seguito allo scoppio della prima guerra punica, che, come è noto, ebbe una durata tra il 264 e il 241 a.C., allo scopo di prevenire eventuali sbarchi di contingenti militari romani, nei centri fortificati furono insediate alcune guarnigioni costituite da truppe mercenarie, ali' epoca soprattutto di
' provenienza iberica, ligure e campana. E forse da porre in connessione con gli eventi bellici la grande ristrutturazione dell ' abitato, poiché l'analisi cronologica dei materiali relativi al primo strato abitativo permette di collocarli appunto nel secondo quarto del III secolo a.c.e5
).
Quindi, sembra sia da attribuire proprio a questo periodo, e non a quello immediatamente successivo alla conquista romana della Sardegna, come proposto altrovee6), una radicale ristrutturazione dell'abitato, desunta dai recenti studi effettuati da Lorenza Campanella sulle ceramiche di
e9) BARTOLONl 1981 a, pp. 24-25.
e~ cr. B ARTOLONI-BONDì-MoscATI 1997, pp. 75, 89-90.
e1) BoNDÌ 1988 b, pp. 185-86.
e2) Cf. MELONI 1990, pp. 18-19.
e3) Sulle strutture di queste fortificazioni cf. BARRECA 1986, pp. 55-90.
(34
) Sull ' inquadramento cronologico del tofet di Monte Sirai, cf. , da ultimo, BoNoì 1992 c, pp. 55-59; BoNoì 1995, pp. 235-36.
e5) BoNDÌ 1988 b, p. 186.
e6) BARTOLONI 1995 C, pp. 21 0-11.
44 Parte Prima
importazione e di imitazione degli strati relativi agli ultimi secoli di vita dell'insediamentoe7).
L'insediamento cambiò totalmente il suo aspetto, l'impianto viario fu integralmente ritracciato e nuove abitazioni sorsero sul vecchio impianto fenicio. Lo stesso tempio del Mastio fu completamente ristrutturato.
A parte ciò, l ' insediamento di Monte Sirai a prima vista non fu sfiorato dagli avvenimenti bellici occorsi e neppure dalle conseguenze derivanti dalla grande battaglia navale che nel258 a.C. vide la flotta cartaginese opposta a quella romana nelle acque del Golfo di Palmas, in prossimità della vicina SulcisC8
). Infatti, anche se la flotta cartaginese fu apparentemente sconfitta, non vi furono palesi mutamenti nella vita delle città circostanti.
Subito dopo la fine della prima guerra punica, che vide il passaggio della Sicilia sotto il dominio romano, i centri del Nord-Africa e de11a Sardegna furono scossi da una rivolta delle truppe mercenarie di guarnigione che reclamavano la loro paga arretrata. Come è ampiamente notoC9),
Cartagine, ingaggiata nei territori della provincia nord-africana una lotta inespiabile e n1ortale contro i suoi antichi soldati, dopo aspri e violentissimi combattimenti vinse la sfida a caro prezzo. Infatti, poiché, secondo una subdola interpretazione del senato romano, Cartagine era entrata in guerra contro le sue truppe mercenarie in deroga al trattato di pace impostale dopo la fine della Prima Guerra Punica, la metropoli africana fu costretta da Roma a cedere la signoria della Sardegna. Dunque, senza colpo ferire, l'isola cadde sotto il dominio di Roma nel 238 a.C.
L'età neo-punica o romana
Dopo essersi impadronita della Sardegna, Roma si limitò a demolire e a radere al suolo tutte le fortificazioni erette da Cartagine, per evitare sul nascere eventuali tentativi di revanscismo e la creazione di possibili capisaldi di resistenza. In particolare furono completamente demolite le mura di Monte Sirai e tutti i materiali furono utilizzati per il rimaneggiamento del nuovo centro abitato. Anche in questo caso e nonostante i mutamenti radicali, la vita sul monte continuò attiva e anzi si ravvivò. Ciò poiché il centro abitato aveva onnai raggiunto la massima estensione della dorsale ignimbritica e già iniziavano a sorgere numerosi edifici anche al di fuori dei vecchi limiti dell'insediamento, in particolare nell'area della cosiddetta Opera Avanzata e nelle immediate adiacenze dell'angolo settentrionale del circuito murario(40
).
Ma, per cause non ancora interamente accertate, verso la fine del II secolo a.C. e, più precisamente, attorno al IlO a.C. l'abitato di Monte Sirai fu improvvisamente abbandonato. A quanto è dato di apprendere dalle indagini, ciò non accadde in maniera lenta e progressiva, ma in modo subitaneo e improvviso. Tutto questo si può desumere dallo stato delle abitazioni e dagli oggetti lasciati sul posto dagli abitanti. Infatti, le case relative all'ultimo periodo non presentano danni vistosi e gli oggetti di grandi dimensioni appaiono abbandonati nella loro collocazione di origine, mentre senza dubbio è sintomatica l'assenza dei piccoli recipienti e delle lucerne, che avrebbero dovuto essere presenti in caso di distruzione repentina e violenta.
Le cause di un abbandono tanto subitaneo dell'abitato di Monte Sirai probabilmente non sono da ricercare in fatti legati a episodi di guerra, poiché non vi sono tracce di distruzione o di incendio, ma piuttosto a eventi quali quelli che Roma denominava repressioni degli atti di brigantaggio. Infatti, è negli anni attorno alla fine del II secolo a.C. che fu dato forte impulso al soffocamento
e7) CAMPANELLA 1999.
es) BoNDì 1988 b. pp. 202-203.
e9) PoLIBIO, r. 65-88.
(40
) BARTOLONI 1995 C, p. 210.
Storia dell'im;ediamento 45
delle ribellioni che andavano serpeggiando nell'isola da ounai oltre un secolo(41). È probabile che
gli abitanti di Monte Sirai, collocati in una posizione difesa naturalmente, abbiano partecipato a una rivolta organizzata contro Roma o si siano dati al vero e proprio brigantaggio a spese dei traffici commerciali transitanti sulla sottostante strada di grande comunicazione, ma è anche possibile che l'abitato di Monte Sirai risultasse in viso ai Romani solo per la sua eccellente collocazione naturale. Si può ipotizzare quindi che, in seguito a questi ipotetici fatti, Roma abbia deportato gli abitanti per punizione o più semplicemente per metterli in condizione di non nuocere. D'altra parte un ulteriore e alternativo popolamento del luogo da parte di veterani è da escludere poiché il pianoro, se poteva ospitare una notevole quantità di bestiame, mal si prestava a colture a causa dell'acidità del suolo e ben difficilmente il monte avrebbe potuto essere incluso in una centuriazione.
Inoltre, accanto all'azione dell'uomo, non è da escludere che Monte Sirai sia stato abbandonato in seguito a qualche calanùtà naturale, quale ad esempio l'improvviso impoverimento delle risorse idriche. In ogni caso, a partire dagli anni attorno al 110 a.C. Monte Sirai apparentemente fu frequentato solo in modo occasionale. A testimonianza di queste frequentazioni sporadiche sono alcune monete di età costantiniana, deposte nel sacello del tempio del tofet nel IV secolo d.C., e un ampio frammento di vaso del VII secolo della nostra era con decorazione incisa a pettine, trovato nella cisterna del tempio del Mastio(42
).
Un piccolo e limitato insediamento di età tardo antica e medievale ha raccolto almeno in parte l'eredità del grande insediamento fenicio e punico. Si tratta di un santuario dedicato a Santa Maria posto in località Flumentepido su una collina mammifonne e particolarmente eminente per chi, seguendo la strada costiera, giunga da nord. Sulla collina è costruita una chiesetta restaurata recentemente che aveva la funzione di santuario agreste e che era officiata dagli abitanti di un piccolo borgo posto nella sella tra le pendi ci di Monte Sirai e la base dell'altura della chiesa. L'edificio, composto da un solo corpo di fabbrica, presenta lungo il lato orientale un piccolo porticato che poggia su alcune pietre miliari di età romana imperiale reimpiegate come pilastri.
Più a sud, in una località denominata Su Campu 'e sa Domu, sempre lungo l'antico tracciato della strada costiera, accanto a una sorgente, era ubicato un santuario dedicato probabilmente a Demetra, che, a giudicare dai materiali raccolti in superficie, doveva essere sorto attorno al III secolo a.C.(43).
(41
) BoNol 1988 b, pp. 205-208; MELoNI 1988, pp. 213-19.
(42
) Cf. BA!rrOLONJ 1992 d, p. 42, fig. 25.
( 43) BARTOLONI c.d.s. a.
STORIA DEGLI SCAVI E DEGLI STUDI
La collina di Monte Sirai ha destato l'attenzione degli studiosi del territorio fin dai primi decenni del secolo scorso grazie alla sua particolare forma e alla sua posizione emergente sul piano di campagna ed isolata nella piana costiera, che permettono di distinguerla nettamente anche da grande distanza.
Il primo studioso che fu attratto dalla struttura morfologica dell'altura e ne descrisse sia pur brevemente e in modo sommario le caratteristiche geologiche fu Alberto Perrero della Marmora, che, appunto per la sua peculiarità, la inserì nel volume Vojage en Sardaigne, pubblicato con una prima edizione nel 1826, e nella sua Carta topografica dell ' isola del 1845, la prima ad essere rilevata con moderni sistemi di triangolazione topografica ed eseguita correttamente secondo i criteri dell'U.T.M.
Invece, iJ primo a intuire e a citare la presenza di un antico centro abitato sul monte fu il Canonico Vittorio Angius che curò la parte storica nella monumentale opera sulla Sardegna edita da Goffredo Casalis a Torino tra il 1833 e 1856. Infatti, alla pagina 349 del Dizionario geografico, storico, statistico, commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna si può leggere quanto segue: « ... Sirài ... I molti rottami che trovansi in questo sito fan congetturare molto considerevole l'antico paese di questo nome, che distrussero i barbari ... >>e).
' E evidente che l'episodio riferito dali' Angius, legato ali' aggressione di non meglio precisate popolazioni barbare, è del tutto immaginario ed ha un valore puramente leggendario, poiché, come sembra più probabile in relazione alle indagini effettuate in questi ultimi anni e come detto più sopra, l'insediamento di Monte Sirai fu abbandonato più o meno volontariamente dai suoi abitanti.
In ogni caso, anche se non ne erano stati ancorà :accertati né l'origine né i caratteri, il centro abitato sulla collina nel 1892 destò nuovo interesse tra gli studiosi, quando Don Vincenzo Atzoni, Parroco di Tratalias e cultore di antichità, visitò la località di Monte Sirai e, rinvenute alcune stele del tofet, tra le quali sembra anche una, oggi purtroppo smarrita, recante una iscrizione punica, informò Filippo Vivanet, all'epoca Direttore del Regio Museo Archeologico di Cagliari. Sia detto per inciso, il racconto del rinvenimento di una stele con iscrizione punica da parte di un non meglio identificato Parroco è parte della tradizione orale tramandata anche attualmente nel circondario e viene collocato soprattutto attorno agli anni '40 del nostro secolo. A questi racconti fantastici sono da associare le leggende riguardanti le fantomatiche gallerie esistenti tra Monte Sirai e il nuraghe omonimo, leggende che del resto sono presenti in ogni comunità e in genere sono attribuite ad ogni antico monumento. :
Comunque, il Vivanet, per verificare la consistenza della scoperta e per non affrontare inutilmente un viaggio, che in quel periodo era lungo e non facile, inviò al Parroco una lettera contenente una lunga serie di precise domande. Le risposte fomite tempestivamente pern1isero al Direttore del Museo di constatare l'indubbia importanza dell'antico centro abitato. Tuttavia, i prevedibili disagi, creati dalla considerevole distanza dell'insediamento da Cagliari - 75 chilometri - e gli alti costi dell'impresa per il reperimento in loco della n1ano d'opera e per il trasporto degli eventuali reperti, costrinsero il Vivanet a rimandare di qualche tempo le indagini sulla collina.
Ma le speranze di Filippo Vivanet di realizzare le indagini progettate andarono deluse poiché,
(1) CASALIS 1833-1856, p. 349.
48 Parte Prima
a causa di ulteriori lavori altrettanto importanti ed urgenti in altre località de li' isola, non ebbe mai più la possibilità di interessarsi di Monte Siraie).
Dopo circa cinquanta anni di silenzio, all'inizio dell'ultima guerra mondiale sulla sommità del monte fu installata una batteria contraerea, oggi in parte restaurata e riutilizzata come luogo di ristoro per i visitatori. La batteria, che aveva il compito di proteggere dagli attacchi aerei le miniere di Carbonia, fondata il 18 dicembre del 1938, occupa un settore ove sono state rinvenute tracce forse di un villaggio di età neolitica, appartenente alla Cultura di San Michele. Sempre nello stesso luogo è stata individuata parte di un santuario di età ellenistica, sorto dopo la conquista romana della Sardegna e dedicato probabilmente a Demetra. I soldati occuparono e utilizzarono come rifugio antiaereo anche una tomba a camera ipogea della necropoli punica, ma in nessun caso si resero conto della presenza di un antico centro abitato o, qualora se ne siano resi conto, fortunatamente nulla fecero per esplorarlo e renderlo maggiormente noto.
Nel frattempo, le pietre trachitiche crollate appartenenti alle antiche abitazioni erano state ampiamente utilizzate per la costruzione della città di Carbonia. I lavori, iniziati nel 1935, si conclusero alla fine del 1938, periodo in cui fu inaugurata ufficialmente la città. Quindi, anche se la città sorse dal nulla, poiché nessun centro abitato le preesisteva, si può ben dire che in qualche modo la città è fondata su antiche testimonianze. In particolare, il tornante finale dell'attuale strada di accesso fiancheggia una cava di ignimbrite attiva fino quasi ai giorni nostri, poiché anch'essa ha contribuito alla costruzione dell'attuale città di Carbonia. Anche se taluno tende a rifiutare un continuum storico tra l'antico e l'attuale abitato, continuum che, a rigor di logica, è inesistente, il reimpiego delle pietre delle abitazioni fenicie e puniche di Monte Sirai nella città di Carbonia costituisce un legame emotivo culturalmente indissolubile.
Per la definitiva riscoperta di Monte Sirai si deve giungere fino al periodo attorno alla seconda metà del nostro secolo e più precisamente al 1962 per ritrovare chi fu attratto di nuovo dai resti dell'antico insediamento. Si tratta di Antonio Zara, all 'epoca giovane studente della vicina Carbonia e oggi Assistente Principale della Soprintendenza Archeologica, che, appassionato per la storia della Sardegna e per le origini della civiltà nell'isola, visitava gli antichi monumenti. Salito sul monte, lo studente si imbatté nel tofet, visto a suo tempo dal Parroco di Tratalias e, intuitane l'importanza, ne comunicò immediatamente la scoperta a Vittorio Pispisa, Ispettore Onorario per la zona del Sulcis per conto della Soprintendenza alle Antichità. Constatata la rilevanza dei monumenti, ne fu immediatamente informato a sua volta Gennaro Pesce, allora Soprintendente alle Antichità di Cagliari e Oristano.
Fu inviato sul posto Ferruccio Barreca, all'epoca giovane Ispettore della Soprintendenza, che subito dispose il recupero delle stele rinvenute nel tofet e il loro temporaneo trasferimento nel più vicino luogo sicuro. In attesa di essere trasferite al Museo Nazionale di Cagliari, le stele trovarono provvisorio ma eccellente asilo nelle camere di sicurezza del Comando della Compagnia dei Carabinieri di Carbonia. Contemporaneamente, sempre a cura di Ferruccio Barreca, iniziò una serie di esplorazioni archeologiche sul monte, per verificare l'estensione e la consistenza dei monumenti, per constatarne lo stato di conservazione e per disporre una prima serie di interventi di salvaguardia.
Ferruccio Barreca, succeduto a Gennaro Pesce come Soprintendente Archeologo dal 1967 al 1986, può essere certamente considerato uno dei rifondatori di Monte Sirai, poiché si deve alla sua indefessa e competente opera di archeologo se l'antico insediamento è stato esplorato e valutato in tutta la sua giusta importanza e se oggi è pervenuto al mondo degli studi e alla pubblica fruizione.
Non appena ritornato a Cagliari, Ferruccio Barreca comunicò la considerevole consistenza e il cospicuo interesse dei monumenti rinvenuti all'allora Soprintendente, Gennaro Pesce, il quale pre-
e) Su queste vicende cf., da ultimo, MoscATI 1988 a, pp. 167-72.
Storia degli scavi e degli studi 49
dispose immediatamente un progetto di intervento e di valorizzazione dell'antico insediamento di Monte Sìrai. A questo scopo prese contatti con Sabatino Moscati, studioso di antichità semitiche e all'epoca Direttore dell'Istituto di Studi del Vicino Oriente dell'Università di Roma.
Nel corso del 1962 fu siglato un accordo tra la Soprintendenza alle Antichità di Cagliari e Oristano e l'Istituto di Studi del Vicino Oriente dell'Università di Roma che aveva lo scopo di promuovere una serie di campagne archeologiche a Monte Sirai, che avrebbero avuto inizio nel 1963.
Fu fonnata una équipe congiunta della quale facevano parte come direttori dei lavori Ferruccio Barreca, Ispettore della Soprintendenza di Cagliari, e Giovanni Garbini, allora giovane Professore di Epigrafia Semitica dell'Università di Roma. Nel settembre di quell'anno furono iniziati i lavori nelle aree del tofet e della necropoli e si intraprese una prima esplorazione della zona antistante il centro abitato, attualmente nota con il nome di Opera avanzata.
Ma, nel frattempo, la notizia della scoperta si era ampiamente diffusa nel circondario e, prima dell'inizio dei lavori, alcuni scavatori clandestini, saliti sul monte e individuate alcune tombe a camera sotterranea della necropoli punica, per trafugarne più facilmente i reperti, ne scoperchiarono una facendone saltare il tetto con la dinamite. Altre due furono violate e depredate con sistemi meno drastici, ricorrendo cioè a strumenti più tradizionali. Nell'occasione fu anche asportata la testa demoniaca che pendeva dal soffitto della Tomba ipogea l*.
Fortunatamente però questa volta il furto non ebbe gran fortuna poiché le indagini, subito avviate congiuntamente dal Personale della Soprintendenza e dalla Compagnia dell'Anna dei Carabinieri presente a Carbonia, portarono ali' immediato arresto dei responsabili e al recupero di tutto il materiale trafugato, che era stato momentaneamente accantonato in una fattoria abbandonata ai piedi del versante occidentale del montee). I materiali delle tre tombe ipogee erano stati accatastati alla rinfusa dai trafugatori, quindi è stato impossibile ricostruire i tre diversi corredi.
La prima fase degli scavi in collaborazione tra la Soprintendenza di Cagliari e l'Università di Roma ebbe dunque inizio nel 1963 e terminò nel 1966. Dopo le prime indagini effettuate nelle aree della necropoli e del tofet(4
), a partire dal 1964 fu intrapresa l'esplorazione dell'abitato. Ali' impresa effettuata in quegli anni, oltre a Sabatino Moscati e a Gennaro Pesce, che coordinarono il comune lavoro, e a Ferruccio Barreca e a Giovanni Garbini;che diressero le attività sul terreno, parteciparono alcuni giovani studiosi e studenti dell'Università di Roma. In particolare si ricordano, oltre a chi scrive, Maria Giulia Amadasi, Isabella Brancoli, Serena Maria Cecchini, Patrizia Moretti, Bice Pugliese, Maria Luisa Uberti. Dal 1965 si affiancarono all'équipe anche Mhamed e Dalila Fan tar.
Per quanto riguarda i lavori svolti, in particolare, dalla seconda campagna di scavi è stato ampiamente indagato il cosiddetto Mastio, che era un luogo di culto e come tale l'edificio principale dell'antico insediamento. Contemporaneamente fu iniziato e portato a compimento il disboscamento de li' intera area abitata, che nel corso dei secoli era stata completamente ricoperta dalla macchia mediterranea. Di questi arbusti emergeva dalle macerie unicamente la chioma, mentre il fusto era inserito tra il pietrame. Quindi, mentre la chioma germogliava piegata dalla forza del Maestrale, il tronco invece, protetto dal crollo dello spessore di oltre un metro, cresceva in verticale. Il disboscamento e lo spietramento dell'area dunque hanno dato origine agli olivastri che oggi crescono sul monte con l' onnai caratteristico aspetto, che però, per i motivi addotti più sopra, è da considerare completamente artificialee).
e) Per una più ampia descrizione dei fatti esposti, cf. MoSCATI-PESCE 1964, pp. 7-10.
(4) Cf. BAR RECA 1964, pp. 11-63; GARBINI 1964 a, pp. 65-99: MoscATI-PEscE 1964, pp. 7-1 O; sulla storia degli studi nell'area del tofet, cf., da ultimo, BoNol 1995, pp. 223-38.
e) BARRECA 1965 a, pp. 13-17; BARRECA 1965 b, pp. l 9-62; BARRECA 1965 C, pp. 63-78; GARBINI 1965, pp. 79-92.
50 Parte Prima
N el 1964 e nel 1965 furono scavate rispetti v amen te le Tombe 11 * e 12 *, le due ultime tombe ipogee della necropoli punica ancora intatte(6
). Inoltre si proseguì con l'indagine del settore meridionale del tofet, ponendo in luce alcune deposizioni di età tarda e procedendo al recupero dei frammenti "di stele sparsi nell'area(). Contemporaneamente fu parzialmente indagato un edificio di abitazione di tipo rurale posto al centro del pianoro, che si rivelò essere stato in uso non prima della fine del III secolo à.C.(8).
Nel 1966, a cura di Maria Giulia Amadasi e di Mhamed e Dalila Fantar, furono messi in luce nell'abitato due edifici di abitazione privati costruiti attorno alla metà del III secolo a.C.(9). Sempre nell'abitato, ad opera di Luisa Anna Marras e di Renato Monticolo, allora neolaureati dell'Università di Cagliari, nel 1979 furono esplorati due vani abitativi nei settori A e B de li' Acropo
li. Contemporaneamente veniva effettuata una accurata e capillare prospezione archeologica de1
monte che portava al rinvenimento della rete viaria interna e di approccio ali' abitato, di alcuni piccoli nuraghi, collocati in posizione periferica lungo i fianchi del rilievo, e della fattoria tardo-punìca citata più sopra, posta al centro del pianoro sommitale. I risultati di tutti questi lavori sono stati pubblicati in quattro volumi, intitolati Monte Sirai I-IV, editi tra il 1964 e il 1967(10
).
Dopo una stasi nei lavori durante l'arco degli anni '70, nel 1980 sono state riprese le indagini nell'area sacra del tofet( 11
). Fin dall'inizio i lavori sono stati condotti da Sandra Filippo Bondì, che negli anni precedenti, tra il 1972 e il 1980, aveva curato lo studio, il catalogo e la pubblicazione delle stele rinvenute nel tofet di Monte Sirai durante i lavori effettuati tra il 1963 e il 1966(12
).
Gli scavi, conclusi nel 1985 e pubblicati fino al 1987, hanno pennesso di fare piena luce sulla reale sistemazione dell'area sacra e sull'effettiva struttura architettonica del monumento( 13
), mentre lo studio dei materiali, tra i quali le stele e le numerose urne cinerarie, ha consentito di dare al tofet una precisa collocazione cronologica nel quadro della storia di Monte Sirai( 14
).
Nel 1979, a cura di chi scrive, furono effettuati alcuni saggi stratigrafici nel settore della cosiddetta Opera avanzata, al fine di individuame con precisione i limiti cronologici che, per quanto riguarda le abitazioni, si sono dimostrati non anteriori alla seconda metà del III secolo
15 . a.C.( ).
.
Già da tempo alcuni ritrovamenti sporadici effettuati sul monte avevano pe1 messo di intuire la presenza di una necropoli ad incinerazione di età fenicia, ma solo nel 1980 durante l'esecuzione di alcuni lavori di restauro e di protezione effettuati al margine della necropoli punica ne era stata individuata l'esatta collocazione( 16).
(6) AMADASI-BRANCOLI 1965, pp. 95-121; FANTAR 1966, pp. 63-81.
C) CECCHINI 1965, pp. 123-33.
(8) BARTOLONI 1965, pp. 135-37.
(9) AMADASI 1967, pp. 55-93; fANTAR 1967, pp. 27-54.
e o) Per l'analisi delle indagini effettuate in questo periodo cf. MoscATI 1967' pp. 95-100.
e 1) BARRECA-BONDl 1980, pp. 143-45; M osCATI 1983 a, pp. 183-91.
('2
) BoNol 1972.
(13
) BoNoì 1981, pp. 217-22; BoNoì 1982, pp. 273-81; BoNoì 1983, pp. 193-203; BoNoì 1984, pp. 185-98; BoNoì 1987' pp. 179-90.
('4) SARTOLONI 1981 b, pp. 223-30; BARTOLONI 1982 C, pp. 291-94; BoNDl 1980 a, pp. 51-70.
( 15) Le indagini furono da me effettuate su esplicita richiesta e per conto di Fenuccio Barreca; cf. BARTOLONI 1995 a, p. 99.
('6) SARTOLONI 1981 a, pp. 24-25; BARTOLONI )982 a, pp. 265-70; BARRECA 1983, pp. 294-95.
Storia degli scavi e degli studi 51
I lavori, condotti da chi scrive, sono iniziati nel 1981, temporaneamente interrotti nel 1987(17)
e ripresi nel 1996, ed hanno consentito di porre in luce alla data attuale oltre cento tombe a fossa di età fenicia, databili tra il 600 e il 525 a.C., nelle quali era praticato in prevalenza il rito dell'incinerazione, anche se, come si vedrà, non mancano testimonianze di individui inumati. In ogni caso, in questa sede si tratta delle indagini effettuate nel primo periodo - tra il 1981 e il 1987 - nel quale sono state individuate 72 sepolture. Di questi lavori sono state date più volte notizie preliminari, notizie che, per altro, sono state via via fomite anche per quanto riguarda le indagini più recenti ( 18
).
Attualmente le indagini a Monte Sirai, oltre che nell'area della necropoli, hanno luogo nella zona dell'antico abitato(9), noto anche con il nome di Acropoli, sempre a cura di chi scrive e per conto dell'Istituto per la Civiltà fenicia e punica del Consiglio N azionale delle Ricerche, che fin dal 1969 si è sostituito nelle ricerche all'Istituto di Studi del Vicino Oriente dell'Università di Roma. Come è noto, i lavori avvengono costantemente in proficua collaborazione con 1a Soprintendenza Archeologica di Cagliari e Oristano. Alcuni giovani studiosi hanno la bontà e l'entusiasmo di offrire la loro collaborazione e, tra questi, Carla Perra e Stefano Finocchi, che hanno diretto i lavori ali' abitato rispettivamente tra il 1996 e il 1998 e nel 1999, Lorenza Campanella e Debora Martini, che hanno seguito l'esplorazione della necropoli tra il 1997 e il 1999. Emanuela Solinas, che è coautrice di questo volume, e Laura Impagliazzo hanno curato quelli alla necropoli nel 1996.
L'insediamento nuragico, fenicio e punico di Monte Sirai è oggi un campo di scavo dove si applicano alle indagini archeologiche giovani studiosi e studenti che provengono prevalentemente dalle Università di Cagliari, Genova, Padova, Pisa, Roma, Santa Maria Capua Vetere, Urbino e Viterbo. L'interesse destato dall'insediamento nel corso degli anni è attestato dall'elenco delle abbreviazioni posto all'inizio di questo volume, che corrisponde in buona parte alla bibliografia generale sul sito.
e7) B ARTOLONl 1982 b, pp. 283-90; BARTOLONI )983 a, pp. 35-53; BARTOLONf 1983 b, pp. 205-17; BARTOLONI 1985 a,
pp. 247-63; BARTOLONI l 987 a, pp. 153-59.
es) BARTOLONI 1998, pp. 353-58.
(19
) BARTOLONI 1994 b, pp. 75-82; BOTrO 1994, pp. 83-115; PESERICO 1994, pp. 117-44.
IL CENTRO ABITATO
Negli anni passati, subito dopo la sua scoperta e dopo i primi anni di scavi che avevano posto in luce strutture in parte composte da elementi architettonici con modanature particolari, era stata data una interpretazione dell ~insediamento in chiave soprattutto militare. Infatti, si era ritenuto che si trattasse di una fortezza, prima fenicia e poi punica, costruita assieme ad altre principalmente ai fini di uno stretto controllo del territorio e in opposizione a11e popolazioni nuragiche, che in genere venivano considerate piuttosto turbolente e mal tolleranti una supposta intrusione del loro ambiente da parte delle genti vicino-orientali, la cui politica invece veniva interpretata in chiave unitariae).
Studi più recenti e comparati con la situazione dei restanti insediamenti fenici, soprattutto nei rapporti politici e commerciali con il mondo autoctonoe), hanno ormai dimostrato che fin dalla sua origine, l'abitato di Monte Sirai ha avuto unicamente caratteristiche di tipo civile e solo per un breve periodo, probabilmente tra il secondo quarto del IV secolo a.C. e il 238 a.C., è divenuto un centro fortificato. In ogni caso, la sua posizione isolata ed elevata sul piano di campagna circostante lo ha sempre reso comunque abbastanza sicuro e naturalmente protettoe).
Poiché sono entrati ormai nella consuetudine e nel lessico del sito, si è preferito conservare i nomi con i quali venivano abitualmente indicati i vari settori o i singoli edifici dell'insediamento, quali ad esempio, l'Acropoli(4
) o l'Opera avanzatae), che corrispondono all'abitato di età punìca. Tra questi il Mastio(6
), che, pur essendo un edificio di indubbia robustezza, costruito per di più sui resti di una torre nuragica, in realtà costituisce il principale luogo di culto dell'insediamento e, almeno fino ad oggi, forse l'unico dell'area abitata.
Le vie di accesso
L'abitato di Monte Sirai è collocato nel varco naturale che chiude la regione sul ci tana nel suo versante settentrionale e domina al contempo sia la strada che, dalla costa occidentale, giunge al Campidano e alle spalle di Cagliari, sia la strada costiera che congiungeva il bacino minerario dell'Iglesiente con Sulcis (Fig. 1).
Il fianco meridionale della regione sulcitana era invece custodito dali' insediamento costiero di Bitia, collocato alle spalle del passo che tagliava l'impervia e tonnentata costa meridionale. In particolare, il centro occupava un enclave privo di sbocchi verso il settore occidentale della costa e controllava Ja via che s'inerpicava tra le montagne, aggirando il massiccio montuoso di Capo Spartivento, per raggiungere poi, dopo molti chilometri, la costa sud-occidentale.
Volti a congiungere il Campidano, nel lato orientale della regione sulcitana sboccavano due
e) Sull'analisi di questa interpretazione, cf. BARTOLONI 1987 b, pp. 79-86 e, da ultimo, BARTOLONI-BONDì-MOSCATI
1997, pp. 38-40.
e) BARTOLONI-BONDl-MOSCATI 1997, pp. 10-37.
e) Cf. BARTOLONI 1994 a, pp. 817-29; BARTOLONI 1995 a, pp. 99-108.
(4
) BARRECA 1965 b, pp. 25-29.
e) BARRECA 1965 b, pp. 19-25.
(6
) BARRECA 1965 b, pp. 29-36.
54 Parte Prima
itinerari che si aprivano la via, quantunque tortuosa e impervia, tra i monti sulcitani. Il più settentrionale dei due percorsi traeva origine dalla valle del Cixerri, che costituiva il margine settentrionale della sub-regione, e transitava in quota presso l'attuale colle di Campanasissa. Quello meridionale invece iniziava dal margine sud-occidentale della piana costiera caralitana e, seguendo verso sud-ovest il corso del Riu Gutturu Mannu, valicava la regione di Pantaleo, incastrata tra rilievi di oltre l 000 metri di quota. I due percorsi si congiùngevano nel settore nord-orientale della valle del Riu Palmas, dove era ubicato l'insediamento fenicio di Paniloriga. Al pari di quelli di Monte Sirai e di Bitia, questo centro conserva numerosissime vestigia di età prenuragica e nuragica, a testimonianza della sua peculiare collocazione.
L'antica via di comunicazione costiera che collegava il bacino minerario dell 'lglesiente con la città di Sulcis, principale porto del circondario, correva più a ovest e più vicino alla costa rispetto all'attuale tracciato. La strada, provenendo da nord, toccava sul versante occidentale il santuario di Santa Maria di Flumentepido, posto su un rilievo mammiforme. Che il percorso transitasse nelle immediate vicinanze di questo santuario è dimostrato anche dal colonnato che attualmente sorregge il portico dell'odierna chiesa ed è composto esclusivamente da caratteristici miliari cilindrici di età romana imperiale. L'itinerario quindi percorreva la base delle pendici occidentali della collina di Monte Sirai (Fig. 3), traversava una lieve depressione ubicata nella località denominata sintomaticamente Arcu de Ulmus, collocata e controllata dai nuraghi Piliu, a ovest, e Nuraxeddu, a est, collocati entrambi su modesti rilievi. Sia il nuraghe Piliu che il suddetto Arcu de Ulmus sono ubicati su una dorsale che, sorgendo dalle pendici di monte Sirai, si protende verso ovest. Quindi il tragitto, lasciato ad est il nuraghe Sirai e traversata la piana di Su Campu 'e sa Domu (Fig. 2), giungeva a sfiorare il santuario omonimo, per poi proseguire verso sud. Infine, la strada transitava a sinistra della cresta ignimbritica di Locci Santus per poi affrontare la traversata dell ' istmo, custodito dai menhirs di Su Para e Sa Mongia eretti nel neolitico recente(), e finaln1ente giungeva al porto di Sulcis.
Mentre l'unica strada attuale che conduce al pianoro è stata tracciata solo da pochi decenni per consentire la realizzazione e l'accesso alle batterie antiaeree che durante l'ultima guerra mondiale avevano il compito di difendere gli impianti minerari di Carbonia, le due antiche strade di accesso all'abitato di Monte Sirai erano tracciate su altri versanti della collina. La strada che si percorre ai giorni nostri segue il fianco nord-orientale della collina e con un tornante supera il crinale roccioso attraverso una breccia ricavata artificialmente. ll tornante finale della strada fiancheggia una cava di ignimbrite attiva fino quasi ai giorni nostri, poiché, come già accennato, l'attuale città di Carbonia è stata in gran parte costruita con materiali cavati dalle rovine di Monte Sirai(8
).
Quanto alle strade tracciate in età antica, la principale scendeva lungo il versante occidentale della collina (Fig. 4, a) e, percorrendo la valle della necropoli, conduceva ad una sorgente perenne che, oltre all'acqua raccolta nelle cisterne, costituiva l'unico approvvigionamento idrico per il centro abitato. L'origine del sentiero, carrabile come dimostrato dalle tracce lasciate dalle ruote dei veicoli a trazione animale antichi e n1oderni, era nello spazio tra la parte di abitato nota con il nome di Opera avanzata e l'ingresso all'abitato. La carrareccia, toccata la sorgente citata, conduceva verso la piana che si affaccia a nord-ovest del monte, probabilmente coltivata dagli abitanti di Monte Sirai, e si innestava nella grande strada costiera. Questa, che collegava la zona mineraria dell'lglesiente con Sulcis e che fino al secolo scorso correva ad ovest di Monte Sirai tra la collina e il mare, attualmente transita lungo il versante orientale del monte(>).
Una ulteriore strada di accesso, anch'essa percorribile dai carri, si staccava sempre dalla stra-
C) LILUU 1995, p. 24.
(8
) BARTOLONI 1992 C, pp. 28. 109. fig. 9.
(9) BARRECA 1964, pp. 56-57 e, da ultimo, BARTOLONI J 992 c, p. 31.
Il centro abitato 55
da costiera, ma circa un chilometro più a sud della precedente, in prossimità del nuraghe Nuraxeddu. La strada (Fig. 4, b), sfruttando la cresta trachitica in pendenza, relativa al primo grande terrazzamento inclinato posto sul versante meridionale del monte, giungeva suJ pianoro in corrispondenza con 1' Opera avanzata. Anche in questo caso sono visibili i solchi lasciati nella roccia dalle ruote dei carri, a testimonianza del considerevole traffico che ha interessato l'insediamento dall'antichità fin quasi ai giorni nostriC0
). ' E probabile che entrambe le strade abbiano avuto origine in età nuragica, se non addirittura in
precedenza, poiché la strada di accesso meridionale al monte aveva inizio in prossimità del nuraghe Sirai e, prima di affrontare la salita verso la sommità del monte, transitava accanto al nuraghe Nuraxeddu .
Resta da citare un sentiero esclusivan1ente pedonale che scende dal crinale nel versante orientale attraverso un varco nella cresta trachitica e giunge in prossimità dell'attuale nodo stradale, che tuttavia non esisteva in età anticaC 1). Il sentiero taglia in diagonale da sud a nord il fianco del monte con un angolo di circa 45° ed è tracciato nel versante più elevato della collina dove, tuttavia, il piano di campagna si eleva maggiormente.
L'Opera avanzata
La parte dell'abitato, nota con il nome di Opera avanzata (Fig. 4, c) e anch'essa interamente costruita attorno alla metà del III secolo a.C., è esterna al perimetro dell'agglomerato urbano principale ed è situata su un basso zoccolo di ignimbrite che si erge davanti all'ingresso dell'acropoli. In questa zona, sia lungo il crinale che nella parte centrale, sono ubicati alcuni edifici di abitazione, in precedenza ritenuti torri difensive, ma che in effetti sono stati edificati nel corso del III secolo a.c.e 2
), quindi, dopo l'occupazione romana e il conseguente smantellamento delle fortificazio-•
n t.
Nel settore della cosiddetta Opera avanzata si notano tra l'altro due edifici, uno situato al centro (Fig. 4, d) e l'altro all ' estremo occidente dell'area (Fig. 4, e), entrambi fonnati da due corpi di fabbrica posti ad angolo, che ali' origine dovevano essere raccordati da un muro o da uno steccato, oggi scomparsi, e che probabilmente racchiudevano il cortile della casaC3). Ne11a parte nord-orientale invece si possono notare due abitazioni composte da più ambienti, ubicate nel versante settentrionale presso lo sbocco della strada carraia che dal nuraghe Nuraxeddu conduceva alla sommità del monte. La prima abitazione (Fig. 4, f), denominata originariamente Torre N. 1(14
) , è costituita da un grande ambiente rettangolare ripartito da tramezzi al quale si addossa un piccolo vano costruito con grandi ortostati di trachite posti di coltello. La seconda abitazione (Fig. 4, g), un tempo interpretata come porta a tenagliaC 5
), in effetti è composta da più vani i cui muri hanno un andamento curvilineo e senza dubbio per alcuni aspetti ricorda le capanne nuragiche di tipo pluricel1ulare presenti nel grande villaggio di Seruci('6). Lungo il crinale sud-orientale è possibile notare
('0
) B ARTOLONI 1992 c, pp. 3 1-32; le strade conservano vistose tracce di carrate, che, quando sono incise nel tufo, probabilmente riguardano un traffico recente volto a11a raccolta della legna sul pianoro del monte.
(11
) B ARTOLONI 1992 C, p. 32.
(12
) Su questo settore cf. BARRECA 1964, pp. 13-19; B ARRECA 1965 b, pp. 19-25; sulle indagini effettuate e sulla sua cronologia, B ARTOLONI 1995 a, pp. 99-101.
(~) BARRECA 1964, pp. 16-19.
(14
) B ARRECA 1965 b, pp. 20-21; B ARTOLONl 1995 a, p. 99 .
('5) B ARRECA 1965 b, p. 20.
('6
) Cf. A. TARAMELLI, Gonnesa. Indagini nella cittadella nuragica di Serrucci: MAL, 24 (1917), coli. 633-96 e, da ultimo, V. SANTONI-G. BAcco, L'isolato A del Villaggio nuragico di Serucci - Gonnesa. Lo scavo dei vani 3 e 6: QuadCagliari, 5 ( 1988), pp. 39-64.
56 Parte Prima
quanto resta di un tratto de11e fortificazioni in blocchi con bugnato rustico (Fig. 4, h). Si tratta evidentemente di quanto sussiste di un saliente volto a controllare lo sbocco sul pianoro della via di accesso principale.
L'Acropoli
L'originaria area abitativa di Monte Sirai sorge su un mammellone trachitico di fonna vagamente ellissoidale allungata. Un lato dell'area si affaccia sul versante meridionale ed è precipite con varianti di quota che, dai 4/5 metri in prossimità dell'Opera avanzata, giungono almeno a 20/25 metri decisamente strapiombanti verso la parte occidentale. Gli altri versanti, invece, pur scoscesi, non superano i 4/5 metri di dislivello sul piano di campagna circostante, ma sono pur sempre eminenti e si ergono con stacco netto. In sostanza, si tratta di un settore naturalmente difeso, che si eleva sul pianoro già di per sé protetto. L'ingresso all'area dell'abitato, nota anche con il tradizionale nome di Acropoli, avviene attraverso un corridoio fortificato che percorre in leggera salita lo spessore de Be abitazioni che si affacciavano verso l' estemoC 7) . Dunque, i muri perimetrali degli edifici di abitazione, appoggiati alla roccia strapiombante, fungevano anche da mura urbane, mentre i tetti delle stesse case, generalmente piatti, costituivano i possibili camminamenti di ronda.
Ai lati dell 'ingresso, davanti agli edifici summenzionati, si notano due lunghi muri che delimitano l'area davanti alla cinta muraria e restringono notevolmente lo spazio tra l'abitato, e l'Opera avanzata. Si tratta del pomerio (Fig. 4, i), rappresentato da un fossato artificiale che costituisce una delle opere difensive costruite attorno alla metà del Ill secolo a.C.C8
) .
Il corridoio di accesso al cuore dell'abitato (Fig. 4, j) è rappresentato da un camminamento incassato che sfrutta con ogni probabilità una crepa naturale aperta nello zoccolo di trachite su cui è impiantato l'abitato. I muri che lo fiancheggiano avevano evidentemente il duplice scopo di regolarizzare il passaggio e di rendere impossibile o, comunque, assai difficile la scalata agli edifici che stavano ai lati dell'ingresso. A destra dell'ingresso imbutifoune, nel punto di innesto tra il muro esterno del fossato artificiale e il lato destro del varco, si può notare una rientranza che fo11na uno spazio di circa un metro quadrato, la quale poteva costituire il posto di guardia nella caratteristica posizione sceact9
) .
Attraversato il corridoio di ingresso, a metà circa della sua lunghezza si può constatare la presenza di una soglia palesemente posticcia, che in questo allestimento non corrisponde di certo alla prima sistemazione del corridoio, ma che probabilmente è stata collocata nella terza e ultima fase di vita dell'abitato di età tardo-punica, cioè attorno al 150 a.c.e0
). Percorso interamente il corridoio, si sbocca nella unica piazza dell ' abitato degna di questo nome che, nel lato destro, è occupata dalla facciata del cosiddetto Mastio (Fig. 4, k), principale e ancora attualmente unico luogo sacro dell'intero abitato, se si escludono il tempio del tofet e il santuario agreste a nord delJ'intera area archeologica, entrambi extra moeniae 1
).
Dali' angolo occidentale della piazza ha origine una strada che corre lungo il lato meridionale del tempio e dalla quale, a loro volta, si staccano tre strade dirette verso sud. Queste tre arterie ini-
(17
) Cf. BARRECA 1965 b, pp. 27-29.
(18
) B ARRECA 1966 b, p. 50~ B AIUOLONr 1995 a, p. 101.
(19
) B ARRECA 1965 b, p. 28.
eo) BARRECA 1965 b, pp. 28-29.
CZ1) Si tratta di un piccolo santuario, del quale erano conservate labili tracce, che era ubicato nel punto di incrocio
tra la strada che, percorrendo il pianoro, conduceva a nord e il sentiero che portava al tofet; il santuario si sovrapponeva a strutture riferibili alla cultura Monte Claro: cf. UsAI 1993, p. 314.
Il centro abitato 57
zialmente hanno un percorso parallelo, che diviene poi convergente nella loro parte finale che coincide con la parte più bassa dell' abitatoe2
). Le tre strade dividono i quattro grandi isolati, che, assieme a1Ie insulae ubicate in prossimità dell'ingresso e a quelle affacciate ali ' esterno, componevano l'intero centro abitato e si incontrano all ' estremità meridionale dell ' insediamento, in una ulteriore piazza di fonna vagamente triangolare, se così si può chiamare viste le esigue dimensioni.
Oltre all'edificio del cosiddetto Mastio, apparentemente non risultano tracce di altre opere pubbliche, che tuttavia dovevano certamente esistere, prime tra tutte ulteriori luoghi di culto. Negli anni passati si era ritenuto che una vasta depressione nel banco di ignimbrite ubicata nella succitata piazza meridionale (Fig. 4, l) costituisse una sorta di cisterna di uso pubblico. Thttavia, si è potuto constatare che si tratta di una semplice crepa naturale nel terreno roccioso la quale forse non era, e certamente oggi non è, in grado di trattenere l'acqua pio vana per più di un giorno e che, per di più, non conserva tracce di antiche sistemazioni. Non è dato di percepire se le sue pareti fossero intonacate, ma la totale assenza di strutture lungo il suo perimetro pennette di escludere che si trattasse di una cisterna, inconcepibile a cielo apertoe3) .
Il Mastio
Come accennato, nell'area dell 'abitato di Monte Sirai per il momento è stato individuato un solo luogo di cultoe4
), dedicato in questo caso alla dea Astarte, per il quale si possono percepire tre successive fasi di vita. L'edificio è particolarmente importante poiché è l'unico manufatto dell'intero abitato che sia stato utilizzato con continuità dalla fondazione dell'insediamento fino al suo abbandono. Il luogo di culto era situato nell'edificio comunemente noto con il nome di Mastio, poiché nel momento iniziale delle indagini si era ritenuto che si trattasse di un edificio fortificato, adibito esclusivamente alla difesa del centro abitato. L'edificio, del quale si è potuta appurare la qualità di luogo di culto, si trova affacciato sulla piazza e immediatamente a destra per chi entra attraverso il corridoio di accesso all'acropoli.
Nel periodo relativo all'insediamento fenicio, cioè tra la metà dell'VIII secolo a.C. e il 525 a.C. circa, si è potuto accertare che il tempio con la statua della dea Astarte doveva essere ospitato all'interno della torre nuragica poi demolita. Questo risulta particolarmente evidente poiché nessuna delle strutture murarie superstiti di età fenicia è sovrapposta al perimetro della torre stessaCZ5
).
In effetti, Ja situazione non è stupefacente, poiché risulta non infrequente in età antica che luoghi di culto siano stati inseriti all'interno dei nuraghi, come ad esempio si è già avuto modo di notare nel caso del nuraghe Su Mulinu di Vi11anovafranca, e diviene addirittura quasi consueta dopo il IV secolo a.C., come esemplificato tra gli altri dal nuraghe Lugherras di Paulilatino e dal nuraghe Genna Maria di Villanovaforru.
Un ulteriore probante indizio che ci consente di ipotizzare la presenza del luogo di culto collocato all'interno della terre nuragica è costituito dalla presenza di frammenti fittili di recipienti inseriti nel battuto pavimentale dell' ingresso del nuraghe. L'indagine, dovuta a Vincenzo Santoni, ha accertato come i più recenti tra questi materiali siano databili non più tardi della seconda metà del VI secolo a.C. Che poi un santuario esistesse di certo
e2) B ARRECA 1966 b, pp. 51-54.
e3) B ARRECA 1986, p. 82; BARTOLONI 1995 a, p. l 04.
e4) BARRECA 1965 b, pp. 29-52; BARRECA 1966 a, pp. 9-48; BARRECA 1967, pp. 7-25; sulle finali tà e sulle fasi edili
zie de11' edificio, cf., da ultimo, PERRA 1998.
es) B ARTOLONI 1995 a, p. IO 1.
58 Parte Prima
nel luogo prima dell'avvento di Cartagine è confermato da alcuni oggetti presenti nel donario, quali appunto i ben noti bronzetti dell'arpista e del mescitoree6
).
Con la distruzione del nuraghe di Monte Sirai provocata dall'assalto cartaginese, sofferto do-...
po il 525 a.C., il tempio deve essere stato ricostruito nello stesso luogo dai nuovi abitanti. E in que-sto periodo che la statua della dea Astartee7
) deve avere subito dei forti ritocchi, già menzionati in precedenza, che hanno teso a trasfonnarla secondo l'iconografia del personaggio con stola, comune tra le stele dei tofet di Sulcis e di Monte Siraie8
). Che 1' aggressione cartaginese a Monte Sirai abbia avuto probabilmente anche risvolti di carattere religioso è dimostrato non solo dal rimaneggiamento della statua di culto, ma anche da una iscrizione votiva in bronzo, dedicata in origine a una divinità maschile e trovata in un sacello del tempio, nella quale il nome proprio della divinità appare accuratamente cancellato. Tuttavia è evidente che quest'ultimo episodio non può essere legato a11'aggressione cartaginese, poiché l'iscrizione è palesemente di epoca più tardae9
).
Non sappiamo quale fosse l'aspetto del tempio in questa fase poiché 1' edificio, oltre ad essere stato radicalmente ricostruito dopo il 525 a.C., deve essere stato almeno in parte rimaneggiato attorno al 370/360 a.C., quando fu fortificato il centro abitato. L'unica parte che appartiene a questo periodo e che è giunta fino ai giorni nostri è costituita dalla cisterna che è situata lungo il lato sudoccidentale del fabbricato. La cisterna, che doveva assicurare l'acqua necessaria al culto, era intonacata con uno spesso strato di intonaco idraulico nel quale erano inseriti frammenti fittili tesi a rinforzarne la struttura. L'uso di questo manufatto, che ha subito nel corso dei secolo numerosi restauri e vistosi rimaneggiamenti, è perdurato fino al VII secolo d.C., come dimostra un frammento di vaso con caratteristica decorazione ondulata a pettinee0
).
L'edificio attualmente visibile è stato in gran parte costruito attorno alla metà del III secolo a.C., nel quadro della ristrutturazione generale del centro abitato. 11 tempio è composto di tre settori distinti e ben separati tra di loroe1
).
Il primo settore, rivolto verso sud-est, ha il lato esterno semicircolare, poiché almeno in parte segue l'andamento del muro esterno del nuraghe, del quale attualmente è rimasto unicamente il filare di base. Nel versante meridionale, dove la prima assisa del nuraghe si perdeva all'interno dell'edificio, un muro curvilineo eretto appositamente, completava 1'andan1ento semicircolare di questo lato del tempio. Del resto, anche durante l'ultima fase di vita dell'edificio, l'accesso a questo primo settore era nel Jato de li' antico ingresso della torre nuragica, aperto canonicamente nel versante sud-orientale.
L'area di ingresso era sistemata come una bassa terrazza sulla quale erano collocati almeno tre altari di diverse dimensioniC2
). Un blocco prismatico di calcare, allineato agli altari, costituiva probabilmente la base per un pilastro destinato a sorreggere la copertura dell'area. Gli altari, indagati solo superficialmente, conservano ali' intorno abbondanti tracce di bruciato con numerosissimi minuti frammenti ossei, per lo più appartenenti a volatili. Le strutture degli altari sono composite e sono costituite in prevalenza da blocchi trachitici con bugnato e risega, prelevati e riutilizzati dalle fortificazioni della tarda età punica.
Durante i riti, gli officianti dovevano occupare la platea degli altari, mentre i fedeli probabilmente trovavano posto nella piazza antistante e verosimilmente potevano comodamente assistere ai sacrifici che avevano luogo sulla terrazza stessa.
e6) Cf., da ultimo, MosCATI 1996, pp. 51-54, tav. x.
e7) MosCATI 1996, pp. 17-21, tavv. I-11.
es) Su questa particolare iconografia a Sulcis cf. s. MosCATI, Le officine di Su/cis(= StPu, 3), Roma 1988, pp. 41-44, tavv. XI-XIV, XVII; per quanto riguarda Monte Sirai, cf. MoscATI 1996, pp. 85-87, tav. XIX.
e9) GARBINI 1965, pp. 79-92; Guzzo AMADASI 1967, pp. 122-23; BARTOLONI 1989 d, p. 19, fig. 7.
C0) BARTOLONI 1989 a, p. 29; BARTOLONI 1995 a, p. 103.
e•) PERRA 1998, pp. 59-74, 169-71.
C2) BARTOLONI 1992 d, p. 42, fig. 28; BARTOLONI 1995 a, p. l 04, fig. 3, g; PERRA l 998, p. 170, tav. 52.
Il centro abitato 59
Al secondo settore del tempio, presumibilmente riservato alla preghiera, si accedeva per mezzo di una breve scala composta di due gradini. Questi sono costituiti prevalentemente da pietre calcaree che, per la maggior parte, null'altro sono che numerosi piccoli conci triangolari, provenienti con ogni verosimiglianza dalle strutture interne della torre nuragica. Dalla terrazza sommitale del nuraghe deriva invece un grande concio di ignimbrite, oggi spezzato e visibile, poiché inserito nella struttura del muro perimetrale del cortile di destra nel punto di unione tra questo e la suddetta scala. Questa scala a due gradini, infatti, dava accesso a due cortili abbastanza ampiC3
), separati tra di loro da un muro centrale che doveva contribuire anche a sorreggere la loro probabile copertura.
In fondo ai due cortili si apriva il terzo settore, cioè quello che ospitava gli oggetti del culto e il donario e che plausibiln1ente era riservato ai sacerdoti. Si tratta di quattro celle allineatee 4
): la prima da sinistra era verosimilmente un ambiente di servizio del tempio, poiché conteneva unicamente una iscrizione punica su lamina di bronzo, con fori e chiodi agli apici, che dovevano essere utilizzati per infiggere la lamina stessa su un supporto ligneoe5
).
La seconda cella da sinistra doveva costituire il luogo di culto vero e proprioe6), poiché con
teneva la statua della dea Astarte e un betilo a davanzaleC7), assieme ad un ricco donario, compo
sto da un frammento di arenaria sagomato e dipinto con vernice rossa, forse parte di una statuae8).
Sempre nel donario erano due statuine di bronzo, due frammenti di coppe parimenti di bronzo, alcune protomi delle quali una maschile barbata e un'altra femminili di tipo classico, due statuette acefale raffiguranti due divinità, l'una eretta e l'altra seduta, due kernophoroi, tre lucerne del tipo a tazzina e un piatto da pesce, nonché altri oggetti, quali una ulteriore lucerna di imitazione atticaC9). Mentre alcuni materiali erano alla rinfusa nella cella, buona parte dei recipienti era disposta a semicerchio alla base della statua di culto.
Nella terza cella invece è stato rinvenuto un bronzetto assieme ad alcuni frammenti di protomi e di statuette e a numerose monete(40
). La quarta e ultima cella probabilmente conteneva un mobile, forse un tavolo o un cassettone, poiché sono stati ritrovati numerosissimi frammenti lavorati di lastrine di osso, verosimilmente utilizzate come intarsi, tra le quali alcune raffiguranti una palmetta, un busto del dio Bes e una sfinge(41
).
Sempre nello stesso periodo, posteriore allo smantellamento delle fortificazioni, lungo il lato nord-orientale del tempio era stata costruita una torre composta da sei vani interni(42
). Per la sua costruzione, cosl come per quella di parte degli altari, sono stati uti1izzati numerosi blocchi trachitici provenienti dalle fortificazioni stesse(43
), costruite attorno al 370/360 a.C. e demolite attorno alla metà del secolo successivo, che in tale modo ci confermano la sua cronologia. Un particolare di notevole importanza è costituito dalla presenza di due menhirs prenuragici inseriti nelle strutture di questa torre. Tra 1 'altro, i due betili presentano alcune caratteristiche coppelle ricavate su quella che doveva essere la faccia anteriore(44
). Le considerevoli dimensioni di almeno uno di essi porta-
e3) fERRA 1998, p. 169.
e4) BARTOLONI 1992 d, p. 42.
e5) BARRECA 1965 b, p. 41 .
e6) BARRECA 1965 b, pp. 40-4 J; BARTOLONJ )989 d, p. 14.
e7) B ARTOLONI 1989 d, p. 14, fig. 4.
e8) BARRECA 1965 b, p. 55.
e9) BARRECA 1965 b, pp. 52-56.
(40
) BARRECA 1965 b, p. 41 ; BARRECA 1966 a, pp. 18-25.
(41
) BARRECA 1965 b, pp. 41 -42; M oscATI 1996, pp. 47-50, fig. 7, tav. lX.
(42
) B ARRECA 1965 b, pp. 34-35.
(43
) BARTOLONI 1992 d, pp. 42-43, 119, fig. 27; BARmLONI 1995 a, p. l 04 . .
(44
) BARTOLONI 1989 d, p. J 7.
60 Parte Prima
no ad escludere o, comunque, ad attenuare la possibilità che la loro collocazione originaria fosse molto distante dal luogo del loro riutilizzo. Pertanto, la presenza dei due betili potrebbe confennare che la località ove era poi sorto il nuraghe e dove in seguito era stato eretto il tempio rivestiva già precedentemente caratteristiche eminentemente sacre e che questa peculiarità aveva origine almeno dal III millennio a.C.
Come detto, la cronologia della torre cosiddetta cava, addossata al tempio, ci viene confet nlata in modo particolare e definitivo dalla presenza di blocchi trachitici con risega e bugnato relativi alla fortezza, in questo caso utilizzati impropriamente addirittura come fondazioni. In particolare, il blocco angolare orientale, che presenta le bugne su due facce contigue, è rimesso in opera in posizione verticale, invece che in quella orizzontale, come doveva risultare all'origine(45
).
Durante le indagini effettuate nel corso del 1965, sotto le fondazioni e tra i setti di questa torre erano state rinvenute le tracce di un manufatto che, in virtù di un vistoso tratto curvilineo in muratura intonacata, poteva essere interpretato come un lacerto di cisterna del tipo a bagnarola. La stessa presenza della torre, a causa dei suoi esigui vani, aveva impedito ulteriori e più precise indagini, ma, a giudicare dalla sua ubicazione, addossata al settore nord-orientale del paramento esterno della torre nuragica, probabilmente si doveva trattare della cisterna adibita alle funzioni cultuali del tempio di età fenicia. La cisterna, probabilmente danneggiata durante l'assalto cartaginese, era state) quindi abbandonata a favore di quella costruita lungo il lato opposto de li' edificio, totalmente ristrutturato dopo il 520 a.C.
Infatti, come detto, la cisterna relativa ali' edificio cultuale di età punica era sistemata in un vano chiuso, ubicato a sinistra dei cortili. Utilizzata fino al VII secolo d.C., come dimostrato da alcuni frammenti fittili di recipienti strigilati, era rivestita di uno spesso strato di intonaco idraulico, misto a frammenti fittili. Verosimilmente la cisterna era alimentata unicamente dalle acque piovane che cadevano sulla copertura del tempio.
L'abitato
Se si prescinde dai due agglomerati di case addossati alla fronte dell'abitato, ognuno dei qua ttro lunghi isolati di cui era composta l'acropoli era fonnato da una doppia fila di case, che si affacciavano ciascuna su una strada diversa. Le case di abitazione avevano un unico ingresso sulla strada e il muro del retro era in comune con I' abitazione opposta, che si affacciava sull'altra strada(46
).
Mentre sono state poste in luce le sommità dei muri degli edifici in tutta l'area dell'abitato, nel corso degli anni sono state quasi interamente scavate stratigraficamente solo due case di abitazione. La prima (Fig. 4, m), esplorata nel 1966 ad opera di Mhamed Fantar, prende appunto il nome di Casa Fantar ed è collocata nell'angolo nord-occidentale del settore B. La seconda casa (Fig. 4, n), in corso di scavo fin dal 1990, è invece denominata Casa del lucernario di talco ed è situata nella parte centrale del Settore C. Si tratta di un edificio di origine fenicia, distrutto nel 525 a.C. e ricostruito non prima del 238 a.C.
La Casa Fantar Questo edificio(47
) costituisce un eccellente esempio che mostra come la struttura delle case puniche sia il diretto antecedente delle attuali case campidanesi, caratterizzate dal cortile, perlopiù
(45
) BARTOLONI 1992 d, p. 42, fig. 27.
(46
) BARTOLONI 1992 d, pp. 42-45.
(47
) FANTAR 1966, pp. 63-81; BARTOLONI 1989 d, pp. 28-32, fig. 17; BARrOLONI 1992 d, pp. 42-45.
Il centro abitato 61
in posizione centrale, denominato lolla. Infatti, le case di Monte Sirai erano generalmente costruite attorno ad un cortile, ove si svolgevano le attività domestiche della famiglia.
In genere in queste abitazioni non esistevano finestre praticate nei muri perimetrali e anche nella casa in esame l'unica apertura verso l'esterno era l'ingresso a corridoio, lungo il quale correva la canaletta di scolo per il deflusso delle acque bianche usate. A destra dell'ingresso è situato un ambiente, che probabilmente doveva essere usato come vestibolo o come magazzino per gli attrezzi agricoli o forse anche come negozio, eventualità quest'ultima abbastanza frequente nelle case di abitazione del mondo punico. Superata la seconda soglia, che costituiva il vero e proprio ingresso, si accedeva al cuore della casa.
Infatti, giunti al centro dell'abitazione, di fronte all'ingresso principale si apriva la cucina, che, ali' epoca della sua scoperta, era ancora attrezzata con un bancone, forse utilizzato per la preparazione dei cibi, costruito lungo il lato sinistro con lastre di pietra calcarea. Oltre a questa struttura, sono state rinvenute alcune pentole e, ancora sul posto fino a pochi anni or sono e attualmente purtroppo trafugato, un catillus tronco-conico in pietra calcarea per la molitura dei cereali.
A destra della cucina si apriva un vano, verosimilmente la stanza da letto del padrone di casa, nota nel mondo antico con il nome di thalamos. Era questa l'unica stanza dell'abitazione che, per favorire il riposo, era priva di prese di luce diretta e per questo veniva denominata camera oscura, poiché per illuminarla si doveva necessariamente fare ricorso alla luce artificiale. Molto vistoso per la tecnica costruttiva utilizzata risulta il tramezzo divisorio tra questo vano e l'adiacente cucina, costituito da grandi lastre di tufo messe in opera verticalmente.
Racchiuso dai muri perimetrali costituiti originariamente in grandi blocchi tufacei oggi in parte scomparsi, il cortile occupava l'angolo settentrionale dell'abitazione ed era il locale più ampio della casa. Al fine di un suo pieno utilizzo, probabilmente il vano era coperto almeno in parte da una tettoia, forse di materiale stramineo a sua volta coibentato con argilla battuta. Poiché non vi è traccia di cisterne, le acque piovane che cadevano sul tetto e sulle coperture dovevano essere raccolte in anfore onerarie collocate nel cortile.
Lungo il lato sud-orientale di questo vano si aprivano altri due ambienti, uno dei quali, troppo angusto per essere adibito ad uso abitativo, poteva fungere da ripostiglio, mentre il secondo poteva costituire una ulteriore stanza da letto. Il tramezzo di separazione dal cortile e gli stipiti dei due ambienti sono costruiti in blocchi di tufo modanati, nei quali sono particolannente evidenti gli incassi per gli stipiti l ignei. Forse ali' origine era presente anche un piano superiore, oggi scomparso, ancorché manchino tracce della scala, ben testimoniate in altri edifici dell'abitato.
Sia per quanto riguarda la cronologia che la tecnica, i confronti più prossimi a questo edificio, così come in genere a quelli d eli' intero abitato, sono visibili sia a Kerkouane(48
) che a Solunto(49
).
La Casa del lucernario di talco L'esplorazione di questo edificio, ubicato n eli' insula C dell'abitato, ha avuto inizio nel 1990 e
da allora ogni anno si sono susseguite le campagne di scavo volte ad isolare l' abitazioneC0). La
Casa del lucernario di talco trae il suo nome da una lastra di questo materiale traslucido che, rinvenuta ormai in piccoli frammenti in un ambiente chiuso, doveva essere utilizzata appunto come lucernario. La pianta di quest'abitazione è molto articolata e varia a seconda del periodo del suo utilizzo.
(48
) Sulla struttura delle case puniche tra il VI e il III secolo a.C. cf. M. FANTAR, Kerkouane. Cité punique du Cap Bon (Tunisie), 1-3, Tunis 1984-1986, che offre un panorama completo detrimpianto urbano, delle tecniche e dei materiali da costruzione.
(49
) Cf., da ultimo, AA.VV., Solunto (= Itinerari, 15), Roma 1994, pp. 33-36.
eo) Cf. BAKTOLONI 1994 b, pp. 75-82 e, da ultimo, CAMPANELLA 1999.
62 Parte Prima
L'edificio originario è di età fenicia e, costruito verso la fine del VII secolo a.C., successivamente, tra il 600 e il 525 a.C., ha conosciuto ben tre rifacimenti totali delle pavimentazioni. Distrutta in seguito all'aggressione cartaginese, la casa è stata ricostruita attorno alla metà del III secolo a.C., almeno in parte sulle fondazioni fenicie, come dimostra il lembo di muro che separa l'ambiente della cucina di destra dal vano-scala.
Di questa casa relativa all'ultimo periodo di Monte Sirai, quindi dopo il 260/250 a.C., si riconoscono ben quattro fasi, dipanate nell ' arco di poco più di un secolo. L' edificio, che originariamente doveva essere composto almeno da quattro vani, attualmente appare fonnato da sei ambienti, poiché sia l'andito adiacente all'ingresso che quello della cucina di destra sono stati successivamente divisi.
Si accede all'interno della casa attraverso un ingresso fiancheggiato da una canaletta di scolo, provvista verso l'interno di una lastra calcarea con incavo per la prima raccolta dell'acqua. Davanti all'ingresso, pavimentato con un battuto di tufo e argilla, è la scala interna che conduceva al piano superiore. Rimangono visibili solo i primi tre gradini e il terrapieno che sorreggeva quelli oggi mancanti. Dalla forma del manufatto si arguisce che all'origine il vano doveva essere aperto e probabilmente era accessibile anche attraverso la piccola soglia, poi occlusa dallo stesso terrapieno. La scala piegava ad angolo per guadagnare in quota e per poter raggiungere il vano che sovrastava l'ambiente ove si trovava la cucina di destra. Questo, a giudicare dalle dimensioni dei primi gradini, che hanno una media di circa 35 centimetri per l'alzata e di circa 50 centimetri per la pedata, doveva essere posto ad una altezza di circa tre metri. Sia questa scala che la già citata canaletta di scolo sono relative all'ultima fase.
In fondo al lungo vano che si apre a sinistra dell'ingresso, oggi parzialmente occupato da un olivastro, nell'angolo meridionale era situato un focolare di fonna circolare, composto da pezzi di forno integrati con frammenti di anfora. Cronologicamente si tratta della cucina relativa al livello abitativo più tardo e immediatamente precedente ali' abbandono di Monte Sirai. Altrettanto importante la cucina che invece era ubicata a destra dell ' ingresso e che ha conosciuto almeno due fasi successive nella medesima collocazione. In questa cucina tra l'altro sono stati rinvenuti nello strato inferiore, databile tra il 260/250 e il 200 a.C., un grande forno in terracotta, adibito alla cottura delle focacce, e un focolare costruito con mattoni di argilla cruda al centro del vano, sul quale al momento del ritrovamento erano conservati una pentola, un tegame e una piccola anfora. Nello strato superiore, databile tra il 200 e il 150 a.C., invece sono stati ritrovati sempre in posto, collocati sul fondo del vano, un grosso mortaio in pietra calcarea, un grande secchia in terracotta e una pentola.
Il grande vano a destra delle cucine conserva il basamento di un pilastro che garantiva il sostegno della copertura dell'ambiente. All'interno di questo vano, nella parte orientale, è stata rinvenuta quella che può essere interpretata come l'officina di un artigiano, forse un fabbro. Ciò poiché all' interno sono state trovate numerosissime coti per affilare le lame, assieme ad alcune scorie ferrose e a qualche como di cervo, forse utilizzato per i manici dei coltelli. A questo proposito occorre ricordare che dalla zona della scala proviene appunto un manico in corno di cervo, mentre nell'angolo accanto ali' anfora della cucina di destra è stato rinvenuto un grande falcetto in ferro.
Nella parte settentrionale del grande vano, adiacente alla cucina e separata unicamente da un sottile setto realizzato con una lastra di calcare, era un vasca di forma trapezoidale, onnai priva della coibentazione in intonaco idraulico, ma con la traccia palese del pozzetto di raccolta al centro del pavimento. Si tratta visibilmente di una vasca da bagno di uso domestico, collocata presso la cucina, e separata da questo ambiente tramite un sottile monolite calcareo. La sua ubicazione presso la cucina risulta logica poiché era 1' unico luogo dell'abitazione o ve poteva essere riscaldata
Il centro abitato 63
l'acqua. Impianti balneari simili, a volte semplici e a volte più complessi, sono ampiamente noti nel mondo fenicio e punico, soprattutto per quanto riguarda gli insediamenti nord-africani. Tra l'altro, una sala da bagno del tutto simile a quelle di Kerkouane è visibile in uno degli edifici adiacenti al tempio di Eshmun di Bostan ech-CheikhCS 1
).
e') Da ultimo, su questo santuario cf. N. JJDEJIAN, Sidon à travers /es ages, Beyrouth 1995.
LE NECROPOLI
Le due necropoli di Monte Sirai, cronologicamente l'una successiva all'altra, sono situate nella valle che si apre sul fianco occidentale del monte e a nord dell 'abitato(') (Fig. 5). Si tratta di una grande necropoli ad incinerazione, la cui area è stata utilizzata per scopi analoghi o totalmente diversi non solo in età fenicia ma anche in quelle precedente e successiva, e di una piccola necro-
... poli ad inumazione, della quale gli abitanti si servivano in età punica. E sintomatico che in ogni pe-riodo dell'esistenza dell'insediamento sia stata utilizzata la stessa area per l'impianto cimiteriale, poiché, come accennato, fin dall'epoca eneolitica, al centro della valle e lungo le sue pendi ci settentrionali sono state ricavate alcune Domus de Janas - almeno quattro - come si vedrà, in parte riutilizzate in epoca successivae ). Invece, a prima vista, non è del tutto in linea con le apparenti consuetudini di età fenicia la collocazione della necropoli nell'unico settore dell'insediamento che, oltre al pianoro, fosse sfruttabile da un punto di vista agricolo. Infatti, fino ad ora era sembrato peculiare degli impianti funerari fenici l 'utilizzo di aree non altrimenti utilizzabili, come ad esempio le dune litoranee o le colline rocciosee).
La necropoli fenicia
L'area della necropoli ad incinerazione, tutta composta da tombe singole (Tav. I, a), si estende ad est della zona attualmente occupata dalla necropoli ad inumazione (Fig. 5) e, superato il sentiero che attualmente conduce ali' abitato, giunge in prossimità dell'odierno ingresso agli scavi e prosegue davanti al settore settentrionale dell'insediamento, altrimenti noto con il nome di Opera avanzata. Come già detto in precedenza, tutta la zona è interessata da una vasta coltre di ceneri vulcaniche piroclastiche, che per semplicità denomineremo tufo, nella quale sono escavate sia le Domus de Janas che le sepolture di età fenicia e punica. La qualità del tufo non è omogenea, ma presenta zone in cui la roccia risulta più consistente, alternate a settori decisamente più incoerenti. Per di più, alcuni bothroi assolutamente naturali talvolta si aprono perpendicolarmente in numerosi punti dell'area. Anche la superficie non è uniforme, ma appare ondulata da repentini avvallamenti naturali. In età antica, così come del resto in quella attuale, il tufo era totalmente coperto da uno strato di humus di potenza variabile tra gli 80 e i 40 centimetri. Lo spessore più considerevole normalmente si raggiunge al centro della valle. Occorre aggiungere che, se esposta agli agenti atmosferici, la superficie del tufo subisce un considerevole quanto rapido degrado.
L'impianto funerario di età fenicia non dà l'impressione di seguire una pianificazione precostituita, ma le tombe sembrano essere state collocate ove si presentava uno spazio disponibile (Fig. 6). Anzi, a questo proposito, si è potuto notare che spesso l'impianto di alcune tombe ha danneg-
(1) Sulle necropoli di Monte Sirai cf., da ultimo, BARTOLONI 1995 c, pp. 215-20.
e> Cf., da ultimo, UsAI 1995, pp. 83-93.
e> Per le necropoli su dune litoranee cf. ad esempio s. LANCEL, Tipasitana III: LA nécropole préromaine occidentale de 7ipasa. Rapport préliminaire (campagnes de 1966 et 1967): BAA, 3 (1968), pp. 85-166; BARTOLONI 1996, p. 50; BERNARDINI 1996 pp. 535-45, e, da ultimo, BERNARDINI 1997, pp. 55-57; si veda inoltre la necropoli di Tiro, relativa allo scorcio del IX e all 'Vlll secolo a.C., recentemente indagata da Maria Eugenia Aubet; per le necropoli ubicate in colline rocciose, cf. ad esempio. TARAMELLI 1912.
68 Parte Seconda
giato o addirittura obnubilato quelle precedenti anche di pochi anni. In ogni caso, come mostrato dal corredo della Tomba 2 (Fig. 7; Tav. II, b), appare evidente che le tombe più tarde occupano il settore più distante dal centro abitato. Tuttavia, l'accorpamento in nuclei di alcune tombe, unito alla sovrapposizione di · altre, nonché all 'evidente soluzione di continuità tra alcuni gruppi di deposizioni, portano a ipotizzare la presenza, non altrimenti documentabile, di grandi agglomerati di sepolture pertinenti allo stesso gruppo familiare, come suggerito in ipotesi anche dalla presenza di due sigilli/scarabei con la stessa raffigurazione (NN. 133, 183) rinvenuti in due tombe diverse (Tombe 50, 66) dello stesso supposto nucleo.
Il rito dell'incinerazione in età fenicia
A Monte Sirai, come del resto in tutte le città fenicie della Sardegna e degli altri territori occidentali, nel periodo compreso tra la loro fondazione, avvenuta in gran parte tra il 750 e il 700 a.C.(4
) , e gli anni tra il 540 e il 510 a.C.C) si usava soprattutto il rito dell'incinerazione dei defunti.
Il rito funebre comprendeva numerose fasi che sono simili in tutti i centri fenici, già descritte altrove(6
), ma puntualmente riscontrate anche nella necropoli fenicia di Monte Sirai. L' unica variante era costituita dal luogo dove venivano riposte le ossa bruciate, che poteva essere una semplice fossa nel terreno, come nel nostro caso, oppure una cassetta costruita con lastre di pietra, tipologia quest'ultima attualmente non ancora testin1oniata nel nostro insediamento( ).
A Monte Sirai, dove si utilizzavano unicamente le fosse, dapprima gli affossatori scavavano nello spessore del terreno superficiale e, se lo raggiungevano, nel tufo sottostante una cavità di forma ellissoidale allungata o sub-rettangolare della lunghezza di circa due metri e della profondità di circa quaranta centimetri (Tav. I, a). Durante lo scavo, venivano conservate le scaglie di tufo di maggiori dimensioni, da impiegare in seguito nella copertura della fossa.
Nel frattempo, i parenti del defunto, effettuate probabilmente le lamentazioni di rito(8),
procedevano alla preparazione del corpo, che consisteva principalmente nel lavaggio e nella unzione. Allo scopo venivano utilizzati i due recipienti rituali specifici. Come è noto, si tratta della brocca con orlo espanso, nota anche con il nome di brocca con orlo a fungo(9
) ,
e della brocca con spalla ribassata, denominata bilobata o biconica(0). Quest'ultima conteneva
forse l'unguento, mentre la prima veniva usata per cospargerlo grazie appunto al suo orlo fortemente espanso. Tuttavia, è anche possibile che la brocca bilobata, che era palesen1ente parte integrante del rituale, fosse adibita a contenere altri liquidi invece dell' olio. Non è
(4
) Cf. BAIITOLONI-BoNol-MoscATI 1997, pp. 29-32.
e) È in questo periodo che si pone l'azione conquistatrice di Cartagine nei confronti delle città fenicie di Occidente, cf. BoNDì 1988 b, pp. 129-211 ; AA.VV., Eparchia punica in Sicilia: Kokalos, 36-37 (1990-1991), pp. 159-265; S. F. BoNol, Siciliae partem domuerant: Studi Moscati 1996, pp. 21-28; inoltre sull ' argomento cf. BAIITOLONI-BoNoì-MoscATI 1997, pp. 63-77.
(6) Cf., da ultimo, BARTOLONI 1996, pp. 51-54.
C) Cf. TusA 1972, p. 35; TusA 1978, p. 9; BARTOLONI 1996, p. 56.
( 8) BENICHOU-SAFAR 1982, pp. 272-83.
(9
) Sulle funzioni di questa brocca cf., da ultimo, BARTOLONI 1996, pp. 52, 95-96; è probabile che le lekythoi fune-. ' . ,;
rarie del mondp greco di VIII e VII secolo a.C. traggano origine dalle brocche fenicie con orlo espanso, grazie anche al-la mediazione prima .rodia e poi euboica: cf. in proposito FRns JoHANSEN 1957, pp. 161-64; BucHNER-RIDGWAY 1993; il recipiente forse funzionalmente equivalente nel mondo greco di età classica è la lekythos, che, con il corso del tempo e principalmente dal periodo classico, assurge a simbolo, cf. KuiiTZ-BOARDMAN 1971, pp. 100-105.
(10
) Sulle funzioni di questi recipienti cf. BAIITOLONI 1996, pp. 52, 102-104.
Le necropoli 69
da escludere, infatti, che questo recipiente contenesse del vino, destinato alla libagione sacra, come indicato più sotto( 11
).
Effettuata l'unzione del corpo, questo veniva adornato con i gioielli, gli amuleti e gli oggetti più cari in vita al defunto, quali ad esempio il vaso porta-unguenti, necessario in vita per la pulizia personale. Si tratta generalmente della ben nota piccola brocca piriformect2), che normalmente, durante l'uso, veniva portata assicurata al polso ed era sostituita talvolta da un aryballos o da un alabastron, che, come è manifesto, nel mondo greco avevano la medesima funzionee 3) di vasi adibiti alla cosmesi e all'igiene personale. Occorre notare per altro che in alcuni casi i gioielli, gli amuleti e i vaghi di collana non presentano tracce di combustione e dunque dovevano essere deposti all'intemo della tomba dopo il rogo.
A questo punto, presumibilmente il corpo veniva avvolto in un sudario ed era deposto su alcune assi che fungevano da letto funebre. Nel frattempo venivano raccolte frasche di lentisco o di altri arbusti oleosi o resinosi che erano deposte sulla fossa per tutta la sua lunghezza. Quindi, sopra le frasche veniva accatastata legna da ardere, soprattutto di quercus ilex o di juniperus macrocarpa, poiché gli alberi di questo tipo, del resto endemici della zona, garantivano una fiamma forte che raggiungeva un alto calore, indispensabile per la rapida calcinazione delle ossa.
Dunque, il cataletto con il corpo disteso veniva deposto sulla catasta di legna, alla quale poi veniva dato fuoco. La combustione non era di lunga durata, ma il fuoco ve n i va attizzato e il rogo proseguiva fino a quando le ossa principali si erano calcinate e fino al momento in cui la legna, ormai completamente carbonizzata, crollava all'interno della fossa. In seguito, le eventuali fiamme residue e i carboni ardenti venivano probabilmente spenti con getti di liquido, verosimilmente acqua. Quest'ultimo procedimento, evidentemente teso a interrompere la combustione, si rendeva necessario per impedire che il fuoco distruggesse totalmente i principali resti ossei e attualmente è posto in evidenza dalla presenza lungo le pareti e sul fondo della fossa di tronchi interi, ancorché carbonizzati, che, invece, nel caso di una combustione prolungata, si sarebbero prima spezzettati e quindi inceneriti (Tav. XXXIX, d).
Sulle ossa principali cadute ali' interno della fossa e maggiormente conservate in virtù delle loro dimensioni (Tav. XXXIX, c), quali ad esempio il cranio, il bacino o i femori, venivano deposti alcuni vasi del corredo di accompagnamento, soprattutto forn1e aperte quali piatti o tazze, o alcuni grandi frammenti fittili derivanti con ogni evidenza da pare~i di anfore (Tav. XX, d). Infine, le due brocche sopra descritte, che costituivano il corredo rituale del defunto ed erano usate per l'unzione del corpo, venivano collocate lungo il margine della fossa (Tav. VII, d), nel luogo dove avrebbero dovuto trovarsi i piedi. La posizione di questi recipienti, che di norma vengono rinvenuti quasi sempre con la bocca danneggiata e il collo spezzato, sembra suggerire che forse i vasi venissero collocati appositamente in tale modo per consentire che emergessero almeno in parte dal tumulo
. (Tav. XXIX, d). Ciò forse al fine di pennettere il reiterarsi di una cerimonia simile alla libagione sacra o al refrigerium in suffragio del defunto( 14
).
e 1) J. A. GREENE, The beginnings of Grape Cultivation and Wine Production in Phoenician-Punic North Africa: l. E. McuovERN-F. J. FLEMING-S. H. KATZ (a cura di), The Origins and Ancient History of Wine, Amsterdam 1996, p. 317; da ultimo, M. BoTTO, l contatti fra le colonie fenicie di Sardegna e l'Etruria settentrionale attraverso lo studio della documentazione ceramica: Atti dell'XXI Convegno di Studi Etruschi ed Italici, Sassari -Alghero - Oristano - Torralba, 13-17 ottobre 1998, in stampa.
e2) Cf., da ultimo, BAIITOLONI 1996, pp. 52, 95-97.
e3) Cf., da ultimo, BARTOLONI 1996, p. 95; cf. inoltre, per quanto riguarda la necropoli fenicia di Monte Sirai: BARTOLONI )998, p. 357, tav. 29.
(14
) Sul culto dei morti cf. BENICHou-SAFAR 1982, pp. 283-88 e, da ultimo, BARTOLONI 1996, p. 53; sulla libagione in onore dei defunti si ricorda la ben nota stele del tofet di Cartagine (III secolo a.C.), che raffigura una donna inginocchìata su un sepolcro mentre impugna una brocca nell'atto di versare del liquido in un foro della tomba stessa: cf. CIS, I, 5780.
•
l
l l
'
J
'
70 Parte Seconda
Oltre agli orecchini, alle collane (Tav. XXV, c) e a quanto altro di individuale aveva adornato il defunto durante la sua vita, che costituì vano appunto il corredo personale e che, come accennato più sopra, erano collocati sui corpi, accanto ai defunti era deposto un corredo di accompagnamento. Questo era composto dai recipienti aperti, piatti o tazze (Tav. XXVII, c), che, come abbiamo visto, erano usati per coprire le ossa principali, e da altri vasi, talvolta di tipologia chiusa. lvi compresi quelli rituali, si è potuto constatare che generalmente per le donne venivano deposti cinque
' recipienti, mentre per gli uomini appena tre e, infine, per i bambini solamente uno. E verosimile che le coppe, deposte assieme ai vasi rituali e che talvolta costituiscono l'unico esemplare di forma vascolare del corredo di accompagnamento suindicato, facessero parte del rituale della libagione sacra( 15).
Come accennato più sopra, al termine del rogo e dopo la deposizione del corredo fittile, i resti ossei e la legna carbonizzata venivano completamente ricoperti e sigillati con le scaglie di tufo (Tavv. V, a, VII, d, XVI, c), ricavate dall ' escavo della fossa e precedentemente accantonate, ed erano messe in opera assieme ad abbondante argilla e a ciottoli di fiume (Tav. I, b) . Alla copertura talvolta potevano concorrere anche ampi frammenti di anfore commerciali (Tav. V, a). Quindi la fossa veniva ricoperta con un tumulo non molto elevato formato da terra e da piccole pietre. Infine, sul sepolcro veniva posta una pietra apparentemente sempre anepigrafe e aniconica, che costituiva il sema, ad indicazione della tomba (Tav. X, b)(16
).
Attualmente, come logica e immediata conseguenza dei lavori agricoli effettuati nel corso dei secoli e in relazione allo stesso peso del tumulo, i segnacoli sono stati quasi totalmente rimossi e le coperture in tufo delle fosse hanno ceduto e si sono adagiate sul fondo delle cavità schiacciando quanto contenuto nella tomba.
Sempre nella necropoli fenicia di Monte Sirai è stato possibile riconoscere una variante del rito funebre, che consisteva nella combustione del corpo in un luogo che non coincideva con la fossa nella quale poi venivano deposti i resti ossei. Il corpo veniva bruciato e i frammenti ossei, raccolti in un contenitore o in un pezzo di stoffa, venivano collocati a parte. Dunque, ciò sembra riguardare degli ustrina che, tuttavia, non paiono essere stati di impiego collettivo, bensì sembrano essere stati utilizzati in una singola occasione. Si tratta di quelle lenti di bruciato che in prima istanza erano state classificate come tombe( 17
) , ma che, in quanto prive di corredo e contenenti infimi frammenti ossei, per di più in numero assai ridotto, sono state successivamente classificate, probabilmente in modo più corretto, come ustrina. Occorre comunque rilevare che, allo stato attuale dei lavori, non sono state ancora individuate le tombe di possibile riferimento agli ustrina citati, poiché nella nostra necropoli sembrano mancare appunto le ciste litiche, sepolture queste ultime caratteristiche nel quadro di questo specifico uso(8).
Il rito dell'inumazione in età fenicia
Come detto, a Monte Sirai il rito dell'incinerazione era prevalente, ma, anche se in misura assai minore, in epoca contemporanea era in uso anche quello dell'inumazione, forse derivante da in-
es) BARTOLONI 1996, p. 95; sulla disposizione dei corredi nel mondo greco, cf. cf. KuRTZ-BOARDMAN 1971 ' pp. 76-79.
(16
) Analoghi segnali, talvolta di dimensioni monumentali e assai elaborati, erano utilizzati ne11e incinerazioni contemporanee nel mondo greco: cf. KvRTZ-BoARDMAN 1971, pp. 80-84, figg. t O, 13.
(17
) Cf. le Tombe 3, 23-24, 28, 37-38~ BARTOLONr 1985 a, pp. 248-49; per ustrina analoghi ne11a necropolì di Bitia, cf. BARTOLONI 1996, pp. 55-56.
('8
) Cf. ad esempio le necropoli e i tofet di Cartagine, Mozia, Bitia, Nora e Tharros: cf. BARTOLONI 1983 a, pp. 64-65; BARTOLONI-TRONCHEITI 1981, pp. 23-24~ A. CIASCA, Lo scavo de/1970: Mozia - VII(= StSem, 40; PCFP, 10), Roma 1972, p. 91, tavv. LXIII-LXV; C.NTAS 1970, pp. 323-24, tavv. VII-IX; TusA 1972, p. 35, tav. XXIX, l; TusA 1978, p. 9, tavv. 1-111.
Le necropoli 71
flussi autoctoni o di matrice cartaginese. Del resto è noto già da tempo che tra la metà dell'VIII e la fine del VI secolo a.C. in tutti gli insediamenti fenici di Occidente, ad eccezione di Cartagine e della sua chora, era in uso il rito dell' incinerazione. Questo fu sostituito da quello dell'inumazione dopo la conquista cartaginese dei territori rivieraschi del Mediterraneo occidentaleC 9).
In dettaglio il rituale consisteva nella deposizione del corpo ali' interno di una fossa opportunamente eseguita e nel suo seppellimento. Il rito dell'inumazione veniva usato forse anche perché in precedenza era stato quello praticato prevalentemente dagli abitanti di stirpe nuragica, che in seguito, assieme ai Fenici, avevano contribuito al popolamento dei primi nuclei urbani della Sardegnae0
).
Per il seppellimento veniva approntata una fossa che in genere era della lunghezza di oltre due metri e della profondità di circa ottanta centimetri (Tav. X, c), anche se non mancano esempi di tombe di maggiori dimensionie1
). Per la realizzazione dello scavo, come suggerito dalle tracce superstiti nel tufo, veniva utilizzato uno strumento, verosimilmente una zappa o un piccone, con una lama della larghezza di circa 7/8 cm. Anche in questo caso venivano conservate le lastre di tufo risparmiate dallo scavo e, anzi, gli incavi che frequentemente appaiono sui lati brevi delle fosse dimostrano che il processo di lavorazione avveniva con l'esecuzione di due trincee parallele che avevano la lunghezza della tomba (Fig. 12, T. 25). Ultimate le trincee, si provvedeva al distacco della lastra di tufo centrale ottenuta tra le due cavità, che veniva utilizzata per la copertura della tomba. Se la fossa era di dimensioni analoghe a quelle del corpo da deporre, sul fondo della cavità, in prossimità dei lati brevi, venivano scavate due ulteriori fossette, consuete per questo tipo di sepolturee2), nelle quali venivano spesso deposti gli eventuali oggetti di corredo. Per quanto riguarda la posizione di questi recipienti, risulta caratteristica la collocazione dei recipienti NN. 99 e 121, appartenenti rispettivamente alle Tombe 35 e 48 (Figg. 14-15, 21): dunque si ricorderà quanto tramandato da un noto testo ugaritico, che recita come segue: « ... Una coppa di vetro sarà posta a protezione della mia testa l Un'offerta funeraria presso la sommità del mio cranio ... »e3
).
Dopo la consueta preparazione che probabilmente veniva effettuata come nel caso del rito dell'incinerazione, il corpo era posto su un letto funebre formato da semplici tavole di legno e veniva calato sul fondo della fossa dopo la deposizione del corredo di accompagnamento. Quindi, come accennato più sopra, la fossa era ricoperta con lastre di pietra, tra le quali quelle di tufo risparmiate durante lo scavo, e veniva accuratamente sigillata con argilla. Sulla fossa, senza che ne toccassero i bordi, venivano posti dei macigni. Queste grandi pietre, collocate in corrispondenza dei corpi dei defunti, venivano probabilmente sistemate in questa posizione per impedire che i rephaim uscissero dalle tombe durante la notte a spaventare i vivie4
).
Un ulteriore rituale utilizzato nel quadro dell'inumazione e, per quanto riguarda la Sardegna, fino ad ora posto in luce unicamente a Monte Sirai, è quello che riguarda la particolare posizione
(' 9) Sul problema del cambio di rito funebre cf. BARTOLONI 1981 a, pp. 24-25; sulla possibile presenza di elementi autoctoni inumati nelle necropoli fenicie di Sardegna, cf. BARTOLONI 1983 a, pp. 59, 64-65, BARTOLONJ 1996, p. 53; sulla possibile presenza di individui cartaginesi inumati nelle necropoli fenicie di Sardegna, cf. BARTOLONI 1998, pp. 353-58.
e o) Sulle tracce di elementi autoctoni inurbati, cf. BAJITOLONI 1985 b, pp. 167-92; sulle rare tombe di età del ferro cf. UoAS-LuciA 1987, p. 256; BARRF.CA 1985 b, pp. 266-67.
e') cf. BARTOLONI 1998, pp. 354-55.
e2) Cf. ad esempio BARTOLONI 1983 b, p. 207.
e3) Cf. KTU, 1.17 VI, 36-37; P. XELLA, Gli antenati di Dio. Divinità e miti della tradizione di Canaan, Verona 1982, p. 201; per ulteriori versioni cf. A. CAQUOT-M. SzNYCER-A. HERDNER, Textes ougaritiques, l. Mytes et légendes, Paris 1974, pp. 432-33; G. DEL OLMO LETE, Mitos y leyendas de Canaan segun la tradicion de Ugarit, Madrid 1981, p. 378.
e4) Per quanto riguarda i ritrovamenti effettuati durante gli scavi più recenti nella necropoli di Monte Sirai e sul
problema dei rephaim, cf. BARTOLONJ 1998, pp. 353-58.
72 Parte Seconda
dell'individuo inumato. Infatti, unica nel suo genere, la Tomba 50 conteneva il corpo inumato di una giovane donna collocata in posizione fetale, con la testa volta verso nord-ovest. Se, per quanto riguarda l' orientamento del volto, questa direzione è consueta a Cartaginee 5) , la particolare posizione, propria del remoto mondo neolitico anche isolanoCZ6), non trova riscontri nell'ambiente fenicio di Sardegna, né in quello nuragicoe 7
) . Del resto, se, come sembra ovvio, questa particolare posizione appare estremamente rara a Cartaginee 8
) , è invece ben nota nelle sepolture di elementi autoctoni della tarda età fenicia rinvenute nel circondario tangerinoe 9
).
Un'altra variante, riferibile alla Tomba 31 (Fig. 13) e apparentemente inusitata nel mondo fenicio dì Oriente e di Occidente, è quella che vede l'applicazione della pratica della semicombustione del corpo del defunto. Come a suo tempo registrato in sede di rapporto prelin1inaree 0}, si tratta di un cadavere che presenta tracce di parziale combustione, tali da conservare lo scheletro nella posizione originaria e in relativo buono stato (Tav. XVI, c-d). Ciò contrariamente a quanto accade di nmtna con i resti ossei degli inumati in modo tradizionale, che si presentano quasi completamente assorbì ti e sfarinati dali' azione acida del terreno che li ha accolti.
Data la singolarità della situazione, non è possibile esprimere un giudizio certo su questa particolare pratica funeraria, comunque, non è da escludere anche l' ipotesi che non vi sia stata intenzionalità nella parziale combustione del cadavere della Tomba 31. Infatti, è possibile che si sia verificata l' eventualità che, su quest'ultima tomba, forse ali ' epoca collocata a modesta profondità, successivamente sia stato allestito un rogo per una ulteriore sepoltura, che necessariamente ha influito sulle ossa deposte in precedenza. Anche questa situazione del resto non è nuova per la nostra necropoli, poiché ad esempio è stata registrata per quanto concerne le Tombe 44, 48 e 49 (Fig. 15;
31 • Tav. XXIII, a)( ).
La necropoli punica
Dopo il525 a.C. e comunque in concomitanza con la conquista di Monte Sirai da parte di Cartaginee2) e con il conseguente ripopolamento del1 'abitato da parte di nuovi coloni, almeno in parte di probabile stirpe nord-africana, il rito funebre mutò quasi repentinamente passando dal rito dell'incinerazione a quello dell ' inumazione, secondo le usanze in vigore a Cartagine e tra le popolazioni nord-africanee 3
). La rapidità del cambiamento di rito funerario sottintende con ogni probabilità sia la cruda realtà degli aspetti violenti e cruenti della conquista cartaginese, sia la ovvia immissione nell'isola di considerevoli nuclei di abitanti, provenienti dalla metropoli e dal suo circondario, destinati al controllo burocratico locale e alla manovalanza agricola, come ovviamente traspare anche dalle rare fonti classichee4
).
e s) Cf. BENJCHOU-SAFAR 1982, p. 258.
(26
) Cf. ad esempio, V. SANTONI, Tharros-VIII: Cabras - Cuccuru S'Arriu. Nota preliminare di scavo (1978, 1979, 1980 ): RStF e n, 10 (1982), pp. 106-1 08, fig. 4.
e7) Per un panorama suiJa tipologia delle sepolture di questo periodo cf., ad esempio, E. CASTALDI, Domus nuragi
che , Roma 1975; UaAs-LucJA 1987, pp. 255-77; C. TRONCHETn-F. MALLEGNI-F. BAJITOU, Gli inumati di Monte Prama: QuadCagliari, 8 ( 199 1 ), pp. 119-31.
es) Due soli esemplari accertati: cf. BENICHOU-SAFAR 1982, p. 258.
e9) Cf. PoNSICH 1967, pp. 43, 46, e, da ultimo, EL A ziFI 1995, pp. 417-21.
(~ BAJITOLONI 1983 b, pp. 207, 210.
e') BARTOLONI 1985 a, pp. 253-54, fig. 9.
e2) Cf. BARTOLONI-BONDl-MosCATI 1997, p. 7 1.
e3) BARTOLONJ 1981 a, pp. 24-25 e, da ultimo, BARTOLONI 1996, p. 30.
e4) Cf. tra l' altro il primo trattato tra Cartagine e Roma, che in ogni transazione commerciale con l'estero prevede
il costante intervento di araldi e scribi cartaginesi: cf. Poua1o, III, 22.
Le necropoli 73
A questo scopo fu utilizzata una zona della vane situata immediatamente ad ovest dell'area della necropoli fenicia ad incinerazione (Fig. 5). Non è dato di sapere se l'impianto della nuova zona cimiteriale abbia in qualche modo provocato danni ad alcune tombe della necropoli fenicia, ma il ritrovamento fuori contesto di alcuni oggetti, certamente di età fenicia e per di più di uso anche funerario, pennette di ritenere che almeno alcune tombe di quell ' epoca siano state sconvolte o almeno in parte danneggiate. Infatti, ad esempio, durante lo sterro del dromos della Tomba a camera ipogea 2* (Fig. 22), al margine del corridoio è stato rinvenuto un piatto ombelicato con decorazione a raggi alternati bianchi e neri su vernice rossae5), che visibilmente era parte del corredo di una precedente tomba ad incinerazione, forse la Tomba 23 o 24 (Figg. 5-6).
La necropoli punica di Monte Sirai non è certamente molto estesa come quella della vicina Sulcis, che annovera almeno un migliaio di ipogeie6), ma è composta unicamente da tredici tombe sotterranee, due delle quali, come accennato, sono state ricavate attraverso l'ampliamento di due precedenti Domus de Janas situate ai piedi della scarpata del tofete7
). A questi tredici ipogei è da aggiungere una ulteriore tomba, la T. 9* (Fig. 5), in realtà costituita unicamente da un dromos, che tuttavia risulta privo di camera. Questo corridoio privo di sbocchi costituisce probabilmente un tentativo di realizzazione di una tomba ipogea non portato a completamento, forse a causa della cattiva qualità della falda tufacea nel luogo ove avrebbe dovuto essere praticata la came.ra sotterranea.
Come accennato, mentre tutte le tombe fenicie ad incinerazione contenevano un solo corpo, quelle puniche invece accog1ievano numerosi defunti e, viste le loro considerevoli dimensioni, decisamente più ampie di quelle di altre località del n1ondo punicoe8), sono probabilmente da considerare vere e proprie tombe di famiglia.
La struttura delle tombe ipogee
Come già indicato, le tombe puniche a camera sotterranea erano riservate al seppellimento degli adulti. Il tipo di lavorazione ali' interno dello spessore del tufo, abbastanza omogeneo pur nella diversità di pianta degli ipogei, unito alle in1pronte degli strumenti utilizzati per lo scavo, visibili ancora oggi, portano a ritenere che nell ' ambito della necropoli forse agisse una confraternita di affossatori, che provvedeva alla costruzione della tomba e alle successive onoranze funebri. Queste considerazioni scaturiscono anche dalla constatazione della sostanziale omogeneità tipologica degli ipogei rinvenuti, che permette di ipotizzarne la realizzazione in un arco di tempo assai ristretto.
Come accennato, le tombe risultano composte, come è consuetudine per questo tipo di sepolturee9). L'inclinazione della superficie del terreno nel quale erano escavati gli ipogei ha consentito di praticare dei dromoi con un numero di scalini limitato e con una lunghezza totale ridotta rispetto
C5) BARTOLONI 1982 a, pp. 266-68.
e6) Per alcune notizie preliminari sulla necropoli punica dì Monte Sirai, cf. BARRECA 1964, pp. 36-55 ; AMADASI
BRANCOLJ 1965, pp. 95-121; FANTAR 1966, pp. 63-81 ; BARTOLONJ 1995 c, pp. 216-20, figg. 12-14; per la necropoli punica di Sant' Antioco cf., ad esempio, MoscATI 1986, pp. 245-46; BARTOLONT 1987 c, pp. 57 -58; BARTOLONI 1989 a, pp. 41-49; BERNARDINI 1991, pp. 191-93.
e7) Cf. BARTOLONI 1992 e, pp. 47-54 e, da ultimo, UsAI 1995, pp. 86-88, figg. 2-6.
es) Mentre le tombe della necropoli ad incinerazione sono indicate con il semplice numero arabo progressivo, quelle della necropoli ad inumazione sono contrassegnate dal numero arabo progressivo con asterisco.
C9) Cf. ad esempio gli ipogei delle necropoli puniche di Kerkouane e di Tuvixeddu che sono visibilmente destinati a contenere due soli defunti, verosimilmente due coniugi: BARTOLONI 1973 b, pp. 9-68; TARAMELLT 1912, coli. 45-223.
74 Parte Seconda
a quello dei corridoi delle tombe sulcitane(40). Pertanto, la fronte del dromos delle tombe di Monte
Sirai risulta di un'altezza media di circa m 2,10 e comunque non superiore ai m 2,65(41). Dalle mi
sure rilevate sembra che, anche in questo caso, si possa arguire che l'unità di misura lineare utilizzata dalle maestranze puniche sia stata quella del cubito di cm 52(42
). Sempre nella parete di fondo del dromos, opposta alla scala di accesso, si apriva il portello di ingresso alla camera sotterranea. La sua altezza raramente superava i m 1,10 mentre la larghezza era contenuta tra i cm 60 e i 70(43
).
Un gradino, atto ad impedire o almeno a contenere le acque di infiltrazione, separava in tutti i casi il piano di calpestio del dromos da quello della tomba(44
). Di norma la chiusura del portello era ottenuta con una lastra di tufo messa in posizione verticale, certamente risparmiata dall'escavo dell'ipogeo, ma si ricordano anche occlusioni ottenute con blocchi più o meno inforrni(45
). Una ulteriore particolarità che differenzia le tombe ipogee di Monte Sirai da quelle sulcitane è la pianta dei dromoi, che nel nostro caso è ampia ed è accostabile a que1li più antichi della necropoli di Sulcis.
La camera sotterranea era di varie forme, ma queste erano quasi sempre regolari e raramente le sue dimensioni, pur considerevoli per un ipogeo, superavano i 15/16 metri quadri. L'altezza raramente tra valica i 180 centimetri. Hanno pianta quadrata le Tombe l*, 3 *, 5 *, 7 *, 12 * (Figg. 22-24 }, presentano pianta rettangolare con ingresso in un lato lungo le Tombe 2*, 4*, 8*, 10* (Figg. 22, 24), mostra pianta rettangolare con ingresso in un lato breve la sola Tomba 11 * (Fig. 24) e, infine, ha una pianta decisamente irregolare la Tomba 6* (Fig. 23). La tipologia delle tombe puniche di Monte Sirai rispecchia quella delle più antiche tombe puniche della necropoli di Sulcis, comprese tra il 500 e il 400 a.C. mentre una sola, la Tomba 5* (Fig. 23), si riferisce ad una tipologia più tarda, che prevede J'utilizzo di un tramezzo centrale(46
).
Ali' interno della tomba, lungo le pareti, erano ricavati dei loculi, che venivano utilizzati per la deposizione dei corpi dei primi proprietari. Sempre lungo le pareti erano praticate delle nicchie che venivano usate per la deposizione di vasi o di offerte votive. Rare e onnai scomparse sono le tracce di decorazione, apparentemente sempre in vernice rossa. Tutte le tombe sono di forme e dimensioni diverse tra di loro. Come accennato, una sola, la Tomba 5* (Fig. 23), presenta al centro della camera un pilastro che, sorreggendo il soffitto, consentiva di ampliare lo spazio interno. Come detto, questo tipo di tomba è caratteristico delle tombe puniche della necropoli di Sulcis comprese tra i1 400 e il 250 a.C. circa.
La Tomba 5* (Fig. 23) reca ancora oggi, scolpito in rilievo sulla faccia del pilastro volta verso l'ingresso, un simbolo della dea Tinnit rovesciato(47
). Il fatto che sia raffigurato in questo modo
(40
) In particolare, le lunghezze dei dromoi risultano come segue: T. l* (m 3,90), T . 2* (m 3,20), T. 3* (m 4, 10), T. 4* (m 4,00 e 4, 10), T. 5* (m 4,30), T. 6* (m 4,10), T. 7* (m 3,90), T. 8* (m 4,00), T. 10* (m 4,00), T. l l* (m 4,00), T. 12* (m 3,40); sui dromoi sulcitani cf. BARTOLONJ-TRoNCHETII 1981 , pp. 26-27, e, da ultimo, BARTOLONI 1989 a, p. 43.
(41
) In particolare, le altezze delle fronti risultano come segue: T. l * (m 2,65), TT. lO* e 12* (m 2,40), TT. 2*, 4*-8*, 11 * (m 2,1 0), T. 3* (m 2).
(42
) Cf., da ultimo, anche per la bibliografia precedente, BARTOLONI 1998, p. 353, nota 6, e, da ultimo, A. CiASCA, Tecniche murarie e fortificazioni puniche in Sicilia: Actos del li Seminario Internacional sobre temas fenicios «Fenicìos y Territorio», Guardamar de Segura, 9-1 l aprile /999, in corso di stampa, da cui si evince come l'unità di misura per la realizzazione delle mura fosse il cubito fenicio, che notoriamente è di cm 52.
(43
) In particolare, le misure dei portelli risultano come segue: T. l* (m 1,10 x 0,64), T. 2* (m 1,04 x 0,70), T. 3* (m 1,04 x 0,64), T. 4* (m 1,14 x 0,68), T. 5* (m 1,14 x 0,72), T. 6* (m 1,40 x 0,80, rimaneggiata), T. 7* (m 150 x 0,62, manca il gradino), T. 8* (m 1,04 x 0,70), TI. 9*-10* (m 11 2 x 0,62), TI. 11*-12* (m 1,10 x 0,70).
(44
) Il gradino non compare nel porte Ilo della Tomba 7*, che comunque appare visibilmente rimaneggiato.
(45
) BARRECA 1964, p. 37.
(46) BARTOLONJ 1989 a, pp. 37-40~ BARTOLONJ 1992 e, pp. 47-54.
(47
) BARTOLONJ 1995 C, pp. 218, 220 , fig. 13.
Le necropoli 75
può implicare forse un errore dello scultore a cui era stato consegnato un disegno a lui sconosciuto e quindi da lui riprodotto in modo sbagliato. Il simbolo della dea Tinnit rovesciato forse può anche significare la discesa de li' anima verso la morte o verso gli inferi. Infine può essere collegato con le raffigurazioni dei capovolti di età neolitica. In questo caso si tratta di personaggi rappresentati con la testa verso il basso spesso incisi all'interno di alcune Domus de Janas preistoriche.
In tre tombe erano scolpite delle facce demoniache di pietra il cui scopo, specificamente apotropaico, era quello di vegliare sulla tomba, di proteggere i defunti e di spaventare chiunque avesse voluto turbare il loro sonno eterno. Una di queste teste è ancora visibile al suo posto nella Tomba 6* (Fig. 23)(48), mentre la seconda è stata anticamente reimpiegata all'interno di una tomba come materiale edilizio per un muretto divisorio(49
). La terza testa demoniaca, asportata dai clandestini nel 1963 dall'interno della Tomba l* (Fig. 22), era stata ricavata dalle maestranze sul soffitto durante la costruzione della tomba punicae0
). Ancora oggi rimangono sul volto della scultura, conservata nel Museo Nazionale di Cagliari, tracce del colore rosso - caratteristico colore funerario -probabilmente ottenuto con l'ocra, con la quale talvolta erano decorate anche le pareti delle tombe sotterranee(5 1).
Il tufo nel quale è ricavata la necropoli non è sempre omogeneo e di qualità sufficientemente solida e compatta. Due tra le tombe sotterranee mostrano ripensamenti durante la loro esecuzione. Si tratta di palesi tentativi di realizzazione di una tomba interrotti a causa della inadeguatezza della falda tufacea. Ciò riguarda la Tomba 9* (Fig. 5), già citata e composta dal solo dromos, e la Tomba 4* (Fig. 22). In quest'ultimo caso la camera, dopo un tentativo di ottenere un ambiente in asse con il corridoio, è stata aperta lateralmente rispetto al dromos. Questa tomba è stata violata durante la seconda guerra mondiale dai soldati in servizio presso le batterie antiaeree piazzate sul monte a difesa delle miniere di carbone ed utilizzata come ricovero antiaereo.
La necropoli dei bambini
Nel periodo compreso tra l'ultima parte del VI secolo a.C. fino al 370/360 a.C. circa, si è potuto appurare che i bambini deceduti in età prepuberale venivano sepolti in una zona poco distante dalla necropoli ad inumazione, ma diversa e distante da quella degli adulti, situazione questa che, laddove documentabile, risulta frequente nel mondo fenicio e punicoCS2
). Infatti, in questo periodo la maggior parte delle tombe dei bambini di età punica era situata nella zona che in precedenza era stata occupata dalle tombe fenicie ad incinerazioneC3
). Per quanto riguarda il rito funebre, è possibile che questo seguisse le modalità descritte per gli adulti, anche perché recentemente, in un'area contigua, è stata rinvenuta una sepoltura ad enkytrismòs con all'esterno i due vasi rituali di dimensioni quasi miniaturistiche. Quindi, probabilmente i corpi dei bambini venivano sottoposti al consueto rito del lavaggio e de li' unzione, ma, a differenza degli adulti, erano inseriti ali' interno di anfore di tipo commerciale e sepolti in tombe a fossa appositamente scavate nello spessore terroso e nel tufo. L'ubicazione di queste fosse nell'area della necropoli di età fenicia, ha avuto come conseguenza logica che alcune di queste abbiano gravemente danneggiato non poche tra le precedenti tombe, poiché evidentemente gli affossatori non si erano resi conto della loro presenza o non ne avevano tenuto debito conto e doveroso rispetto (Fig. 6; Tav. XX, c-d).
(48
) MoscATI 1964, pp. 1-5; BARJ'OLONI 1995 c, p. 218, fig. 13.
(49
) MoscATI 1983 b, pp. 219-22.
( 50) MoscATI 1982, pp. 297-99.
e') GARBINI 1964 a, pp. 94-96, tav. XLIX; MosCATI 1974, pp. 76-82.
e2) Cf. da ultimo BENICHOU-SAFAR 1995, pp. 98-99.
e3) BARTOLONI 1989 C, pp. 67-81.
76 Parte Seconda
Apparentemente fino ad oggi una sola sepoltura infantile in anfora ha trovato collocazione nell'area della necropoli ipogea destinata agli adulti: si tratta di una deposizione ad enkytrismòs collocata sui primi due gradini del dromos della Tomba 3* (Fig. 22) grazie ad una sorta di terrazzamento ottenuto con blocchi di tufo sostenuti da un basamento di argillaCS4
).
Come detto, in questo periodo le tombe dei bambini erano soprattutto quelle contenute in anfore, ma almeno in un caso -la Tomba 56- si è potuto riscontrare come il corpo del piccolo defunto fosse stato sepolto semplicemente nella terra (Fig. 18). Nella maggior parte dei casi la sepoltura era completata da un piccolo corredo personale (Tav. XXIV, b), fonnato da gioielli in argento e bronzo, da scarabei e da collane con amuleti e vaghi in pasta vitrea o in pietra. Inoltre a volte, ma assai più raramente, il corredo risulta composto anche da recipienti fittili.
Occorre notare infine che, mentre nessuna tra le sepolture rinvenute scende oltre la data indicata più sopra, è proprio in questo periodo che nell'insediamento di Monte Sirai ha luogo ex novo l'impianto del tofet.
Il rito dell'inumazione in età punica
Il rito funebre prevedeva il consueto lavaggio del defunto e la sua vestizione con un sudario o con una tunica chiusa con bottoni in osso. Quindi il corpo, adornato con i beni preziosi personali composti da amuleti, sigilli e gioielli, veniva adagiato su un letto funebre formato da assi di legno e veniva trasportato presso la tomba. Talvolta veniva preparato un sarcofago di legno, completamente smontabile e composto da sezioni separate, per consentirne il trasporto e il passaggio attraverso lo stretto portello di ingresso della tomba. Le pareti del sarcofago venivano introdotte nella camera sotterranea e quindi venivano rimontate con l'aiuto di perni lignei e coppiglie di bronzo o di ferro.
Il corpo veniva posto nei loculi lungo le pareti o era introdotto in un sarcofago che poggiava sul pavimento della camera. Presso i piedi venivano collocati i vasi rituali, il cui uso probabilmente era divenuto ormai solo rappresentativo e non più funzionale. Presso la testa veniva collocato un recipiente chiuso - una brocca o un'anfora - contenente forse acqua.
Al tern1ine della cerimonia funebre il portello di accesso alla camera ipogea veniva richiuso con una lastra di pietra o con mattoni di argilla cruda. Quindi venivano gettati all'interno del corridoio alcuni recipienti di uso sacro, quali le doppie patere(55
), o alcuni piccoli vasi che contenevano unguenti profumati, la cui funzione, apparentemente rituale, era in realtà quella di eliminare i miasmi della morte.
Con il passare del tempo, e con il progressivo aumentare del numero dei corpi collocati all'intemo delle tombe, i defunti venivano deposti sul pavimento della camera, mentre i vasi appartenenti ai corredi più antichi venivano spostati e collocati alla rinfusa negli angoli della parete ove si apriva il portello di ingresso.
Come già accennato, oltre alle undici tombe a camera ipogea presenti nella valle, altre due di questo tipo sono collocate al margine della stessa valle e ai piedi del dirupo del tofet. Si tratta con ogni probabilità di due Domus de Janas riutilizzate in età punica. Le due cameree6
), prive di dromos e ampiamente rimaneggiate, sono state violate in epoca imprecisabile, forse ancor prima che fossero piazzate sul monte le batterie antiaeree a difesa delle miniere di Carbonia.
e4) BARRECA 1964, pp. 36-55, tav. XXVII.
CS5) BARTOLONJ-TRONCHETII 1981, p. 53.
C6) UsAI 1995, pp. 83-93.
Le necropoli 77
La necropoli neo-punica
Attorno al periodo della conquista romana della Sardegna, avvenuta nel 238 a.C., cioè in età cosiddetta ellenistica, il rito funebre iniziò lentamente a mutare e, sotto l'influsso della cultura greca onnai diffusa in tutto il Mediterraneo, a ritornare verso l' incinerazione dei defunti. Il rito funebre doveva assomigliare sostanzialmente a quello in uso durante l'epoca fenicia, con una sola variante. Questa prevedeva la combustione dei corpi dei defunti in un unico spazio comune predefinito, denominato ustrinume7). Durante il rogo venivano gettati nel fuoco piccoli recipienti in terracotta, verosimilmente contenenti sostanze profumate, che rimanevano tra i carboni e tra i frammenti ossei più minuti. Sia i vasi, spezzati e combusti, che le ossa più piccole venivano lasciati tra le ceneri e i carboni, mentre i frammenti più grandi delle ossa erano raccolti e venivano conservati in recipienti di terracotta o in drappi di stoffa. Quindi si provvedeva alla deposizione dell'urna cineraria o dell'involto che in alcuni casi sono stati rinvenuti all'interno dei loculi contenenti i corpi dei primi proprietari delle tombe a camera ipogeae8
).
Poiché in età ellenistica, cioè tra la conquista romana della Sardegna e il 110 a.C. circa, momento del1' abbandono definitivo di Monte Sirai, il numero degli abitanti era salito probabilmente a circa 500 o 600 individui, mentre invece il numero delle urne rinvenute nelle tombe è minimo, poiché non supera i dieci esemplari, è probabile che esistesse in prossimità dell'abitato un'altra area adibita a necropoli che però non è stata ancora ritrovata e che, in ogni caso, si può presumere non possa essere eccessivamente distante dal centro abitato.
e7) BARTOLONJ 1983 b, p. 206.
e8) AMADASI-BRANCOLI 1965, pp. 100-101, tavv. XLII-XLIII.
• & &
IL TOFET
Il tofet di Monte Sirai sorge attorno al 370/60 a.C., periodo in cui Cartagine decise di fortifica-, re l'insediamento. E evidente dunque che il rito del tofet è stato introdotto in questo periodo da nuovi abitanti che si sono aggiunti ai primi coloni cartaginesi, insediati dopo il 525 a.C., a loro volta probabilmente al posto dei primi abitanti di stirpe fenicia. Che il rito che si svolgeva nel tofet avesse anche un carattere funerario, oltre che sacro, è dimostrato dal fatto che, come si vedrà, i primi coloni cartaginesi di Monte Sirai seppellivano i loro bambini defunti all'interno di anfore e, quantunque nella valle della necropoli, in un settore adiacente, ma diverso e ben distinto da que1lo delle tombe ipogee degli adultie).
Il tofet di Monte Sirai è ubicato su una terrazza di ignimbrite affacciata sul versante settentrionale della valle della necropoli (Fig. 3, C). Si tratta di una vasta spianata rocciosa su due livelli, dei quali quello inferiore conteneva le urne, appoggiate sulla roccia e poi sepolte artificialmente con terra di riporto. Oltre che per ricoprire i recipienti, il riempimento artificiale si era reso necessario anche per poter sistemare convenientemente le stele. Subito dopo la scoperta del tofet si era ipotizzato che tra il tempio e il settore dedicato alla deposizione delle urne vi fosse una grande scalinata monumentale composta da sette gradini e quindi il complesso templare era stato restaurato seguendo questa soluzione architettonicae).
Recenti studi effettuati da Sandro Filippo Bondì hanno permesso invece di constatare che il collegamento tra il livello occupato dalle urne e quello della platea del tempio era realizzato da una scalinata monumentale formata da unicamente tre gradini, che a sua volta dava accesso ad una rampa, la quale si apriva la strada attraverso un varco nel muro di terrazzamento, che sosteneva il terrapieno teso a regolarizzare la platea del tempio, e conduceva al livello superioree).
Le urne rinvenute nell'area, tutte pentole da cucina evidentemente mai utilizzate e chiuse da un coperchio o da un piatto, sono circa 400 ed erano deposte secondo una stratigrafia composta da due differenti livelli(4
). All'interno delle urne vi erano le ossa calcinate dei bambini e di piccoli animali sacrificati al momento della deposizione. Oltre a questi resti sono stati rinvenuti alcuni amuleti, alcuni piccoli gioielli e numerosi piccoli vasi di dimensioni minime che come fonna imitavano i recipienti in grandezza naturalee). Dato che non sono stati rinvenuti in tutte le urne, questi piccoli recipienti non possono essere considerati una sorta di corredo di accompagnamento simile a quello dei defunti adulti, ma è possibile che si tratti di veri e propri giocattoli appartenuti in vita ai piccoli defunti.
Il più antico dei due strati era senza dubbio il più ampio e ricco di deposizioni ed era quello nel quale erano state utilizzate anche le stele, mentre il secondo, in funzione dopo il 238 a.C. era contenuto in una superficie più ridotta rispetto alla precedente, presentava un numero più ridotto di urne ed era addossato alla scala che dava accesso al tempio, senza travalicame l'ampiezza.
Le stele del tofet di Monte Sirai in genere rappresentano sia la consueta facciata egittizzante, con gli elementi canonici costituiti dal fregio di serpenti, dalla gola egizia, dai pilastri e con l' im-
et) B ARTOLONI 1989 c, p. 74; BAJITOLONJ 1992 e, p. 50.
~) BARRECA 1964, pp. 21-36; CECCHINI 1965, pp. 123-33.
e) BO:"'DÌ 1992 C, pp. 55-59 e, da ultimo, BoNDI 1995, pp. 223-38.
(4
) Sulla tipologia delle urne, cf. BARTOLONI 1981 b, pp. 223-30; BARTOLONI 1982 b, pp. 283-90.
e) 8ARTOLONI 1982 b, p. 289, fig. 5, i.
80 Parte Seconda
magine della divinità al centro del sacello, sia- ma in questo caso assai più raramente- quella di tipo grecizzante con timpano e acroteri. I modelli a cui senza dubbio si sono ispirati, sia pure con molta libertà, g1i artigiani di Monte Sirai provengono in modo incontrovertibile dal tofet dell'antica Sulcis(6
) • .
Il livello superiore della terrazza del tofet ospitava un luogo di culto, articolato anch'esso in differenti settori(). Il primo, probabilmente privo di copertura, era costituito dalla breve spianata. A questo luogo di disimpegno si accedeva attraverso la rampa citata più sopra. Questa spianata dava accesso a un vano coperto, come testimoniato dalla presenza di un pilastro collocato in posizione centrale, ed era verosimilmente il naos nel quale avevano accesso i devoti. Superato questo vano mediano, attraverso una stretta porta si entrava nel penetrale. In questo locale, addossati all'angolo di destra sono stati rinvenuti due focolari parzialmente sovrapposti, uno rettangolare ed uno pari ad un quarto di cerchio, riferibili alle due diverse fasi d'uso del tempio, corrispondenti ai due diversi periodi di frequentazione del tofet.
A destra dell'ingresso e quindi davanti ai focolari si apriva un piccolo vano, al cui interno sono state rinvenute le ceneri dei sacrifici avanzate dopo che i resti ossei di maggiori dimensioni erano stati raccolti e deposti nelle singole urne. All'interno del vano sono stati rinvenuti tra l'altro anche i frammenti di alcune statuine votive, probabilmente spezzate durante il rito(8
) .
Attualmente l'area sacra è stata sottoposta ad interventi di restauro che hanno seguito, sia pure in modo non completo e pienamente rispondente, le indicazioni raccolte durante le indagini.
Le urne rinvenute, praticamente tutte pentole da cucina, erano disposte su tre strati sovrapposti(9). La tipologia, che è riscontrabile speculannente anche in seno all'abitato(10
), comprende, tra la metà del IV e il primo quarto del III secolo a.C., soprattutto recipienti con orlo verticale appena gonfio esternamente, due anse nastriformi orizzontali, pancia globulare schiacciata e, assai raramente, un versatoio cilindricoe 1). Nel pieno III secolo, invece, prevalgono le pentole con orlo obliquo, provvisto di risalto interno per l'appoggio del coperchio, e due anse cilindriche orizzontali(12
).
Non mancano, soprattutto in quest'ultimo periodo, tipi diversi dalla norn1a, tra i quali alcune pentole con orlo rientrante e anse a orecchia e numerose imitazioni di originali attici di piena età ellenistica(13). I coperchi, nella fase più antica, sono costituiti prevalentemente da piatti ombelicati con orlo pendentee4
), mentre negli strati più tardi sono parzialmente sostituiti da piatti cosiddetti da pesce oppure di imitazione attica(' 5
) o anche da tappi conici con bottone di presaC 6).
• l.
d.
h.
a.
(6
) Sulle stele cf. BoNol 1972; B o NDì 1980 a, pp. 51-70; da ultimo, MoscATr 1996, pp. 65-98.
() Cf. BoNDl 1992 c, pp. 55-60, e, da ultimo, PERRA 1998, pp. 165-68, 247-52, tavv. 29-39.
(8
) GARBINI 1964 a, pp. 96-99, tavv. L-LI.
(9
) Cf., da ultimo, BoNDt 1989, pp. 23-43.
( 1 0
) Cf. CAMPANELLA 1 999.
e 1) BARTOLONI 1981 b, pp. 224-25, fig. l, l, 3, 5, 7; BARTOLONI 1982 b, pp. 284-87, figg. l, b, d, f, h, 2, b, d, f,
(12
) BARTOLONI 1981 b, pp. 226-27, figg. }, 11 , 2, 3, 3, 5; B ARTOLONI 1982 b, pp. 287-88, figg. 3, b, d, f, h, 5,
(13
) BARTOLONI 1981 b, pp. 226-27, fig. 2, 7; BARTOLONI 1982 b, pp. 287-88, figg. 3, d, 4, d, 5, b.
e4) B ARTOLONI 1981 b, pp. 225-26, figg. l, 4, 6, 2, 6, 11 ; B ARTOLONI 1982 b, pp. 286-87, figg. l, a, c, e, g, 2, a , C, e,
es) Cf. injra, Forma 3.
(16
) BARTOLONI 1981 b, pp.' 227-28, figg. l , 10, 2, l , 4; BARTOLONI 1982 b, pp. 287-88, figg. 3, a, C, e, g, 4,
'
LE TOMBE
La tipologia
Nel corso dei rapporti preliminari di scavoe) si è avuto modo di presentare i diversi tipi di sepolture in uso nella necropoli fenicia di Monte Sirai e si è posto l'accento sia sulla indubbia prevalenza del rituale dell' incinerazione, sia sulla considerevole percentuale, rispetto ad altri impianti funerari coevi, delle tombe che invece hanno seguito la pratica delrinumazionee). In dettaglio, su settantatre situazioni sono distinguibili settantadue sepolture e un ustrinum di età ellenistica. Tra le settantadue sepolture, ben sessantatre sono ascrivibili al periodo fenicioe), mentre sette più una sono rapportabili ali' occupazione cartaginese e riguardano unicamente tombe infantili a enkytrismòs(4). Tra le sessantatre tombe di età fenicia, cinquantasei sono ad incinerazionee), mentre sette sono ad inumazione(6). Sempre tra le tombe ad incinerazione, sei casi possono riguardare dei possibili ustrina(), dei quali si tratterà in seguito. Infine, una fossa, originariamente classificata come tomba(8
), è da considerare probabilmente un tentativo di realizzazione di una fossa non portato a compimento. Pertanto, riassumendo quanto esposto, nella necropoli di Monte Sirai fino ad ora esplorata sono presenti sessantatre tombe fenicie, delle quali sette ad inumazione e sei identificabili come possibili ustrina di età fenicia, mentre riguardano 1' età punica sette enkytrismòi, una sepoltura di infante priva del vaso contenitore e del corredo e, infine, un ustrinum di età ellenistica.
Le necropoli di età fenicia documentate in Sardegna e, come tali, le uniche esistenti al momento, sono quella di San Giorgio di Portoscusoe), quelle settentrionale e meridionale di Tharrose0), quella di Othocae 1
) e quella di Sulcise2), delle quali in ogni caso non conosciamo l'origi
naria consistenza. La necropoli di San Giorgio è un piccolo sepolcreto fami1iare composto da undici tombe e come tale caratteristico della più antica colonizzazione fenicia. Quanto alle necropoli di Tharros, queste sono state esplorate soprattutto tra la fine del secolo scorso e i primi anni di questo secolo e i risultati editi sono assolutamente sommari e non forniscono dati pienamente utilizzabili. La necropoli di Othoca, della quale sono note alcune tombe, è in gran parte sottoposta ali' abitato
e) BARTOLONI 1982 b, pp. 283-90; BARTOLONI ]983 b, pp. 205-17; soprattutto BARTOLONI 1985 a, p. 249.
e> Contrariamente a quanto prospettato in BARTOLONI 1983 a, pp. 35-53, ove per la necropoli fenicia di Bitia si in
dicava una percentuale di inumazioni pari al 4% circa, si veda invece BARTOLONI 1996, pp. 55-59, ove, se si esclude una testimonianza di inumazione secondaria, non vi sono ulteriori tracce di questo tipo di rituale, che riguarda unicamente la successiva età punica. Per quanto riguarda invece la necropoli di Monte Sìrai, la percentuale di inumatì di età fenicia è pari al 10,5%.
e) Tombe 1-28, 30-40, 42-44, 48-55, 57-58, 60-68, 70-72.
(4
) Tombe 29, 41, 45-47, 56, 59, 69.
e) Tombe 1-19, 21-24, 26, 30, 32-34, 36-40, 42-44, 49, 51-55, 57-58, 60-68, 70-72.
(6) Tombe 20, 25, 27, 31, 35, 48, 50.
() Tombe 3(?), 23-24, 34, 37-38.
( 8) Tomba 28.
(9
) Cf. BERNARDINI 1997, pp. 55-58.
( 10
) Cf. BARTOLONI 1983 a, pp. 64-70, e da ultimo, anche per la bibliografia, ZuccA 1997, pp. 95-98.
e1) Cf. da ultimo, Io., L'insediamento fenicio di Othoca: Phoinikes, pp. 91-94.
(12
) Cf. BARTOLONI 1981 a, pp. 22-24; BARTOLoNr 1989 a, pp. 30-31, 33.
84 Parte Terza
attuale e altrettanto accade per quella del capoluogo sulcitano, la cui ubicazione è nota solamente grazie al reperimento di un'unica fossa ad incinerazione. L'unica in grado di fornire testimonianze probanti, poiché in apparenza totalmente esplorata è quella di Paniloriga, che era costituita da circa centocinquanta tombe, presumibilmente coeve a quelle del settore di Monte Sirai attualmente indagato. Tuttavia, questo impianto funerario è praticamente inedito e, purtroppo, si suppone Io rimarrà a causa della prematura scomparsa dello studioso che ne curava l'indaginect3
).
Se confrontata con quella della necropoli di Bitia, unica tra quelle fenicie di Sardegna, oltre a quella di Monte Sirai, della quale sia stato possibile esplorare e documentare un numero di tombe sufficientemente ampio e significativoe4
), la situazione si presenta come segue. Innanzi tutto, contrariamente a quanto prospettato in precedenza per la necropoli fenicia di Bitiae5
), ove si indicava una percentuale di inumazioni pari al 4% circa, si vedano le ultime risultanze che riguardano il settore indagato tra il 1976 e il 1979. Infatti, se si esclude una testimonianza di inumazione secondaria, non vi sono ulteriori tracce di questo tipo di rituale, che invece riguarda unicamente la successiva età punica. Occorre comunque aggiungere che, tra le tombe indagate nella stessa località tra il 1979 e il 1983, compaiono quattro tombe ad inumazione di età fenicia, che, assieme alla sepoltura con rito secondario, riportano la percentuale al 5% circact6
). Per quanto riguarda invece la necropoli di Monte Sirai, la percentuale di inumati di età fenicia è assai più considerevole poiché risulta pari al 10,5% e tale percentuale sembra confennata anche dalle indagini effettuate recentemente(17).
Dunque, la maggior parte delle tombe della necropoli di Monte Sirai - ben cinquanta esemplari - segue il rito dell' incinerazione e, per di più, tutte queste tombe hanno la medesima tipologia. Questa infatti è costituita prevalentemente da una semplice lente di bruciato, di fonna ellittica (Fig. 7; Tav. IX, c), della lunghezza assai raramente superiore ai 2 metri e della larghezza spesso inferi'ore al metroct8
), il cui processo esecutivo e la tipologia sono stati descritti più sopra. Occorre aggiungere, come già segnalato in sede di rapporto preliminare, che alcune fosse sono state praticate nello spessore dell'humus e intaccano più o meno profondamente il sottostante strato di tufo, mentre altre non lo raggiungono neppure e risultano ricavate direttamente nel terreno. Questa situazione diffonne dipende con ogni probabilità unicamente dalla potenza del terreno, che in genere, come detto più sopra, è di circa 40 centimetri, ma che, in determinati settori, quali ad esempio gli impluvi, raggiunge spessori maggiori. La forma delle fosse ad incinerazione è prevalentemente lenticolare (Fig. 8; Tav. IX, c)C9), fonna da cui del resto deriva la denominazione di lente di bruciato, ma non mancano anche le fosse di forma vagamente quadrangolare (Figg. l O, 15-16)e0).
N eli' ambito della necropoli risultano assenti testimonianze di altre tipologie tombali, riscontrate, invece, tra l'altro nell'area cimiteriale di Bitiae1
). In effetti, nell'area di Monte Sirai non sono presenti le ciste litiche, che, come già registratoe2
), non sembrano cronologicamente ristrette ad un preciso periodo, ma, almeno per quanto riguarda l'Occidente mediterraneo, sono testimoniate in tutto l'arco occupato dalla civiltà fenicia. Pertanto, risulta evidente che le ciste litiche non sono as-
( 13
) Cf., da ultimo, T oRE 1995, pp. 239-52.
(14
) BARTOLONI 1983 a, pp. 35-53.
('5
) B ARTOLONI 1996, p. 59.
(16
) B ARTOLONI 1983 a, pp. 58-60.
('7
) Cf., da ultimo, BARTOLONJ 1996, p. 55; B.~RTOLONI 1998, pp. 353-58.
( 18
) B ARTOLONI 1983 b, p. 207.
(19
) Cf. ad esempio le Tombe 4, 6, 18, 21 , 32.
eo) Cf. ad esempio le Tombe 16, 39-40, 53.
e1) Anche per ulteriori testimonianze cf. BARTOLONI 1996, pp. 55-57.
e2) BAR'fOI.ONI 1996, pp. 56-57.
Le tombe 85
senti nella nostra necropoli per motivi cronologici, ma a causa di una evidente e specifica scelta. Del resto, le deposizioni in cista litica sono evidentemente di tipo secondario, come evidenziato dall'assenza di tracce di bruciato nel loro interno, ad ovvia eccezione delle ossa combuste opportunamente inserite nel contenitore.
Inoltre, sempre nella nostra necropoli, sembrano mancare i vasi cinerari destinati a raccogliere le ceneri di roghi effettuati in altre sedie3
). Come detto, è stata invece più volte registrata la presenza di possibili ustrina totalmente privi di corredo, che potrebbero essere riferibili a urne deposte altrove e non ancora rinvenute. In effetti, questi ustrina sono costituiti da una lente di bruciato di estensione senza dubbio minore rispetto a quella delle tombe ad incinerazione contenenti sia le ossa che il corredo. Non è da escludere tuttavia che, vista lo loro collocazione periferica, almeno in alcuni casi, come quelli delle Tombe 23-24, classificabili anche come ustrina (Fig. 6; Tav. XII, a-. b), si tratti di tombe ad incinerazione parzialmente danneggiate durante i lavori di sterro effettuati nel 1963e4
), tesi alla messa in evidenza del dromos della Tomba ipogea 2* (Fig. 22). Infatti, come è stato possibile notare, in alcuni casi, sia a causa di precedenti smottamenti del terreno, sia per le arature effettuate nella valle, le tombe ad incinerazione più superficiali hanno subito considerevoli danni, tra i quali la totale asportazione del corredo, già di per sé in condizioni precarie, data la notevole acidità del terreno.
Per quel che riguarda il rito dell ' inumazione di età fenicia, la necropoli di Monte Sirai, come detto, ci offre sette esempi, tutti collocati in tombe a fossa. Queste sepolture sono tutte costituite da fosse di fonna rettangolare allungata profondamente scavate nel terrenò, certamente assai più di quanto non lo siano quelle ad incinerazione. Mentre la lunghezza di queste fosse supera talvolta abbondantemente i due metri (Figg. 11-14), la loro larghezza talvolta appare appena sufficiente a . contenere il corpo e raramente supera gli 80 centimetri (Fig. 11-12, 15; Tav. XIV, c). La profondità di norma è compresa tra gli 80 centimetri e il metro, ìvi comprese le due depressioni speculari che in molti casi occupano il fondo della fossa in corrispondenza dei lati brevi (Fig. 21 )e5
). Come già notato, questi incavi erano destinati a contenere il corredo di accompagnamento. Quindi risulta evidente come il corpo del defunto dovesse poggiare su un letto funebre - probabilmente una semplice asse - che poggiava sul diaframma centrale, che separava le due depressioni, in modo da rendere uniforme il fondo della fossa. Nell'ambito della necropoli non è stato possibile notare un particolare orientamento del corpo degli inumati poiché le tombe seguono la linea di naturale declivio e quindi hanno tutte lo stesso orientamento.
Un particolare di notevole interesse, già riferito in altra sede, consiste nella presenza di grosse pietre (Tav. XVI, c)e6
) o di altri oggetti di notevoli dimensionie7), che non provengono dalla co
pertura della fossa, ma appaiono deposti intenziomilmente e poggianti direttamente sul corpo del defunto (Fig. 21). Questa pratica, della quale non sembra sussistere traccia nelle tombe di Cartaginee8), era tesa con ogni evidenza ad impedire l'uscita dei rephaim dall'interno della sepoltura.
Come detto, in genere il corredo occupava le depressioni praticate alle estremità della fossa e, nella maggior parte dei casi, un recipiente - una founa chiusa - era collocato
e3) BARTOLONI 1996, p. 56.
e4) B ARRECA 1964, pp. 36-55.
e s) B ARTOLONI 1983 b, pp. 208, 2 10, 217, figg. 3, 7.
e6) Cf. B ARTOLONI 1985 a, pp. 249-50, e, da ultimo, BARTOLONI 1998, p. 356 . .
•
,
e7) Almeno in un caso si tratta di un'anfora da trasporto presumibilmente vuota deposta longitudinalmente sul
. . .
corpo del defunto e rinvenuta nella Tomba 95, durante la campagna di scavi del 1998.
es) Nella pur capillare rièerca effettuata da Hélène Benichou-Safar non vi sbno riscontri di questa particolare usanza.
86 Parte Terza
a stretto contatto con la testa del defuntoe~. forse in allusione ad una sorta di rito del refrigeriume0).
Restano da descrivere le sette sepolture a enkytrismòse1), più l'unica deposizione infantilela Tomba 56- priva di anfora e di corredo (Fig. 18; Tav. XXX, a), rinvenute nell'area della necropoli ad incinerazione, ma riferibili al successivo periodo punico. Come già notato, per quanto riguarda l'aspetto cronologico, queste sepolture, così come le altre tipo logicamente affini rinvenute in questi ultimi anni, sono tutte indistintamente appartenenti all'arco di tempo compreso tra la fine del VI secolo a.C. e i primi anni del IV secolo a.C. La cronologia ci viene fornita soprattutto dai vasi contenitori delle spoglie dei bambini - tutte anfore di tipo commerciale - che nella maggior parte dei casi sono stati rinvenuti nelle fosse (Figg. 12, 14-16, 20-21; Tav. XXI, d). Ma preci sazi on i cronologiche derivano anche, quando siano presenti, dai pur modesti corredi - recipienti o gioielli - che accompagnavano i piccoli defunti e che verranno esaminati in seguito. Le fosse sono collocate nell'area della necropoli fenicia, senza alcun rispetto per le sepolture precedentie2
). Si tratta generalmente di piccole fosse, di dimensioni esigue e appena necessarie all'inserimento delle anfore. Tuttavia almeno in un caso, che riguarda le Tombe 46-47 (Figg. 14, 21; Tav. XXII, d-e), la fossa è ampia e profonda e presenta lungo il suo perimetro un gradino, destinato ad accogliere le lastre di coperturae3
).
Quanto all'unica sepoltura priva di corredo, questa conteneva i resti assai consunti -praticamente ridotti ormai all'impronta- delle ossa del piccolo in posizione supina (Fig. 18, T . 56; Tav. XXX, a). Se si deve giudicare dalle dimensioni, l'età dell'infante al momento del suo decesso doveva essere compresa tra i 18 e i 24 mesi.
La cronologia
Per quel che riguarda la cronologia de1l'impianto funebre occorre dire innanzi tutto che il settore di età fenicia appare compreso tra la fine del VII e l'ultimo quarto del VI secolo a.C., mentre, per quel che concerne il settore punico riservato ai bambini, questo è ristretto tra il V e i primi anni del IV secolo a.C.
Passando ad un esame più dettagliato della necropoli fenicia, si noterà come due sole tombe appartengono al periodo compreso tra fine VII- inizi VI secolo a.C.C4
), mentre quattro sono comprese nel primo quarto del VI secolo a.c.e5) e altrettante nel secondo quarto dello stesso secoloe6). Diciassette tombe appartengono, senza più precisa distinzione cronologica, alla prima metà del VI secolo a.c.e7
) , mentre tredici sono collocate negli anni attorno alla metà del VI secolo a.C.C8) e solo due sono attribuibili genericamente alla seconda metà del VI secolo a.c.e9). Due ul-
e9) Cf. ad esempio le Tombe 25, 35, 48.
eo) Cf. BENICHOU-SAFAR 1982, pp. 284-85; BAIITOLONI 1996, p. 61.
e•) Cf. BENICHOU-SAFAR 1982, pp. 65-67; BARTOLONI 1996, pp. 57-58.
C2) Cf. BARTOLONT 1985 a, pp. 251-53, 261, e, in particolare, la Tomba 40, di età fenicia, e la Tomba 41 , di età punica, o la Tomba 42, dì età fenicia, e le Tombe 46-47, di età punica.
20. C3) Cf. BARTOLONI 1985 a, pp. 252-53, 261; per la tipologia della tomba cf. 8ARTOLONI 1985 a, p. 252, nota
C4) Tombe 49, 54.
C5) Primo quarto del VI secolo a.C. = Tombe 27, 32, 35, 55.
(36
) Secondo quarto del VI secolo a.C. = Tombe 25, 39-40, 68.
C7) Prima metà del VI secolo a.C. = Tombe 4, 9, 11, 14-18, 21, 42, 51-52, 57, 60-62, 64, 67.
C8) Attorno alla metà del VI secolo a.C. = Tombe 6, 10, 26, 33, 43-44, 48, 50, 53, 58, 63, 65-66.
C9) Seconda metà del VI secolo a.C. = Tombe 20, 30.
Le tombe 87
teriori tombe sono inserite nel terzo quarto del secolo(40) e, infine, una sola riguarda l'ultimo quar
to del VI secolo a.C.(41).
Per quel che concerne la necropoli di età punica, cinque sepolture sono inseribili nel V secolo a.C. senza maggiori dettagli cronologici(42
) e solamente una è attribuibile agli inizi del IV secolo a.C.(4J).
A conclusione di questo capitolo, si richiama l'attenzione, se ciò è ancora necessario, sulla coincidenza cronologica che riguarda la cessazione delle deposizioni di bambini nell'area della necropoli ad incinerazione e l'inizio delle deposizioni nell'area del tofet, il cui primo impianto è da collocare appunto nella prima metà del IV secolo a.C.(44
).
(40
) Terzo quarto del VI secolo a.C. = Tombe 2, 31.
(41
) Ultimo quarto del VI secolo a.C. = Tomba l.
(42
) V secolo a.C. = Tombe 41, 45-47, 59.
(43
) Inizi del IV secolo a.C. = Tomba 29.
(44
) BoNDì 1995, p. 225.
I CORREDI
Tra le sessantaquattro tombe della necropoli fenicia, quelle' fomite di corredo sono ben cinquantaquattroe ), mentre, come è ovvio, quelle che ne sono totalmente sprovviste sono diecie). Già in altra sede è stata fatta una netta distinzione tra le varie componenti che concorrono in diversa misura a formare il corredoe). Nel caso della necropoli di Monte Sirai non è mai comparsa, almeno per il momento, la prima di queste componenti, costituita dal recipiente utilizzato come contenitore delle ossa combuste, poiché, come si è posto in evidenza nel capitolo precedente, tutte le tombe di età fenicia sono costituite da lenti di bruciato e non vi è traccia di sepolture del tipo a cista litica. La seconda componente è costituita dai vasi che erano parte del rituale funebre: come è noto si tratta della brocca con orlo espanso (Forma 16), destinata probabilmente a contenere olio profumato e utilizzata per l'unzione del corpo del defunto, e della brocca con bocca bilobata (Forma 26), deputata forse ad accogliere il vino e quindi usata verosimilmente per la libagione sacra(4
). La terza componente è co~tituita dal corredo di accompagnamento, che di nonna è formato da quei recipienti, forme aperte e chiuse, che erano deposte all'interno della tomba appunto per accompagnare il defunto nel suo viaggio verso l' oltretombae). La quarta ed ultima componente era costituita dagli oggetti personali, quali i gioielli(6) o il recipiente per l'igiene personale(). In quest'ultimo caso, mentre nella necropoli di Bitia il rinvenimento di questi particolari recipienti (Forma 19), sia all'interno delle sepolture che fuori contesto, è numericamente considerevole(8
), a tal punto da poter essere considerato quasi una costante, nella necropoli di Monte Sirai questa forma ceramica compare in un solo caso e per di più fuori contesto(9).
' Nella nostra necropoli le tombe che mostrano tutte le diverse componenti del corredo, fatta
eccezione per la prima, che, come detto, non è testimoniata, sono sei (Figg. 7, 9, 12-13)(10). Quelle
che presentano invece sia i vasi rituali che quelli di accompagnamento, ma non conservano tracce di arredi personali, sono ben venticinque (Figg. 7-12, 14, 16)e 1
). Inoltre, le tombe che custodiscono sia il corredo rituale che quello personale sono tre (Figg. 7, 15)ct2
), mentre, come detto, quelle che preservano testimonianze sia del corredo di accompagnamento che di quello personale sono sei (Figg. 1-s, 14, 17, 19)e3).
Passando ali' analisi dettagliata delle tombe che presentano il corredo rituale, occorre segnalare che diciannove sepolture sono dotate sia della brocca con orlo espanso che di quella con bocca
" (') Tombe 1-2, 4-11, 14-18, 20-22, 25-27, 30-33, 35-36, 39-40, 42-44, 48-55, 57-58, 60-68, 70-72.
e) Tombe 3, 12-13, 19, 23-24, 28, 34, 37-38.
e) Cf. BARTOLONI 1996, p. 61.
(4
) Cf. supra, pp. 68-69 e BARTOLONI 1996, p. 61.
e) Cf. BENICHOU-SAFAR 1982, pp. 262-72; BARTOLONI 1996, p. 61.
( 6) Cf. BENICHOU-SAFAR 1982, pp. 260-61; BARTOLONI 1996, p. 61.
C) Cf. BARTOLONI 1996, p. 61.
(8) Cf. BARTOLONI 1996, pp. 95-97.
(9
) Cf. N. 221.
{'0) Cf. Tombe 2, 14-15, 26, 30, 32. :
e 1) Cf. Tombe 4, 6, 9-11, 16, 20-21, 25, 33, 39-40, 49, 51-53, 55, 57, 60, 62-63, 65, 67-68, 72.
e2) Cf. Tombe 8, 44, 50.
(13
) Cf. Tombe 5, 7, 35, 42, 54, 66.
90 Parte Terza
bilobata (Figg. 7-10, 13-14, 16-20)(14), mentre nove sono fomite della sola brocca con orlo espanso
(Figg. 8, 12, 15-17, 19-20)e5) e undici conservano la sola brocca con bocca bilobata (Figg. 7-9,
11-12, 18-20)( 16), dunque con un totale di trentanove tombe sulle cinquantaquattro dotate di corredo rituale.
Entrando nel novero delle tombe che non mostrano traccia dei vasi rituali ma che hanno testimonianze sia del corredo di accompagnamento che di quello personale, occorre dire che si tratta di sole sei sepolture (Figg. 7-8, 14, 17, 19)( 17
), mentre sei conservano il solo corredo di accompagnamento (Figg. 7, 10, 14-15, 18, 20)C8). Passando ad un'analisi dettagliata di quest'ultimo, fatte salve le fonne che in qualche modo possono sostituire i vasi rituali canoniciC9), si potrà notare che ben quarantuno tombe sono fornite di corredo di accompagnamento (Figg. 7-20)e0
). Di queste, trentacinque presentano uno o più piattie1
), mentre, tra le restanti sei, cinque conservano una coppa o, comunque, una forma apertae2
). Rare sono le fonne chiuse - per lo più brocche, anfore o pentole - associate ai piatti o alle tazzee3
), mentre isolata è la Tomba 62 che presenta il corredo di accompagnamento composto da una sola fonna chiusae4
). Da considerare assolutamente a parte sono i frammenti di anfora oneraria - soprattutto parti di parete - che, sia pure isolati, visibilmente partecipano alla copertura della tomba e non al suo corredoe5
).
Infine, è necessario segnalare che nessuna tomba è dotata unicamente del corredo personale, ma questo non si presenta mai isolato ed è invece sempre accompagnato o da quello rituale, o da quello di accompagnamento, oppure da entrambi.
Per quanto riguarda invece le sepolture a enkytrismòs (Figg. 12, 14-16, 18, 20)e6), mentre una sola, come detto, è priva di anfora (Fig. 18) e, quindi, a rigor di logica, non potrebbe neppure essere classificata tra gli enkytrismòie1
), solo un'altra è dotata unicamente della sola anfora ed è mancante di ogni altro corredo (Fig. 12)e8
). Tra le altre sei, se tutte sono fomite dell'anfora e di un corredo personale sia pur minimo, sempre costituito da gioielli, solo due (Figg. 14, 16)e9
) presentano in associazione il corredo di accompagnamento, costituito da recipienti fittili. In particolare, la Tomba 4 7, che del resto è quella più monumentale, mostra una brocca e una tazzae0), mentre la Tomba 41 conserva invece un frammento di piattoe1
). Tuttavia quest'ultimo recipiente, se si deve giudicare dalla fonna, è pertinente alla metà del VI secolo a.C. ed è quindi da considerare un intru-
(14
) Cf. Tombe 2, 9-11, 14, 16, 27, 31-32, 39-40, 49, 51, 53, 55, 57, 62, 67, 72.
es) Cf. Tombe 6, 25, 30, 44, 50, 52, 58, 64-65.
e6) Cf. Tombe 4, 8, 15, 20-21, 26, 33, 60, 63, 68, 71.
e7) Cf. Tombe 5, 7, 35, 42, 54, 66.
es) Cf. Tombe l, 18, 43, 48, 61, 70.
e9) Sì intendono in questo caso le forme ceramiche che sostituiscono i vasi canonici e soprattutto la brocca con
bocca bilobata (Forma 26), rimpiazzata in genere dalla brocca con bocca trilobata (Forma 29): cf. in proposito il corredo della Tomba 32, nel quale la brocca trilobata N. 91 prende il posto di un recipiente relativo alla Forma 26.
72. eo) Cf. Tombe 1-2, 4-7, 9-1 J, 14-18, 20, 25, 30,32-33, 35, 39-40, 42-43,49, 51-55, 57-58, 60, 62-63, 65-68, 70,
e1) Cf. Tombe 2, 4-7, 9-11, 14-17, 25, 30, 32-33, 39-40, 42, 49, 51-55, 57-58, 60, 63, 65-68, 70, 72.
e2) Cf. Tombe l, 18 (Ponna 11), 20, 35 (Forma 11), 43.
e3) Cf. Tombe 16, 20, 25, 30, 32, 35, 60, 66.
e4) Cf. N. 169 (Forma 17).
es) Cf. Tombe 6, 9, 20, 22, 25, 36, 40, 53, 66.
e6) Tombe 29, 41, 45-47, 56, 59, 69.
e7) Tomba 56.
es) Tomba 29.
e9) Tombe 41, 47.
e<) Cf. NN. 208-209.
e') Cf. N. 198.
I corredi 91
so, penetrato nella tomba stessa durante la realizzazione della fossa, che probabilmente ha distrutto una precedente sepoltura, alla quale apparteneva per l'appunto il piatto. Quindi, in realtà, tra le tombe di età punica, solo la Tomba 47 mostra la presenza di un corredo di accompagnamento.
A conclusione di questo capitolo occorre ricordare che nei corredi tombali della necropoli fenicia di Monte Sirai non vi è traccia di armi, in palese contrasto con quanto è dato di constatare per le necropoli coeve di Sardegnae2
).
( 32) Cf., da ultimo, Bono 1996, pp. 137-44.
LA TIPOLOGIA
Gli oggetti rinvenuti all'interno delle tombe o nelle loro adiacenze sono duecentonovantuno~ tra questi, ben duecentoquarantacinque sono costituiti da recipienti fittili , mentre i restanti quarantasei sono rappresentati da gioielli o da altri oggetti.
In questa sede viene esaminata la tipologia delle forme ceramiche, divise come di consueto tra quelle aperte e quelle chiuse. Per quanto possibile, ancorché fosse una tipologia dettata piuttosto dali' argomento contingente che non da analisi specifiche, si è cercato di rispettare la sequenza a suo tempo seguita per quanto riguarda la ceramica fenicia e punica della necropoli di Bitiae). Poiché la sequenza numerica delle foune aperte comprendeva tredici tipi, l'unica differenza sostanziale rispetto al criterio utilizzato in quella sede consiste nella Forma 13, alla quale, nel nostro caso, sono stati assimilati bacini, patere e spianee). Infatti, in questa forma sono riuniti i recipienti aperti da mensa, mentre, per quanto riguarda la tipologia proposta per la necropoli di Bitia, nella Forma 13 erano comprese le lucerne a due becchi contrapposti, di imitazione grecae).
Come si potrà notare, il numero delle forme presenti tra i corredi del nostro impianto cimiteriale è decisamente inferiore a quello della necropoli di Bitia, ove erano presenti, tra fonne aperte e chiuse, ben quaranta tipi(4
). Nel nostro caso, invece, sono riscontrabili solo venticinque tipi, tra i quali tredici relativi a fonne aperte. Non sono chiari i motivi di questa scarsa varietà, che, visti gli archi temporali quasi coincidenti occupati dalle due necropoli, non ha certamente implicazioni di carattere cronologico. In effetti, le due necropoli sono praticamente contemporanee, con un divario di circa un trentennio a favore dell'impianto funerario di Bitiae). A puro livello di ipotesi si potrebbe avanzare la proposta che la modesta varietà di forme riscontrabile nei corredi di Monte Sirai possa derivare dalla posizione «marginale» dell'insediamento, ma, in realtà, le analisi tipologiche effettuate sui materiali provenienti dali' abitato(6
) mostrano come l'insediamento in ogni momento della sua storia abbia avuto contatti e scambi, sia pure sostanzialmente attraverso la mediazione di SulcisC), tanto con i più vicini insediamenti fenici che con i centri al di fuori della Sardegna(8
).
Le forme aperte sono tredici, rappresentate da novantuno esemplari, tra i quali ben sessantadue ascrivibili ai piatti della Forma l (9), e i restanti ventinove ripartiti tra le altre dodici forme nel modo che segue: cinque recipienti per la Ponna 13, che, come accennato, raccoglie bacini e spia-
e) BARTOLONI 1996, pp. 67-71.
e) In questa forma sono riuniti i recipienti aperti per la preparazione e la cottura dei cibi.
e) BARTOLONI 1996, p. 87.
(4
) BARTOLONI 1996, pp. 73-87, 89-114.
e) Per l'arco cronologico occupato dalle due necropo]i cf. BARTOLONI 1983 b, pp. 211-12; BARTOLONI 1985 a, pp. 250-51; BARTOLONI 1996, pp. 59-60.
(6) BOTro 1994, pp. 83-115; CAMPANELLA 1999, passim; PESERico 1994, pp. 117-44.
() Cf. ad esempio BARTOLONI 1983 a, pp. 38-39; BoNoì 1972, pp. 89-90; MoscATI 1996, pp. 9-13.
(8
) Tra tutti i possibili influssi allogeni, si veda ad esempio la statua di Ashtart: cf. GARBINI 1964 a, pp. 65-99; B1s1 1986-1987, pp. 107-21; CECCHINI 1991, pp. 683-89; per lo stato della questione e per un riesame della statua, cf., da ultimo, MoscATI 1996, pp. 17-21.
(9) Cf. NN. 7-8, 12-14, 19, 21, 28, 31, 35, 37, 40, 43, 48-50, 53, 64, 68, 77-78, 92, 96, 102, 106, 109, 112, 123, 127, 137, 140, 145, 147, 152, 154, 159-61, 166, 173, 175-76, 178, 181, 186, 188, 190, 194, 198,220,231,234, 237,241, 243, 247, 258-59, 261, 267, 281-82.
94 Parte Terza
neC0); quattro esemplari sono invece attribuiti sia alla Ponna 4, la quale comprende le coppe a ca
lottaC 1), che alla Ponna 10, che riguarda le coppe di imitazione greca(12), che alla Ponna 12, nella
quale sono raccolte le lucerne a conchiglia(13).
Sono riportabili due vasi sia alla Forma 7, la quale concerne le coppe troncoconicheC4), sia
alla Ponna 9, della quale fanno parte le coppe con orlo verticalect5), che alla Ponna 11, alla quale
fanno riferimento le coppe con vasca carenatact6). Infine, sono rappresentate da un solo esemplare la Ponna 2, che riguarda i piatti con risalti sull'orlo(17
), la Forma 3, che comprende i piatti di imitazione atticae8), la Ponna 5, che concerne le coppe con orlo gonfioe9), la Forma 6, nella quale è inserita la coppa con orlo estroflesso(20), e la Ponna 8, della quale fa parte la coppa con risegae1
).
Tra i novantuno esemplari di tipo aperto è compreso anche un frammento da attribuire ad una forma aperta non meglio identificabileCZ2
).
Anche tra le dodici fonne chiuse, rappresentate da centoquarantanove esemplari, accade lo stesso fenomeno osservato per le fonne precedenti: la maggior parte degli esemplari - ben centosedici- è rapportabile a sole tre fonne. In dettaglio quarantacinque esemplari sono riferibili alla Forma 16, che comprende le brocche con orlo espansoCZ3
), trentasette sono rapportabili alla Ponna 26, nella quale sono inserite le brocche cosiddette biconiche o bilobatee4
), e, infine, trentaquattro sono invece riconducibili alla Ponna 39, che comprende le anfore da trasportoCZ5
). I restanti trentatre recipienti sono suddivisi tra le rimanenti nove fonne nel modo che segue: quattordici vasi per la Forma 29, nella quale sono inserite le brocche con bocca trilobatae6), cinque vasi per la Fottna 41, che concerne le anfore di imitazione grecae7
), quattro contenitori per la Ponna 37, che riguarda le pentolee8), tre recipienti relativi alla Forma 42, nella quale sono inserite le anfore con spalla carenatae9), due vasi pertinenti rispettivamente alle Forme 17, che riguarda le brocche con collo carenatoe 0), e 25, che si riferisce alle olpie1
). Infine, un recipiente ciascuna per la Ponna 19, relativa alle
(10
) Cf. NN. 89, 251-52, 272, 274.
(11
) Cf. NN. 56, 153, 244, 246.
e2) Cf. NN. l , 141, 155, 260.
e3) Cf. NN. 51, 88, 158, 233.
(14
) Cf. NN. 107, 116.
(15
) Cf. NN. 20, 209 (quest'ultimo esemplare è di età punica).
( 16) Cf. NN. 54, 98.
e7) Cf. N. 279.
(' 8) Cf. N. 280.
(19
) Cf. N. 33.
e~ Cf. N. 2.
e1) Cf. N. 6.
e2) Cf. N. 217.
e3) Cf. NN. 4, IO, 16, 18, 26, 30, 34, 39, 45,66-67,73,79, 83, 85, 87, 103-104, 108, 117, 122, 124, 126, 128, 135, 139, 144, 151, 157, 162-63, 168, 174, 177, 185, 192, 222, 226, 232, 235-36, 248, 262-63, 291.
(24) Cf. NN. 5, 11, 24, 27, 29, 32, 36, 38, 42, 46, 58, 61 , 70, 74, 82, 97, 105, 111, 125, 138, 143, 150, 156, 165, 170, 172, 187, 189, 191, 193, 219, 223-24, 240, 245, 249, 278.
es) Cf. NN. 17, 25, 57, 62, 65, 101, 110, 142, 146, 179-80, 195, 197, 199,202, 210-11 , 214,218, 225,227-28, 238-39, 253-57, 264, 266, 276, 286-87.
e6) Cf. NN. 52, 55, 60, 69, 75, 80, 91 , 121, 136, 167, 171, 208 (questo esemplare è di età punica), 242, 277.
e7) Cf. NN. 63, 72, 288-90 (gli ultimi tre esemplari sono di età punica).
es) Cf. NN. 86, 1 15, 148, 265.
e9) Cf. NN. 59, 99, 288.
(30
) Cf. NN. 169, 275.
e•) Cf. NN. 76, 250.
La tipologia 95
brocche piriformie2), per la Forma 21, che comprende gli attingitoie3
), e per la Forma 27, quest' ultima unica rappresentante delle brocche di derivazione cipriotaC4
).
A queste fonne vanno aggiunti due frammenti di kernoiC5) e un frammento di thymiate
rionC6), nonché tre fittili d ' importazione e, più precisamente, una olpee1), una kylixe 8
) e un aryballose 9
).
Per quanto riguarda invece i materiali non fittili ascrivibili alla necropoli di età fenicia, sono da segnalare le dieci collane o parti di queste(40
), i sette anelli(41 ), i due orecchini(42
), i tre bracciali(43), i due scarabei/sigilli(44
) , uno dei quali con montatura a falce in argento, e, con un esemplare ciascuno, una catenella(45
) , una pinzetta(46) e quel che resta di una pisside in avorio(47
). Nella necropoli di età punica, composta quasi esclusivamente da sepolture infantili a enkytrismòs, sono da ricordare unicamente due fonne ceramiche, già segnalate più sopra, unitamente a numerosi piccoli oggetti. Per quanto riguarda i gioielli, si ricordano cinque collane o loro parti(48
) , due anelli(49) ,
due braccialiC0) e due orecchini(51
). Sono inoltre da menzionare tre moneteCS2), due scorie di fu
sionee3), un peso(54), un raschiatoio in ossidianaCS5
) e, infine, dalla necropoli ipogea, un rilievo in pietraCS6
).
e2) Cf. N. 221.
e3) Cf. N. 47 .
e4) Cf. N. 90 .
es) Cf. NN. 283-84.
e6) Cf. N . 285.
e7) Cf. N . 84. In sede di rapporto preliminare, questo recipiente e la coppa che segue sono stati da me attribuiti ad
ambiente greco-orientale (cf. BARTOLOJ\1 1983 b, pp. 2 13-14), ma i recenti studi di Carlo Tronchetti, che ha parte in questo lavoro e alla cui analisi aderisco in toto, collocano le due fonne di preferenza neiJ'ambiente dell'Etruria meridionale (cf. inf ra, p. 117).
e&) Cf. N. 93.
e9) Cf. N . 182.
(40
) Cf. NN. 3, 15, 23, 44, 94 , 113, 118, 129, 149, 184.
(41
) Cf. NN. 9, 7 1, 100, 114, 119, 131 , 164.
(42
) Cf. NN. 22, 95.
(43) Cf. NN. 41, 130, 132.
(44
) Cf. NN. 133, 183.
(45
) Cf. N. 120.
(46
) Cf. N. 134.
(47
) Cf. N. 81.
(48
) Cf. NN. 200, 203-204, 206, 213.
(49
) Cf. NN. 212, 215.
C'1 Cf. NN. 196, 20 l.
(51
) Cf. NN. 205, 207.
C2) Cf. NN. 216, 268, 273.
C3) Cf. NN. 269-70.
e4) Cf. N. 229.
(55
) Cf. N. 230.
C6) Cf. N. 27 1.
LE FORME APERTE
Forma l
Se si esamina la tipologia esistente alla ricerca degli antecedenti orientali di questa fonnae ), appare evidente che questa, se non può oggetti v amen te vantare addirittura un'origine occidentale, in questo versante ha almeno un forte sviluppo in autonomia pressoché totale. Come si ricorderà, l'arco cronologico della forma in questione ha inizio non prima del terzo quarto del VII secolo a.C. e risulta essere un prodotto caratteristico della seconda ondata colonizzatrice dei Fenici in Occidentee). Va riscontrato per altro che lo stesso piatto con breve orlo e ampio cavo, che negli stessi territori oltremarini precede cronologicamente la fonna oggetto di esame, sembra non avere in Oriente il numero di testimonianze che sarebbe ragionevole attendersie), mentre nelle regioni della diaspora risulta attestato più che ampiamente(4
).
La Forma l nell'ambito della nostra necropoli risulta quella con maggior numero di esemplari tra tutte le forme ed è testimoniata da sessantadue recìpientie), come, del resto, si è potuto già notare per quanto riguarda la necropoli di Bitia(6). I piatti, data la cronologia di questo settore cimiteriale, sono tutti tipologicamente abbastanza affini e rispondono pienamente ai criteri già osservati nell'esame dei recipienti della già evocata necropoli di Bitia(). Per riassumere, si è potuto constatare che, nel corso del tempo, le pareti esterne dei piatti fenici tendono a curvarsi, mentre la vasca tende ad appiattirsi fino a divenire parallela al piano di appoggio. In tutto l'arco cronologico occupato dalla necropoli fenicia l' ombelicatura occupa circa un terzo della vasca e questo elemento distintivo permane fino al momento in cui le caratteristiche peculiari della ceramica fenicia di Sardegna vengono sostituite da quelle di matrice cartaginese(8
).
L'elemento più distintivo per quanto riguarda l'aspetto cronologico e che caratterizza i piatti dell'insediamento di Monte Sirai collocabili attorno alla metà del VI secolo a.C. è la forma dell'orlo, che, sommata a quella della parete adiacente, risulta decisamente semiconvessa.
L'unico esemplare con solcatura sull'orlo, abbastanza raro in Sardegna come si è già avuto
e) Sulle forme aperte della costa siro-palestinese classificabili come piatti, cf. AMIRA'l" 1970, pp. 192-212, figg. 60-67; LEHMANN 1996, forme 26-37, pp. 365~66, tavv. 6-7; per un esemplare apparentabile alla forma occidentale, cf., da ultimo, BADRE 1997, pp. 73-74, fig. 36, 8; occorre aggiungere che questo esemplare, assieme a quello illustrato alla fig. 36, 7, viene definito dal1a sua Editrice « ... very popolar plates ... », ma se questa definizione si adatta perfettamente a quest'ultimo, che è dotato di un breve orlo superiormente concavo e che ha oggettivi e amplissimi riscontri nell'area, non è altrettanto calzante per il primo tra quelli citati, che è molto simile ai nostri.
e) Cf., da ultimo, BAIITOLONI-BONDì-MosCATI 1997, pp. 33-37.
f) Cf. LEHMANN 1996, forma 26, p. 365, tav. 6.
(4
) Per l'abitato di Monte Sirai cf. ad esempio PEsERico 1994, pp. 118, 125, fig. l, a-b; per i centri vicini ori, quali Sulcis e San Giorgio di Portoscuso, cf. BERNARDINI 1990, pp. 88-89, figg. 7-9; BERNARDINI 1997, pp. 55-58.
5 . ' () Cf. NN. 7-8, 12-14, 19, 21, 28, 31, 35, 37, 40, 43, 48-50, 53, 64, 68, 77-78, 92, 96, 102, 106, 109, 112, 123, 127, 137, 140,145, 147, 152, 154, 159-61, 166, 173, 175-76, 178, 181, 186, 188, 190, 194, 198,220,231,234,237,241, 243, 247, 258-59, 261, 267, 281-82.
(6) BARTOLONI 1996, pp. 73-75.
C> BARTOLONI 1996, p. 74.
(8
) BARTOLONI 1983 a, pp. 35-36.
98 Parte Terza
modo di notare(9), trova i suoi naturali antecedenti e paralleli nella costa siriana e, anche se non
abbondanti, nelle città della Fenicia meridionalee0).
Per quanto riguarda gli aspetti tecnici e decorativi, come è consueto per il periodoe 1) tutti i piatti appaiono lucidati unicamente sulla faccia superiore e la maggior parte risulta dipinta con vernice matta all'interno del cavo dell'ombelicatura e con una linea che investe l'orlo(12
). Un solo esemplaree3) risulta decorato con gruppi di due righe nere delineati in prossimità dell'orlo, nella vasca e nel cavo dell' ombelicatura.
Forma 2
Questa fonna comprende un solo esemplare relativo ai piatti con risalti digradanti sull'orloe4). Il recipiente è lucidato sulla faccia superiore e ricoperto solo su questa parte con una vernice simile al colore dell'argilla. La forma, derivante forse da prototipi atticie5
), passa in seguito nel repertorio campano, ove sembra databile nell'ambito del primo terzo del III secolo a.C.ct6). Nel nostro caso la fonna è imitata localmente e, ancorché non edita, è attestata attorno alla metà dello stesso secolo in altri settori dell'insediamento quali l'abitato ed entra dunque a pieno titolo nel repertorio delle forme aperte di età ellenistica presenti a Monte Siraie7).
Forma 3
In questa sezione è inserito un solo esemplare, anch'esso, come il precedente, reperito durante la ripulitura effettuata nell'area della necropoli di età punica. Anche questo recipiente risulta lucidato e ricoperto limitatamente alla faccia superiore di una vernice simile al colore dell'argilla. Si tratta evidentemente di una forma che deriva dai piatti di imitazione atticae8
), caratteristici praticamente di tutte le necropoli puniche di Sardegna(19
) ed attestati in egual misura anche in altre regionie0
).
Nel caso specifico, sembra trattarsi palesemente di una rivisitazione locale del tipo, con alcuni esiti evolutivi che collocano il piatto non prima del III secolo a.C. I confronti più prossimi sono ovviamente nell'area di Monte Sirai, localizzati più precisamente tra le deposizioni del tofete1).
Non si tratta invece, in questo caso, di un prodotto del processo evolutivo dei cosiddetti
(9) BARTOLONI 1996, p. 74.
eo) LEHMANN 1996, forma 85c, pp. 376-77, tav. 17; da ultimo~ BADRE 1997, pp. 72-73, fig. 36, 5-6.
(11
) Cf. BAirrOLONI 1996, p. 74.
e2) NN. 8, 12, 28, 49, 53, 64, 106, 112, 123, 137, 140, 145, 154, 159, 161, 175, 186.
(13
) N. 78.
(14
) Cf. N. 279.
( 15
) Cf. SPARKES-TALCOIT 1970, n. l 095, pp. 150, 312, fig. l O.
e6) Cf. MoREL 1981, n. 1634c l, p. 128, tav. 25.
(17
) Cf. CAMPANELLA 1999, pp. 42-53.
es) Cf. N. 280.
e9) Cf. BARTOLONI 1996, pp. 77-78, fig. 35, tav. XXVIII, 3.
eo) Cf., da ultimo, F. CHELBI, Céramique à vernis noir de Carthage, Tunis 1992, n. 3, p. 93, fig. 3.
e·) Cf. BARTOLONI 1982 b, p. 290, fig. 5, e.
Le forme aperte 99
piatti da pesce, intuito da Jean-Paul Morele2) e recentemente rivisitato in modo convincente
da Lorenza Campanenae3).
Forma 4
Per quanto riguarda le coppe a calottae4), queste sono già ampiamente note nel repertorio fe
nicio di Sardegnae5). La fonna è diffusa in tutto il Mediterraneo occidentale ed occupa un arco
cronologico che, dalla prima colonizzazione, giunge fino agli esiti finali, collocabili nell'ambito della seconda metà del VI secolo a.c.e6). Gli antecedenti orientali, generalmente con piede distinto, ancorché non testimoniati in numero cospicuo, sono collocati prevalentemente nell'area feniciae7). Risulta evidente che molte fanne potrebbero derivare dalla ceramica cosiddetta samaritanae8), ma ciò che apparentemente contrasta questa ipotesi è, nel nostro caso, la presenza del piede distinto o indistinto, che invece nella Samaria Ware risulta sostituito prevalentemente dal fondo convesso.
Quanto alla decorazione, le coppe risultano totalmente ricoperte di vernice rossastra, mentre una solae9
) si richiama ai prototipi che, oltre ad essere in red slip, sono dotati di righe e fasce. Pertanto, il nostro esemplare è dotato di quattro gruppi di tre righe nere, parzialmente svanite, delineate ad interva11i non equidistanti tra 1' orlo e il piede indistinto.
Forma 5
Di questa coppa con orlo gonfioC0), con caratteristica unghiatura all'interno dell'orlo, mentre
a Monte Sirai è già noto un esemplare di matrice punica assai attardato proveniente dali' area del tofetC1
), fino ad oggi non si riscontrano testimonianze negli insediamenti fenici di Sardegna e, a ben vedere, anche altrove non risulta particolarmente evidente. Tuttavia, almeno per il momento, per quel che riguarda il periodo che ci interessa, la forma sembra testimoniata quasi esclusivamente nel Mediterraneo occidentale, con un esemplare in red slip da Cartagine, e, in particolare, appare localizzata nel Circuito dello Strettoe2
).
Un discorso a parte meritano i confronti orientali, che, ivi compresi i prototipi del Tardo Bronzo, appaiono ubicati tra l'altro alla periferia meridionale di Tiro e in ambito samaritano, con forbì-
f 2) Cf. MoREL 1981, pp. 83, 518.
e3> CAMPANEllA 1999, pp. 49-53.
e4) NN. 56, 153, 244, 246.
e5) BARTOLONI 1996, p. 78, fig. 44, tav. X, 2.
e6) Cf. ad esempio, da ultimo, KBIRI ALAOUI-LoPFZ PARDO 1998, pp. 18-21, fig. 8.
e7) Cf. ad esempio, Tell Keisan, p. 188, tav. 53, IO; ANDERSON 1988, pp. 656-57, tav. 47, X-288, X-28C; LEHMANN
1996, fonna l 07, p. 380, tav. 19; da ultimo, BADRE 1997, pp. 72-73, fig. 36, l O; per l'area cipriota (White Paited IV e Black-on-red Il) , nelle versioni apoda e con piede, cf. GJERSTAD 1948, tavv. XXVIII, 4, XXX, 10, 12.
es) Sembra ormai acclarato che questa classe di ceramica, contraddistinta da una particolare qualità tecnica unita ad una decorazione altrettanto curata, provenga da ateliers fenici; sul tipo di coppe cf. ad esempio ANDERSON 1988, pp. 656-57, tav. 47, F-2A.
(~ N. 153.
eo) N. 33.
C1) Cf. BoNol 1983, pp. 198, 202, fig. l, a.
e2) Cf. VEOAS 1989, pp. 233, 235, fig. 5, 60; KBIRI ALAOUI-LOPEZ PARDO 1998, pp. 17-19, fig. 7.
100 Parte Terza
ce cronologica nel Ferro II A-BC3). In ogni caso, mentre vi è coincidenza temporale con la fonna
occidentale - VI secolo a.C. - l'ampio divario cronologico tra il confronto orientale e il nostro recipiente - almeno 150 anni - pone il problema della conservazione del tipo, in rapporto con la sua quanto meno scarsa attestazione. Infatti, la apparente genericità del recipiente non sembra collegarlo ad usi particolari.
Quanto alla decorazione, la coppa appare verniciata totalmente nel cavo.
Fonna 6
Questa coppa con orlo estroflesso trova, come è naturale i suoi prototipi più aderenti in area feniciaC4
) e, come fonna particolarmente corrente, gode di numerosi confronti sia nell'isola che nei centri nord-àfricaniC5) . L'unico esemplare presentato in questa sede proviene da un settore ubicato all'estrema periferia dell'area della necropoliC6
) ed è presumibilmente da ritenere attardato e, comunque, non anteriore alla seconda metà del VI secolo a.c.e7
). In effetti, la coppa si presenta totalmente acroma con sagoma decisamente più bassa rispetto ai prototipiC8
), siano essi muniti o meno di falso versatoio, e, per di più, risulta associata ad una ulteriore coppae 9) che imita prototipi ionici del tipo B2.
Forma 7
Le coppe troncoconiche comprese in questa sede(40) sono senza dubbio ben note in
Sardegna(41). Oltre al resto, nel nostro insediamento di recente sono venuti in luce numerosi
esemplari ancora inediti, localizzati nello strato di riempimento cinerognolo, proveniente con buona probabilità da ambiente funerario, che sigillava gli strati fenici della Casa del lucernario di talco(42
). Questa fonna, di evidente uso potorio, negli esemplari provenienti dal nostro insediamento, mostra un rigonfiamento sul fondo della vasca che non ha riscontro paritetico negativo nell' umbone del piede. Tale particolarità, che non ha paragoni negli esemplari rinvenuti negli altri insediamenti di Sardegna(43
) e nei numerosi riscontri in area fenicia(44), potrebbe
avere uno scopo funzionale, che, almeno per il momento, sembra di non facile soluzione. Un possibile compito del solco periferico, in relazione alla funzionalità potoria del recipiente,
e3) Cf. AMIRAN 1970, pp. 210- 11, fig. 67, 6; DouMET-BORDREUIL 1982, p. 97, tav. XVI; per i prototipi cf. ANDERSON
1988, pp. 614-15, 622-23, tavv. 29, 19, 32, 13.
5. ( 34) N. 2; per gli antecedenti cf. ANDERSON 1988, pp. 630-31 , tav. 35, 12; da ultimo, BADRE 1997, pp. 64, 67, fig. 33,
es) Per il tipo cf. BARTOLONI 1996, pp. 79-80, fig. 15.
e6) Area del quadrato v /9.
e7) Per un esemplare da Cartagine con la medesima cronologia, cf. VEGAS 1989, pp. 247, 252-53, fig. 8,
164. (38) Cf. ad esempio MAASS-LINDEMANN 1982, pp. 182, 188-89, tavv. 25, K 5, 7, 27, K 15, 3, K 16, 2, K 17, 2; VEGAs
1990, pp. 46-48, fig. 4, 55-56.
e9) N. l; per il tipo cf. infra, Forma 10.
(40
) NN. 10, 116.
(41
) Per il tipo cf. BARTOLONI 1996, pp. 80-8 1, fig. 16, tav. VI, 7-8.
(42
) Le coppe sono state rinvenute durante le campagne di scavo del 1997 e del 1998, soprattutto nei vani 33 e 35: cf. BAJrrOLONI 1994 b, p. 76.
(43
) Per questi esemplari e per la loro bibliografia cf. BARTOLONI 1996, pp. 80-81, fig. 16, tav. VI. 7-8. ·
(44
) Cf. da ultimo LEHMANN 1996, forma 1 O, pp. 361-62, tav. 3.
Le forme aperte 101
potrebbe essere quello di convogliarvi eventuali depositi della bevanda contenuta. Entrambi gli esemplari sembrano acromi.
Forma 8
Segue la coppa con risega netta sulle pareti della vasca(45). L'unico esemplare presente nella
nostra necropoli(46) è acromo ed è stato rinvenuto recentemente anche nella necropoli ipogea di
Sulcis(47). Come suggerito recentemente da Luisa Anna Marras(48
), la coppa, interpretata in un primo momento come frutto di imitazione di calici etruschi, sembra derivare invece da alcune tra le forn1e aperte della ceramica fine samaritana(49
). La fonna, con la medesima cronologia, è presente anche nell'abitatoCS0
), mentre esemplari più antichi provengono dall'area del Cronicario di Sulcis(51).
I ritrovamenti sulcitani, effettuati nelle tombe a camera più antiche della locale necropoli, come si evince dall'impianto architettonico e dalla tipologia degli ipogei(52
), confennano la cronologia del nostro corredo, che proviene da una delle tombe più tarde dell'impianto funerario fenicio di Monte Sirai.
Forma 9
Abbastanza attardato risulta anche l'esemplare fenicioCS3) ascrivibile alle coppe con orlo verticalee4
), al quale si aggiunge il recipiente rinvenuto in una tomba a enkytrismòs e dunque serioree5
). Dato l'arco cronologico occupato dal settore della necropoli indagato, mancano gli esemplari di tipo più antico, rinvenuti invece in numero considerevole nell'area dell'abitato(56
) e nel capoluogo sulcitanoCS7). La forma ha origine in ambiente fenicio(58
)
ed è ampiamente attestata in tutta l'area vicino-orientaleCS9), i vi compresi gli insediamenti ciprioti(60
). La fonna di età punica risente della rivisitazione che conserva solo pallide reminiscenze del prototipo e ne fa un ibrido prossimo alle più tarde coppe a calotta, relative alla Forma 4 presentata più sopra, accostandola anche a materiali più tardi di produzione
15.
(45) N. 6.
(46
) Cf. BARTOLONI 1982 C, pp. 291-94, fig. 2, e; MARRAS 1982, pp. 295-96.
(47
) Cf. BERNARDINI 1989 b, pp. 149-52; TRONCHETTI 1989 a , p. 152.
(48) Cf. MARRAS 1992 C, pp. 179-80.
(49
) Cf. ANDERSON 1988, pp. 638-39, tav. 38, 21; da ultimo, LEHMANN 1996, forma 78a-b/l-16, pp. 372-74, tav.
eo) Cf. PESERICO 1994, pp. 128, 133-34, fig. 2, q-r.
e1) Cf. BERNARDINJ 1990, pp. 83-84, fig . 2, a-f.
e2) Cf. BARTOLONI 1987 C, pp. 60-61 ; BARTOLONI 1989 a, pp. 42-43.
e3) N. 20.
e4) Sul tipo, da ultimo, cf. BAJITOLONI 1996, pp. 82-83.
es) N. 209.
e6) Alcuni esemplari sono di prossima pubblicazione a cura di Giulia Balzano.
(57
) BERNARDINI 1990, p. 84, fig. 3, d.
(58) Cf., da ultimo, LEHMANN 1996, forma 85c, pp. 376-77, tav. 15.
CS9) Cf. AMIRAN 1970, pp. 207-209, tav. 66.
(60) Cf. BIKAI 1987, pp. 39, 56, tav. XIX, 476-79.
102 Parte Terza
greca(6l). La decorazione in vernice rossa investe totalmente la vasca, mentre la parete esterna solo nella parte prossima all 'orlo
Forma 10
In questa for1na sono riunite le due coppe di imitazione greca(62) rinvenute in due differenti
corredi. È nota la tendenza degli ateliers fenici coloniali all'imitazione delle coppe di matrice greca, dipanata nel tempo e via via indirizzata verso i tipi al momento più in auge(63
). Mentre il recipiente N. 141 sembra derivare dalla serie delle coppe carenate(64
), alla quale sono state giustapposte due anse orizzontali, l'esemplare N. l è senza dubbio più aderente ali' originale, che nel caso specifico è la coppa ionica dì tipo B2(65
). La forma è stata rinvenuta nella necropoli anche in epoca successiva, in tombe non comprese in questo lavoro. Entrambi gli esemplari risultano acro-
• fil.
In una iscrizione del III secolo a.C. edita recentemente, una coppa di argento di quest' ultimo tipo viene defmita con il termine punico skt(66) . È probabile che, trattandosi di una forma di imitazione greca, il termine sia stato adattato ali' oggetto stesso e che, ali ' origine sia dunque da applicare genericamente a tutte le for t ne aperte fenicie di uso potorio.
Forma 11
Questa fonna comprende il tipo della coppa con vasca carenata ed orlo aggettante(67), distri
buito da est a ovest con minime varianti in tutta l'area toccata dai naviganti fenici(68), quindi alla
stessa forma partecipa ovviamente il tipo della doppia patera(69), che è appunto composto da due
coppe sovrapposte. Apparentemente un solo esemplare(0) risulta decorato in modo canonico in
vernice rossa ali' interno della vasca e, per quanto riguarda la parte esterna, a ri sparmio tra l'orlo e la carenatura.
Passando ad esaminare in dettaglio questa fonna, è opportuna una precisazione, che riguarda genericamente il tipo. Infatti, con il tennine doppia patera personalmente intendo indicare quel recipiente composto ali' origine da due coppe pratican1ente gemelle, sovrapposte ed unite tra di loro per mezzo di un gambo. Questo, dal centro della vasca della coppa inferiore, raggiunge il piede di quella superiore. Il gambo risulta cavo nella parte inferiore sia per consentirne una cottura omogenea anche all'interno, sia per impedirne la rottura durante questa operazione.
' E palese che il tennine di doppia patera può sembrare non del tutto proprio, poiché, come è
(61 ) Cf. ad esempio le coppe attiche di IV secolo a.C. in SPARKEs-TALcorr 1970, nn. 830-35, pp. 131-32, fig. 8.
(62) NN. l, 141.
(63) Per questa caratteristica tendenza cf. BERNARDINI 1988 b, pp. 8 I -83, figg. 2, b-d, 3, a-d, 4, a-c; RouiLLARD 1990, pp. 179-80, fig. 1, 1-8, e, da ultimo, BRrESE-DOCTER 1992, pp. 25-69, figg. I -15.
(64) Cf. ANoERSON 1988, pp. 656-57, tav. 47, X-22A; da ultimo, LEHMANN 1996, forma 89c, p. 377, tav. 17.
(65) Sulla classificazione delle coppe ioniche e, in particolare, sul tipo identificato, cf. PIERRO 1984, tipo A2 > B2, pp. 49-51, tavv. IX, 30, XXII, 30.
(66) BARTOLONl-GARBINl 1999, pp. 79-82, fig. l.
(67
) NN. 54, 98.
(68) Cf. ad esempio KsiRI ALAOUI-LùPEZ PARDO 1998, pp. 21-22, fig. 9.
(69) Sul tipo cf. BARTOLONI 1996, pp. 83-85, fig. 16, tav. VI, 4.
C0) N. 98.
Le forme aperte 103
noto, patera o phiala è il termine con il quale di norma viene indicato un vaso destinato specifica-,
mente a11a libagione sacra. E altrettanto vero che le singole coppe, comuni in tutto il bacino del Mediterraneo toccato dalla civiltà feniciaC 1
), che compongono la doppia patera erano certamente destinate al bere. Tuttavia, mi sembra evidente che la definizione di doppia patera rappresenta solo un termine di comodo per indicare una forma composita, mentre con questo tennine non si vuole certamente indicare que11a che era la funzione propria del recipiente.
Se è impropria la definizione di doppia patera, Io è certamente, forse anche in misura maggiore, quella di brucia-profumi, definizione attribuitale con sicurezza e decisione in un recente contributo(72). Occorre notare a questo proposito che il tennine di brucia-profumi ben si attaglia ai portaincensieri che compaiono in un settore della classificazione proposta da A. Najim(3), poiché )a funzione di questi particolari oggetti era appunto quella di sostenere contenitori destinati a bruciare sostanze aromatiche. Lo stesso termine trova invece scarsa rispondenza con la fot ma oggetto di indagine in questa sede, poiché nella quasi totalità degli esemplari rinvenuti non sono state riscontrate tracce di combustioneC4
).
A questo punto appare evidente che qualsiasi termine per indicare questo oggetto è da considerare improprio fino a quando non sarà stata individuata con sicurezza la sua funzione, che, almeno all'origine e contrariamente a quanto pensa A. NajimC5
), non è quella di bruciare i profumi. Infatti la fonna con due coppe sovrapposte tradisce palesemente almeno parte della sua funzione, poiché, indipendentemente dal fatto che la coppa superiore fosse destinata a contenere materiali solidi o liquidi, quella inferiore era certamente deputata a raccogliere eventuali surplus che potevano traboccare da quella superiore. Si trattava, in definitiva, di una sorta di coppa con vassoio o sottocoppa incorporato, che non avrebbe avuto alcuna funzione né ragion d'essere se gli oggetti contenuti nella coppa superiore, appunto nel caso di una sua funzione come brucia-profumi, fossero stati destinati a volatilizzarsi. Inoltre, sembra anche chiaro che questo recipiente composito non era funzionale alla libagione, poiché, se entrambe le coppe fossero state riempite, il liquido contenuto
in una de11e due coppe sarebbe andato perso.
Forma 12
Rare nella nostra necropoli sono le lucerne cosiddette a conchiglia con due o più becchiC6). In particolare il tipo con due becchi è ampiamente noto(77
), anche se, come già sottolineato in altra sedeC8
), risulta problematica una precisa e puntuale attribuzione cronologica degli esemplari fuori contesto, mentre il tipo della lucerna a un becco è ap-
C1) Per il tipo, cf. Tell Keisan, p. 169, fig. 46, b; A NDERSON 1988, pp. 630-31 , tav. 35, 7-9; LEHMANN 1996, forma
84, pp. 375-76, tav. 16; da ultimo, BADRE 1997, pp. 68, 71, fig. 36, 1-2.
(72
) Cf. NAJlM 1996, pp. 61-73.
C3) N AJJM .1996, p. 69, fig. 2, g; sul tipo si veda C uu cAN 1980, pp. 99-100, fig. 4, e KARAGEORGHIS 1977, pp. 28, 39-
41, fig. 7, tav. XII:« ... Terracou~ stand for an incense-burner ... »,e, da ultimo, L EHMANN 1996, fonna 179, p. 394, tav. 30. ..
C4) Tra i rarissimi esempi è da ricordare quello presentato in FANTAR 1986, pp. 319, 367, tav. CLII, ove, per altro,
le tracce . di bruciato sono visibili unicamente sul piede del recipiente.
C5) NAJIM 1996, p. 64, nota 20: « ... L'évolution de la forme de ce vases reflète probablement le changement de leur
role initial qui est celui de brUJe-parfums ... ».
C6) NN. 51' 88, 158, 233.
C7) SuJ tipo cf., da ultimo, B ARTOLONI 1996, pp. 85-87, fig. 20, tav. XI, 5.
C8) B ARTOLONI-TRONCHETII 1981 ' pp. 43-45.
'
104 Parte Terza
parentemente assai più raro e relegato nel primo periodo della colonizzazione fenicia in SardegnaC9
).
Se vi è ben poco da aggiungere riguardo alle lucerne con uno o due becchi citate più sopra, un discorso a parte merita il tipo con sette becchi, raro sia in Oriente che in Occidente, ove attualmente appare attestato con solo due esemplari(80
) . All'esemplare presente nella nostra necropoli si affianca significativamente quello rinvenuto ad Utica, contribuendo a confermare i rapporti privilegiati tra la città nord-africana e i centri della Sardegna sud-occidentale, già ampiamente posti in evidenza per quanto riguarda le osmosi commerciali e culturali dell'insediamento di Bitia(81
). Tutti gli esemplari presenti nella nostra necropoli risultano acromi.
Forma 13
Nel tipo in oggetto sono state comprese tutte le forme aperte da cucina, quali le spiane e i bacini(82), generalmente acromi in relazione alloro uso tipicamente alin1entare. Tranne la spiana proveniente dal corredo della Tomba 32(83
) , i tre frammenti di recipienti che restano sono tutti di provenienza sporadica. In particolare, si tratta di un bacino con orlo esternamente gonfio, già aQlpiamente trattato in altra sede(84
), che senza dubbio costituisce una sorta di fil-rouge della colonizzazione fenicia in Occidente tra il VII e il VI secolo a.C.(85
).
L'essenzialità della forma della spiana, decisamente cosmopolita nella sua funzione di testo per la cottura di focacce, non permette di stabilime con certezza l'origine. Inoltre, sia l'esecuzione con tecnica ad impasto del nostro esemplare che la presenza del tipo nei contesti nuragici del Bronzo Medio(86
) ne rendono ancora più problematica l'attribuzione. Quanto all'esemp1are N. 252, già at~stato nei contesti abitativi del nostro insediamento(87
), il frammento appartiene con ogni evidenza ad un bacino di uso domestico per la confezione dei cibi, che trae probabile origine dali' ambiente costiero nord-siriano(88), anche se non mancano attestazioni in taluni centri palestinesi(89
). Caratteristici del tipo appaiono i risalti salva-gocce, che rendono composita la sezione dell'orlo e ne interrompono la linearità.
L'ultimo frammento, appartenente ad una patera, probabilmente del tipo su alto piede, attiene ad un periodo ben più tardo rispetto ai tre frammenti citati in precedenza. La forn1a, già nota n eli' a-
C9) Per la cronologia e la tipologia della lucerna monolicne in Sardegna, cf. BARTOLONI 1992 h, pp. 419-21, figg.
4-5.
(80) Per il tipo con più di due becchi in Oriente, cf. LEHMANN 1996, fonna 422, p. 445, tav. 81, e, in Occidente, an-che per la bibliografia, BARTOLONI 1983 b, p. 213, fig. 10, e.
(8 1
) Cf. BARTOLONI 1996, p. 1 o l. (
82) NN. 89, 251-52, 272.
(83) Cf. BARTOLONJ 1983 b, p. 211, fig. 11 , c-d; BARTOLONI 1988 a, pp. 410-13, tav. I; BARTOLONI 1988 b, p. 230; BARTOLONI 1989 d, p. 39, fig. 25; BERNARDINI 1988 a, pp. 51-52.
(84) Sul tipo cf. BARTOtoNl 1992 g, pp. 99-103, fig. 1, e, da ultimo, V. BeuELu-M. BOTro, I bacini di tipo f eniciocipriota: considerazioni sulla diffusione di una forma ceramica nell'Italia medio-tirrenica nel periodo compreso fra il Vll e il VI secolo a.C. : Atti del XXI Convegno di Studi Etruschi ed ftalici, Sassari-Alghero-Oristano-Torralba, 13-17 ottobre 1998, in corso di stampa; sul tipo in Oriente, cf. BADRE 1997, pp. 74-75, fig. 37, 8, e, da ultimo, SAPIN 1998, pp. 87-120.
(85) BARTOLONI-MoscATI 1995, pp. 38-39, tav. I, 2.
(86) FADDA 1998, p. 180, fig. 20.8, 5-8.
(87
) MARRAS 1981 , pp. 197-98, 207, fig. 6, 5-6.
(88
) LEHMANN 1996, fonna 99, p. 379, tav. 19.
(89) AMIRAN 1970, pp. 198-99, fig. 63, ]3; DOTHAN-PORATH 1982, pp. 120-21, fig. 10, 10.
Le forme aperte 105
rea della necropoli ipogea punica di Monte Sirai attraverso un esemplare integro(90), ma frequente
anche nell ' area dell'abitato(9 1) , deriva probabilmente da esemplari greci di età ellenistica(92
), anche se non si può escludere una origine del tipo da esemplari fenici rinvenuti sia in Oriente(93) che in Occidente(94
) e databili almeno nell'ambito dell'VIII secolo a.C.
eo) Cf. AMADASI-BRANCOLI 1965, pp. 98, 110, tav. XLV, 20.
(91
) C f. CAMPANELLA 1999, pp. 54-55, fig. 8, 55-56.
~) MoREL 1981, forma 1310- 15, pp. 102-105, tavv. 11 -13.
(93
) L EHMANN 1996, fonna 4, pp. 359-61 , tav. l.
(94
) Cf., da ultimo, P/W, p. 309.
LE FORME CHIUSE
Forma 16
Le brocche con orlo espanso presenti nella necropoli di Monte Sirai( 1 ), note anche con il termine di brocche con orlo a fungo, appartengono ad un tipoe), che ormai si discosta sensibilmente dai prototipie), secondo un criterio evolutivo che investe il repertorio ceramico di tutte le regioni interessate dalla diaspora fenicia(4
). In particolare, la forma presenta l'orlo che perde la linearità e si piega con un angolo ottuso e il collo sagomato con la parte inferiore ormai con un diametro analogo a quello della strozzatura superiore. La pancia nella maggior parte dei casi diviene fusiforme, anche se non mancano casi seriori di forma piriforme troncaC), appartenenti ai momenti più tardi dell'impianto funerario fenicio, come già segnalato per quanto riguarda la necropoli di Bitia(6
).
Per quanto concerne la decorazione, gli esemplari più antichlC), che fanno riferimento al primo terzo del VI secolo a.C., conservano gli aspetti canonici(8), costituiti dalla immersione a risparmio in vernice rossa della bocca e di circa un terzo del collo e da un gruppo di due, tre o quattro righe nere nel punto di incontro tra la spalla e la pancia. la bocca risulta talvolta decorata con righe nere, alle quali si aggiungono in un caso tre triangoli apicati. Gli esemplari di poco più attardati(9), collocabili per lo più nel secondo terzo del VI secolo a.C., acquistano una colorazione rossa distribuita su tutto il corpo, sul quale, dali' orlo al piede indistinto, sono distribuiti a intervalli non costanti alcuni gruppi di due, tre o quattro righe nere. Del resto questo tipo di decorazione, prevalentemente associato alla caratteristica fonna fusiforn1e della pancia, ricorre negli esemplari coevi provenienti da altri centri della Sardegna meridionale(10
). Da menzionare infine un esemplare in pasta buccheroide grigiastra(11), decorato con ·quattro gruppi di tre righe in vernice biancastra.
Non mancano gli esemplari acromiC2), ma in questo caso la mancanza di decorazione potreb
be essere solo apparente poiché occorre ricordare che la coltre terrosa della valle della necropoli si
e) Cf. NN. 4, 10, 16, 18, 26, 30, 34, 39, 45, 66-67,73,79,83, 85, 87, 103- 104, 108, 117, 122, 124, 126, 128, 135, 139, 144, 151, 157, 162-63, 168, 174, 177, 185, 192, 222, 226, 232, 235-36, 248, 262-63, 291.
e) Sul tipo cf. BARTOLONI 1996, pp. 92-93, fig. J 3, tav. III, l ; PESERICO 1996, passim; LEHMANN 1996, fonne 240-41, pp. 404-405, tav. 40; da ultimo, BADRE 1997, pp. 86-87, fig. 45, 13.
e) Sui più antichi esemplari presenti nell'isola, cf., da ultimo, BERNARDINI 1996, pp. 542, 547, tav. I, 1a-2a; BER-NARDINI 1997, pp. 55-58, 235, 238.
(4
) Cf. da ultimo BARTOLONJ-MosCATI 1995, pp. 44-45 .
(5
) NN. 83, 128, 163.
(6) Cf. BARTOLONI 1996, p. 92.
C) Cf. ad esempio NN. 73, 85, 87, 139.
(8) Cf. BARTOLONI 1996, p. 93; PESERICO 1996, pp. 47-49.
(9
) Cf. ad esempio NN. 45, 66, 104, 185.
(10
) Per queste brocche nell'insediamento di Bitia, cf. BARTOLONI 1996, ad esempio nn. 114, 252, p. 93, tavv. VII, XVIII; per le brocche dell'insediamento di Paniloriga, cf. MoscATI 1980, pp. 202-203; ToRE 1995, pp. 244-46.
c'') a. N. tos. (
12) Cf. ad esempio NN. 4, 10, 16, 39.
108 Parte Terza
presenta estremamente acida, provocando in molti casi la parziale o totale spatinatura delle superfici degli oggetti fittili.
Lo stato frammentario di alcuni esemplari conferma la posizione della forma nell'ambito tombale. Infatti, nonnalmente, nel caso delle tombe che seguono il rito dell' incinerazione, la brocca viene rinvenuta quasi costantemente lungo il margine della fossa, nel luogo prossimo ai piedi del defunto, con la pancia ali' interno della sepoltura e con il collo appoggiato alla sponda della depressione. Le arature effettuate nella valle della necropoli in età medievale e moderna hanno dunque strappato in diverse occasioni la parte superiore delle brocche con orlo espanso, che per questo motivo è stata rinvenuta in qualche caso in posizione sporadica(3
) .
Forma 17
A proposito delle brocche con collo carenatoe4), si può aggiungere ben poco per quanto ri
guarda i prototipiC 5). Risulta evidente in modo immediato come la brocca N. 169 rappresenti un
episodio de li' evoluzione della fonna legato specificamente all'insediamento di Monte Sirai. Infatti gli esemplari coevi, databili appunto nel secondo quarto del VI secolo a.C. e reperibili negli insediamenti insulari, quali quelli di SulcisC6) e di Tharros( 17
), e oltremarini, quali quelli di Cartagine(8) e di MoziaC 9), si discostano sensibilmente dal tipo presente nella nostra necropoli. Infatti, ad un esame autoptico anche superficiale, il nostro recipiente nel complesso appare assai più snello dei suoi simili, con il collo stretto e fortemente cordonata, con la pancia rastremata, laddove di norma questa si presenta altrove in forma globulare. La sola struttura decorativa, delineata con una fascia rossa limitata da due righe nere, mostra chiari riscontri cosmopoliti, con precisi riferimenti in area fenicia orientalee0
).
Un discorso a parte richiede il frammento N. 275, di provenienza sporadica, che è stato inserito in questa forma anche se di cronologia assai più avanzata. Si tratta infatti di quel tipo di grandi brocche che, pur derivando probabilmente dai prototipi trattati in questa sede, ha smarrito quasi completamente i contatti. Il tipo, con attacco dell'ansa sul bordo gonfio, è già noto a Monte Siraie1) ed è caratteristico dell'età ellenistica avanzata in tutta la Sardegnae 2
), ma non mancano frequenti attestazione nei centri p unici ubicati lungo l'asse del Mediterraneo centralee3).
42.
e3) Cf. NN. 222, 235, 248, 262-63.
C4) Cf. NN. 169, 275.
es) Sul tipo cf. BARTOLONI 1996, p. 94, fig. 26, tav. XIX, 3; LEHMANN 1996, forma 250, pp. 406-407, tav.
C6) BARTOLONI 1988 c, pp. 168-69, fig. 4, L.
('7
) A cQUARO 1989, pp. 23-128.
es) H ARDEN 1937, pp. 75-76, fig. 4, S-U.
(19
) CiASCA 1991, pp. 620-21.
eo) Cf. ad esempio BIKAI 1978, pp. 33-41, tav. xxv, 9; B IKAI 1987, p. 43, tav. XXI; MAASS-LINDEMANN 1982, pp. 182, 194, 196, tavv. 25, 31 ; M ARTiN Rmz 1995, pp. 224-25, figg. 231-32.
CZ') CAMPANELLA 1999, pp. 69-71, figg. 12-13.
e2) B ARTOLONI c.d.s. b.
e3) BTSI 1971, p. 725, fig. 64; GALLET DE SANTERRE-SLIM 1983, pp. 23-28, tav. XVII; DI STEFANO 1993, p. 33, figg.
16-17.
Le forme chiuse 109
Forma 19
L'unica brocca piriformee4) rinvenuta fino ad ora nell'area della nostra necropoli è purtroppo di provenienza sporadicae5). Ciò non astante, la sua forn1a caratteristicae6), tipologicamente localizzabile nella prima metà del VI secolo a.C., tende a far ritenere che il recipiente possa provenire da una tomba viciniore al luogo del suo ritrovamento.
Sul contenitore vi è ben poco da aggiungere, anche in considerazione del suo status non consolidato, ma di certo risulta inusuale che tale tipo di recipiente sia talmente raro nella nostra necropoli, quando invece ad esempio nella necropoli di Bitia raggiunge la considerevole percentuale del 5,7% della totalità della ceramica vascolare. D'altro canto, se nella sua funzione di vaso contenitore di cosmetici la brocca piriforme veniva talvolta sostituita dagli aryballoie1
), nell'ambito della nostra necropoli ciò non risulta se non in un solo casoe8).
Forma 21
Anche per quanto riguarda gli attingitoi, nel quadro della prima fase degli scavi è stato rinvenuto un solo esemplare di questo tipo di recipientee9
), che in tutta la sua storia appare sempre privo di decorazionee0
). La forma, che, come è noto, nasce sia pure con la bocca lobata nell'area vicino-orientale fin dal Medio e Tardo Bronzee 1
), ha ampi riscontri nei centri fenici di Occidente con la bocca che acquisisce ormai forma circolare a partire dal Primo Ferroe2
). Inoltre, il tipo vicino-orientale, che nel secondo millennio ha il fondo cuspidato, tra l'VIII e il VII secolo a.C. presenta il fondo convessoe3). A questi criteri si adegua ovviamente la tipologia degli attingitoi di Sardegna, il cui fondo, tuttavia, a partire dal secondo quarto del VI secolo a.C. nella maggior parte dei casi diventa nuovamente cuspidatoe4
).
e4) Cf. N. 221.
e5) In questo caso e a titolo di anticipazione si intendono sia la prima fase dei lavori (campagne 198 1- 1 987) che Ja
seconda (campagne 1996-1999).
e6) Sul tipo e per la essenziale bibliografia precedente, cf. BARTOLONI 1996, pp. 95-97' fig. 28, tav. XXI, 4; per i
prototipi, da ultimo, LEHMANN 1996, forma 251, p. 407, tav. 42; BADRE 1997, pp. 74-75, fig. 37, 14.
e7) BARTOLONI 1996, p. 95.
es) Cf. N. 182.
e9) Cf. N. 47; ne] caso specifico, contrariamente a quanto occorso riguardo alla forma precedente, nella seconda fase dei lavori alla necropoli sono emersi alcuni esemplari di attingitoi.
eo) Un esemplare eccezionalmente decorato con righe nere è emerso dalla necropoli di Monte Sirai durante la campagna del 1999.
e1) AMIRAN 1970, p. 106, tav. 34; ANDERSON 1988, pp. 590-91, tav. 20, 4, 10-11.
e2) Sul tipo, ampiamente attestato in tutta la regione fenicia così come nel Mediterraneo occidentale, cf. ad esem
pio CINTAS 1954, p. 105, fig. 24; VEGAS 1989, pp. 246-47, fig. 8; MAJITIN Rmz 1995, pp. 102-104, 112-13, figg. 88-89; per gli esemplari vicino-orientali cf. ad esempio BIKAI 1978, pp. 41-42, tav. XII, 1-23; ANDERSON 1988, pp. 634-35, tav. 37, 2.
e3) LEHMANN 1996, forma 211, p. 398, tav. 38; da ultimo, BADRE 1997, pp. 74-75, fig. 37, 10-13.
e4) Sulla tipologia degli attingitoi in Sardegna cf. BARTOLONI 1996, pp. 97-99, fig. 33, tav. xxxv, 6.
IlO Parte Terza
Forma 25
Ultima tra le forme fornite di bocca circolare è un' olpe, delle quali almeno per il momento l'esemplare .in situ costituisce un unicum databile nell'ambito della necropolie5
). Il tipo è ben noto in Sardegnae6
), così come a CartagineC7), anche se, in alcuni casi e come già posto in evidenza,
sembra godere di una cronologia eccessivamente altaC8). La pancia del recipiente si presenta gene
ralmente di fonna pirifonne rovesciata, ma anche, seppure più raramente, di forma circolare. Nel nostro caso tutti i reperti in corredo concorrono a confermare la sua cronologiaC9
), che è senza dubbio da porre nella seconda metà del VI secolo a.C. Quanto alla possibile genesi del tipo, questa sembrerebbe senza dubbio di origine greca(40
), anche se oggettivamente in area vicino-orientale esistono alcune fonne abbastanza simili, che, occorre aggiungere, sono forse solo apparentemente assonanti(41 ).
Forma 26
Nella nostra necropoli compaiono ben trentasette esemplari relativi al tipo della brocca biconica(42). La forma è ben nota(43
) poiché è costante paredra della brocca con orlo espanso citata più sopra (Forma 16) e assieme a questa costituisce il corredo rituale. Che nel caso delle brocche rinvenute nella necropoli si tratti di un vaso preposto specificamente al rito funebre è dimostrato dalla costante malcottura che coinvolge indistintamente tutti gli esemplari. Ciò ha provocato la disgregazione delle brocche, che, sottoposte all'azione del terreno, ben di rado vengono rinvenute in condizioni accettabili. Infatti, su un totale di trentasette recipienti, sono superstiti e sono documentabili in qualche modo solo ventidue(44
). Il fenomeno risulta ancor più incisivo se si considera che tra questi ultimi solo dodici sono interamente ricostruibili(45). D'altro canto nessuno tra questi recipienti mostra tracce d'uso che di norma sono localizzate sul piano di appoggio e si concretizzano con l'abrasione della superficie.
L'ansa è costantemente gemina e conserva ancora il doppio cannello, che ben presto e, più precisamente, dai primi decenni del V secolo a.C., sarà sostituito da un'ansa per lo più nastriforme(46). La linea di sutura appare costantemente in rilievo.
Negli esemplari più tardi il piede accenna a divenire distinto; ciò è dovuto senza dubbio a motivi statici, poiché la tendenza della pancia a divenire sempre più fusiforme fa in
45.
e5) Cf. N. 76; il N. 250 è invece di provenienza sporadica.
e6) Sul tipo cf. BARTOLONI 1996, pp. 101-102, fig. 12, tav. I, 5, 6; LEHMANN 1996, forma 275, p. 413, tav.
e7) VEGAS 1990, pp. 44-45, fig. 3.
eR) Cf., da ultimo, M AIITJN RUIZ 1995, p. 140, fig. 128.
e9) Cf. Tomba 30.
(40) BARTOLONI 1996, pp. 101-102.
(41
) LEHMANN 1996, forme 268, 275, pp. 411, 413, taVV. 44-45.
(42
) Cf. NN. 5, 11, 24, 27, 29, 32, 36, 38, 42, 46, 58, 61, 70, 74, 82, 97, 105, 111, 125, 138, 143, 150, 156, 165, 170, 172, 187, 189, 191, 193, 219, 223-24, 240, 245, 249, 278.
(43
) Sul tipo cf. BARTOLONl 1996, pp. 102-104, fig. 31, tav. XXXV, 7; LEHMANN 1996, forma 302, p. 417, tav. 49; da ultimo, cf. BADRE 1997, pp. 73-74, fig. 36, 13-14.
(44
) Cf. NN. 5, 11, 24, 27, 32, 38, 42, 61 , 70, 74, 105, 111, 138, 143, 150, 156, 165, 170, 172, 187, 189, 249.
(45
) Cf. NN. 5, 11, 38, 74, 105, 138, 143, 150, 165, 170, 187, 189.
(46
) Cf. ad esempio BARTOLONI 1983 a, p. 45, fig. 2, c-f; BARTOLONI 1987 c, pp. 62, 69, fig. 4, tav. IX.
Le forme chiuse 111
modo che l'area del piano di appoggio si restringa, obbligando il figulo ad allargarla autonomamente(47
).
Per quel che riguarda la decorazione, la casistica non è certamente ampia e ricalca quanto già osservato per gli esemplari della necropoli di Bitia(48
) e dei coevi centri fenici della Sardegna(49).
Passando ad un esame dettagliato, si potrà notare la sopravvivenza della decorazione a risparmio in vernice rossa per immersione obliqua della bocca e di parte dell'ansa. Accanto a questo caratteristico e modesto decoro si potrà notare quello altrettanto consueto delle righe nere delineate sulla pancia, che in alcuni esemplari, tra i quali i più antichi della necropoli, si conserva secondo la consuetudineC0) con un gruppo singolo di tre o quattro righe nere tracciate subito sotto la linea di suturae1). Le brocche realizzate nel corso del VI secolo a.C. tendono ad arricchire il loro bagaglio decorativo con ulteriori gruppi di righe nere tracciate sulla pancia a intervalli più o meno regolariC2
).
Alcune particolarità decorative costituiscono delle eccezioni nel panorama abbastanza sobrio della nostra necropoli. Occorre segnalare un esemplareC3) che conserva tre gruppi di due righe nere delineate tra la massima rastremazione del collo e la linea di sutura della pancia, a probabile ricordo di precedenti spazi metopali o di tremuli(54
). Completano la decorazione alcune righe orizzontali tracciate a intervalli regolari sull'ansa gemina.
Un ulteriore esemplare(55), invece della scansione metopale indicata più sopra, mostra un
tronco di palma, rappresentato da una sorta di traliccio, delineato sempre in vernice nera nello spazio tra la bocca e la pancia, che travalica anche la linea di sutura. A integrazione dell'immagine sono due rami di palma tracciati sui lati del collo. Anche in questo caso appaiono le righe orizzontali tracciate sull'ansa a doppio cannello. A completamento della sovrabbondante decorazione sono dei tratti delineati sul labbro: se in un caso possono essere considerati la prosecuzione delle righe già osservate sull'ansa, in un altro caso conservano una caratteristica già osservata per quanto riguarda la decorazione di una brocca con orlo espansoC6
). Si tratta di un triangolo apicato, che, in questo caso particolare, potrebbe essere interpretato come una lettera sin. Una ulteriore decorazione tracciata accanto alla precedente, laddove sia conservata nella sua interezza, potrebbe essere interpretata come una lettera nun.
Come è noto, la raffigurazione del palmizio nel mondo fenicio e punico riveste specifiche caratteristiche legate al mondo funebre e sembra alludere alla vita post mortem, anche se, in alcuni casi, taluni autori propendono piuttosto per gli aspetti legati alla fertilitàe7).
Per quanto riguarda questo tipo di decorazione, confronti non speculari con raffigurazioni di
(47
) Cf. NN. l, 27, 138, 150, 172, 187, 189.
(48
) BARTOLONI 1996, pp. l 03-104.
(49
) Cf. ad esempio la brocca da Paniloriga in MoscATI 1980, p. 202.
CS0) BARTOLONI 1996, n. 306, fig. 29~
CS 1) NN. 11, 61, 74, 156, 170.
e2) NN. 138, 150, 187, 189.
e3> N. 138.
e4) Cf. ad esempio CIASCA 1991, pp. 618-20; CINTAS 1970, tavv. XIX, 98-99, XXVI, 22, 25, 29, XXXI, 76, 80, 86,
89-91, XXXIV, 103-108.
es) N. 189.
(56
) N. 139.
e7) Si vedano ad esempio le raffigurazioni di palmizi incise sulle stele di Cartagine: cf. HouRs-MIÉDAN 1951, pp.
45-46, tavv. XIX, XXX, XXIV: l'Autrice in particolare sostiene che l~immagine della palma abbia soprattutto una valenza di fecondità; il tema è ripreso da PICARD 1976, pp. 77-78, tavv. X-XI, e anche in questo caso l'autrice propende per una simbologia legata alla fecondità, ma in ipotesi secondaria propone che la palma sia: « ••. un emblème d'immortalité ... » con « ... valeur eschatologique ... »(p. 78); per le referenze delle raffigurazioni e per l'iconografia, cf. PICARD 1978,
'
pp. 17-18, tavv. XVIII. XXIV. . .
112 Parte Terza
rami di palma in posizione centrale sul collo, sempre su brocche di questo tipo, sono reperibili tra l'altro in due recipienti provenienti rispettivamente dalle necropoli di Bitia e di UticaCS8
) e in un altro, ancora inedito, rinvenuto recentemente in un ipogeo sulcitanoe9
).
Forma 27
Funzioni analoghe a quella della fonna precedente ricopre la brocca di derivazione cipriota, presente nella necropoli con un solo esemplare(60
). Di questa particolare fonna si è già avuto modo di trattare in altra sede(61
) e quindi restano valide le considerazioni emerse in quel contesto. Il recipiente è privo di parte del labbro, che si intuisce ampio e parzialmente a cartoccio. Il collo è troncoconico, strombato ali' attacco con la linea di sutura appena in rilievo. L'ansa è coerentemente gemina e il piede risulta distinto. La sobria decorazione si concretizza con due righe nere tracciate sulla spalla subito sotto la linea di sutura.
Forma 29
Segue la fonna che raccoglie alcuni tipi di brocche con bocca trilobata(62). La forma è nota ed
è caratteristica dell'ambiente con una diffusione cosmopolita(63). La tipologia comprende tre di
versi aspetti della medesima fotrna, concretizzabili con un primo tipo snello e caratterizzato dal collo stretto e dalla pancia pirifonne rovesciata(64). La decorazione è prevalentemente a risparmio, per immersione obliqua della bocca e del collo, e con gruppi di righe nere delineati sulla spalla e sulla pancia.
Il secondo tipo mostra una bocca ampia, un corpo pirifonne rovesciato con il piede per lo più distinto(65
). L'ansa è nastrifornte, ma in un caso si presenta genùna con rocchetto, in maggior aderenza con i prototipi rodi. Anche in questo caso la decorazione è prevalentemente a risparmio, per immersione obliqua in vernice rossa della bocca e del collo, e con fascia nella stessa vernice tracciata sulla pancia, inquadrata da due righe in vernice nera, o con un gruppo di tre righe del medesimo colore. La decorazione dell'ansa della brocca N. 55, composta da numerosi tratti orizzontali, anche in questo caso trova concordanze in area fenicia(66
).
Il terzo tipo è costituito anch'esso da tre recipienti(67) che in questo caso sono decisamente
tozzi. Il tipo è già noto nell'area sulcitana e sussiste ancora nella necropoli ipogea di Monte Si-
e s) BARTOLONI 1997 a, p. 257, n. 140; CINTAS 1951, pp. 64, 66, fig. 29.
(59) Si tratta di una brocca biconica rinvenuta all'interno della tomba 9 AR; ringrazio Paolo Bemardini e Agnese Lemme per la cortese anticipazione.
( 60) Cf. N. 90.
(61
) Cf. BARTOLONI 1996, p. 104, fig. 15, tav. V, 4~ sul tipo in Oriente cf. LEHMANN 1996, forma 306, p. 418, tav. 49; sul tipo in Occidente cf. ad esempio B ISI l 977, pp. 27-29, tav. V , 1.
(62
) Cf. NN. 52, 55, 60, 69, 75, 80, 91, 121, 136, 167, 171, 208 (esemplare di età punica), 242, 277.
(63
) Sul tipo cf. BARrOLONI 1996, p. 105, fig. 18, tav. VIII, 4.
(64) NN. 52, 69, 75, 80, 167, 208, 242, 277; cf ad esempio CINTAS 1954, p. 105, fig. 21.
(65
) NN. 55, 60, 91; cf. ad esempio CINTAS 1951 , pp. 44-45, fig. 14.
(66) Per decorazioni simili sia sul corpo che sull'ansa, cf. ad esempio BrKAI 1978, pp. 36-37, tav. XX, 7, 9; ANDERsoN 1988, pp. 628-29, tav. 34 , 2; BADRE 1997, pp. 74-75, fig. 37, 15.
(67) NN. 121, 136, 171; cf. ad esempio CrNTAs 1954, p. 114, fig. 33.
Le forme chiuse 113
rai(68). La decorazione è di tipo ornitomorfo ed è assolutamente caratteristica e costante per questo
tipo di recipiente. Infatti, sono presenti gli occhi delineati sui lobi della bocca in vernice nera e can1piti in vernice bianca, una linea di punti bianchi e neri alternati alla base del collo e tre gruppi di righe verticali, tre bianche e due nere alternate tra di loro, tracciate sulla pancia.
Infine, sempre nell'ambito di quest'ultimo tipo, è da notare in modo particolare la brocca N. 136, unico tra i recipienti chiusi della necropoli, se si eccettuano le pentole che vedremo successivamente, ad essere realizzato ad impasto.
Forma 37
Proprio i recipienti classificabili come pentole sono tra quelli che, per loro stessa natura e modalità di realizzazione, sono quelli meno standardizzati. Infatti tre sono le pentole rinvenute nella nostra necropoli(69
) e tutte sono eseguite a mano con la tecnica ad impastoC0). Come risulta evi
dente, pur nel quadro delle stesse funzioni, il tipo si discosta sensibilmente dalla pentola fenicia con orlo amigdaloide obliquo(1
) , quest'ultima ben nota poiché risulta una sorta di fossile guida cosmopolita nel panorama della ceramica fenicia di Occidente e già individuata a suo tempo cometale da Anna Maria Bisi(72
).
Si è discusso se questa particolare forma, di varie dimensioni e talvolta munita di versatoio funzionale o falso(3
), potesse derivare da reminiscenze nuragiche(4), cioè se si potesse trattare di
una delle rare ma pur presenti forme transitate dal repertorio nuragico a quello fenicio(5). In real
tà, come già segnalato da Massimo BottoC6), questa fonna eseguita a mano con l'orlo appena sva
sato esiste anche nel repertorio fittile fenicio della penisola ibericaC7). È quindi possibile che, quantunque la forma non sembri comparire nel repertorio fenicio di Oriente, questa particolare pentola abbia origini non locali ma appartenga a tutti gli effetti al bagaglio culturale fenicio. In ogni caso il tipo è talmente elementare da poter essere cosmopolita anche in diacronia.
Di particolare interesse risulta l'urna N. 148 (Fig. 37; Tav. XXIX, b), che presenta tre bugne localizzate simmetricamente sulla massima espansione della pancia assieme ali' ansa spezzata. La bugna diametralmente opposta ali' ansa potrebbe e_ssere interpretata come falso versatoio. Un confronto attualmente ancora inedito proviene dal settore della necropoli fenicia di Bitia esplorato tra il 1980 e il 1984.
(68) Cf. BARRECA 1964, nn. 17/78, 19/83, p. 41, tav. XXXIII; AMADASI-BRANcou 1965, nn. 16, 30, 36, 46-47, 49, 56, 70, 73-74, 79, 80-81, 83, pp. 109-114, 116- 18, tavv. XXXIX-XL; BARTOLONI 1983 a, pp. 45-46, fig. 2, h-j.
(69) Cf. NN. 86, 115, 148.
(0
) Sul tipo cf. BARTOLONI 1996, p. 112, fig . 29, tav. XXI, 6.
C1) Sul tipo cf. BARTOLONI 1996, p. 114.
(72
) Cf. B1s1 1970, pp. 49, 123-24, 14 1, tav. 11, 6.
C3) Cf. BARTOLONI 1996, p. 112; sul tipo cf. inoltre BARTOLONI 1987 d, p. 242, fig. 9 ; BERNARDINI 1997, pp. 55-57, 236.
C4) Cf. B ARTOLONI 1996, p. 1 12, fig. 16.
(5
) Cf. ad esempio i vasi bolli-latte o le olle con collo a tromba del tofet di Sulcis: BARTOLONI 1985 b, pp. 179-81, figg. 3, 10-11.
C6) Ringrazio Massimo Botto per la cortese anticipazione.
C7) Cf. ad esempio H. ScHUBART apud MAASs-LrNDEMANN 1982, pp. 65-66, tavv. 17-18; MARTfN RUJz 1995, pp. 130-
31 ' fig. 120.
114 Parte Terza
Forma 39
Trentaquattro recipienti più o meno conservati o in frammenti appartengono alla fonna riguardante le anfore onerarie(8). Occorre chiarire che nell'area della necropoli fenicia compaiono recipienti di questa classe riferibili a due ben diversi periodi. Infatti, se una parte, per lo più in frammenti spesso non ricomponibili, condivide i corredi di età fenicia o, pur in condizione sporadica, è tipologicamente apparentabile a questo periodoC9
), un ulteriore gruppo costituisce invece quanto resta dei vasi contenitori delle sepolture a enkytrismòs di età punica(80
).
Per quel che riguarda i recipienti di età fenicia, questi erano utilizzati, soprattutto con ampi frammenti, per coprire parti delle ossa combuste. In ogni caso le anfore sono tutte appartenenti ad un medesimo arco temporale compreso tra i primi anni e circa la metà del VI secolo a.C.(SI).
Altrettanto si può dire per le anfore di età punica, tutte comprese tra la fine del VI o i primi anni del V secolo a.C. e i primi decenni del IV secolo a.C. Nel caso specifico, tutti gli esemplari rinvenuti sono riferibili alla prima metà del V secolo a.C.(82
), tranne l'anfora N. 195 (Fig. 40)(83),
che è un evidente prodotto collocabile nei primi anni del secolo successivo.
Forma 41
La fonna concerne l'anfora di tipo domestico(84), quindi di dimensioni contenute rispetto ai ti
pi commerciali. La fonna, che è assai nota ed è ben percepibile in ogni fase del suo processo evolutivo, dovrebbe derivare dalle anfore di uso prevalentemente domestico del tipo cosiddetto Cruz del Negro(85
). Tuttavia, considerato che il caratteristico cordolo del collo sul quale si appoggiano le anse costituisce un dettaglio tecnico cosmopolita, non si può escludere una ispirazione della forma attraverso le anfore cosiddette 2::02:, ben note al mondo fenicio di Oriente(86
) e, come è ovvio, di Occidente(87
).
Tra i cinque esemplari rinvenuti, i NN. 63 e 72 provengono dalla necropoli fenicia, mentre i NN. 288-90 derivano dall'area della necropoli punica ed erano evidentemente parte di uno o più corredi delle tombe ipogee. La forma delle anfore di età fenicia è decisamente più vicina ai prototipi evocati. Infatti il recipiente N. 63 (Fig. 29) ricorda decisamente le succitate anfore attiche, mentre il N. 72 (Fig. 30), con la pancia globulare, evoca senza dubbio le anfore di origine iberica. La loro decorazione, con righe nere e fasce rosse alternate e in un caso con gruppi di tremuli sulla
(8
) Cf. NN. 17, 25, 57, 62, 65, 101, 110, 142, 146, 179-80, 195, 197, 199, 202, 210-11, 214, 218, 225, 227-28, 238-39, 253-57' 264, 266, 276, 286-87.
e9) Cf. NN. 17, 25, 57, 62, 65, 101, 110, 142, 146, 179-80, 218, 225,227-28, 238-39, 253-57, 264, 266, 276,
286-87.
(8~ Cf. NN. 195, 197, 199, 202, 210-11 , 214.
(111
) Per i tipi cf. ad esempio BARTOLONI 1988 d, pp. 45-46, fig. 8, D 2-D 3; Borro 1994, pp. 1 06-l 08, fig. 7; RAMON
ToRREs 1995, pp 135, 174.
(82
) Per i tipi cf. ad esempio B ARTOLONI 1988 d, p. 47, fig . 9, D 4; BoTIO 1994, pp. 107-108, fig. 7; R AMON T o RRES
1995, pp. 174-175.
(83
) Per il tipo cf. ad esempio BARTOLONI 1988 d, pp. 49-50, figg. 9-10, D 6-D 7; Bono 1994, pp. 109-110, fig. 8; RAMON TORRES 1995, p. 175.
(84
) Cf. NN. 63, 72, 288-90.
(85
) Per il tipo cf. ad esempio MARTfN Ru1z 1995, pp. 121-22, fig. 107; da ultimo, anche per l'ampia bibliografia, cf. KBIRI ALAOUl-LOPEZ P ARDO 1998, pp. 9-15' figg. 2-4.
(86
) Cf. ad esempio CHAMBON 1980, p. 173, tav. 44, 2, 128; BADRE 1997, pp. 86, 89, fig. 46, 2.
(87
) Cf. ad esempio VEaAs 1989, p. 216, da Cartagine; BARTOLONI 1990 b, pp. 41-42, tav. V, l, da Sulcis.
Le forme chiuse 115
spalla, è in accordo con i canoni del periodo. L'anfora di età punica N. 288 (Fig. 43), interamente ricoperta di vernice rossa come tutti i confronti noti esclusivi dell'area sulcitana(88
), presenta una decorazione superstite con due gruppi di quattro righe nere.
Le anfore NN. 289-90 (Fig. 42) rappresentano la forma nel suo processo evolutivo del tardo IV secolo a.C., se non addirittura della prima metà di quello successivo, soprattutto per quanto riguarda il recipiente N. 290.
Forma 42
Le anfore di tipo domestico con spalla carenata(&9) rappresentano l'ultima fonna chiusa della
nostra necropoli. Il tipo risulta decisamente longevo ed è certamente da considerare una forma caratteristica del mondo fenicio e punico di Occidente. Infatti, gli esemplari più antichi sono testimoniati non solo nella metropoli africana, ma, anche a Mozia o, per quanto riguarda la Sardegna, anche a Sulcis o nei più antichi centri della penisola iberica(90). La fonna sopravvive con mutazioni, quantificabili soprattutto per quanto riguarda l'orlo, almeno fino al IV secolo a.C. ed è cosmopolita al pari degli esemplari più antichi(91
).
La presenza dei due recipienti documenta la rapida evoluzione del tipo che in un venticinquennio transita dalla sagoma pirifonne dell'anfora N. 99 (Fig. 33), la più antica, certamente più aderente agli originali, a quella con andamento biconico dell'anfora N. 59 (Fig. 28), la più tarda, che tradisce un gusto tipico delle botteghe figuline dell'area su1citana. Questo si evidenzia in particolare nelle brocche con bocca bilobata e negli attingitoi(92
), ma anche in altri recipienti quantunque testimoniati con minor frequenza(93
).
La decorazione è legata ai canoni del periodo, poiché nel caso dell'anfora N. 99, la più antica, è rappresentata da una sequenza di fasce in vernice rossa tracciate nello spazio tra l'attacco inferiore delle anse e la linea di massima espansione della pancia. Per quel che concerne l'anfora N. 59, si percepisce sulla massima espansione della pancia una ormai consueta fascia in vernice rossa marginata da due gruppi di due righe nere. Tremuli di diversa lunghezza tracciati in vernice nera arricchiscono lo spazio della spalla tra le anse e il dorso delle stesse anse.
(1111) Cf. BARTOLONI 1983 a, pp. 35-53, fig. 4, a-b.
(89
) Cf. NN. 59, 99.
(90) Per il tipo cf. ad esempio GAucKLER 1915, tav. CCIX; HARDEN 1937, pp. 67-68, fig. 3, h; CINTAs 1970, pp. 353-60, tavv. XXXIII-XXXIV; BARrOLONI 1990 b, pp. 53-54, fig. 12; CIASCA 1991, pp. 618-19, fig. l; MAKriN Ru1z 1995, pp. 133, 135, fig. 124.
(91 ) Cf. ad esempio MERLIN-DRAPPIER 1909, n. 18, tav. III; TARAMELLI 1912, col. 102, figg. 16, 3, 17, l; HARDEN 1937 pp. 77-78, fig. 5, k; RoDERO RtAZA 1980, pp. 95-97, fig. 36, 1-3, 37, l; BARTOWNJ 1983 a, pp. 46-47, fig. 4, c; LANCEL 1987, pp. t l O, 129, tav. J 3; CIASCA 1991, p. 621, fig. l; BARTOLONI c.d.s. b, forma 61.
(92) Cf. ad esempio BARTOLONI 1983 a, pp. 43-54, figg. l-2.
(93) Cf. ad esempio N. 169.
CONCLUSIONI
Al tennine dell'indagine sulla necropoli fenicia dell'insediamento di Monte Sirai scaturiscono alcune considerazioni che recano nuovi squarci di conoscenza nel non dovizioso panorama riguardante la civiltà e la storia del mondo fenicio e punico.
Un risultato senza dubbio di grande importanza è l'aver individuato un legame significativo tra le persone defunte e gli oggetti di corredo contenuti ali' interno delle singole tombe. In particolare, è senza dubbio di notevole importanza l'identificazione dei vasi rituali e delle loro specifiche funzioni, l'una legata all'unzione rituale del corpo e l'altra alla libagione sacrae). Tra l'altro, vista la diffusione della pratica rituale nelle sue diverse articolazioni, ciò comporta la contemporanea esistenza non occasionale o casuale dell'olivicoltura e di un'attività vitivinicola intensa, quest'ultima per altro già segnalata in precedenza e attiva fin dalla metà dell'VIII secolo a.c.e).
Per quanto riguarda gli oggetti di corredo personale, tra i quali gli amuleti, risulta particolarmente significativa l'identificazione delle loro precipue funzioni profilattiche, che, per quanto riguarda il campo degli studi fenici e punici, per la prima volta vengono evidenziate in modo significativo e poste in rapporto con il contesto di appartenenza. Sempre in relazione al corredo, si conferma quanto a suo tempo proposto per l'identificazione delle tombe femminili. Infatti, si era notato che cinque recipienti di corredo sembravano caratterizzare questo tipo di sepolturee), laddove tre vasi erano dedicati alle tombe maschili e un solo recipiente a quelle infantili. L'analisi globale del corredo della Tomba 2, con cinque recipienti, ha mostrato che gli amuleti indossati dalla defunta (Tav. III, a-b), poiché a questo punto si tratta di inequivocabilmente di una donna, alludono tutti alla gravidanza, alla nascita e ali' infanzia.
Dali' esame dei rari prodotti importati rinvenuti nei corredi della necropoli si potrebbe essere propensi a classificare l'insediamento di Monte Sirai quale centro periferico e di modesta importanza, soprattutto se confrontato con i ritrovamenti relativi allo stesso periodo effettuati nelle necropoli arcaiche tharrensi(4
). Tuttavia, i reperti rinvenuti nello strato di distruzione e incendio dell' abitato, in gran parte in corso di studio e di prossima pubblicazione, mostrano come la percentuale di prodotti di importazione e di imitazione sia certamente più considerevole di quella riferibile alla necropoli. Infatti, accanto a numerosi recipienti in bucchero, quali kantharoi, kylikes, olpai e oinochoai, tutti databili tra l'ultimo quarto e la fine del VII secolo a.C., sono presenti non rare coppe di imitazione euboica, cronologicamente e tipologicamente affini a quelle rinvenute a Cartagine o a Sulcise). Del resto, le indagini effettuate nell'area della necropoli negli anni più recenti mostrano, accanto a un modesto numero di materiali di importazione, una discreta quantità di coppe di imitazione simili alla coppa N. l e, come questa, derivanti o di libera interpretazione da modelli greco-orientali.
In ogni caso e come appare ovvio, il centro di Monte Sirai sembra dipendere per lo meno culturalmente, se non in modo totale, almeno in parte dalla vicina metropoli di Sulcis, come mostrato
e) Cf. anche per la bibliografia, J. DEBERGH, s. v. Libation: DCPP, p. 259; inoltre, cf. LANCEL 1992, pp. 260-61; FANTAR 1993, pp. 80-81; BENrcaou-SAFAR 1995, pp. 95-105; BEN YouNES KRANDEL 1995, pp. 109-13.
e) Cf. BARTOLONI 1988 a, pp. 410-13; Bono 1993, pp. 15-27.
e) BARTOLONI 1983 b, p. 211; CAMPANELLA c.d.s.
(4
) Cf. GRAS 1974, pp. 79-139; GRAS 1985, pp. 310-20.
e) BRIESE-DOCTER 1992, pp. 25-69; BERNARDINI 1988 b, pp. 73-89.
134 Conclusioni
dai prodotti e dai motivi che in ogni periodo della sua esistenza hanno caratterizzato questo insediamento(6
).
Per quanto concerne il periodo posteriore alla conquista cartaginese della Sardegna si è posta in evidenza la dicotomia tra la necropoli destinata agli adulti e quella che accoglieva gli infanti. Risulta altrettanto palese che l'utilizzo di quest'ultima viene a cessare attorno al 370/360 a.C., periodo nel quale viene impiantato il tofet. Da questo dato archeologico pur negativo, risulta dunque evi-
....
dente la natura funeraria del tofet, la cui componente sacra non è mai stata posta in dubbio. E dun-que evidente che l'impianto di quest'area sacra, che ospitava i corpi degli individui in età prepuberale e probabilmente collocati in luogo separato perché non ancora iniziati, sia dovuto ali' assommarsi nell'insediamento di Monte Sirai di una nuova componente etnica, portatrice di questa usanza. Che si tratti di elementi provenienti dalla vicina Sulcis, il cui tofet è databile almeno dalla metà dell'VIII secolo a.C., o di elementi cartaginesi, la cui area sacra corrispondente gode della medesima cronologia alta, non è dato di saperlo né sarà semplice appurarlo, ma è probabile che nel nuovo gruppo etnico sia da riconoscere le maestranze che dettero corpo alle fortificazioni che in pratica, oltre a Monte Sirai, munirono simultaneamente i principali centri del Nord-Africa, di Sicilia e di Sardegna.
PIERO BARTOLONI
(6
) MoscATI 1996, passim.
TABELLA CRONOLOGICA I
Necropoli fenicia
Tomba l Tomba 2 Tomba 3 Tomba 4 Tomba 5 Tomba 6 Tomba 8 Tomba 9 Tomba 10 Tomba 11 Tomba 12 Tomba 13 Tomba 14 Tomba 15 Tomba 16 Tomba 17 Tomba 18 Tomba 19 Tomba 20 Tomba 21 Tomba 22 Tomba 23 Tomba 24 Tomba 25 Tomba 26 Tomba 27 Tomba 28 Tomba 30 Tomba 31 Tomba 32 Tomba 33 Tomba 34 Tomba 35 Tomba 36 Tomba 37 Tomba 38 Tomba 39 Tomba 40 Tomba 42 Tomba 43 Tomba 44
(Lente di bruciato) (Lente di bruciato) (Lente di bruciato) (Lente di bruciato) (Lente di bruciato) (Lente di bruciato) (Lente di bruciato) (Lente di bruciato) (Lente di bruciato) (Lente di bruciato) (Lente di bruciato) (Lente di bruciato) (Lente di bruciato) (Lente di bruciato) (Lente di bruciato) (Lente di bruciato) (Lente di bruciato) (Lente di bruciato) (Fossa) (Lente di bruciato) (Lente di bruciato) (Lente di bruciato) (Lente di bruciato) (Fossa) (Lente di bruciato) (Fossa) (Fossa) (Lente di bruciato) (Fossa) (Lente di bruciato) (Lente di bruciato) (Lente di bruciato) (Fossa) (Lente di bruciato) (Lente di bruciato) (Lente di bruciato) (Lente di bruciato) (Lente di bruciato) (Lente di bruciato) (Lente di bruciato) (Lente di bruciato)
Ultimo quarto del VI secolo a.C. Terzo quarto del VI secolo a.C. Cronologia non precisabile. Prin1a metà del VI secolo a.C. Cronologia non precisabile. Attorno alla metà del VI secolo a.C. Cronologia non precisabile. Prima metà del VI secolo a.C. Attorno alla metà del VI secolo a.C. Prima metà del VI secolo a.C. Cronologia non precisabile. Cronologia non precisabile. Prima metà del VI secolo a.C. Prima metà del VI secolo a. C Prima metà del VI secolo a.C. Prima metà del VI secolo a.C. Prima metà del VI secolo a.C. Cronologia non precisabile. Seconda metà del VI secolo a.C. Prima metà del VI secolo a.C. Cronologia non precisabile. Cronologia non precisabile. Cronologia non precisabile. Secondo quarto del VI secolo a.C. Attorno alla metà del VI secolo a.C. Primo quarto del VI secolo a.C. Cronologia non precisabile. Seconda metà del VI seco1o a.C. Terzo quarto del VI secolo a.C. Primo quarto del VI secolo a.C. Attorno alla metà del VI secolo a.C. Cronologia non precisabile. Primo quarto del VI secolo a.C. Cronologia non precisabile. Cronologia non precisabile. Cronologia non precisabile. Secondo quarto del VI secolo a.C. Secondo quarto del VI secolo a.C. Prima metà del VI secolo a.C. Attorno alla metà del VI secolo a.C. Attorno alla metà del VI secolo a.C.
136
Tomba 48 Tomba 49 Tomba 50 Tomba 51 Tomba 52 Tomba 53 Tomba 54 Tomba 55 Tomba 57 Tomba 58 Tomba 60 Tomba 61 Tomba 62 Tomba 63 Tomba 64 Tomba 65 Tomba 66 Tomba 67 Tomba 68 Tomba 70 Tomba 71 Tomba 72
(Fossa) (Lente di bruciato) (Fossa) (Lente di bruciato) (Lente di bruciato) (Lente di bruciato) (Lente di bruciato) (Lente di bruciato) (Lente di bruciato) (Lente di bruciato) (Lente di bruciato) (Lente di bruciato) (Lente di bruciato) (Lente di bruciato) (Lente di bruciato) (Lente di bruciato) (Lente di bruciato) (Lente di bruciato) (Lente di bruciato) (Lente di bruciato) (Lente di bruciato) (Lente di bruciato)
N ecropoli p unica
Tomba 29 (Enkytrismòs) Tomba 41 (Enkytrismòs) Tomba 45 (Enkytrismòs) Tomba 46 (Enkytrismòs) Tomba 47 (Enkytrismòs) Tomba 56 (Fossa) Tomba 59 ( Enkytrismòs) Tomba 69 (Enkytrismòs)
Tabella cronologica I
Attorno alla metà del VI secolo a.C. Fine VII - inizi VI secolo a.C. Attorno alla metà del VI secolo a.C. Prima metà del VI secolo a.C. Prima metà del VI secolo a.C. Metà del VI secolo a.C. Fine VIl - inizi VI secolo a.C. Primo quarto del VI secolo a.C. Prima metà del VI secolo a.C. Attorno alla metà del VI secolo a.C. Prima metà del VI secolo a.C. Prima metà del VI secolo a.C. Prima metà del VI secolo a.C. Attorno alla metà del VI secolo a.C. Prima metà del VI secolo a.C. Attorno alla metà del VI secolo a.C. Attorno alla metà del VI secolo a.C. Prima metà del VI secolo a.C. Secondo quarto del VI secolo a.C. Cronologia non precisabile. Cronologia non precisabile. Cronologia non precisabile.
Inizi del IV secolo a.C. V secolo a.C. V secolo a.C. V secolo a.C. V secolo a.C. Cronologia non precisabile. V secolo a.C. Cronologia non precisabile.
TABELLA CRONOLOGICA II
Fine VII - inizi VI secolo a.C. Primo quarto del VI secolo a.C. Secondo quarto del VI secolo a.C. Prima metà del VI secolo a.C.
Attorno alla metà del VI secolo a.C. Seconda metà del VI secolo a.C. Terzo quarto del VI secolo a.C. Ultimo quarto del VI secolo a.C. V secolo a.C. Inizi del IV secolo a.C.
= Tombe 49, 54. = Tombe 27, 32, 35, 55. = Tombe 25, 39-40, 68. = Tombe 4, 9, 11, 14-18, 21, 42, 51-52, 57, 60-62, 64,
67. = Tombe 6, l O, 26, 33, 43-44, 48, 50, 53, 58, 63,
65-66. = Tombe 20, 30. = Tombe 2, 31. = Tomba l. = Tombe 41, 45-47, 59. = Tomba 29.