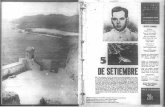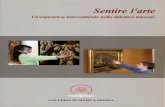Intervento conservativo su Selle e Staffe da parata periodo Edo della collezione del Museo d'Arte...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Intervento conservativo su Selle e Staffe da parata periodo Edo della collezione del Museo d'Arte...
Intervento di manutenzione di selle e staffe giapponesi conservate nelMuseo d’Arte Orientale di Venezia
Programma congiunto UNESCO – Comitati Privati Internazionali per laSalvaguardia di Venezia
Con il contributo del comitato giapponese Venezia aVvenire
Allegati: 2 DVD con relazione e documentazione fotografica2 CD con documentazione grafica
Direzione lavori : Dott.ssa Fiorella Spadavecchia
Restauratrice : Beatrice Falconi
Data dell’intervento: 27Agosto/31Ottobre 2012
Relazione d’intervento
Restauratrice :Beatrice Falconi, via Filiasi 27, 30134 Mestre – Ve
Cell. 3357227567 – e-.mail :[email protected] collezione di selle e staffe giapponesi del periodo Edo ( 1600 – 1868 )
conservate presso il Museo d’Arte Orientale di Venezia
Descrizione delle opere1
La collezione di selle e staffe da parata giapponesi del Museo d’Arte Orientale di Venezia, fa parte del ricco patrimonio di oggetti in lacca che il museo possiede in seguito alla raccolta che il principe Enrico di Borbone fece durante il suo viaggio intorno al mondo tra il 1887 e il 1889.Le opere sono collocate nella vetrina n.1 della seconda sala del museo in un allestimento progettato e realizzato da Nino Barbantini tra il 1925 ed il 1928, infatti lo sfondo stesso della vetrina è costituito da un paravento originale in legno con aperture a griglie decorate. Le selle e le staffe che appartengono al museo, kura e abumi nella lingua originale, facevano parte della bardatura del cavallo probabilmente utilizzata durante le parate dei samurai ( un esempio di bardatura è presente nella vetrina n. 4 della sala II ).La collezione è costituita da 37 elementi di cui 8 set di sella e due staffe, 3 coppie di staffe e 7 selle singole.Le opere sono costituite da legno duro e stagionato, come quercia od acero, e laccate in superficie con lacca giapponese chiamata urushi.
1 Fonte delle informazioni sugli oggetti sono le schede di catalogo di cui i numeri d’inventario compaiono nello schema topografico insieme ai numeri di riferimento fotografico ( vedi pag. successive)
L’urushi è la lacca più pregiata di tutto l’oriente, ed è la linfa elaborata dalla pianta omonima ( Rhus verniciflua ) da cui si ricava lalacca universalmente conosciuta con lo stesso nome.Essa viene stesa a più strati sopra un supporto, in questo caso illegno, precedentemente preparato con una garzatura e degli strati di argilla ( dal più grossolano al più fine ), e successivamente levigato con materiali opportuni fino ad ottenerne la sua caratteristica lucentezza.La bellezza dei manufatti è determinata non solo dalla lacca stessa, ma anche dagli elementi decorativi e le varie elaborazionidi essa dovute alla bravura dei maestri laccatori.Infatti abbiamo vari tipi di decorazioni, che in gran parte raffigurano animali ed elementi floreali, spesso di natura simbolica, realizzati in lacca, con lamine metalliche applicate e tante altri tipi di lavorazione.Le lacche che decorano le selle e le staffe della collezione sono
1. Lacca nera lucida detta roiro;
2. Lacca rossa;
3. Lacca rossa intagliata detta tsuishu;
4. Lacca makie (con polveri metalliche sparse);
5. Lacca hiramakie ( un makie leggermente a rilievo);
6. Lacca takamakie ( un makie a rilievo);
7. Lacca makie nashiji (letteralmente “a buccia di pera”);
8. Lacca makie con kirigane (applicazione di minuscole laminerettangolari);
9. Lacca con applicazione di lamine metalliche sulla superficie.
1) Lacca nera lucida roiro 2) Lacca rossa
3) Lacca rossa intagliata tsuishu 4) Lacca makie ( polveri metalliche sparse)
5) Lacca makie hiramakie 6) Laccamakie takamakie ( leggermente a rilievo) ( a rilievo)
7) Lacca makie nashiji 8) Lacca makie con kirigane ( a buccia di pera ) ( minuscole lamine metalliche rettangolari)
9) Lacca con lamine metalliche
Le selle
Le selle ( kura ) sono in legno stagionato e laccato, costituito daquattro elementi chiamati montanti e tenuti tra loro da corde passanti per appositi fori.La sella è formata da:
Un montante anteriore verticale con otto fori per i finimenti;
Un montante posteriore verticale con otto fori per i finimenti;
Due montanti orizzontali per la seduta con, ciascuno, otto fori e un intaglio longitudinale per i finimenti e le legature.
Alcune selle hanno conservato i finimenti originali costituiti da corde con la parte finale avvolta da un tessuto ( in seta o feltro) ai quali si annodano degli anelli in metallo.I finimenti passano per dei fori appositi realizzati nei montanti e legati tra loro, allo stesso modo i montanti sono uniti da cordeche spesso troviamo legate semplicemente con un nodo, ma che in alcuni casi troviamo unite con degli incroci molto elaborati. 2
La maggior parte delle selle reca sulla parte sottostante della seduta l’ideogramma del maestro laccatore e decoratore caratterizzata da un simbolo identificativo.Nella stessa parte della sella troviamo anche gli ideogrammi che indicano la data di realizzazione del manufatto; spesso gli ideogrammi sono incisi ed in pochi casi segnati a pennello.I due montanti della seduta sono composti ciascuno da una parte centrale allungata e sagomata in modo tale da adattarsi al corpo 2 Vedi da documentazione fotografica le selle n.inv.. 10182; n.inv.10179; n.inv.10184
umano e con un taglio longitudinale spostato leggermente di lato al quale corrisponde un dislivello nella parte sottostante dove spesso rileviamo gli ideogrammi.I fori per i finimenti sono doppi e posti lungo il bordo interno in linea con il taglio longitudinale.Infine, nelle parti più esterne del lato corto sono creati due prolungamenti per alloggiare i montanti verticali che qui si incastrano.La parte sopra descritta è rinforzata, nella parte sottostante, dauna vasta garzatura e che risulta laccata nella parte anteriore che contiene il montante verticale. I montanti verticali sono sempre decorati maggiormente nelle partiesterne, mentre in quelle interne si presentano con la laccatura priva di decorazioni che poi è la stessa dell’esterno dei montantidi seduta.I montanti posteriori sono sagomati in modo da adattarsi alla forma umana da seduta.Nelle parti della zona sottostante troviamo spesso il legno a vista, ed è laccato in maniera elaborata ( spesso in nashiji) solo nelle zone dei sottosquadri dei montanti verticali, mentre il resto della superficie è protetta da strati di lacca trasparente.
Le staffe
Le staffe ( abumi ) sono costituite da legno stagionato laccato e ferro sia nella struttura che all’esterno.La loro forma curva è contenuta da una struttura perimetrale e unafascia centrale in metallo che si uniscono al legno tramite chiodifissati nei bordi laterali.Quanto detto sopra è riscontrabile da un approccio ravvicinato in quanto spesso in corrispondenza delle parti in metallo interne la lacca è sollevata o lesionata; inoltre si può riscontrare anche dalla documentazione effettuata durante i restauri precedenti3. Le staffe sono composte da:
Una parte anteriore; Una parte interna; Una parte sottostante; Una parte verticale.
3 Rx del restauro eseguito nel 2001 del set n.inv. 10167/10168/10169
Sopra la parte anteriore si inserisce un elemento verticale in metallo laccato con un anello finale ed un perno in modo da formare una fibbia nella quale si inseriva il finimento della bardatura da cavallo.Nella stessa parte è sempre presente una foggiatura nel ferro raffigurante forme simboliche di riferimento e che le collegano alla sella ed al loro proprietario ( a forma di fiore, foglie, libellule ), e con un foro circolare probabilmente utile per passarci dei finimenti.Spesso , sotto il perno, troviamo un simbolo per tutti uguale e solo su un lato della fascia in ferro, ed è una forma geometrica dorata inscrivibile in un rombo, forse in metallo o laccata in makie.La parte anteriore è laccata e spesso reca delle decorazioni ad immagini in vari tipi di laccatura;la parte interna delle staffe è sempre uniforme e non è decorata con immagini; lateralmente alla staffa troviamo i bordi rialzati.
Stato di conservazione
Per valutare lo stato di conservazione delle opere, bisogna tenereconto del luogo nel quale sono collocate.La vetrina che le contiene ( vetrina 1 sala II ) è costituita da una parete lignea di fondo ( un paravento originale con finestrature ) che dal lato esterno si affaccia sulla rampa delle scale interne al museo.La parte anteriore è costituita da tre ante vetrate di cui solo l’anta anteriore si apre permettendo l’accesso ai manufatti che sono posti su una fila di quattro livelli composti da due listelliin legno ciascuno.La vetrina fa parte dell’allestimento che Barbantini ha realizzatonella seconda metà degli anni venti del novecento, e perciò esso stesso deve essere mantenuto il più possibile, ma per permettere l’accesso alle opere in modo più agevole rispetto la struttura originale è stata modificata la parte centrale della vetrina.Inoltre, la direzione del museo ha proceduto a rendere le vetrine idonee alla conservazione applicando una pellicola protettiva antiUV ai fragili vetri della vetrina e inserendo un impianto di illuminazione più idoneo. Purtroppo la sala due è in un punto logistico in cui si formano sempre delle correnti d’aria e non si riesce a mantenere una temperatura costante, anche perché il museo non è fornito da un impianto di climatizzazione tale da mantenere la temperatura e l’umidità a livelli ottimali per i vari materiali che esso ospita4.
Degrado5
I raggi ultravioletti sono la maggiore causa di degrado della superficie delle lacche se sono esposte in modo costante e continuativo ad essi, ed analizzando le selle e le staffe della collezione, notiamo che le parti esposte verso l’esterno sono molto più degradate di quelle esposte all’interno.Infatti notiamo dei fenomeni di opacizzazione della lacca dovuto amicro lesioni della superficie ed un conseguente viraggio cromatico.In specifico, per la posizione in cui si trovano nella vetrina le opere, sono maggiormente degradati tutti i lati esterni dei montanti posteriori, i lati interni di quelli anteriori e la parteanteriore delle staffe, tale fenomeno è probabilmente dovuto
4 Si dovrebbe mantenere una situazione costante di Umidità Relativa al 55%; ed una temperatura di. 20-25° C5 Vedi Tabella 1-2 del degrado pagine successive
all’esposizione continuativa ai raggi uv ( provenienti dalla finestra della sala) fino a circa trent’anni fa.Un altro tipo di degrado dovuto ai cambiamenti di temperatura ed umidità dell’ambiente, sono le fessurazioni ed i sollevamenti della superficie che provocano distacco e caduta degli strati della lacca e notiamo questi fenomeni su tutti i manufatti, ma soprattutto sulle staffe.Infatti le staffe sono composte da un’armatura interna in metallo che determina la forma stessa dell’oggetto, ma il contatto tra materiali con movimenti e tensioni differenti quali la lacca, il legno ed il metallo a lungo andare formano il tipo di degrado descritto.Non riscontriamo in modo eccessivo depositi coerenti ed incoerenticome polvere superficiale e stratificazioni di varia natura in quanto le opere sono state sottoposte a periodica manutenzione.Un tipo di degrado apparentemente secondario ma invece molto importante, è la presenza delle impronte digitali sulla lacca.Infatti, le impronte digitali sulla superficie laccata provocano un danno irreversibile se non vengono subito rimosse.I residui lasciati dalle dita possono produrre delle microfessure che seguono i contorni delle impronte in seguito a reazioni chimiche. Il fenomeno è maggiormente visibile nel caso in cui una lacca sia già stata degradata dalla luce, ma se sono presenti impronte su una superficie integra che viene poi esposta alla luce otteniamo lo stesso tipo di degrado.Molti oggetti sono stati sottoposti ad interventi precedenti, infatti spesso troviamo tracce di stuccature ed integrazioni eseguite molto tempo fa in maniera piuttosto improvvisata, tanto da creare a volte ulteriori danni alle opere stesse.Dei restauri eseguiti in un tempo relativamente recente sono quelli operati su due set di selle e staffe: i n.inv. 10157/10158/10159 restaurati nel 1993 e i n.inv. 10167/10168/10169restaurati nel 2001.Avendo potuto accedere alla documentazione degli interventi è stato possibile analizzare il comportamento della materia superficiale dal tempo del restauro ad oggi, e si è notato che glielementi di degrado osservati, come le fessurazioni sulle staffe, hanno continuato a procedere: questo è probabilmente dovuto al fatto che l’ambiente museale non è adatto e che subisce troppe oscillazioni climatiche.
Come supporto alle indagini conoscitive delle opere, abbiamo utilizzato un microscopio digitale Dino-Lite Basic AM 2011 che tramite PC riesce ad eseguire fotografie digitali con ingrandimenti da 10x a 200x.
Modalità d’interventoi
L’intervento che è stato eseguito sulle selle e le staffe della collezione è stato essenzialmente di analisi del degrado effettivodi ogni singolo manufatto e di manutenzione.
Comunque durante il lavoro si sono prospettate delle situazioni ulteriori da analizzare e risolvere, perciò in alcuni casi siamo andati oltre il semplice intervento manutentivo ed abbiamo realizzato un restauro quasi completo.Successivamente all’analisi del degrado dovuta all’osservazione diretta sulle opere, abbiamo proceduto per fasi relative al tipo di situazione che ogni elemento presentava.Ogni fase dell’intervento è precedentemente ponderata in base a studi approfonditi sul materiale della lacca ed il suo restauro.
Pulitura
La fase della pulitura è stata eseguita solo quando la superficie della lacca, già molto degradata, lo permetteva, infatti spesso cisiamo limitati ad una spolveratura con pennelli morbidi in pelo divaio di varie dimensioni.Per quanto riguarda l’uso dei solventi dobbiamo considerare il tipo di lacca sulla quale andiamo ad intervenire, partendo però dal presupposto che la lacca degradata dai raggi ultravioletti ha i legami chimici che costituiscono l’urushi ormai rotti, perciò può essere ulteriormente degradata da solventi polari, uno su tutti l’acqua, portando alla formazione di macchie irreversibili.In seguito a prove di pulitura eseguite sulla superficie6si è optato per i seguenti solventi:
Alcool Etilico , un alcool puro a 99,9°; Alcool Isopropilico , un alcool leggermente meno polare
dell’Alcool Etilico; Acetone , nonostante sia un solvente polare, non riesce a
solubilizzare lo strato alterato di urushi perché è molto volatile e non permane a lungo sulla superficie;
Ligroina , solvente apolare poco volatile e stabile chimicamente, è il solvente più largamente impiegato e consigliato dai restauratori giapponesi per la pulitura dei manufatti laccati;
Soluzione di Alcool Etilico + Acetone ( in proporzione di 1:1).
L’ acqua non è stata quasi mai utilizzata, almeno non direttamente, anche perché in seguito alle prove rilasciava sul
6 Per le prove di pulitura si è fatto riferimento al Test di Solubilità citato nel testo di P.CREMONESI, L’uso dei solventi organici nella pulitura di opere policrome, sec. Edizione aggiornata., 2004, Il Prato,Padova.
tampone delle tracce del pigmento interno alla lacca oltre che macchie irreversibili.
Per ogni tipo di laccatura si è proceduto dove era possibile nel modo seguente:
Alcool Isopropilico Alcool Etilico puro + Acetone (1:1) per superficie
degradate dai raggi UV Ligroina (es:
zone esposte dei montanti verticali; lacca nashiji)
Acetone Alcool Etilico puro + Acetone + per superficie non
degradata dai raggi UVAcqua demineralizzata (1:1:1) ( es.:lacca makie, hiramakie takamakie )
Consolidamento
Questa fase del lavoro non sempre viene eseguita dopo la pulitura,infatti in certi casi si è reso necessario farla anticipatamente per non peggiorare ulteriormente la situazione del degrado, soprattutto nei casi in cui la lacca presenta delle lamine metalliche o dei frammenti sollevati.Come per la pulitura, anche per il consolidamento la lacca ha bisogno di accorgimenti particolari e ponderati di volta in volta.Un prodotto largamente usato nel restauro e che si adatta per questo intervento è il Paraloid B 72, una resina acrilica al 100% a base di etil-metacrilato, con ottime caratteristiche di durezza,brillantezza e adesione sui più svariati supporti.In questo caso il Paraloid è stato scelto per le sue caratteristiche di poter penetrare nelle fessurazioni e per la capacità di ancoraggio e flessibilità che offre, inoltre per far riaderire la lacca sollevata ai bordi delle lacune.L’unica cosa da considerare però, è il fatto che questa resina deve essere sciolta in solventi, in questo caso l’acetone, che puòammorbidire la materia della lacca e deformarla, quindi è molto importante dosare le percentuali di solvente che viene miscelato con il Paraloid ( al 5% al 25% al 40%) e permetterne
l’evaporazione durante la sua applicazione, perciò deve essere inserito a più riprese.Per le zone in cui gli strati di lacca sono fessurati e completamente sollevati dallo strato preparatorio, come per esempio le parti centrali anteriori delle staffe, la resina è stata caricata con degli inerti come le microsfere di vetro ( 50-100Infatti l’aria che rimane imprigionata nel composto gli conferiscemaggiore elasticità e gli permette di assecondare ulteriori movimenti del materiale.7
Nelle lacune della lacca che lasciano esposta la preparazione di argilla e tessuto che si frappone solitamente tra il legno e la lacca, è stato steso preventivamente al consolidamento, un fissativo solitamente utilizzato nel restauro della carta, il Klucel G, composto da idrossipropilcellulosa e utilizzato come adesivo stabile in soluzione acquosa al massimo al 5%.In questo caso è stato utilizzato per proteggere e non alterare l’argilla con la stesura del Paraloid utile per i bordi della lacuna di lacca, una volta essiccato può essere rimosso con tamponature di acqua demineralizzata. Per quanto riguarda la situazione in cui c’erano scaglie di lacca molto sollevate, come lungo i bordi di alcune lacune e con distacchi profondi tra legno e primi strati di lacca, si presentava la necessità di un adesivo forte e compatibile con essi: la colla animale8.La colla animale che abbiamo utilizzato è la colla di coniglio sciolta in acqua demineralizzata (1:7) e scaldata ad una temperatura di 50-60° C.È stata data solitamente a pennello in quei punti che non erano troppo degradati dall’azione della luce.Un altro modo di utilizzare la colla animale è stato per fare riaderire le lamine metalliche sollevate dagli ultimi strati di lacca; in questo caso la colla è stata utilizzata insieme alla stessa urushi.La modalità è stata la seguente:
7 Metodo già sperimentato nel restauro del 2001 sul set n.inv. 10167/10168/10169 e descritto nell’articolo di J.DEI NEGRI La struttura e lasuperficie: due livelli di recupero di sella e staffe laccate, datate 1671 nel n° 28, anno 9, di Progetto restauro, 2003. 8 Da M.WEBB, Lacquer. Technology and Conservation – A comprehensive Guide to the Technology and Conservation of Asian and European Lacquer, Oxford, Butterworth-Heinemann, 2000.
Strato di lacca urushi data a pennello e diluita leggermente con essenza di petrolio;
Strato di colla di coniglio a temperatura di 50-60°C; Adesione della lamina con l’aiuto meccanico di tamponi
morbidi; Mantenimento della pressione sulla superficie per 24h circa.
Integrazioni
In certi casi si è reso necessario eseguire delle integrazioni di alcune lacune, non tanto per motivi estetici, ma per evitare di far sedimentare ulteriore deposito superficiale negli interstizi delle fessure.In altri casi si è dovuto fare delle integrazioni come conseguenzaalla rimozione di stuccature di precedenti interventi a volte troppo degradati oppure perché limitanti all’operazione di consolidamento.Il materiale scelto è lo stucco Polyphilla Interior, preferito al gesso perché non è igroscopico ed è privo di ritiro, ma essendo diaspetto bianco viene addizionato da pigmenti in polvere ( terre ) per raggiungere la tonalità simile a quella della zona da integrare.Si diluisce in acqua demineralizzata e per renderlo più plastico si addiziona con la resina acrilica Acril 33.Una volta essiccato si procede ad un intervento pittorico con acquerelli per dare una tonalità maggiormente compatibile con la superficie circostante.
Protezione
Non è stata eseguita nessun tipo di protezione naturale o sintetica della lacca, anche se in certi casi sarebbe stato necessario.La scelta è stata guidata dal fatto che questo tipo di manufatti richiedono un protettivo compatibile con la superficie e la cosa migliore sarebbe l’urushi stessa, come eseguito nel restauro del 2001.Infatti l’urushi rinnoverebbe in maniera totale la superficie e creerebbe un ulteriore strato protettivo contro gli agenti esterni.Dal momento che non è stato possibile eseguirlo durante questo intervento, si consiglia di effettuarlo in un altro momento.
i Le scelte operative sono state effettuate sulla base di un approfondimento dello studio della lacca urushi presso il Laboratorio di Restauro Polimaterico dei Musei Vaticani a Roma diretto dalla Dott.ssa Stefania Pandozy, nonché basandosi sull’operato del precedente restauro eseguito su di un set di selle e staffe dalla ditta Lac.Care nel 2001/02 per il Museo d’Arte Orientale di Venezia.