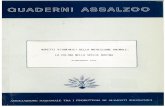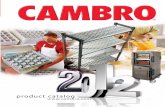Intervento nella discussione
Transcript of Intervento nella discussione
-
DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LA CALABRIA
Per un atlante apertodei beni culturali della Calabria:situazione problemi prospettive
ATTI DELvtI CoNGRESSo SToRICO CALABRESE
(Vibo Valentia - Mileto, ll-l4marzo 1982)
@Gangemi editore
t1t\
x*
ìt
. LXPaL,glq yiele-dala-a--G-i.egtel-qp §,g.lex*G,.rylsppe Be-*qf-o, presenta-tori di due interventi non programmati. "---
-:"-sofia parla sul tema Ascetismo o ,superstizione: fenomeni di credenza
nell'attualità popolare. comunica risultati d'una ricerca sul manifestarsiattuale di pratiche nragiche e di fenomeni a carattere ascetico. si soffermasui casi di persone cui si attribuiscono capacità divinatorie, che si ritengonoderivate dal loro .colloquio, col divino. Cita, fra questi, un fenomeno Àe siverifica a Taurianova, dove una donna, Concettina Viola, quotidianamenteparla a gruppi di persone, trasponendo in termini dialettali brani dellaparabole evangeliche, secondo una gestualità rituale e con una partecipa-zione corale di fedeli-astanti. Afferma di aver voluto, con le sue parole, nondare una comunicazione cronachistica bensì invitare ad uno studio siste-matico ed approfondito dei fenomeni del ,uenere, che ne cerchi le motiva-zioni storico-sociali ed anche religiose, oltre il riferimento generale a situa-zioni di sottosviluppo e di sottocultura, tenendo presente anche la sacralitàdella nostra tradizione.
Giuseppe Restifo espone Ie linee d'una ricerca storico-antrooolosica suR o m @Éfifi r,o,di-s ro?A-m; d eil;Gffiiffiffià di Messina. e"ioenrià-i6?ffff6ò1i[ ffrUfiiffitilffi,=aF}.+*.=.;:#
i problemi sorti nel corso del lavoro, dopo la prima fase di catalogazionegià espletata. Si sofferma in particolare sulle questioni di metodo che coin-volgono l'analisi d'una comunità di tradizione contadina, da ternpo inoltra-tasi in un processo di trasformazione.
Il presidente evidenzia l'importanza d'una volontà di apertura di dia-logo da parte storiograflrca verso una metodologia antropologica,.fllgyg[lSdall'intervento Resti[o. Ha inizio. quindi, la discussione.
%
MINUTo - Due brevissimi interventi. Il primo riguarda I'interessan-tissima comunicazione di vito Teti sui cibi. In essa, ho sentito che I'abbon-danza è espressione di un altro sistema di vita ritrovato altrove. Ho consta-tato che nei nostri paesi, questi greci per esempio, c'è ancora I'abitudine diversare il liquore nei bicchierini fino a farlo traboccare, a indicare I'abbon-.danza e la gioia dell'offerta. Desideravo sapere che significato puo averequesto. L'altro è una domanda che pongo: nella pittura bizantina - comesappiamo - il gesto della benedizione viene fatto coll'indice, I'anulare e ilmignolo ritti; il pollice e il medio piegati. È possibile che ne sia derivata unaforma di scongiuro?
MINICUCI - Vorrei soltanto fare una domanda al prof. Minuto. Dellasua comunicazione mi ha interessato particolarmente la parte relativa allatessitura, cioè laddove ha presentato dei tessuti. Questo - devo dire - unpo per ragioni personali, nel senso che mi sono trovata, per it Museo diPalazzolo Acreide, in provincia di Siracusa, a schedare ottanta tessuti, lamaggior parte dei quali erano coperte. Per fare poi una relazione a unconvegno sulla tessitura, ho consultato la bibliografia su questo stesso tema.Il prof. Minuto, mentre mostrava dei tessuti, diceva: «Questo è un motivogreco», «Questi sono motivi greci". Ora, io gli vorrei chiedere, perché è una
38
paio diÈ statodonna
della
dell'uo-a. Si
Suonava per ore e ore di seguito. Io credo che con lui è veramente finito tuttorrn patrimonio, che purtroppo non e stato a sufficienza conservato.
FILENI - La parte più semplice del mio intervento è una domandasulla relazione di Faeta. Purtroppo. l'ho sentita a metà. perche era già
iniziataquando sono arrivato in.sala. Mi ha interessato molto. M'interessa
chiederti questo: indubbiamente I'immagine è una delle fonti di informa-zioni per demologi, antropologi ed etnologi. Pero, come tutte le fonti d'in-formazione. a mio avviso e anch'essa distorta in un certo senso. Vale a dire.
noi andiamo a distribuire un questionario. Alcuni credono che le risposte al
questionario siano nella realtà che si trova all'interno del gruppo: altri fanno
delle interviste. C'è un caso abbastanza divertente, non so se conoscil.lto o
sconosciuto. Lo racconto in breve; dall'America sono arrivate alcune per-
sone, sociologi, per studiare il fenomeno della mafia a Corleone. Amicicomuni hanno organizzato un incontro fra questi sociologi e la popolazionedi Corleone. I sociologi sono arrivati con le loro batterie di lc'.st"s e di que-
stionari, hanno fatto le domande, la popolazione ha risposto. Poi. tutticontenti si sono salutati. hanno bevuto, se ne sono andati in America. La sera
le persone sottoposte all'intervista sono andate dal nostro amico conlune e
gli hanno detto-:'.,beh, professo, abbiamo risposto esatto alle domande che ci
hanno fatte?» È un po una cosa vicina al «mettiamoci i vestiti che arrivano i
turisti». Ora mi chiedo se nella fotografia c'è un qualche cosa per cui non si
rappresenta tanto una quotidianità del vivere, quanto invece una stlrta di
idealità del vivere, cioe un «mettiamoci in po§a ". Paradossalmente non so
bene come la pensi - per me la fotografia e la morte del gesto, e l'immobi-lità. Quindi, c'è tutto il problema, per esempio, del rapporto fotografia-ri-costruzione gestuale. D'altro canto, tutta I'analisi della gestualità pone que-sti grossi problemi ma, fin dalle analisi di Ifron che hanno tentato di ri-proiettare su carte millimetrate i gesti ripresi. c'e un passaggio dall'analogicoal digitale, c'è una perdita di senso. Questa era la domanda che ti ponevo,
cioè se tu sai qualche cosa, se hai fatto ricerche tu stesso o se sai di altrericerche a proposito di questo rapporto tra modello di rappresentazione, che
può essere la fotografìa, e ricostruzione del reale' Ed è un rapporto che si
pone in più tempi. Un conto è la fotografia di un certo periodo, un conto è la
fotografia quando diventa (tu oggi accennavi alla Polaroid, che ha una
funzione particolare), per esempio, fotografia paesaggistica, quando diventafotografica turistica. Una volta si aveva il problema delle rappresentazionispaziali, il «mettiamoci in posa" col padre in una certa posizione, la madre in
un'altra. entro un certo sPazio.
Abbiamo studi, che consentono di sapere se queste forme del «mettersl
in posa, venivano rispettate in altre situazioni spaziali, in altre situazioni
sociali? se c,era sovrapposizione fra tale tipo di strutture, fra loro, e le
strutture quotidianamente vissute?
Ho poi da comunicare una riflessione. Saro brevissimo'. *9-§§*3BSÉ*{g"' P:*É'Praticamente' si
ffi;.ffi;.f ur. cò" aéitè pèrioiiJippartenenti-f§iuppi incontaminati.
Io credo che molto spesso ci sia una serie di fantasmi. Torna questo mito e
cioè lao- Se si
. can-i chenon licanta
usical-
insisterevolte,
ne
inutilecontr-
questosfatatacrtare r
diè sba-
se bru-
ch'eramuore
ia degli,se
mutata,
nome diun Pezzoe encora
41
laanogli
nellaio che actnolo-
santa.di esor-
nel
ritualinel mo-
questarn
di no-
Vorreiiedè
PrutemPoto di
condelle
e
IXX§OnonFssunche nei
nnvla
dei
mutamento potesse essere recepito come positivo. Altre cose, a mio awiso,potrebPelo ès-s.qre risposje ne-l sqnso di apAgtg-{ §g.lggg*t99g;Lq9gt9}lecitazione ili Restifo e io voÈéi rlcòidaie che certo è estremamente positivo
,i!-w-ffidr4gia antròpòlogica. Forse sarei estrèààmènte esitante prima di definire cul-iura residuale la cultura contadina, perché non vorrei che nè storici nè
antropologi ci trasformassimo in ufficiali di stato civile, che debbano regi-strare decessi e andare a guardare se una loro autonomia l'hanno, quandoproblemi di autonomia e implicazione percorrono tutta la storia, go{tlg-c§Ilg
Bgs-tifo sa benissim-s j)er ra8iiqni difnestiere. E allora forse il problema sta
nel trovare una meiodologia di storiografia antropologica o di antropologiastorica. Dopo per anni aver ignorato una certa tradizione di studi, dopo aver
parlato dell'esperienza delle .Annales, di Braudel e di Le Goff, occorre
iniziare anche da noi con umiltà a conoscere gli statuti rispettivi e awiare dei
processi di conoscenza critica. Ma, dicevo, non voglio dilatare le domande e
ie sollecitazioni.Darei subito la parola a chi e stato chiamato in causa ed a chi ritenga di
voler rispondere alle sollecitazioni emerse in quest'ultima fase del dibattito.
TETI - "I1 vino è poco e i giocatori siamo assai,, quindi ognuno deve
sacrificare qualcosa e rinunciare a dire delle cose perché le suggestioni che
sono emerse sono veramente tante e bisognerebbe parlare a lungo. Rapida-mente al prof. Minuto: io purtroppo non mi sono occupato di alimentazionee di sistema alimentare dei Grecanici anche se, quando ho lavorato in RAI,ne ho sollecitato lungamente i responsabili perché televisione e radio si
occupassero delle minoranze linguistiche della Calabria. Credo che qualco-sa è stato fatto e qualcosa spero che si farà. È un problema anche di accesso,
come diceva lei, e di gestione in prima persona da parte delle minoranze.Perché non si è fatto è anche un limite probabilmente di queste comunità e
qui toccheremmo dei problemi, probabilmente di una morte già awenuta dicerte cose, di una morte reale già verificatasi. L'accorato invito ad occuparsidi certe tradizioni, di certe manifestazioni da parte del professor Minuto miricorda gli inviti di alcuni folkloristi dell'Ottocento. Il problema sta nelcapire che le culture si trasformano e che vengono distrutte per motiviendogeni ed esogeni, come diceva Luigi Lombardi Satriani. A proposito delvino, voglio ricordare come, presso numerose popolazioni, la rottura delbicchiere di vino in occasione di alcune cerimonie, di alcuni rituali, ha valoreaugurale. Così anche presso le minoranze albanesi durante i matrimoni. InCalabria, la caduta del vino è associata a buon auspicio, buon augurio.
Quindi, probabilmente, senza avere griglie interpretative entro le quali farquadrare tutto quanto, potrebbe essere anche questo un segno di abbon-danza, di buon auspicio, di'augurio.
Una serie di suggestioni mi venivano dal discorso di Trumper che mi ha
interessato molto e penso che sia il caso di parlarne, magari dopo. Sonosostanzialmente d'accordo, proprio, con riferimento al discorso dei cantirelativi al «mondo alla rovescia". Su un altro versante, per esempio, perquanto riguarda le farse di Carnevale, è verissimo quanto notava lui: manca
47
tutti gli schedatori. in modo che ad esso si riferiscano specificamente. Certo ,il problema non è solo locale, riguarda lTtalia, anzi il bacino mediterraneonel suo insieme; ovunque ed in ogni epoca sono coesistite tecniche diverse,ed è un esercizio perfin troppo facile mostrare come murature apparente-mente arcaiche, già in epoca protostorica come nei nuraghi, seguano cro-nologicamente altre più accurate. Non conosco, peraltro, nessun repertorioregionale del genere; la Calabria potrebbe iniziarlo facendo un esperimentod'avanguardia. Altro tipo di manuale da distribuire, facendone una edizioneitaliana, è almeno il volumetto sulla tipologia delle scale del GlossariumArtis, edito a Tribingen e Strasburgo22.Lavarietà di forme, in parte indivi-duate da precise defrnizioni linguistiche, attestata in questi schizzi potrebberisultare peraltro insufficiente ad uno studio regionale, che dovrebbe pre-sentare assai più numerose varianti specialmente a livello vernacolare; maprobabilmente si possono usare indicazioni numeriche, associabili fra diloro,. in modo da rendere esaustivo l'inventario delle forme da descrivere.Rispetto ai tipi di volte o di archi, descritti iir analoghi manùali, i tipi di scalami sembrano meglio campionabili sia a livello di architettura culta chepopolare, con una possibilità, forse, di mappe distributive aventi qualchesignilicato storico-culturale23.. Certo, anche tutta l'urbanistica minore dovrebbe essere aggredita me-diante strumenti descrittivi il più possibile diretti2a evitando quegli schemi
22 Glossarium Artis, Deutsch-Franzosisches Worterbuclt zur Kunst, Ttibingen-Strassburg.Mi riferisco, in particolare, al vol. 5, Treppen un Rampen, 1973 ed al volume 6, Gewdlbe undKuppeln. 1975.
23 La strada da percorrere è probabilmente quella suggerita dal computer grafico, cuiormai andrà delegata la corretta stesura a disegno dei dati d'el rilevamento diretto degli edifici,sia manuale che fotogrammetrico. La proposta più aggiornata che conosco è in una tesi di J. B.HARRIS, Concepts of Architectural Organisation: Methods of Numerical Taxonomy in theAnalysis of Built Forms, discussa presso I'università di Manchester nel 1980. Invece che partireda tipologie prestabilite, che entrano in crisi già di fronte all'architettura popolare e all'urba-nistica minore, la catalogazione scaturirebbe, secondo questo metodo, dall'infinita varietà di'forme costruite, o di funzioni svolte architettonicamente, mediante tabelle numeriche. Forse, intal modo, sarebbe anche più facile lentare delle statistiche, sulla base di forme o tipi significanti,oppure muovendo, invece, da aree ben precisate, entro cui rilevare caratteri tipici.
Fondamentale sarebbe poter avere una serie di mappe storiche concernenti i feudi, ed
alberi genealogici non approssimati. -EggmpJa-qq.
è il tal lenso la ricerca di GIUSEPPE REST_!..-
;. mi riferisco in particolare alla comunicazione prese4tata a Spello il 15-16 novembre 19'17:
La sezione archivi privati degli archivi di Stato e altre J'onti per lo studio dellafamiglia aristocra-rica, e pubblicata in "Genus", XXXV (1979), n. l-2, pp. 219-236. Purtroppo per la Calabria, inquesta accuratissima rassegna sia di problemi che di materiali documentari, risultanb solo glistudi di Saverio Di Bella sulle carte Pignatelli.
Sul feudalesimo calabro, vedi ancora N. CORTESE, Feudi e feudatari napoletani dellaprima metà del Cinquecento, Napoli, 1931.
Potrebbe risultare veramente utile, per una distinzione in aree culturali diverse, uno studiodelle misure usate per la costruzione edilizia, sia secondo consuetudini locali, che per ragionisimboliche (quali sono state presentate da ROSARIO JURLARO, Nuove tesi per la letturaplanimetrica della Cattolica di Stilo, «Calabria bizantina. Tradizione di pieta e tradizionescrittoria nella Calabria greca", Reggio Calabria-Roma, 1983, pp. 55-58.
2a Per il catasto degli edifici rustici, esemplare è la catalogazione compiuta da AndreaEmiliani,.per conto della Regione Emilia e Romagna.
anche dgiche *ii cicittà,Ji Édocumtgfunzi.u ltstribuzirrtate duilcon -sli mmenrc gppos§ttfc qripnlJufi rnpemrrErv&trr- spGUcamtrlrgFlqualcfoc rraruLf dbdptrlseurr orichl.tmnforme.dl-arCIe ifudapFf\rf{rdsusulfuul-r- sr c5l'srl.prnnr dprù!Èflltugurm eplfCL]El§CffifL'lre.: