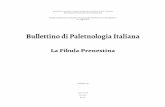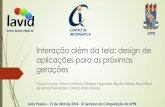A. Cerasuolo, G. Zorzetti, L'Epifania di Francesco de Mura: resoconto di un intervento su una tela...
-
Upload
beniculturali -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of A. Cerasuolo, G. Zorzetti, L'Epifania di Francesco de Mura: resoconto di un intervento su una tela...
151
Premessa
Questa comunicazione riguarda un intervento di restauro che risale ormai a vent’anni fa 1.
Vuole essere il resoconto di una procedura di in-tervento suggerita da una particolare condizione con-servativa che ci trovammo ad affrontare, ma anche delle riflessioni indotte da quella contingenza, delle letture e dei colloqui che accompagnarono un percor-so inconsueto.
Nei laboratori di restauro di Capodimonte avevamo visto tanti dipinti, soprattutto tele del ’600 e ’700 2, più o meno ben conservate, ma, come è usuale, quasi
sempre manomesse dai restauri precedenti, talvolta in maniera irreversibile: gravi perdite di colore o os-sidazioni provocate da cattive foderature, abrasioni e consunzione derivati da puliture drastiche, ridipinture pesanti e spesso apparentemente immotivate eseguite su strati di stucco di spessore consistente e di difficile rimozione, ampiamente debordanti sull’originale, su cui talvolta successive foderature avevano finito per imprimerle, schiacciando irrimediabilmente il colore. Anche nei casi più fortunati, dovevamo sempre con-frontarci con opere già restaurate, di cui era difficile anche solo immaginare l’aspetto originario, e il nostro intervento appariva legittimato, oltre che dalla neces-
L’Epifania di Francesco de Mura: resoconto di un intervento su una tela mai restaurata
Angela Cerasuolo, Giulia Zorzetti
Fig. 1. Napoli, Chiesa di Santa Maria di Donnaromita, Francesco De Mura, Epifania - Insieme dopo del restauro
L’ingegno e La mano. Restaurare il mai restaurato
152
sità di stabilizzare e conservare quanto rimasto, anche dall’esigenza di recuperarne la visibilità, di rimuovere ciò che le snaturava, di aiutarne la lettura.
Con l’Epifania di De Mura ci trovammo di fron-te per la prima volta un dipinto intatto – sciupato, decoeso, offuscato, ma mai toccato – che esigeva un intervento, ma reclamava anche, ancor più del solito, una rigorosa considerazione di ogni passo che andava-mo ad intraprendere, consapevoli di condizionarne la “trasmissione al futuro” in maniera determinante.
Pur nella limitatezza di mezzi e di tempo in cui era necessario operare, abbiamo cercato così di impronta-re il nostro intervento a questo imperativo, documen-tando il più possibile l’esistente e compromettendone il meno possibile il valore di testimonianza.
Una storia di abbandono: lo stato di conservazione
L’Epifania della chiesa di Santa Maria Donnaromi-ta a Napoli (Fig. 1) fu dipinta da Francesco De Mura nel 1728, uno dei primi saggi dell’attività autonoma del virtuoso giovane allievo del Solimena, celebrata
prontamente dalle parole del De Dominici: «dipinse il bel quadro dell’adorazione de’ SS. Maggi con bel componimento, e dipinto con tal magia di colori, che parvero quelle pitture di mano del suo Maestro agli occhi de’ riguardanti» 3.
Collocato nella controfacciata della chiesa, ad un’altezza considerevole, oltre i 10 metri, il dipinto, di grandi dimensioni – cm 425 x 750 – non era mai stato rimosso dalla sua sede, dove risultava difficil-mente accessibile. Aveva subito però numerosi danni accidentali, causati da episodi traumatici e dall’incuria (Fig. 2). La chiesa, infatti, chiusa al culto, aveva ver-sato, come molte altre chiese napoletane all’epoca, in stato di abbandono, peggiorato dopo il terremoto del 1980, che aveva causato dei danni strutturali all’edi-ficio. Il sottostante portale ligneo si era incendiato, rimanendo completamente carbonizzato, e il calore subito in quell’occasione aveva aumentato lo stato di inaridimento della tela e degli strati pittorici. Inoltre, nell’ambito dei lavori di consolidamento statico, la parete su cui era collocato il dipinto era stata sottopo-sta a iniezioni di cemento – modalità in seguito mes-sa in discussione, ma all’epoca praticata con somma
Fig. 2. Napoli, Chiesa di Santa Maria di Donnaromita, Francesco De Mura, Epifania- Insieme prima del restauro
153
L’epifania di Francesco de mura: resoconto dell’intervento su una tela mai restaurata
leggerezza e diffusione – e, come capitava spesso, la fuoriuscita della malta da lesioni retrostanti il dipinto aveva finito per causare ulteriori danni, costringendo gli operai a lacerare il margine inferiore della tela per permettere lo scorrimento del cemento. Diverse pic-cole lacerazioni, presenti soprattutto nella parte bassa e vistosi cedimenti del tensionamento interessavano inoltre la tela (Fig. 3). Infine, testimoniavano l’abban-dono in cui versava l’ambiente le colature di guano di piccioni, penetrati in chiesa dai finestroni a cui manca-vano diversi vetri, e insediatisi stabilmente all’interno (Fig. 4).
Le condizioni del dipinto non potevano dunque dirsi ottimali: lacerato, coperto di guano e con diffusi difetti di adesione del colore, si presentava estrema-mente inaridito, i toni ingrigiti e spenti nulla più face-vano intuire della «magia di colori» testimoniata dal biografo napoletano.
Un dipinto ‘intatto’
Quando fu possibile ispezionare da vicino il di-pinto, che dopo lo smontaggio dalla parete fu siste-mato nell’area dell’abside, ci rendemmo conto che, nonostante i danni, non mostrava di aver mai subito alcun tipo di intervento. A parte il taglio lungo il bordo inferiore, non si riscontravano segni di manomis-sioni né di restauri. Una piccola la-cerazione, in alto a sinistra, sul cielo, rattoppata sul verso con materiale oleoso e integrata sul recto con co-lori di natura molto simile all’origi-nale, sembrava risalire ad un danno verificatosi durante il trasporto e la collocazione del dipinto all’epoca della sua esecuzione.
La maggior parte dei danni era-no riferibili al naturale processo di invecchiamento dei materiali, certo accelerato dalle pessime condizioni conservative: la preparazione, molto arida e decoesa, presentava un cretto pronunciato, principalmente nelle aree corrispondenti alle stesure scu-
Fig. 3. Napoli, Chiesa di Santa Maria di Donnaromita, Francesco De Mura, Epifania- Particolare prima del restauro
Fig. 4. Napoli, Chiesa di Santa Maria di Donnaromita, Francesco De Mura, Epifania- Par-ticolare prima del restauro
L’ingegno e La mano. Restaurare il mai restaurato
154
re, per cui preparazione e colore, sfaldati in minutis-sime scagliette, tendevano a distaccarsi dal supporto e già si erano verificate piccole diffuse cadute. Si riscon-travano inoltre numerose ossidazioni nella pellicola pittorica, e alcune aree risultavano sbiancate: sembra-va di poter far risalire questo fenomeno alla tecnica esecutiva del dipinto, poiché i più intensi sbiancamen-ti corrispondevano a parti trattate con velature, nei passaggi fra i contorni e le parti in luce del viso della figura femminile in basso a sinistra, per esempio (Fig. 5). Era come se un’alterazione del legante ne avesse ridotto la trasparenza, opacizzando del tutto delle ste-sure che in origine dovevano essere translucide, con un curioso effetto di inversione dei toni, come in una foto solarizzata.
La foderatura. Rinvenimenti inediti: l’abbozzo di una testa, il telaio originale
Non c’erano dubbi sulla necessità di procedere al consolidamento degli strati pittorici, e preliminar-mente provvedemmo a rimuovere i depositi di pol-vere e di guano, a secco e con tamponi umidi, dove la stabilità del colore lo consentiva, quindi applicammo la velinatura.
La foderatura, a parte le difficoltà connesse con le grandi dimensioni della tela, non si presentava par-ticolarmente problematica, anche se preferimmo effettuare un consolidamento preventivo degli strati pittorici dal verso attraverso la tela – con applicazioni di colletta seguite da una stiratura con ferro tiepido – prima di procedere al rifodero vero e proprio.
Tela e preparazione erano del tipo consueto nei di-pinti napoletani del Settecento: la tela sottile a trama fitta e regolare, in due teli giuntati con una cucitura molto accurata, disposta orizzontalmente a circa un metro dalla base; la preparazione a base di olio e terre, di intonazione rossastra, stesa in uno strato piuttosto sottile e regolare. Sul verso della tela, nella parte bas-sa verso il centro, a circa un metro e mezzo dal bordo inferiore era visibile l’abbozzo di una testa eseguito con un colore ad olio bruno direttamente sulla tela, non in relazione diretta con la composizione del di-pinto, ma che tutto lasciava credere autografa di De Mura (Fig. 6). Una testimonianza di grande interesse,
probabilmente dovuta ad un saggio estemporaneo, fi-nalizzato a mostrare una propria idea o semplicemen-te ad esercitarsi; i tratti sicuri e sapienti tracciavano i lineamenti di un volto in maniera analoga all’abbozzo preliminare che si può supporre venisse steso sulla preparazione direttamente col colore ad olio prima di procedere all’esecuzione vera e propria del dipinto.
La foderatura, per quanto potesse rincrescere do-ver intervenire su un dipinto in prima tela, si presen-tava davvero indispensabile per consolidare colore e supporto e per ristabilire un buon tensionamento. L’ipotesi di praticare una sorta di ‘finestra’ per lasciare visibile la testa abbozzata, che avrebbe avuto senso nel caso di un dipinto facilmente amovibile conservato in un museo o comunque in posizione accessibile, nel nostro caso avrebbe solo comportato una disomoge-neità nel tensionamento e la creazione di un punto di debolezza in quella parte.
Vista l’ubicazione del dipinto, che una volta ri-
Fig. 5. Napoli, Chiesa di Santa Maria di Donnaromita, Francesco De Mura, Epifania- Particolare prima del restauro
155
L’epifania di Francesco de mura: resoconto dell’intervento su una tela mai restaurata
collocato sulla controfacciata della chiesa non sarebbe stato più accessibile ed ispezionabile dal retro, non ritenemmo opportuno trovare sistemi che consentis-sero di lasciare lo schizzo della testa visibile; decidem-mo così di affidare alla documentazione fotografica la registrazione del dettaglio, procedendo poi normal-mente al rifodero a pasta, evitando però di abradere o smuovere il disegno nelle operazioni preliminari, che in quella piccola parte furono limitate ad una sempli-ce applicazione di colla.
Il telaio su cui era posta la grande tela era ancora quello originale, e rappresentava un notevole esem-pio di carpenteria, ancora perfettamente efficiente (Fig. 7). Relativamente leggero ma solido, presentava anche una particolarità nella costruzione: un sistema di cerniere sul lato lungo che consentiva a una parte di esso di ripiegarsi sull’altra (Fig. 8). Probabilmen-te questa caratteristica dovette servire ad introdurre il telaio in chiesa attraverso lo spazio consentito dal
vano della porta senza smontarlo, ma semplicemente piegandolo per poi ridistenderlo e bloccarlo; sembre-rebbe da escludere però che un tale sistema potes-se essere stato adottato con la tela già applicata su di esso, poiché ne sarebbe stata danneggiata. Ci sembrò doveroso conservarlo e, visto che aveva ancora buone qualità meccaniche, decidemmo di restaurarlo e riuti-lizzarlo. Fu disinfestato, consolidato, rinforzato negli incastri; per evitare il contatto fra la tela e la struttura del telaio furono applicati lungo tutti i bordi dei listel-li a sezione triangolare come distanziatori.
La circostanza di trovarsi di fronte un dipinto in-tatto implicava dunque la possibilità di rinvenimenti inediti, ma al tempo stesso la crescente consapevolez-za di una responsabilità particolare, che ci induceva ad osservare e documentare più del consueto.
Anni dopo, era anche a questa esperienza che pen-savamo quando ponemmo a Paul Philippot una doman-da a proposito dell’opportunità di istituire una tutela particolare a cui sottoporre l’ opera mai restaurata, «una sorta di vincolo preventivo, alla non dispersione dei messaggi di cui è testimonianza». Il grande studio-so suggeriva di segnalare le opere di questo tipo con una sorta di ‘dichiarazione’ preventiva, sottolineando anche il “valore educativo” di tali testimonianze, che consentono «di capire come si presenta un dipinto mai toccato», oltre a rappresentare un importante elemento di confronto per il restauro di opere affini per epoca o autore, e aggiungendo, non senza ironia: «questa è la cosa importante, una sorta di ‘cataloga-zione’ delle opere in stato vergine. Sarà un libricino piuttosto sottile» 4.
Una strana pulitura
L’operazione che si presentò più problematica fu senza dubbio la pulitura. Ci si prospettò la necessità di elaborare una procedura di intervento in grado di preservare caratteristiche del dipinto che una ‘norma-le’ prassi avrebbe potuto compromettere.
Il problema non era solo di natura tecnica, implica-va riflessioni di metodo basilari, induceva a interrogar-ci, più che mai, sui limiti e sugli scopi di un intervento di restauro. L’aspetto etico appariva centrale, ma il dubbio era fra il dovere di rispetto assoluto del mate-
Fig. 6. Napoli, Chiesa di Santa Maria di Donnaromita, Francesco De Mura, Epifania - Particolare di un disegno presente sul verso della tela
L’ingegno e La mano. Restaurare il mai restaurato
156
riale originale, della conservazione ad oltranza, e l’esigenza, altrettanto doverosa, di recuperare quanto pos-sibile dei valori estetici presenti in quei materiali, che ne rappresentano la ragion d’essere. Il problema va ov-viamente ben oltre una schematica contrapposizione fra istanza estetica ed istanza storica, anche se, come ogni intervento di restauro, implica il contemperamento fra le due istan-ze. Nella Teoria brandiana non è mai affrontato direttamente il problema della conservazione o rimozione dei materiali costitutivi alterati. Anche questo interrogativo, mai sufficien-temente dibattuto, fu da noi posto a Paul Philippot nel corso dell’inter-vista. Pur rimandando ad una con-siderazione caso per caso e rifiutan-do di enunciare regole, lo studioso si diceva favorevole a «mantenere il materiale originale alterato. Come minimo rischio. […] Credo che sia più facile difendere questa posizione che l’altra […] bisogna dire che tut-to il sistema del restauro si muove sempre nei limiti del possibile. For-se, un giorno, un chimico veramente interessato troverà un sistema per ri-generare, migliorare questi materia-li. E staranno ancora lì» 5.
L’opera di Alessandro Conti, in particolare, rap-presentava per noi un monito contro il rischio di es-sere presi da una routine operativa che la consueta programmazione degli interventi dava per scontata 6. Eravamo consapevoli che era nostro dovere meditare anche sulle operazioni più banali e apparentemente scontate da condurre, cominciando da quella strana operazione – che ancora alcuni prezzari ufficiali per le perizie prevedono 7 – che va sotto il nome di ‘sver-niciatura’, sorta di pulitura preliminare che si può ipotizzare, in un’estrema schematizzazione, destina-ta a rimuovere le vernici più recenti, ma presuppone evidentemente un dipinto già restaurato e verniciato,
e non è certo applicabile a dipinti mai restaurati, o oggetto di interventi in antico, nel qual caso la rimo-zione delle vernici, magari ad olio e particolarmente tenaci e inscurite, è parte integrante della ‘pulitura’ vera e propria. Banalizzazioni inevitabili forse nel-l’elaborazione di schemi funzionali alla program-mazione, ma purtroppo spesso acquisite anche nella prassi operativa. Basti ricordare che una pubblicazio-ne scientifica sulle vernici nel restauro uscita in quel periodo riporta la foto di un saggio di pulitura su un dipinto apparentemente mai restaurato con la dida-scalia: «Particolare con tassello di asportazione della vernice originale ingiallita», senza ritenere di dover
Fig. 7. Napoli, Chiesa di Santa Maria di Donnaromita, Francesco De Mura, Epifania- Il telaio originale
Fig. 8. Napoli, Chiesa di Santa Maria di Donnaromita, Francesco De Mura, Epifania- Par-ticolare del telaio originale; si notano gli incastri per le giunture fra le assi nel senso della lunghezza e una delle cerniere che consentivano ad una parte del telaio di piegarsi
157
L’epifania di Francesco de mura: resoconto dell’intervento su una tela mai restaurata
anche solo minimamente dibattere l’opportunità di un’operazione del genere 8.
Il caso del De Mura andava però oltre la sola pro-blematica relativa alla rimozione o conservazione di una vernice originale. In questo caso la rimozione del-la ‘vernice’ comprometteva l’integrità della pellicola pittorica vera e propria, che conservava delle finiture irreversibilmente inglobate nello strato superficiale, che non era possibile rimuovere senza eliminare an-che questi elementi, sicuramente riferibili alla stesura originale. Ce ne rendemmo conto appena provammo a praticare dei piccoli saggi, anche solo con la semplice ‘mista’ di alcool ed essenza di trementina: non appena si cominciava a rimuovere la ‘vernice’, questa porta-va via con sè qualcosa delle ultime stesure pittoriche. Anche osservando le parti in cui la finitura si era acci-dentalmente perduta, dove le colature acide di guano avevano corroso la superficie del colore (Fig. 9) o in al-cuni punti in cui mancava, come sui bordi (Fig. 10), si
poteva notare che lo strato sottostante risultava piat-to, e privo delle sfumature e dei passaggi più delicati, pur essendo di colore molto più chiaro e intenso.
Va qui detto che molti degli interrogativi sorti in quella occasione sono rimasti irrisolti. Quale l’esatta natura di quella ‘vernice’? Il fatto che si rimuovesse con i soventi adatti a sciogliere le più comuni vernici a base di resina disciolta in solvente (come la mastice in essenza di trementina) potrebbe indurre a pensare che si trattasse di un materiale di questo tipo, ma non si può escludere che l’estremo inaridimento degli strati pittorici avesse fatto perdere qualsiasi capacità di coe-sione a questa stesura già probabilmente nata povera di legante. L’aspetto e il comportamento dello strato presente sul dipinto era simile ai depositi di polvere e materiali organici che si fissano alla superficie, ri-manendo inglobati nella vernice o nell’essudato del colore. Il problema è che i ‘depositi’ presenti sull’Epi-fania erano parte essenziale del dipinto. Delle finiture
Fig. 9. Napoli, Chiesa di Santa Maria di Donnaromita, Francesco De Mura, Epifania- Particolare durante il restauro
L’ingegno e La mano. Restaurare il mai restaurato
158
estremamente sottili e lievi, probabilmente stese con pochissimo legante, o con un medium molto liquido e diluito, allo scopo di armonizzare ed abbassare i toni, ma anche di definire alcune parti (Figg. 11, 12 ). È difficile dire se fossero state semplicemente applicate senza più provvedere ad una verniciatura o se il dipin-to avesse subito una verniciatura finale sopra di esse. Quanto alla natura del materiale usato per verniciare, una delle ipotesi possibili è che si trattasse di chiara d’uovo. Allora non ci erano ben chiari i termini della polemica sulle vernici che alla fine del ’700 aveva visto contrapposti Philipp Hackert e i pittori napoletani, ma scorrendo un testo di Alessandro Conti fummo colpi-te da un passo in cui si affermava che gli artisti napo-letani del ’700 prediligevano come finitura per i loro
dipinti la chiara d’uovo 9. Quello strato grigiastro, che a prima vista sembrava ‘sporco’, ma che contribuiva in maniera così essenziale alla costruzione delle stesure, e che, una volta recuperatane la trasparenza rivelava la sua natura ‘pittorica’, poteva essere proprio un sot-tile, impercettibile strato di chiara d’uovo che aveva incorporato le ultime stesure, quasi prive di legante. Il colore grigiastro e spento era quello che generalmen-te si associa alla presenza di ‘vernice’ di chiara d’uovo, anche se col trattamento di parziale solubilizzazione che intraprendemmo (preferiamo non usare il termi-ne ‘rigenerazione’ che evoca procedimenti non esenti dal sospetto di mistificazione taumaturgica), recupe-rava un certo tono caldo più propriamente di vernice, forse anche perché tornando trasparente rivelava il
Fig. 10. Napoli, Chiesa di Santa Maria di Donnaromita, Francesco De Mura, Epifania- Particolare durante il restauro
159
L’epifania di Francesco de mura: resoconto dell’intervento su una tela mai restaurata
tono dell’essudato dell’olio sottostante. Queste con-siderazioni che stiamo riportando – ripercorrendo i dubbi e le osservazioni che ci coinvolsero per tutto il tempo che dedicammo alla tela – sono le parziali e transitorie spiegazioni che ci davamo, sempre pronte a rimetterle in discussione e col cruccio di non po-ter eseguire esami oggettivi che ci aiutassero a trovare una risposta. Non potevamo perché non erano previ-sti fondi per eseguire indagini, e i tempi a disposizio-ne erano piuttosto stretti, ma avevamo anche fondati motivi per credere che uno strato così impercettibile e immedesimato nel colore fosse davvero problema-tico da individuare e da caratterizzare. In ogni caso non averlo rimosso rende sempre possibile – almeno a livello teorico – l’esecuzione di un’analisi.
Sotto l’aspetto più strettamente tecnico, il pro-blema era dunque individuare un trattamento della pellicola pittorica che consentisse di recuperarne la leggibilità senza rimuovere, ma piuttosto restituen-
do trasparenza alle stesure ossidate e inaridite che conferivano un aspetto sbiadito e ‘sporco’ al dipinto (Fig. 13). Non era sufficiente per ottenere questo la stesura della vernice, che non riusciva da sola a pene-trare il velo opaco. Si rivelò efficace l’applicazione, a piccole zone per volta, di tamponi imbevuti di alcool etilico addizionato a minime quantità di alcool benzi-lico e dimetilformalmide frizionati leggermente sulla superficie preventivamente verniciata per il tempo sufficiente ad eliminare l’opacizzazione dello strato superficiale, interrompendo l’operazione prima che si cominciasse a smuovere il materiale parzialmente reso solubile. Ciò significava anche accontentarsi di recuperare un tono meno squillante rispetto a quanto avrebbe consentito l’eliminazione della finitura, che una volta resa trasparente rivelava un tono caldo che abbassava leggermente la saturazione dei colori. L’in-sieme però risultava armonioso ed equilibrato, senza certe crudezze di contrasto e senza l’affiorare della
Fig. 11. Napoli, Chiesa di Santa Maria di Donnaromita, Francesco De Mura, Epifania- Particolare dopo il restauro
L’ingegno e La mano. Restaurare il mai restaurato
160
preparazione bruno rossastra che tanto spesso caratterizzano i dipinti settecenteschi sottoposti a pulitu-ra 10. La tecnica esecutiva del dipin-to si rivelava basata sulla stesura di campiture chiare compatte e brillan-ti per le zone in luce, che lasciavano a risparmio il tono della preparazio-ne per le parti in ombra; su questo substrato la figurazione era poi finita interamente a velature con un le-gante molto liquido e trasparente, dosando l’intensità e la colorazione per modulare le masse abbozzate, ammorbidendone i toni e definen-do i dettagli più minuti. La presen-za, in prossimità di ombreggiature, di colore colato a gocce, testimo-nia l’estrema fluidità del legante e la velocità della stesura. In seguito questa modalità è stata riscontrata in altri dipinti napoletani dello stesso autore 11, e si direbbe caratteristica della pittura di impronta solimene-sca, rapida ed efficace, lieve e raffi-nata quanto poco solida.
La scelta operata nella pulitura era stata guidata soprattutto da una finalità conservativa, dalla volontà di rispettare un materiale che, per quanto alterato, era sicuramente originale e quindi andava preservato, ma la scelta contraria non avrebbe ottenuto, con una maggior evidenza cromatica, un’immagine più vicina a quella realizzata dall’artista.
La verniciatura – con resina mastice e damar, prima a pennello, poi nebulizza-ta – indispensabile per mantenere la saturazione dei toni riacquistata con l’applicazione del solvente, ne aumentava probabilmente la profondità più di quan-to sarebbe stato desiderabile: ricordavamo che a con-tatto con l’acqua, quando avevamo eseguito la prima lieve rimozione dei depositi superficiali con tamponi umidi, – i colori si saturavano in maniera più luminosa
Fig. 12. Napoli, Chiesa di Santa Maria di Donnaromita, Francesco De Mura, Epifania- Particolare dopo il restauro
e meno cupa, ma per sperimentare un protettivo che ci restituisse un indice di rifrazione più appropriato avremmo dovuto allontanarci da una prassi collaudata che garantiva la stabilità dei materiali scelti.
Il percorso che ci condusse a queste scelte non fu lineare: la tentazione di leggere come disturbo lo strato spesso irregolare, evidente soprattutto nei
161
L’epifania di Francesco de mura: resoconto dell’intervento su una tela mai restaurata
chiari, ogni tanto riaffiorava, incoraggiate anche dalla facilità di rimozione. Ma la consapevolezza che ogni elemento, per quanto alterato o modificato dal tem-po, facesse parte della storia esecutiva del dipinto, ce lo faceva sentire particolarmente prezioso. E fu sorprendente il piacere, fino ad allora inedito, di ap-prezzare una pittura ‘stranamente’ armonica e com-pleta, dove nessuna parte presentava le dissonanze e gli squilibri che è facile riscontrare in opere già re-staurate.
Probabilmente siamo in qualche modo assuefatti e rassegnati ad opere impoverite e mutile, ma sicu-
ramente questa esperienza ci ha reso più attente a registrare e capire le perdite irreversibili subite dai dipinti, confermandoci che il problema delle puliture, per quanto dibattuto, rimane un nodo problematico aperto.
Lavorare su opere già compromesse, prive di ver-nici e finiture costitutive è come se ci fornisse, anche in maniera subliminale, lo standard a cui attenersi, complici le aspettative esterne e il formidabile, trito alibi dei restauri precedenti.
Per quanto possibile, vorremmo cercare di non fornirlo a chi verrà dopo di noi.
Fig. 13. Napoli, Chiesa di Santa Maria di Donnaromita, Francesco De Mura, Epifania- Particolare durante il restauro
L’ingegno e La mano. Restaurare il mai restaurato
162
Note1 Il restauro è stato realizzato fra il 1988 e il 1990 nell’ambito
di un intervento di recupero dell’intera chiesa e delle sue perti-nenze decorative realizzato con i fondi speciali stanziati in segui-to al terremoto del 1980 sotto la direzione della Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Napoli.
2 La nostra formazione era avvenuta nei laboratori della So-printendenza annessi al Museo di Capodimonte, in un intenso decennio di attività in cui avevamo partecipato, come collabo-ratrici del restauratore Francesco Virnicchi e quindi come so-cie della cooperativa da lui presieduta, a numerosi interventi di restauro di dipinti su tela del XVII e XVIII secolo, in occasione delle campagne di restauro realizzate per le due grandi mostre “Civiltà del Settecento a Napoli” (1978) e “Civiltà del Seicento a Napoli” (1984).
3 De Dominici, Vite de’ pittori, scultori ed architetti napoletani, Napoli 1742, vol. III, pp. 695-696: «Dipinse dopo le belle vir-tù, che sono intorno alla nave della Chiesa di D. Romata tra i finestroni, e sopra il Coro ch’è sulla porta dipinse il bel quadro dell’adorazione de’ SS. Maggi con bel componimento, e dipinto con tal magia di colori, che parvero quelle pitture di mano del suo Maestro agli occhi de’ riguardanti. Tutte queste pitture sono dipinte ad olio, ma operata a fresco è l’altra adorazione de’ stes-si Santi Maggi, che si vede nella lunetta sopra l’Altar Maggiore della Chiesa nominata la Nunziatella».
4 Cfr. M.I. Catalano-A. Cerasuolo-L. Secco Suardo-G. Zorzetti, A colloquio con Paul Philippot, in «Bollettino dell’Istitu-to Centrale del Restauro» 2 (2001), pp. 31-32.
5 Ivi, pp. 33-34.6 Non è necessario ricordare tutti gli scritti di Conti, che co-
stituiscono un riferimento imprescindibile per chi si occupa di restauro. Particolarmente significativi per le problematiche ine-renti le puliture e la conservazione dei materiali originali – e riferimenti importanti in quel frangente – l’articolo La patina della pittura a vent’anni dalle controversie “storiche”. Teoria e pratica della conservazione, in «Ricerche di storia dell’arte», 16 (1982), pp. 23-35, e il bellissimo Sul restauro, Torino 1988, uscito proprio in quel periodo, che nell’introduzione ripercorreva le polemiche sulle puliture londinesi del dopoguerra raccogliendo una messe di notizie e riflessioni fondamentali, e nella selezione di testi di Otto Kurz e di Ernst H. Gombrich (a cui virtualmente si uni-scono gli articoli di Brandi già pubblicati in appendice alla Teoria del restauro) dava un esempio di come uno storico dell’arte può offrire un contributo determinante al dibattito sul restauro; l’ar-ticolo di Stephen Rees Jones, infine, è l’esposizione più chiara ed onesta che si possa desiderare sui limiti del contributo del-la scienza alla comprensione e risoluzione dei problemi tecnici del restauro. Un altro testo che risultò per noi di riferimento, tradotto e diffuso su iniziativa di Alessandro Conti, è Principi di restauro di Hanna Jedrzejewska (Fiesole 1983, titolo originale Ethics in Conservation, 1975), dove il problema dell’etica è posto
dal punto di vista del restauratore, e che Conti commenterà poi ampiamente nel suo Manuale.
7 Cfr. il capitolo dedicato al restauro di dipinti su tela a p. 89 del ‘Prezzario per la conservazione ed il restauro delle opere e dei beni culturali e paesaggistici della Campania 2006’ elaborato dalla Regione Campania, pubblicato sul «Bollettino Ufficiale del-la Regione Campania» n. 27 del 19 giugno 2006, (Deliberazione N. 688 del 1 giugno 2006, Prezzario dei lavori e delle forniture relativo ai Beni Culturali e Paesaggistici della Campania. Rettifi-ca deliberazione di G.R. n. 95 del 26/01/2006), scaricabile sul sito http://www.sito.regione.campania.it.
8 V. Massa-G.Scicolone, Le vernici per il restauro, Firenze 1991, p. 68; nel testo non si rintracciano riferimenti all’eventualità dell’asportazione di una vernice originale, ma un’indicazione sulla posizione degli autori si può indirettamente desumere a p. 37, dove affermano, a proposito della scelta della vernice da applicare ad un dipinto restaurato: «il restauratore… non può, non deve anzi, influire sulla estetica dell’opera a lui affidata salvo il caso che altri ai quali è delegata la responsabilità della conser-vazione (in questo caso, per le opere tutelate, le Soprintendenze ai Beni Artistici e Storici) non dispongano, se e quando possano disporre, diversamente». Non credo che sia necessario commen-tare un passo del genere, se non manifestando l’invidia per una tale serafica non assunzione di responsabilità.
9 Il tema delle vernici e delle finiture è sempre stato centrale negli scritti di Alessandro Conti, che già nella Storia del restauro e della conservazione delle opere d’arte (Milano 1973, p. 235) delinea-va i termini della contesa di fine Settecento originata dalla Lettera sull’uso delle vernici di Philipp Hackert, che sarebbe tornato a commentare più volte. L’uso della chiara d’uovo come protetti-vo dei dipinti al posto della vernice mastice proposta da Hackert era propugnato dagli oppositori del paesaggista tedesco, primi fra questi gli artisti napoletani, dichiaratamente contrari all’uso di vernici. In tempi più recenti l’intera vicenda è stata riconside-rata nelle sue varie implicazioni nel dossier a cura di M.I. Catala-no, Napoli, Roma, Dresda: il dibattito sulle vernici tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo, in «Bollettino dell’Istituto Centrale del Restauro», 10-11 (2005), pp. 3-87. Da ricordare in proposito anche il parere di Francesco De Mura contrario alla verniciatu-ra dei dipinti di Ercolano, cfr. P. D’Alconzo, ‘Picturae Excisae’. Conservazione e restauro dei dipinti ercolanesi e pompeiani tra XVIII e XIX secolo, Studi della Soprintendenza archeologica di Pompei, 8, Roma 2002, p. 62.
10 Gli aspetti conservativi connessi alle caratteristiche esecuti-ve dei dipinti del Seicento e Settecento napoletano, e la precoce attenzione manifestata dai contemporanei alle problematiche da esse derivanti è discussa in A. Cerasuolo, La vernice mastice. Istanze del restauro moderno attraverso la fortuna di un materiale, in Catalano, Napoli, Roma, Dresda…cit., pp. 27-28: «[questi di-pinti sono]eseguiti su una preparazione scura, che tende – già solo con l’invecchiamento, per l’aumentata trasparenza dell’olio – a ‘mangiare’ le mezze tinte, accentuando i contrasti e annul-
163
L’epifania di Francesco de mura: resoconto dell’intervento su una tela mai restaurata
lando i più delicati passaggi nei toni intermedi. Questo effetto viene però attutito dal generale abbassamento di tono dovuto tanto all’assestamento e ingiallimento provocato dall’affiorare dell’essudato dell’olio che dall’opacizzazione e ingiallimento di un’eventuale vernice. La pulitura seguita dalla verniciatura, nel rimuovere questi strati superficiali, assieme alla saturazione delle tinte e allo scoprimento dei dettagli, determina al contem-po un’accentuazione degli scompensi, anche perché induce un aumento dell’indice di rifrazione – e quindi un’ulteriore traspa-
rentizzazione – nelle stesure corrispondenti ai mezzi toni, i «co-lori terrei, o succhi». Il risultato è l’aumento del contrasto – già esasperato dall’emergere della preparazione scura – e la perdita dei passaggi intermedi più delicati, con l’effetto di figure chiare ritagliate sul fondo troppo scuro».
11 Ad esempio, l’Angelo custode della chiesa di San Lorenzo Maggiore, il Cristo in gloria con la Vergine e San Francesco della chie-sa di San Francesco agli Scarioni, un Sant’Agostino della chiesa di Santa Caterina da Siena, tutti di Francesco De Mura.