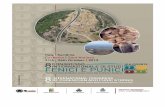I Leoni Fenici di Sulky
-
Upload
beniculturali -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of I Leoni Fenici di Sulky
I LEONI DI SULKY.l’arte : uno strumento di rappresentazione
del pensiero filosofico. da una metodologia applicata sulle opere pittoriche quattro cinquecentesche
per una nuova teoria del restauro, un contributo alla ricollocazione originaria e museale
Roberto Concas
Premessa
D a lunghi anni procedo in uno studio sulle opere pittoriche del Quattro-Cin-quecento con una particolare attenzio-
ne alle soluzioni di rappresentazione artistica impiegate dagli artisti e dissimulate tra forme, colore e racconto. 1
La ricerca, nel solco della semiotica e della psicologia della percezione, si muove tra letture iconografiche, iconologiche, ma principalmente sull’interpretazione della metrica, degli artifici tecnici artistici che conducono lo spettatore lun-go il racconto dell’opera. 2
Nell’obiettivo più generale di una nuova teo-rizzazione del restauro e della musealizzazione la lettura delle opere d’arte è stata condotta con il massimo rigore, cercando di eliminare ogni di-sturbo o condizionamento pregiudiziale, anche solo semantico, peggio ancora se derivante dal cosiddetto immaginario collettivo. 3
La ricerca e l’evidenziazione di sequenze di da-ti oggettivi è finalizzata a proporre nuovi metodi di lettura e interpretazione delle opere d’arte, come detto, nel solco della semiotica dell’arte, della percezione psicologica e nella necessità di superare visioni ormai troppo condizionate da una formazione culturale stratificatasi nel corso del xx secolo ed ancora in questo primo scorcio del duemila. 4
Le nostre letture di opere d’arte, come di altre rappresentazioni artistiche, rimane comunque una lettura “post quem”, con tutto ciò che ne consegue e con le stratificazioni, storico, cultura-li ed interpretative che si sono succedute in que-sti 2.500 anni che ci dividono, nello specifico, dai Leoni di Sulky.
In questi decenni di ricerca, in estrema sintesi, ho trovato le chiavi di lettura per “entrare” nel vero racconto e rappresentazione di un’opera d’arte, come uno spettatore del tempo partecipe della rappresentazione artistica, oltre quello che appare. 5
Tuttavia affinché queste “chiavi di accesso” non diventassero, a loro volta, soggettive e sug-gestive interpretazioni, l’impegno è stato quello di ricercare informazioni e dati, comprovabili dalla regola, per cui il dato scientifico si ottiene, esclusivamente, dall’osservazione e dalla consta-tazione della ripetitività del fenomeno. 6
Il concetto filologico più generale di questa ricerca è riassumibile in uno schema nel quale emerge che l’opera d’arte, altro non è che, uno « strumento di rappresentazione del pensiero fi-losofico » dove l’artista diventa tramite (abile e colto quanto lo si vuole), di una volontà espressa da una committenza.
La sintesi espressa nella successiva formula di-venta esemplificativa :
1 Roberto Concas, anteprima risultati sul retablo di San-t’Eligio Pinacoteca Nazionale Cagliari ; l’« Unione Sarda », « La Nuova Sardegna », « Il Giornale di Sardegna », 11-12- 13 novembre 2007, sito web mibac, 2007-2009.
2 Per analogia vale uno studio analitico di un film, dove si valuta, il racconto, l’espressione ed il coinvolgimento se-mantico, ma anche il montaggio, la scansione ritmica, le inquadrature, la musica, le luci, la sceneggiatura, gli arredi, per scoprire, trucchi, soluzioni di racconto, censure ed ogni altro strumento di rappresentazione impiegato.
3 Un immaginario collettivo dove l’espressione ed il pa-thos della raffigurazione di un santo o di un antico reperto, emozionano lo spettatore, trasmettendoli “valori” che di-ventano “assoluti” e per i quali, solo certe opere, vengono considerate d’arte, oppure il reperto archeologico, antico e originale, perché consunto, ingiuriato dal tempo, somma-riamente realizzato.
4 La nostra formazione culturale e professionale, di stori-ci dell’arte o archeologi, paga il grande impegno di dare alle materie ruolo e dignità scientifica, questo immane lavoro, cui va dato grande merito ai nostri maestri, ha tuttavia la-sciato condizionamenti ed impostazioni di studio, lettura ed interpretazione delle opere d’arte che oggi devono essere necessariamente superate.
5 Entrare nell’opera è il termine più appropriato, in quan-to gli artisti dipingono o scolpiscono, veri e propri “spazi fi-sici” nei quali lo spettatore può idealmente posizionarsi per osservare la scena che viene rappresentata.
6 Ripetitività del fenomeno inteso come ricerca delle so-luzioni tecniche e di rappresentazione ripetute nel fare arti-stico e nei meccanismi di percezione psicologica.
roberto concas2
committenza + artista + società + spettatore+ tecnica della comunicazione artistica =
opera d’arte = strumento dirappresentazione del pensiero filosofico 7
Il metodo di indagine applicato per la ricerca del-le composizioni metriche sui retabli e sulle ope-re del Quattro-Cinquecento, trova, peraltro, un ben più autorevole riferimento in Leonardo da Vinci, che scrive : « Non mi legga chi non è ma-tematico nelli mia principi » (Trattato di Pittura, 1498 c.a). 8
Questo concetto di pensiero matematico è una delle più importanti chiavi di lettura delle opere d’arte, tuttavia è bene precisare che non è stato interesse della ricerca trovare quanto, in gran parte noto, cioè, che esistono metodi come la sezione aurea, la prospettiva, la geometria e la simbologia, ma come questi strumenti sono stati impiegati e sopratutto perché, per quale più profonda ragione, distinguendo queste volontà dal resto dell’impalcato costruttivo derivante da metodi comunemente impiegati. 9
Esistevano negli artisti ma prima ancora nella committenza regole ferree di comunicazione e per queste, strumenti operativi come la sezione aurea o divina proporzione, guidavano la comu-nicazione semantica e semiotica dell’opera d’ar-
te, impiegata quale efficacissimo strumento nella rappresentazione del pensiero politico, teologi-co, filosofico, economico e sociale del tempo.
La metodologia di analisi elaborata sui retabli pittorici quattro-cinquecenteschi, per avere i ne-cessari riscontri di attendibilità ed applicabilità è stata indirizzata in ambito archeologico, e verso i maestosi Leoni di Sulky, 10 anche perché si igno-rava totalmente e rimaneva misteriosa la loro reale funzione. 11
Pertanto sono stato catturato dall’interesse per la civiltà Fenicia 12 che ha fatto della scultura, del-l’architettura, della pittura, della ceramica e dei preziosi monili in oro, uno straordinario mezzo di comunicazione mediatica, per rappresentare il proprio pensiero filosofico. 13
La ricerca viene illustrata in questo articolo, necessariamente e volutamente, scarno di infor-mazioni bibliografiche o di altre citazioni, 14 po-chissime e brevi sono altresì le escursioni storico, filosofiche e stilistiche, e praticamente nessuna specifica volontà di attribuzione o datazione, ma una interpretazione aperta, sostenuta e rigida-mente indirizzata dal rigore della fondatezza dei risultati.
Un percorso di ricerca obbligatoriamente ri-strettissimo, difficile e colmo di insidie, nel quale si incontrano molti “canti di sirene” 15 e dettati
7 Lo strumento di rappresentazione del pensiero filosofi-co, può identificarsi in un’opera d’arte, un’architettura, un canto, un opera lirica, un poema. In contesti di raffronto tra forze opposte, un esercito armato e schierato, rappresenta, con chiarezza, il pensiero filosofico del potere e della società che lo sostiene (= Committenza), mentre i generali e i suoi ufficiali (= Artista e i suoi aiuti) con abilità e tecnica militare distribuiscono le truppe, secondo precisi schemi (= tecnica della comunicazione artistica) definendo i diversi gradi di aggressività potenza, sicurezza, (= semiotica e comunica-zione artistica). Una lettura ed una interpretazione corretta dello schieramento predisposto può avvenire da parte di un altro tecnico militare (storico dell’arte – Archeologo) capace di “decifrare” le tecniche usate, comprese quelle della simu-lazione, del mimetismo, della eventuale contro simulazione. In parallelo lo stesso procedimento di analisi serve per deci-frare un’opera d’arte, con una lettura tecnica e semiotica.
8 Leonardo avverte il lettore del suo trattato di pittura, con un’affermazione, apparentemente paradossale, preci-sando che la matematica, la geometria, la metrica, sono “la chiave” di comprensione di un opera pittorica. Non già o solo i buoni sentimenti, l’iconologia, l’iconografia, le forme e i colori, ma il concetto dell’ordine filosofico matematico, come strumento dotto per rappresentare una cultura, una civiltà, in pittura come in tutte le “Arti” e poi nell’ordine della vita.
9 Questa ricerca mutua le metodologie della metanali-si o più semplicemente impiega la regola aurea, non solo giornalistica, delle cinque domande o sinteticamente delle 5W : Who (Chi ?), What (Cosa ?), When (Quando ?), Where (Dove ?), Why (Perché ?), a cui bisogna aggiungere una sesta domanda (Come ?).
10 Quasi contemporaneamente la stessa metodica è stata
applicata per l’interpretazione del tempio fenicio nominato K dagli archeologi, edificato nell’area di Tharros, con risul-tati altrettanto stupefacenti.
11 Paolo Bernardini, I leoni di Sulci, Sassari, 1988.12 Ritengo doveroso rimarcare, anche in questa sede, il
merito del compianto prof. Ferruccio Barreca, come docen-te e Soprintendente, per aver intuito e sostenuto la rilevanza delle ricerche sulla cultura fenicia in Sardegna.
13 Altri e più autorevoli ricercatori potranno parlare cer-tamente meglio di questa civiltà in termini più completi di quanto non possa fare io che affronto il tema da Storico del-l’Arte che verifica una metodologia di ricerca.
14 Prevale in questa ricerca il risultato e la sua dimostra-zione, essendo praticamente impossibile riassumere o citare gli studi, le metodologie, la infinita bibliografia sulla inter-pretazione di un opera d’arte e sulla comunicazione par-tendo da autorità come Umberto Eco, Cesare Brandi, Gillo Dorfles, Giulio Carlo Argan, Ernst Gombrich e Carlo Lud-ovico Ragghianti. Una nota tuttavia spetta doverosamente all’opera di Gombrich che, controcorrente, ha sostenuto un concetto di rappresentazione artistica legata alla percezione psicologica, un percorso obbligato che pone in giusto rap-porto la sorgente (l’opera d’arte) con il ricevente del mes-saggio, (lo spettatore) dando alla tecnica artistica il ruolo di tramite per la trasmissione del pensiero. Conoscere, quella che oggi chiamiamo psicologia della percezione, ha consen-tito all’artista di impiegare strumenti adeguati, innovativi, capaci di superare la soglia di una percezione distratta per catturare l’attenzione e portare lo spettatore all’interno del racconto rappresentato nel dipinto, nell’architettura o nella scultura.
15 Tra i vari richiami rassicuranti ed accattivanti emergo-no, ad esempio, i numeri e la numerologia, la sezione aurea,
i leoni di sulky 3
dogmatici, evidentemente da non ascoltare, 16 pena la totale perdita dell’orientamento o l’in-gresso in un contesto, infinito, di discussione e teorizzazione senza sostanziali conclusioni.
Il dato oggettivo significa, ad esempio, supe-rare quanto l’opera d’arte ci comunica seman-ticamente, oppure più in generale, cosa ci ram-menta il periodo ed il contesto sociale che l’ha prodotta ; se si parla dei Fenici, oppure del Ro-manico, ovviamente, la nostra mente attinge nei ricordi e nella comunicazione che ci hanno illu-strato studiosi, storici e ricercatori, costruendoci per l’appunto un immaginario collettivo. Questa rappresentazione che la nostra mente elabora, spesso anche in quelle fortemente strutturate dei ricercatori, nei fatti condiziona, indirizza, de-via o blocca, non solo la corretta interpretazione ma anche la stessa visione di un’opera d’arte.
In psicologia si parla di percezione corticale 17 applicabile anche per la lettura di un opera d’ar-te, dove più facilmente si intersecano molti altri messaggi, “subliminali” ?
Come Storici dell’Arte o Archeologi, è nostro compito ricercare condizioni oggettive di inter-pretazione intervenendo con un analisi semio-tica 18 come supporto tecnico per superare una lettura semantica, 19 la simbologia della comuni-cazione artistica, ed altre componenti di “distur-bo” della visione. 20
Per una più completa comprensione, un inte-ressante parallelo, per la lettura ed il metodo di interpretazione, potrebbe venire da questa serie di numeri : 00110001 00110110 00110000 00110000.
Cosa significano ?Per i frequentatori del calcolo informatico è fa-
cile risalire al fatto che si tratta di un cosiddetto “codice binario”, ma poi a seguire, bisogna deco-dificarlo, definire che si tratta di una stringa 21 e ancora che rappresenta un numero : 1600.
Una volta tradotto il “1600” cosa significa ?Il percorso diventa complesso, si fanno ipotesi,
si tratta di un anno, di un periodo storico, di un numero di automezzi, di denaro ?
In pratica una comunicazione in codice bina-rio ci porta verso analisi differenti o comunque ci rallenta (consentendoci di riflettere) invece di elaborare (troppo) velocemente con la mente, quell’immaginario collettivo, che per noi storici dell’arte, il 1600 consiste automaticamente, in un periodo storico caratterizzato dal Barocco, con forme curvilinee, spettacolarizzazioni, ardite prospettive sceniche e poi Caravaggio, Bernini, Borromini. 22
Un percorso di elaborazione che parte dunque e in buona misura, precostituito e “ingabbiato” su precisi schemi 1600 = Barocco.
In realtà perché tale diventi, nella logica della ricerca scientifica, il dato dovrebbe invece ave-re altri oggettivi riscontri, ad esempio un’altra sequenza di numeri binari 01100010 01100001 01110010 01101111 01100011 01100011 01101111 = Ba-rocco.
Viceversa se ipotizziamo di avere un’infor-mazione parziale 23 ad esempio una sequenza 01100010 01100001 01110010, decifrata ci darebbe come risultato : Bar.
la geometria euclidea, le forme simboliche ed i simbolismi, ed altri contesti stilistici, solitamente appaganti, per una co-municazione scientifica, culturale, filosofica, anche colta, ma che nulla o poco avrebbe aggiunto.
16 Non ascoltare non significa non conoscere o non voler capire le ragioni altrui, o ancora non seguire qualche utile suggerimento, ma in questa ricerca come in quella sulle ope-re del 400-500, ha significato seguire coerentemente la propria strada (metodo) senza, ad esempio, le “interferenze di siste-ma” che “impongono”, quasi esclusivamente, ricerche compi-latorie, con ordinamento crono iconografico, iconologico, bi-bliografico, storico, documentario, archivistico, comparativo.
17 La percezione corticale “Protopatica”, carica di conte-nuti emozionali, stimola i recettori verso una sensazione, mentre la percezione “Epicritica” analizza e decodifica un messaggio.
18 La semiotica è una disciplina che studia i fenomeni di significazione e di comunicazione (la significazione è ogni relazione che associa una condizione materialmente esi-stente ad “un qualcosa” di assente. Esempio : se squilla il telefono (condizione materiale) si attiva un processo (condi-zione assente) di comunicazione, derivante da una relazione di significazione : qualcuno ci chiama. Pertanto riconosciamo la suoneria, guardiamo il display, vediamo chi è, valutiamo se rispondere e come rispondere, ci mettiamo in relazione
con l’interlocutore. La semiotica contemporanea si identi-fica nelle opere di Charles Sanders Peirce (1839-1914), Ferdi-nand de Saussure (1857-1913), Roland Barthes (1915-1980) in Italia Umberto Eco con la semiotica interpretativa.
19 Della semantica pongo in evidenza quella componente espressa da F. de Saussure, sul carattere arbitrario del signi-ficato e sul fatto che ogni significato viene definito solo in rapporto ad altri significati nell’ambito di un sistema. Usan-do l’esempio del telefono, lo stesso semplicemente : squilla. Per capire perché squilla è necessario mettere in relazione di significazione il processo di comunicazione, che muove dal-la condizione materiale (telefono) attivando così l’indagine metodologica della semiotica.
20 I disturbi sono le informazioni e le stratificazioni cultu-rali e sociali che non ci consentono di guardare oltre.
21 Stringa è una sequenza di caratteri impiegata nei lin-guaggi di programmazione informatica, composta dai byte con codifiche ascii, Unicode, C. La stringa ha soluzioni di propria rappresentazione per comunicare l’inizio ed il ter-mine della stessa, mentre nel linguaggio Java la stringa non è modificabile, per mantenere sempre l’informazione ori-ginaria.
22 Per un archeologo il 1600 potrebbe, più naturalmente, riferirsi al xvii secolo a.C. ed alle testimonianze del tempo.
23 Informazioni parziali come spesso capita nelle opere d’arte e nei reperti archeologici.
roberto concas4
A questo punto perché, la stringa informazio-ne, diventi Barocco anziché Barcellona, il percor-so necessita di ulteriori informazioni aggiuntive e di riscontri oggettivi anche se l’opera che ve-diamo mostra tutte i riferimenti stilistici di quel periodo.
Ma la stessa opera rappresentava il Barocco o Barcellona in età Barocca ?
Senza andare oltre, questo breve esempio di metodologia, riferita al codice binario, si può obiettare che ricalchi le già applicate regole del-la ricerca scientifica, tuttavia può essere un ul-teriore utile esempio per capire come pensiero, semantica, simbologia, formazione culturale, percezione psicologica, si intreccino offrendoci modelli precostituiti, nei quali troviamo sicurez-za, memoria, “adagiandoci”.
Pertanto l’indagine non dovrebbe arrivare a conclusioni “mediate” solo dalle nostre sovra-strutture culturali, è invece necessario interpre-tare i messaggi senza schemi od ottiche preco-stituite e l’esempio sul codice binario 24 potrebbe essere utile per illustrare le insidie di una ricerca che deve oggi, necessariamente, superare la pre-supposta ovvietà, 25 disarticolando attentamen-te le informazioni 26 per ripartire dalle radici, (il pensiero che muove la rappresentazione artisti-ca) senza per questo uscire da un indispensabile rigore metodologico, verso mete non definite.
I Leoni di Sulky
Gli strumenti utilizzati per questa ricerca sono molteplici, alcuni sono semplici da indicare come, una squadra, un metro, un compasso ed un filo a piombo, altri sono tecnologicamente più avanzati e sofisticati, come l’elaborazione di-gitale della computer graphic e del cad, sostenu-ti da un percorso di studio, di approfondimenti, di letture, lungo almeno tre decenni.
Per ottenere i risultati è necessaria molta umil-tà, la capacità di osservazione, il rispetto e l’at-tenzione per capire, in un opera d’arte, quello che in realtà esiste, ci condiziona nella visione, ma non si vede o non si decifra facilmente, quei messaggi e quelle simbologie forse familiari per la gente del tempo, ma per noi non più comuni o la cui lettura viene fortemente “disturbata” da approcci di visone non corretti, o più semplice-mente deviati dalle nostre sovrastrutture cultu-rali e dalle metodologie di studio dell’archeolo-gia e dell’arte ormai obbligatoriamente datate.
Nelle opere d’arte ed architettoniche, anche se talvolta sono molto complesse da estrapolare, esistono scansioni metriche e segnali posturali, cromatici o virtuali 27 rivolti allo spettatore, 28 con funzione di richiamo dell’attenzione, (guar-da qua) di direzionalità, (sposta la visione verso) di sosta, (guarda, fermati per un certo tempo e rifletti sull’insegnamento) proposti tra segni, cromie e forme più o meno palesi, linee costrut-tive, armonie compositive.
Nelle sculture e nei dipinti i segnali, rivolti al-lo spettatore, di richiamo, direzionalità e sosta per la visione dell’opera, sono dissimulate nella composizione metrica, nelle cromie e principal-mente nelle posture delle figure raffigurate.
In architettura le lunghe fughe ottiche dei tempi greci, venivano “corrette” curvando i ba-
24 Il Codice Binario, come tutti i codici, necessita di un decodificatore, senza il quale la comunicazione tra due sog-getti diversi non può avvenire, basta pensare oggi ai codici, semplici e molto diffusi, che vengono usati negli sms : tvb, ta. Questi messaggi devono essere tradotti e ricondotti al loro originario significato : ti voglio bene, ti amo, etc. Ma se sbagliamo contesto, periodo storico, tvb potrebbe significa-re : terribile virus batteriologico, ta, trattamento antibatte-rico, ancora con una lettura romantica, tvb tenera virtuosa bellezza. Immaginiamo il tutto con quale risultato.
25 Insegnamenti e metodi di ricerca applicati più diffusa-mente.
26 Il codice binario è, di fatto, una sostanziale disartico-lazione di una informazione (leggasi : rappresentazione ar-tistica) che per essere veicolata più facilmente viene trasfor-mata come sequenza numerica composta da 0-1 che forma una stringa che verrà elaborata da un sistema informatico (leggasi : opera d’arte) per rappresentarla al fruitore (leg-gasi spettatore davanti all’opera d’arte). La stringa diventa
pertanto la traccia più interessante di identificazione della originaria informazione e non già il computer “semplice” terminale.
27 Virtuali perché, quasi sempre, non appaiono con se-gni o disegni che è possibile indagare con strumenti della diagnostica artistica, ma come vedremmo sono volontà e strutture che si manifestano nella pienezza della comunica-zione artistica dell’opera d’arte.
28 Lo spettatore, il pubblico è, in assoluto, la chiave di in-terpretazione più rilevante in questa ricerca ed in quella sui retabli pittorici, sull’argomento oltre all’intera bibliografia di E. Gombrich, richiamerei l’attenzione sull’Enciclopedia di Storia dell’Arte Italiana di Einaudi editore del 1979, in par-ticolare il secondo volume “l’Artista e il Pubblico” nel quale, esattamente 30 anni fa, possiamo rileggere un dibattito cul-turale che esprimeva valori e valutazioni di altissima levatu-ra, ma credo purtroppo, mi sia consentito alla luce anche di questo lavoro, solo parzialmente ascoltate e seguite a favore di altre e più “appaganti” percorsi di ricerca.
i leoni di sulky 5
samenti, oppure nelle basiliche paleocristiane, allargando la pianta in prossimità dell’abside per avvicinare idealmente il fedele all’altare.
Inoltre per poter meglio interpretare un’opera d’arte, è di fondamentale importanza individua-re quale rappresentazione del pensiero filosofi-co, quale contesto religioso, politico, filosofico, economico, propone la stessa opera d’arte, in mancanza è necessario attenersi maggiormente ai dati ed alle informazioni oggettivamente ri-scontrabili direttamente nell’opera.
Per avere ulteriori riscontri di questo metodo di indagine sulle opere rinascimentali, l’obietti-vo è stato, non senza qualche timore, quello di spostare l’attenzione e l’applicazione verso ope-re d’arte e di architettura distanti per epoca e per cultura. Non si tratta di un cosiddetto “salto nel vuoto”, anche perché, come detto, esiste un’am-pia letteratura e documentazione sulle costru-zioni metriche e simboliche delle opere d’arte. 29
Per la ricerca e l’interpretazione di questi, se-gnali, segni e metodi simbolico costruttivi « mi-steriosi e nascosti » 30 i “Leoni di Sulky” per la lo-ro non svelata funzione, si manifestavano come un’affascinante occasione e, tali si sono rivelati dando un ottima condizione di controprova po-sitiva per l’innovativo metodo di indagine (Ta-vola 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f).
I Fenici e l’archeologia, come storico dell’ar-te, non sono certo il mio campo di studio, chie-do pertanto venia ai miei colleghi ed amici ar-cheologi per questa “intrusione”, e date le non profonde conoscenze archeologiche ho cercato di supplire con la metodologia, sia nell’indivi-duazione della soluzione stilistico-compositiva che tecnico-costruttiva, rifacendomi, per queste ultime, a quanto osservato nei restauri architet-
tonici nel corso degli anni nell’attività svolta, af-fianco a colleghi architetti ed ingegneri, alla So-printendenza ai Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici di Cagliari.
Ho saputo dei Leoni di Sulky in occasione della mostra internazionale sui Fenici allestita a Venezia nel 1988 a Palazzo Grassi ; 31 a distanza di anni ho potuto rivederli ed osservarli attenta-mente e molto da vicino. La sensazione è stata forte, forse perché mossa da una conoscenza meno superficiale che in passato, forse perché il contatto ravvicinato sollecita un interesse mag-giore di conoscenza.
Stupendi, mi si consenta un linguaggio molto personale, ma sono maestosi e realizzati con una tecnica scultorea raffinata, anche se sostanzial-mente trascurati dagli stessi studiosi e dal pub-blico. 32
Ho chiesto ala collega della Soprintendenza ai Beni Archeologici, Carlo Tronchetti, dove fosse-ro stati ritrovati, in che posizione, in che sito, a cosa erano destinati, da dove venivano e persino il nome dell’artista. Tronchetti, con molta cor-tesia e dopo qualche informazione, insieme ad alcuni “non si sa”, tipici della prudenza degli ar-cheologici, mi ha invitato a leggere e “studiare” quanto altri avevano scritto sui leoni, primi fra tutti Paolo Bernardini e Piero Bartoloni.
Ho letto avidamente tutto quello che era pos-sibile di pertinente. Bernardini 33 nel suo testo offre un’inquadratura complessiva e di ampio respiro sulla collocazione storica, sulle tipologie stilistiche di confronto che attestano alla metà del vi sec. a.C. i due leoni.
Questo onere, di attribuzione storico e stilisti-ca, lo lascio comunque volentieri agli archeologi, ai quali, tuttavia, offro i risultati di questa ricerca,
29 Sarebbe lungo riportare le teorie ed i riscontri geome-trico-matematici applicati al mondo dell’arte. Per stare nel-l’ambito storico a cui ci riferiamo, già a partire dal vii sec. a.C., i greci definirono gli ordini architettonici ed i principali tipi di scultura come il Kùros, con il peso equamente diviso tra le due gambe, ed ancora le ceramiche idealmente rac-chiuse in un quadrato con rapporto 1 :1 oppure in un rettan-golo con rapporto 1 :618. Policleto nel 450 a.C. supportò la sua scultura del doriforo con un saggio teorico, dove enuncia il tema della classicità, illustra il rapporto ideale nella figura umana con la testa che deve risultare 1/8 dell’altezza e teo-rizza che la distanza da terra dell’ombelico corrisponde alla sezione aurea. Armonia, geometria, rapporti, matematica, proporzioni sono, nella conoscenza del nostro anonimo autore dei leoni di Sulci, un percorso artistico connaturato nell’uomo, teorizzato e magnificato da autorevoli filosofi ed artisti come Leonardo, che nel suo Trattato della pittura iniziò con una frase significativa : Non mi legga chi non è mate-matico nelli mia principi.
30 Le virgolette evidenziano il fatto che con questo me-todo di ricerca, questi segni e le formule impiegate, comun-
que così nascosti e misteriosi non sono, anche se non sono altrettanto semplici da individuare, principalmente in termi-ni certi e riscontrabili da tutti.
31 Vedere Catalogo Mostra a Palazzo Grassi, Venezia, I Fenici, Milano, 1988.
32 La mancata o modesta attenzione verso i leoni di Sulky potrebbe avere una ragione filologica e culturale mol-to profonda, che trova spiegazione anche in questa ricerca, e che affonda le proprie radici negli insegnamenti e nelle metodologie di letture del patrimonio culturale ricevuti nel corso del xx secolo. L’antico, l’archeologico, specie nella nostra isola, è tale ed è “veramente antico” se “rustico”, ro-vinato, sbozzato, scrostato, ingiuriato dal tempo ; viceversa un’opera levigata, un monumento “perfetto”, progettato e realizzato con abile maestria e pensiero filosofico, come il pozzo di Santa Cristina di Paulilatino (Or), o gli stessi leoni di Sulky, non rientrano facilmente in questo immaginario collettivo, anzi, talvolta, vengono visti con forte sospetto di autenticità.
33 Paolo Bernardini, I leoni di Sulci, Sassari, 1988.
roberto concas6
stimolata anche da una domanda, sino ad ora, ri-masta insoddisfatta : dove, e principalmente, co-me dovevano essere disposti in origine i leoni ?
La domanda viene sollecitata ed indirizzata anche dalla osservazione dell’inconsueto profilo posto nella cornice posteriore del riquadro che sormonta su tre lati i leoni ; scolpita con cura, la cornice appare come le classiche composizioni geometriche che prevedono la cosiddetta com-penetrazione dei solidi. Un pilastro romboidale che si innesta su corpo quadrangolare, forma complicata in alto, da una incisione profonda della pietra che disegna un angolo.
Ai leoni sono state date funzioni diverse, di portale con cardini incernierati proprio nelle profonde scanalature, oppure di grandi braccioli di un altrettanto imponente trono o ancora di leoni eletti a ruolo di guardiani di un’area forti-ficata.
Sono ipotesi molto suggestive, sostenute con cautela dagli stessi autori, ma soprattutto non suffragate da prove certe.
In generale l’informazione scientifica è restia ad affermazioni su funzioni, uso dei reperti, dei manufatti e delle strutture architettoniche, il rigore scientifico deve giustamente prevalere e quelli che valgono sono i fatti comprovati o comprovabili, perciò a questo cercherò corretta-mente di attenermi.
I leoni, scolpiti in trachite bianca locale, so-no stati ritrovati nello scavo archeologico, posti l’uno di fianco all’altro, ad una distanza di 2.80 metri con alle spalle un muro bugnato, distante dai leoni 40 cm. in un area edificata in età repub-blicana tra il iii ed il ii sec. a.C. 34
Una sistemazione successiva alla realizzazione scultorea dei leoni che poco ci racconta sulla lo-ro originaria collocazione e posizione, e che tut-tavia ci fornisce un dato interessante, quasi ecla-tante, i romani, già al tempo non avevano capito come “funzionavano” i due leoni di Sulky.
All’avvio di questa ricerca, come unico dato di fatto, i due leoni e la loro particolare forma di incorniciatura posteriore ; da questo ed esclu-sivamente da questo si deve partire, per capire almeno come dovevano essere posizionati origi-nariamente.
L’applicazione metodologica richiede, neces-sariamente, di partire dalla lettura analitica del-l’opera, senza altri influenzamenti, riferimenti a tracce stilistiche, epoche od altro riconducibile
ai classici metodi di indagine per comparazio-ne con opere coeve, ante o post quem. Valgono come primissimo elemento le misure, e non già od esclusivamente quelle riferibili al rilievo del-l’opera, ma le misure originariamente impiegate per la metrica costruttiva e filologica dell’opera d’arte. 35
Sono infatti le misure “interne” che è necessa-rio individuare per capire l’opera d’arte o l’archi-tettura, è spesso sono tutt’altro che semplici da individuare in quanto risultano confuse con altri schemi costruttivi, oppure mimetizzate o nasco-ste dal sovrapporsi di pensieri filosofici, espressi con forme, simboli, metrica e semiotica.
La funzione statica strutturale
I due leoni parallelamente disposti sono una for-te tentazione ; rappresentano una condizione di maestosità, di potenza, di forza, incutono timo-re, reverenza, sono i guardiani per antonomasia, così devono averli interpretati anche i romani quando li hanno posizionati sul fronte dell’are-na.
Osservando le due sculture si riscontra che i leoni sono raffigurati nella stessa posizione e non già contrapposti come logica farebbe supporre. Zampa sinistra avanzata, coda ritorta lungo il posteriore sinistro accovacciato, zampa destra perpendicolare all’architrave sormontante, in sintesi una copia esatta (Tavola 2, 2a, 2b).
L’iconografia più diffusa dei leoni ci riporta fi-gure con una postura che privilegia un’azione di movimento con zampe protratte in avanti, non solo ; anche in caso di figure umane o zoomorfe parallelamente disposte, prevale una tipologia di copie ripetute ; una tradizione che trova radici e riscontri nell’antico Egitto.
Quanto detto può confermare l’ipotetica po-sizione frontale e parallela dei due leoni, una posizione che tuttavia non soddisfa appieno, principalmente per la già citata forma dell’incor-niciatura posteriore, che non trova giustificazio-ne corretta con un inserimento perpendicolare in una muratura (Tavola 3, 3a).
Che funzione infatti avrebbe avuto questa cor-nice ?
Non certo di sostegno intersecante di una mu-ratura perché, la stessa, si sarebbe interrotta ver-ticalmente nell’incatenatura, perdendo irrime-diabilmente in staticità e tenuta.
34 Ivi, p. 39.35 Un pentagramma musicale (dal greco penta, cinque
e gramma, linea) può essere utile per illustrare metaforica-mente la metodica, dove il pentagramma è il supporto (in-
gombro o misure complessive dell’opera d’arte compreso il suo supporto, la cornice) mentre le note costituiscono la vera opera d’arte, e con la loro misura, metrica e scansione, è possibile capire e reinterpretare l’opera.
i leoni di sulky 7
Non è peraltro ipotizzabile una posizione dei leoni staccati dal muro, come pure sono stati tro-vati ; la mancanza di rifiniture del parallelepipe-do retrostante sembra escludere tale possibilità ; la pietra risulta, anche in altre parti, come quella superiore architravata della cornice e nello stes-so toro del basamento, decisamente meno rifini-ta del resto della scultura.
Non rimane, di nuovo, che ripartire dalla for-ma e dalla incisione ad angolo retto sull’architra-ve che offre un suggerimento di non semplice interpretazione, ma risolutivo.
Partiamo con l’osservazione più attenta della forma complessiva del leone inquadrato e com-preso, su tre lati, da elementi, definibili architet-tonici, che svolgono una funzione di statica, nel sostegno a terra, con il toro sormontato da listel-li e gola egizia, nel robusto pilastro e nella spessa architrave.
L’inquadratura massiccia e la postura dello stesso leone, suggerisce un’ipotesi costruttiva che prevede i leoni sormontati da un elemento decorativo o architettonico con funzione di con-trafforte per l’elevato, una forma od una figura antropomorfa di una divinità o zoomorfa, che avanza con una postura non dissimile da quella degli stessi leoni e da altre riconducibili alla pro-duzione fenicia. 36
La possibilità e sostenibilità di questa ipotesi viene confermata dalla possente struttura por-tante che incornicia i leoni e dalla postura degli stessi, con il robusto insieme di collo e testa, la zampa sinistra avanzata che giustifica, con l’incli-nazione, l’iconografia complessiva di una figura che sopporta le forze di scarica pseudo-dinamica che proverrebbero da una possibile forma sovra-stante, mentre il carico ortostatico verrebbe inve-ce sorretto dalla zampa di destra, scolpita dritta e quasi perpendicolare alla robusta architrave.
La postura dei leoni con la zampa sinistra avan-zata, evidenzia dunque una sua funzione archi-tettonica di scarica di pesi strutturali sovrastanti, una prova immediata viene con una misurazio-ne, con la quale si evince che le dimensioni delle due zampe anteriori assommate corrispondono, sostanzialmente, alle dimensioni del pilastro po-steriore.
Le due zampe anteriori hanno quindi la possi-bilità di sorreggere un peso, una struttura, identi-ca al pilastro nel quale si incastra posteriormente il leone, gli architetti e scultori fenici sviluppano, con grande abilità, un concetto di alleggerimen-to degli elementi portanti, senza inficiarne la so-lidità 37 (Tavola 4, 4a, 4b, 4c).
Il riscontro metrico puntuale dimostra così che esiste la volontà di dare funzione di sostegno e portata architettonica ai leoni ad alla cornice che li sormonta.
Questa ulteriore scoperta ha spinto l’attenzio-ne verso la lettura più complessiva della fase rea-lizzativa delle sculture.
Con una lettura attenta è risultata più chiara la funzione statica della robusta cornice che rac-chiude il pilastro e l’architrave sagomato, mentre la composizione scultorea e raffigurativa del leo-ne, racchiusa dalle cornici, risulta di dimensioni più ridotte, è riconducibile ad un quadrato di cir-ca cm 136 x 136, una forma ideale che racchiude il “racconto figurativo” (Tavola 5).
Proseguendo nella lettura e nella disarticola-zione delle informazioni costruttive dei leoni, emerge con chiarezza geometrica anche la co-struzione della figura dei leoni : l’imponente e maestoso busto dei leoni si scopre che è stato “costruito” con due cerchi, quasi concentrici, 38 che segnano il dorso ed il ventre degli animali (Tavola 6).
Tralasciando per adesso altre valutazioni sti-listiche e procedendo con un’analisi sistematica dell’insieme architettonico-scultoreo, il dato as-soluto riguarda l’uso di una geometria costrutti-va, certamente anche simbolica come vedremo in seguito, impiegata dallo scultore, 39 e che con-ferma la distinzione di funzione tra la compo-nente zoomorfa della scultura e quella architet-tonica.
Proseguendo si osserva che la scanalatura a forma di V, scolpita sulla sommità architrave, con una profondità di circa 8-10 cm, rispetta inve-ce la forma dell’angolo retto, 40 riscontrabile con la classica squadra da muratore (Tavola 7, 7a).
Sottostante all’incisione, in una osservazione dall’alto, si percepisce meglio la forma a pilastro che sorregge l’architrave sovrastante il leone,
36 Vedi l’altorilievo egittizzante raffigurante Asarte di Sulci, presso il Museo Archeologico di Cagliari.
37 Per vedere soluzioni così ardite dobbiamo attendere la scoperta gli archi rampanti, delle guglie gotiche e poi, nel-l’era proto industriale, il ferro forato per alleggerirne il peso senza inficiarne la resistenza.
38 Nella ricostruzione emerge un leggero disassamento del punto in cui viene centrato il compasso.
39 Lo scalpellino o lo scultore che, più ragionevolmente,
esegue un opera che ha una sicura, forte e curata progettua-lità voluta da una committenza altrettanto forte.
40 È interessante notare come dalla visione diretta ed anche dal modello e dalle fotografie, la nostra percezione visiva ci restituisca un solco a forma di V, mentre nei fatti si tratta di un solco ad L scolpito ad angolo retto ma orientato diagonalmente. Questa osservazione conferma, ancora una volta, la nostra “difficoltà” per una corretta valutazione di quanto percepiamo.
roberto concas8
seppure la stessa architrave appare, in qualche misura, inficiata nella sua funzione statica, pro-prio dai profondi solchi.
Ipotizziamo pertanto che la cornice sia dav-vero un pilastro e riprendendo dall’angolatura a 90 gradi, già descritta, se assumiamo questo dato come valore assoluto ed ipotizziamo una possibile collocazione delle due sculture, quasi istintivamente, si ricava una posizione dei leo-ni ai vertici di una possibile forma quadrango-lare e, comunque, con vertice ad angolo retto, un’ipotesi forse non lontana dalla realtà ma da suffragare con prove nel proseguo della descri-zione.
Tuttavia stabilita ed accettata, filologicamente, la posizione ai vertici come valida, la ricerca si è rivolta alle motivazioni ed alle soluzioni tecniche utilizzate per soddisfare questa possibile posizio-ne dei leoni nella struttura muraria.
La domanda a questo punto è : come si inseri-scono i leoni nell’angolo della muratura ?
Per dare una possibile e realistica risposta la ricerca si è indirizzata verso i conci della muratu-ra e verso il sistema di incatenamento d’angolo degli stessi.
Il problema da risolvere è duplice e si pone tra le necessità di mantenere la statica dell’ipotetico edificio e la necessità di inglobare strutturalmen-te i due leoni incorniciati.
L’angolo è il punto più delicato di qualsiasi struttura architettonica, sostiene e regge le spin-te delle fughe ed i cosiddetti venti delle muratu-re, irrigidisce la struttura e diventa punto d’ap-poggio e scarica per le coperture e i solai.
L’incastro “a pettine” dei conci, nell’angolo di una muratura, svolge una funzione statica di grande importanza che ben conoscono gli archi-tetti od i “maestri di muro”, una funzione nota anche ai costruttori fenici e ancora prima a quelli egizi, nonché ai nostri antenati nuragici.
Non legare adeguatamente la muratura signi-ficava crollo certo della struttura, come risolvere questo fondante problema costruttivo ?
La chiave della soluzione si trova, come spesso accade, sotto i nostri occhi, e precisamente nella inconsueta struttura rombo-rettangolare del pi-lastro che incornicia posteriormente il leone.
Osservando attentamente 41 si intuisce una funzione del listello posteriore a forma rettan-golare, la stessa particolare forma, somiglia ad un sistema ad incastro, 42 ed anche di quelli ro-
busti ; forma molto simile a quella che trovia-mo attualmente nelle strutture cosiddette auto portanti, con montanti incisi con apposite sca-nalature “femmina” nelle quali scorre una trave “maschio” od un semplice reggi mensola ade-guatamente sagomato. 43
Nei leoni le condizioni sono leggermente di-verse e non è ipotizzabile lo stesso meccanismo di innesto, a scivolamento, per una ragione prin-cipalmente di peso e manovrabilità. Lo spirito rimane tuttavia lo stesso, per questo indagando ulteriormente, risalendo alle misure ed alle pro-porzioni, si manifesta una soluzione che rispon-de alle nostre domande e che sostiene una ipote-si plausibile e comprovabile.
Nel tracciare una costruzione, come d’obbli-go, partiamo dagli angoli per trovare l’allinea-mento delle murature ; l’architetto traccia le linee, ricerca l’angolo corretto, cioè a squadra, stabilisce le quote e le livella, posiziona il filo a piombo. Sono azioni dovute per la staticità del edificio e trovano, nello spigolo e nell’angolo, il punto di riferimento geometrico architettonico più importante.
Nel nostro caso questa funzione di spigolo e di incatenamento della struttura muraria, viene as-solta proprio dai due leoni e l’attenzione ricade inevitabilmente alla sagoma della cornice poste-riore che diventa robusta e, insieme dissimulata, ammorsatura d’angolo della muratura.
Per ottenere un perfetto meccanismo di lega-tura della muratura l’architetto fenicio ha pro-gettato e realizzato un imprevedibile concio sagomato, (Tavola 8) che si incastra nelle mo-danature chiudendo staticamente e struttural-mente le pareti dell’edificio (Tavola 9).
Una soluzione tecnicamente ardita, quanto straordinaria, risolve la statica dell’edificio, la portata dei pesi e l’incatenamento della muratu-ra, una soluzione strutturale che sarebbe stata, anche questa, più naturale con l’avvento del ce-mento armato.
La rappresentazione dello spazio architetto-nico che si manifesta, allo spettatore, diventa straordinaria, maestosa, mentre l’insieme diven-ta estremamente ingegnoso e ricercato.
I progettisti fenici calcolarono con attenzione il sistema di incastro e le forze di carico dei pesi, ma forse ancora maggiore fu l’impegno stilisti-co e principalmente filologico, rappresentando la potente e, già allora, secolare simbologia dei
41 Dopo aver tolta la comunicazione scultorea zoomor-fa del leone ed individuata le funzioni di architettura della cornice.
42 Il sistema di incastro è intuibile nella forma a sezione
rettangolare, a sviluppo verticale che mantiene la sagoma-tura sino ai due apici senza interruzione.
43 Strutture esistenti negli scaffali metallici ed in quelle dei piloni in cemento armato impiegate per strade e ponti.
i leoni di sulky 9
leoni, come metafora portante della stessa archi-tettura. 44
La forza e la simbologia dei leoni, l’abilità co-struttiva architettonica, per rappresentare il pen-siero filosofico di una civiltà che si accingeva a fondare ed urbanizzare Sulky ed altri centri della Sardegna. Nelle popolazioni locali e negli stessi uomini conquistatori fenici, non dovevano sor-gere dubbi circa la potenza, l’abilità, la maestria, la determinazione della dominazione fenicia nel Mediterraneo, per questo, ogni strumento di rap-presentazione, l’arte, la scultura, l’architettura, l’abbigliamento, i gioielli, doveva essere realizza-to con la massima attenzione e nel rispetto delle volontà più generali dei governanti fenici. 45
L’affascinante soluzione scultorea, architetto-nica e stilistica svela la “misteriosa” funzione dei due leoni di Sulky, posti “imperiosamente” agli angoli di una muratura e di una architettura da definire.
La ricerca a questo punto dal dato certo si in-dirizza verso altre valutazioni e metodiche per ipotizzare le possibili soluzioni architettoniche, la linea dell’edificio e, se possibile, la destinazio-ne d’uso.
La metodologia dello studio comparativo vie-ne tuttavia indirizzata da un’altra ipotesi affasci-nante è possibile che l’edificio contenesse quat-tro leoni ?
Esistono rari esempi di architetture con i leoni o figure inseriti negli spigoli della muratura ; il mausoleo punico-ellenistico dedicato a Bes (Sa-bratha, Az Zawiyah in Libia) del ii sec. a.C., di cui S. Moscati nel volume sui Fenici della mostra a palazzo Grassi ne presenta anche una ipotetica ricostruzione (Tavola 10, 10a, 10b).
Altro riferimento il mausoleo punico-libico di Dougga in Tunisia, iii-ii sec. a.C. ; il monumento
funerario di Amrit, del iii sec. a.C., riproposto nella ricostruzione da E. Renan 46 (Tavola 11).
Un’annotazione a parte merita il mausoleo pu-nico ellenistico di Bes, ampiamente ricostruito nel 1920, presenta una fortissima analogia stilisti-ca, che tuttavia deve essere valutata con maggio-re attenzione. 47 I Leoni di Sulky rimangono co-munque “concettualmente” molto più avanzati 48 rispetto a quelle del mausoleo di Bes, che presen-tano una postura delle zampe, perpendicolari ed affiancate, il busto molto più rigido, ed ancora per il basamento privo del toro e della gola egizia.
Proseguendo nel percorso di analisi, qualora tenessimo valida l’ipotesi del tempio a spillo o a torre, in questo complesso sistema una misu-ra pari ad una sezione aurea del leone, secondo la seguente formula (136/0.618=220) ci offre una misura di 220 cm, che può ragionevolmente di-ventare il lato della muratura o con la successi-va misura di sezione aurea di 356 cm l’altezza, con un ipotesi ricostruttiva, che mantiene, come unica prova sostenibile, la struttura portante dei leoni e dell’incorniciatura descritta, ma che non ci è dato di poter supportare con altre prove in situ, se non quelle, in questa condizione oppor-tuna, della logica e della comparazione. 49
Capacità tecnica e filosofia, certamente gran-dissima abilità, tuttavia senza spostarci dallo stretto ragionamento, in questa fase è utile com-pletare le informazioni tecniche ed evidenziare che il concio di muratura potrebbe essere ricon-dotto alle dimensioni totali di cm 44 x 68 x 44 di altezza, una misura numericamente interessante nei riscontri modulari dell’architettura in genere ed anche in quella fenicia. 50
Il concio veniva scalpellato per ricavare un in-castro secondo il modello disegnato di cm 17 x 11 x 22 x 44, 51 che riportava fronti di contatto dalle
44 Si potrebbe a lungo disquisire, sia per gli aspetti tecnici architettonici adottati che, sul più profondo significato filo-sofico di questa precisa volontà di rappresentazione segnica e simbolica : la potenza, la forza, la virilità, l’impenetrabilità, la difesa, il monito ed ancora molti altri contenuti che po-tranno essere materia per altri e più specializzati studi.
45 La rappresentazione del pensiero filosofico del tempo, o meglio le tecniche artistiche di rappresentazione, costitui-sce quid dell’intera ricerca, tuttavia il discorso in queste sede si espanderebbe oltre misura e quindi l’evidenza della sco-perta è più che sufficiente per dimostrare la tesi.
46 cfr. op. cit. p. 49, 150.47 Deve essere svolta un’indagine sulla metrica, sulla cor-
nice, sull’eventuale sistema di aggancio alla muratura, per un riscontro oggettivo delle condizioni di parallelismo e raf-fronto stilistico.
48 La definizione di “concettualmente più avanzati” per i Leoni di Sulky non va correlata con la datazione, (per questo posteriori o precedenti) la valutazione è di tipo semantico, dalla quale tuttavia emerge, per i leoni di Sant’Antioco, una interpretazione, molto più evoluta e sofisticata, di rappre-
sentazione del pensiero filosofico, mentre per il monumen-to di Sabratha si può parlare di un intervento di “maniera”, di qualità (leggasi di pensiero) decisamente minore.
49 Piero Bartoloni dopo aver esaminato le proposte di questo lavoro, dall’alto delle sue conoscenze, sostiene e, ci si augura farà oggetto di altra pubblicazione, una soluzione che data i leoni nel momento di massima espansione dei Fe-nici nel Mediterraneo. Questa osservazione di Bartoloni che non concorda con la soluzione del tempio a spillo, nei fatti, rafforza la metodologia fin qui impiegata perché dimostra, ancora una volta, i rischi di un’applicazione del metodo di comparazione stilistica, anche laddove appare credibilmen-te sostenibile e ragionevolmente comprovabile.
50 È una misura comune riscontrabile in centri come Tharros e lo stesso S. Antioco, una misura che consente una manovrabilità ed una modularità del concio, soprattutto di quei conci corti necessari per il pettine della muratura, ri-conducibili a 35 cm circa nel lato orizzontale, una misura che offre la giusta robustezza e scansione.
51 Interessanti le ultime tre misure di 11, 22, 44, che diven-tano multiple di sé stesse, una condizione da non trascurare,
roberto concas10
dimensioni riferibili a conci normali non sago-mati, fermo alcuni millimetri di gioco necessa-rio, sono misure accostabili con quelle del lato del listello rettangolare posteriore, (cm 44 x 17 x 156,5).
Squadrare il concio e prepararvi degli incastri non era certo un problema per gli abili scalpel-lini fenici o isolani ; la difficoltà, sempre che tale possa realmente definirsi, è stata nel concepire il perfetto meccanismo di incastro. La struttura muraria con questo sistema viene perfettamente concatenata e il concio non dimostra, malgrado il dentello profondo nel lato più lungo 22 cm, al-cun punto di debolezza strutturale.
Le spinte laterali vengono sopportate dalle facciate più lunghe del concio sagomato, a e d, di 22 cm, coadiuvate dalle facciate B di 11 cm e C di 17 cm (Tavola 10).
Il concio incastrato nella muratura ha una pos-sibilità di movimento limitato, mentre le forze scaricano sulle facciate più lunghe evitando il ri-schio di incrinatura della pietra e di rottura con la classica forma dello spicchio. 52
Interessante nella ricostruzione risulta essere la vista interna dell’edificio, l’angolo della mura-tura si identifica come un normale angolo retto, con i conci a filo che occludono totalmente il li-stello della cornice posteriore del leone. 53
L’attenzione e la cura per la finitura architetto-nica, non fine a se stessa ma come rappresenta-zione simbolica e significante del credo sociale, politico religioso e culturale in genere, spinge l’architetto fenicio verso un dettaglio, tecnico stilistico e rappresentativo, molto raffinato.
Come ulteriore annotazione è interessante evidenziare che nel ricostruire il modello di in-castro si è riscontrato che il basamento dei leoni presentava, su lati, una leggera smussatura, ap-parentemente insignificante o casuale, ma che in realtà aveva la funzione, come detto, di favorire l’angolo di attacco con il primo concio della mu-ratura, modanato. (Tavola 11).
La struttura architettonica acquista in questo modo continuità stilistica, ideale robustezza, nonché cesura metrica che consente di recupe-rare, anche nella muratura, una scansione ideale segnata da un torello.
Nel complesso il risultato è quello di un inge-gnoso e colto meccanismo geometrico architet-tonico, un incastro perfetto ed abilmente dissi-mulato, in linea con l’impostazione altamente scenografica che i leoni aggettanti verso l’ester-no, sugli spigoli, offrono allo spettatore.
Sembra chiaramente trasparire la volontà di stupire : i leoni e forse anche la eventuale figura antropomorfa sovrastante 54 invadono lo spazio, spezzano le linee, moltiplicano l’impatto visivo dell’insieme della struttura architettonica (Ta-vola 14, 14a, 14b, 14c, 14d).
Completa e supporta ulteriormente la tesi, l’incastro scolpito con una incisione ad L prima descritto, scolpito sulla sommità tra la cornice pilastro e l’architrave, questa singolare sagoma-tura consente di incastrare architettonicamente e strutturalmente, il pilastro di elevazione supe-riore della composizione architettonico- monu-mentale, sempre con un meccanismo (maschio-femmina) estremamente robusto e funzionale al mantenimento dell’allineamento verticale (Ta-vola 15, 15a, 15b).
In pratica un pilastro, identico a quello nel quale si incornicia il leone, trova appoggio ed in-castro perfetto tra la scanalatura ed i conci supe-riori, incatenandosi, ancora una volta con i con-ci seguendo il filo dello spigolo della muratura compenetrata con i leoni.
La tesi e la dimostrazione non possono anda-re oltre o perlomeno personalmente ritengo la comunicazione scientifica di questa componente costruttiva qui conclusa e riassumibile nell’inte-ressante soluzione di incastro, leoni con muratu-ra, con il primo giro dei conci modanati.
per gli amanti dei numeri e di quanto “misteriosamente” e simbolicamente ruota loro intorno, una condizione più alla portata dello scalpellino che metteva così a memoria più fa-cilmente la sequenza delle misure.
52 Se si avesse riscontro sul tipo di pietra impiegata, non sarebbe difficile calcolare con precisione la resistenza alla spinta ed alla rottura del concio, nonché i punti di maggiore debolezza. Calcoli sommari con un ipotetico calcare locale, hanno e possono comunque dimostrare la buona se non ot-tima tenuta del concio sagomato.
53 Non ci è dato di sapere se l’ambiente fosse intonacato o meno, in questo secondo caso possiamo anche immagi-nare quale stupore potesse suscitare questo tipo di mura-
tura d’angolo, che alla vista dei meno esperti o forse anche degli esperti, appariva non legata, anzi inficiata dall’innesto dei leoni. Anche all’interno la vista della muratura doveva apparire con due linee di conci affiancati ma non legati a pettine, quindi apparentemente liberi e contro ogni regola costruttiva.
54 Questa annotazione non ha purtroppo riscontri se non nello sviluppo di un ragionamento, tuttavia non privo di condizioni preliminari di comprovabilità visti i riferimenti al tempio a spillo di S. Moscati.
55 Rudolf Wittkower, La scultura dall’antichità al Nove-cento, Einaudi 1985. Le osservazioni di Wittkower segnano un metodo di indagine ma anche i limiti nelle vedute e nella comprensione reale e completa delle stesse.
i leoni di sulky 11
La costruzione stilistica
Individuata la straordinaria soluzione scultorea e architettonica, l’attenzione si sposta verso la lettura stilistica compositiva delle due sculture raffiguranti un leone, una lettura stimolata an-che dalla necessità di sostenere e comprovare la funzione di sostegno dei leoni.
Come sono stati scolpiti i leoni, praticamente simili in ogni dettaglio ?
Le ricerche scientifiche sulle sculture, seppur numerose, non offrono ancora dati certi sulle tecniche scultoree. Wittkower 55 ne ripercorre la storia con una serie di osservazioni tecniche di un certo interesse, ad esempio sull’uso degli strumenti, sul tipo di incisione ed anche sulle soluzioni di riproduzione in serie o da modelli cartacei.
Altri autori hanno affrontato l’argomento tec-nico costruttivo, 56 ed una indicazione interessan-te viene proprio dall’artista rinascimentale Leon Battista Alberti che indica un metodo costrutti-vo : dimensio e finitio. L’Alberti ci offre anche in-formazioni sugli strumenti, come l’Exempeda, una riga dritta modulare utilizzata per le dimen-sioni, affiancata da squadre da carpentiere, che consentiva di ricavare le dimensioni esatte del modello. Per i dettagli anatomici veniva infine usato il “definitor” uno strumento descritto co-me un disco nel quale viene fissato un righello rotante nella cui estremità veniva legato un filo a piombo.
Forse non erano dissimili gli strumenti degli scultori nuragici, fenici o greci e prima egizia-ni, che sulle misure e sulle proporzioni avevano grande dimestichezza insieme ad un livello di teorizzazione altrettanto avanzato.
Senza dover necessariamente approfondire detti argomenti, l’attenzione nella ricerca è stata rivolta su due problematiche generali, la prima al fare artistico e la seconda a quella costruttiva delle sculture in copie.
Per risolvere il primo aspetto ci viene incontro la “divina proporzione” o meglio la costruzione della forma secondo le regole della sezione aurea.
Indagate le sculture con il metodo della sezio-ne aurea, ritroviamo le linee costruttive o meglio i rettangoli delle sezioni auree che costruiscono l’impalcato anatomico della scultura. Geome-tria e geometria delle forme, rapporti, perfezio-ne, misura, metrica, lirica e simbologia, sono i componenti figurativi e teorici dei nostri leoni di Sulky, dove tutto si ricompone armonicamente, i numeri, le misure, le forme. 57
I multipli, nelle costruzioni dell’epoca ed an-cora di quelle precedenti e successive, sono un fatto ricorrente, corrispondono nel cosiddetto “ordine delle cose”, nonché alle regole della geo-metria euclidea, di quelle apotropaiche di molte convinzioni religiose.
Gli ordini architettonici si basavano su regole precise, la misura, la metà, il doppio, il triplo, il modulo, la scansione, la bilateralità, sono con-dizioni note ed usate con disciplina da millenni, regole forse connaturate con il dna dell’uomo.
La misura aurea dei leoni si può ipotizzare, come detto, in un modulo di cm 136x136 ricava-bile dal quadrato che incornicia i leoni, escluso il toro, 58 oppure una parte del basamento che si presenta con un diverso trattamento della pietra, meno rifinita e che fa pensare ad un suo interra-mento od inclusione in un pavimento.
Di straordinario interesse sono le misure che si ricavano tracciando, di volta in volta, i rettango-li aurei in sottomisura e le diagonali, l’incrocio, gli spigoli determinano gli angoli e le sembianze anatomiche del leone ; la formula “divina” con il coefficiente dello 0,618, ci conduce passo do-po passo all’intero reticolo costruttivo, tuttavia sempre con alcune imprecisioni ed interruzioni delle sequenze.
Molte di queste misure e diagonali devono es-sere ricondotte a pure risultanze geometriche, ma in estrema sintesi è emerso che il busto dei leoni viene ricavato con due semicerchi cerchi, leggermente disassati. In questa parte di analisi stilistica e semantica è possibile allargare il pen-siero e dare ragione ai due cerchi completi che potrebbero significare l’ideale inglobamento del leone con la muratura e la forma sovrastante,
56 Nel rinascimento grande importanza ebbe il trattato del Leon Battista Alberti, De Statua, scritto negli anni ’30 del Quattrocento, nel quale l’autore dà indicazione agli artisti sulla necessità di uno studio profondo delle regole, della morale e della dottrina, rifacendosi a Plinio e Quinti-liano. Più indietro nel tempo Teofilo, pseudonimo di un monaco benedettino, scrisse tra 1110 e il 1140 il De diversis artibus, un trattato in tre volumi nel quale illustra anche il fare artistico dello scultore/architetto.
57 Per quanto attiene la metrica, le scansioni dei rettan-goli aurei è necessario precisare che nei leoni di Sulky, detti
riferimenti emergono con una certa puntualità ma non con continuità assoluta, è lo stesso problema verificatosi per i retabli o per la pittura rinascimentale, dove tuttavia, la pre-cisione e la volontà è molto più marcata e precisa. Più in generale i valori vanno riferiti a metodi di indirizzi, pratici e filosofici, con alcune libertà interpretative da parte dello scultore.
58 L’unità di misura di una rappresentazione pittorica o scultorea veniva abitualmente considerata al netto delle cornici, delle decorazioni o degli eventuali sostegni.
roberto concas12
oggetti e strumenti di rappresentazione di un comune racconto.
Ricorrendo questa volta all’ampia letteratura sulla simbologia nelle opere d’arte, se tracciamo le diagonali del nostro quadrato aureo di 136 cm, vediamo che l’incrocio delle stesse segna un pun-to straordinariamente significativo per la cultura orientale e non solo : il plesso solare. 59
Tuttavia regola di questa ricerca è quella di superare la prima valutazione, (semantica) per verificare se esistono condizioni di ulteriore prova ; una seconda si raggiunge individuando il triangolo simbolico e costruttivo che segna e racchiude il leone di Sulky individuando, ancora una volta, il centro nel plesso solare. Il triangolo, simbolicamente descritto da un ampia letteratu-ra, valutato come indicazione separata, consen-te indirettamente di confermare, a posteriori, il quadrato inizialmente individuato, di 136 cm, che racchiude la raffigurazione dei leoni.
Terzo punto di una geometria piana e non casuale, è dato dall’ipotetico cerchio che pos-siamo ottenere puntando il compasso al centro delle diagonali che ricadono nel plesso solare e tracciando una circonferenza di diametro com-preso tra i due cerchi che disegnano il busto del leone.
Ebbene le dimensioni di questo cerchio, rad-doppiato, consentono di ricomporre, sempre geometricamente, l’ovale costruttivo figurativo che disegna il posteriore del leone accovacciato e la testa, oggi purtroppo in gran parte mancante. Il modello risulta ragionevolmente applicabile soprattutto se partiamo dal progetto sviluppato in piano elaborato dall’artista, architetto (Tavo-la 16, 16a, 16b, 16c).
Questi risultati superano senza grandi difficol-tà la soglia delle indispensabile diffidenza scien-tifica, per confermare una volontà esplicita e ri-cercata, di rappresentazione simbolica, da parte dell’autorevole progettista dei Leoni di Sulky.
Nella ricerca delle forme geometriche e sti-listiche, trovati i cerchi costruttivi del busto, si
manifestata anche la volontà di una rappresen-tazione virile che i due leoni assolvono nella raf-figurazione zoomorfa con le zampe posteriori accovacciate, il busto sorretto dalle zampe an-teriori (pilastro architettonico) ed infine la testa (Tavola 17).
L’espressione simbolica può intrecciarsi con quanto fin qui sostenuto, senza tuttavia modifi-carne il senso, anzi rinforzandone l’importanza, la maestosità e la funzione, dei due leoni, quali straordinari strumenti di rappresentazione del pensiero filosofico del tempo.
Coerente con quanto ribadito più volte in que-sto articolo, l’analisi si ferma, anche in questo ca-so, lasciando aperto il dibattito, su altri contenu-ti, sul concetto più esteso del filosofare fenicio, e su tante altre materie, come ad esempio l’econo-mia, 60 ed ancora di urbanistica, 61 sul quale argo-mentare con altre competenti professionalità.
Le ipotesi ricostruttive
Lo studio ha evidenziato, nei leoni, un traliccio di linee ed un metodo di approccio che, con la preziosa collaborazione di Laura Zucca che mi ha accompagnato nell’intera ricerca, 62 ha con-sentito di “azzardare” ed ipotizzare la ricostru-zione della parte mancante della testa dei leoni (Tavola 18-18a).
Un percorso, questo della ricostruzione, in ap-parente o sostanziale contraddizione, secondo i punti di vista, con quanto detto e puntualizzato più volte in questo lavoro, in merito al dato scien-tificamente riscontrabile. Ma anche un percorso che, se dichiarato ed a margine della ricerca, può consentire di configurare e completare il raccon-to dei leoni senza quella orribile mutilazione del volto che semanticamente disturba la lettura e l’interezza dell’informazione.
Pertanto dopo una ricerca sulla iconografia dei leoni fenici, partendo dal geometrismo del-l’ovale, ricercando, con molta cura, le misure e le sottomisure di sezione aurea, si è cercata, prima
59 Il plesso solare e non già il cuore è punto focale del pen-siero filosofico della cultura orientale, riportato nel Chakra, dal sanscrito “ruota”, il plexus solaris è il punto di forza di personalità, di equilibrio, tra l’uomo il suo corpo e la natura.
60 Di economia, si potrebbe discutere partendo dal dato oggettivo della ricerca che mostra, con chiarezza, quale li-vello di elevata potenza culturale, politica, religiosa ed ap-punto economica i Fenici aveva raggiunto al momento della conquista della Sardegna.
61 È chiara la valenza della volontà di urbanizzazione di Sulky, i leoni, le mura, sono segni rimarcanti di una volon-tà di rappresentazione del pensiero filosofico dei Fenici che miravano a segnare simbolicamente il territorio, comuni-cando a tutti la loro volontà di radicarsi in un territorio, ma certo non con gli strumenti della guerra ma con il potere
del denaro e delle trattative con i locali, sicuramente altret-tanto economicamente potenti.
62 Oltre a Laura Zucca, che magnificamente realizzato i modelli dei leoni della soluzione costruttiva, colgo l’occa-sione di questa nota per ringraziare, Antonia Giulia Maxia per aver condiviso, da subito, le intuizioni di questa ricerca e di quella sui retabli pittorici, Marcella Serreli per i dotti approfondimenti, Carlo Tronchetti per la proficua collabo-razione, inoltre, Fulvia Lo Schiavo, Piero Bartoloni, Paolo Bernardini, Donatella Mureddu, per la sincera disponibili-tà ed onestà intellettuale, ed infine ma non ultima, per la sensibilità mostrata, Lucia Arbace, la prima Soprintendente, storico dell’arte, della nuova Soprintendenza ai Beni Storico Artistici ed Etnoantropologici della Sardegna, che ha ospita-to l’anteprima ufficiale di questo lavoro.
i leoni di sulky 13
la scansione volumetrica, bocca, occhi, orecchie, testa, del prospetto laterale, poi di quello frontale.
Un percorso di ricerca ricostruttiva necessa-riamente rigoroso, vincolato dalle misure della sezione aurea, che comunque costringono alla ragione, almeno nelle proporzioni, qualsiasi al-tra interpretazione che non rispetti dette regole.
Per cui, passo dopo passo, dividendo dopo di-videndo, la forma ha acquistato una definizione ragionevolmente vicina a quella originale, trac-ciata dai rettangoli aurei, dalle diagonali, dall’in-crocio sistematico e non casuale delle linee.
La ragionevolezza della ricostruzione ha co-munque ancora molti margini di interpretazio-ne, il volto dei leoni sarebbe potuto essere più aggressivo o più rassicurante, anche se in termi-ni di comparazione stilistica il leone in arenaria di Tharros offre interessanti suggerimenti.
Questa ipotetica ricostruzione della testa leo-nina ha comunque consentito, nel corso del lavoro, di eliminare un “disturbo” semantico visivo molto forte e condizionate per la lettura dell’opera. Lo stesso risultato si sarebbe potuto ottenere identificando anche solo i volumi del volto e le linee principali, ma sempre nel rispet-to delle proporzioni e degli indizi esistenti nello stato attuale delle figure.
Osservando complessivamente il modello rea-lizzato in scala, l’armonia delle forme, la comu-nicazione semantica e semiotica, con la ricostru-zione della muratura e del suo incatenamento con i leoni, si percepisce un immagine coerente, nella quale il racconto del leone si integra perfet-tamente nel sistema architettonico recuperando la, sostanziale, originaria funzione.
Infine e sempre come pura ipotesi legata al da-to certo che dimostra che i leoni sostenevano un elemento superiore, nella tavola viene illustrata una affascinante e suggestiva soluzione di svilup-po della costruzione, senza alcuna altra pretesa se non quella, in parte ludica, di stimolare anco-ra altre ricerche (Tavola 19).
Nota sulla metrica e le misure
L’ambito delle misure, dei numeri e delle geo-metrie è un settore particolarmente “minato” ; in
troppi si inoltrano in disquisizioni che facilmen-te sconfinano nel misterioso, nell’esoterismo e nel magico, sino alle ricongiunzioni astrali e, se talvolta, il “navigar tra i numeri è dolce”, la ne-cessità è quella di prestare la massima attenzione prima di trarre qualsiasi o possibile conclusione.
Per interpretare filologicamente le opere scul-toree o pittoriche, sino ad almeno il 3.000-4.000 a.C. è necessario rifarsi alle misure ed alla metri-ca simbolica costruttiva impiegata, riconducibile quasi esclusivamente alla sezione aurea o divina proporzione, seppure la stessa abbia teorizzazio-ni attestabili solo intorno al vii e nel v secolo a. C. con Policleto.
La sezione Aurea è uno strumento, prima di tutto filosofico, che prende spunto dalla osser-vazione della natura dove piante, animali, frut-ti, crescono seguendo un’armonia “metrica” 63 che viene codificata con una sequenza numeri-ca ottenuta calcolando le diverse misure con un coefficiente numerico individuato nello 0,618. Questo coefficiente numerico, diviso o molti-plicato per la misura decisa, consente all’artista, all’architetto, oggi al grafico digitale, di ottenere forme, spazi, volumi, armonicamente collegati tra di loro. 64
Il concetto più generale, frutto di una contem-plazione lontana oltre cinque millenni, può esse-re riassunto in un pensiero : « Se Dio ha creato la natura e l’uomo con l’armonia della divina pro-porzione, se l’uomo per il suo “creare” costruire, impiega la stessa metrica, l’uomo sarà più vicino a Dio ».
In estrema sintesi per questa possibile ragione ma, certamente, per ancora più complesse ela-borazioni filosofiche, nella pratica, nella realizza-zione di opere commissionate dal “potere”, tra gli strumenti della comunicazione visiva e filo-sofica, la sezione aurea diventa regola, obbligo, consuetudine, prassi operativa.
I Fenici utilizzano la sezione aurea con l’uni-tà del cubito che misura 52 cm, corrispondente idealmente alla lunghezza dell’avambraccio a partire dal gomito fino alla punta del dito medio
Il calcolo del cubito con il coefficiente 0,618 più naturalmente veniva ricondotto a sistemi fissi e di semplice impiego 65 senza troppe complicazio-
63 L’osservazione della natura mostra, come la sequenza dei numeri di Fibonacci, che il giglio ha 3 petali, i ranuncoli 5, la cicoria 21, la margherita 34 o 55 ; i girasoli hanno una serie di due spirali con la sequenza di 21 e 34, 34 e 55, 55 e 89, 144, così come per le pigne, le conchiglie, l’ananas.
64 La sezione aurea, nel corso di oltre tre millenni, ha tro-vato applicazioni con fasi alterne ; Le Corbusier nella prima metà del Novecento, ritrovò l’ordine della composizione con la sezione aurea, così come Mondriand e molti altri ar-tisti. Oggi nell’era tecnologica produciamo televisori 16/9
che altro non sono, per dimensioni, che la sezione aurea del segmento della base che individua l’altezza dello schermo. Con queste misure e rapporti l’uomo di tremila, e forse an-che più anni fa, ha avuto la sensazione di “possedere” una chiave risolutiva delle forme del mondo e dell’universo ; oggi dalle stesse misure cerchiamo di ricostruire frammenti di storia e di archeologia.
65 Per quanto attiene le misure e le sottomisure è possibi-le pensare a strumenti anche elementari, come una misura, il cubito da 52 cm, segnato in un listello a sezione quadra o
roberto concas14
ni, e per questa ragione nelle costruzioni, nelle opere d’arte, nei manufatti si ritrovano rapporti proporzionati in sezione aurea, spesso impiegati con alcune licenze interpretative che “sfilaccia-no” il racconto.
La sezione aurea tuttavia non spiega tutto né, tantomeno, ci si può arroccare o rimanere ap-pagati dall’averla riscontrata in un’opera d’arte, in quanto la stessa sezione aurea la si troverà in molti contesti, come prassi diffusa. 66
La concreta differenza resta pertanto, esclusi-vamente, nel come è stata impiegata la sezione aurea, con quale maestria, con quale pensiero fi-losofico, con quale dettato teologico, per quale ritualità, per quale rappresentazione del pensie-ro filosofico del tempo.
In questa ricerca mi limito a sostenere e dimo-strare l’avvenuta applicazione sui leoni di Sulky di una formula nota e teorizzata come la sezio-ne aurea, precisando che la vera interpretazio-ne non è riconducibile esclusivamente a questo dato, ma viceversa che concorre per “costruire” l’impalcato simbolico, segnico e semantico dei leoni, molto più complesso.
A supporto della ipotesi ricostruttiva, nella tabella successiva è interessante notare come le misure riscontrate nei Leoni di Sulky nel qua-drato del racconto di 136x136 cm, ed il loro svi-luppo nelle sequenze della sezione auree divisa per la serie di Fibonacci, 67 riconducano, nella
periodicità del calcolo, alla misura di 44 cm, possibile dimensione del concio della muratu-ra che si innesta nei pilastri dei leoni, mentre i 220 cm potrebbero essere una misura utile per ricostruire l’ipoetica muratura che cingeva i leoni.In un opera d’arte maestosa come i Leoni di Sulky, poco o nulla è casuale, ed i numeri rispon-dono ad una elaborazione filologica che diventa geometria, filosofia, semiotica, arte, architettu-ra, statica.
Chiunque possa avere un qualche interesse a ricercare ancora con maggiore “precisione” le misure e le risultanze, non deve comunque in-correre nell’errore di evidenziare differenze di centimetri o di convergenze di linee, potrebbe risultare un serio errore di metodo in quanto la valutazione risulterebbe “viziata” da una vo-lontà forzata e indirizzata nel ricercare l’errore e non già l’armonia ed il meccanismo dell’in- sieme.
Conclusioni
Questa metodologia di indagine innovativa, che offre tangibili riscontri, è bene chiarire che non è semplicissima od immediata da impiegare, anche se supportata dai risultati, in particolare nella individuazione dei sistemi di elaborazione filologici che si confermano nella ripetitività del fenomeno.
triangolare, nelle cui facce una scansione di tacche, indicano i multipli ed i sottomultipli del cubito divisi o moltiplicati con la sezione aurea (coefficiente 0,618). Lo strumento di misura del fare architettonico o scultoreo, il cubito, è fa-cilmente impiegabile dalle maestranze, mentre il pensiero filosofico e quello matematico che l’ha prodotto è ben più alto e complicato.
66 Prassi è anche quella che oggi ci impone di realizzare le porte di ingresso con una apertura minimo di 90 cm per consentire il passaggio dei disabili, la regola è frutto di un
pensiero “filosofico” che presta attenzione alle disabilità, la prassi è quella che anche un muratore sa che deve fare le porte con queste misure e le realizza ovunque anche quan-do non servono.
67 Leonardo Fibonacci matematico del xiii secolo che teorizzò una sequenza numerica (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55) che consentono straordinarie possibilità di calcolo di modelli matematici. La serie con il rapporto F
n / F
n-1 al ten-dere di n all’infinito riconduce al numero algebrico irrazio-nale 0,618, detto appunto della sezione aurea o numero di Fidia.
ASezione AureaDa 52 /0.618
BSerie Fibonacci
C = A/BIpoteticheDimensioniConcio
52 1 52 Cubito Fenicio84 2 42136 3 45,333 Misura del “racconto” iconografico dei Leoni di Sulky220 5 44 Numerica periodico stabilizzato (misura concio ?)356 8 44,5576 13 44,307932 21 44,380 7° numero (della Perfezione) della Serie di Fibonacci
i leoni di sulky 15
Non esiste una chiave di lettura passepartout, 68 esistono semmai più chiavi o combinazioni da organizzare sulla scorta di una osservazione, meglio, di una contemplazione, ma non “estati-ca” bensì di indagine, umile, rispettosa, capace di perforare l’involucro esterno di un opera d’arte, per entrare al suo interno, nella sua radice, nel suo vero ruolo di strumento di rappresentazione del pensiero filosofico.
Nell’avere coscienza che le nostre letture e quelle delle generazioni future delle opere d’ar-te, resteranno sempre letture post quem, l’im-pegno deve essere quello di levare ogni possibile sovrastruttura che ci impedisce di trovare la ra-dice e la volontà primaria di espressione e rap-presentazione.
Trovata la radice, potremmo capire di più, rac-contare, conservare, musealizzare e restaurare meglio.
Confido che queste osservazioni possano sol-lecitare un nuovo dibattito, in un campo, dove le informazioni documentarie, artistiche, cultura-li e le interpretazioni delle stesse, diventano un territorio sterminato, estremamente interessan-te, sopratutto se multidisciplinare.
Nelle attribuzione, nella collocazione del-le opere d’arte, nel restauro e nell’esposizione museale, l’attuale discussione è ancora ecces-sivamente di tipo compilatorio, 69 un grande e
lodevole impegno per riordinare i riferimenti bibliografici, documentari, stilistici, territoriali, cronologici, iconologici, iconografici, tecnici, materici, cromatici, diagnostici ed ancora altro, che non definiscono molto di più. 70
Si arriva così in sede di pubblicazione o dibatti-to, spesso, con gran parte dei temi esplorati che restano irrisolti e con le conclusioni che perdono di efficacia nella comunicazione e nell’insegna-mento.
In tutto questo anche i vecchi insegnamenti riemergono “stagnando” e rallentando la ne-cessità di nuovi approcci che trasversalmente interessano l’archeologia, la storia dell’arte, le tradizioni popolari, la percezione psicologica, la teoria del restauro 71 che, alla luce di queste me-todiche, necessiterebbe, ad ormai oltre 50 anni dalle teorizzazioni di Longhi e Brandi, di una ri-discussione profonda.
In conclusione questa dei Leoni di Sulky è una scoperta interessante e affascinante, che dà maggiore lustro alle due magnifiche sculture ed alla stessa Sardegna, terra di crocevia strategi-co, artistico e culturale nel Mediterraneo ; una grande civiltà sarda, non certo subalterna, forte committente di arte, architettura e cultura, per rappresentare con determinazione, a tutti, la forza e la profondità del proprio pensiero filoso- fico. 72
68 L’eventuale impiego in altri contesti della ricerca illu-strata, come mostrato, è certamente possibile, ma va riba-dito, con estrema prudenza e rigore scientifico, ricercando e dando dimostrazione, con tutti i possibili riscontri, degli elementi rinvenuti. Scoprire linee, perpendicolari, triangoli, è possibile in quasi tutte le forme artistiche e non solo, la differenza è nei contenuti e nei significati veri di questi se-gni e poi nelle conclusioni. La metodologia di analisi di un opera d’arte è complessa, fatta di molteplici fattori, bisogna formarsi, mutuando il tema, un “occhio clinico”, cioè una capacità di mettere insieme più aspetti per definire la dia-gnosi (il giudizio, la scoperta) ; viceversa il rischio potrebbe essere quello di una improvvisazione, dove questa metodo-logia illustrata diventa una sorta “bugiardino” (indicazioni metodologiche e filologiche) per “farmaci” (soluzioni inter-pretative) che invece, non vanno assolutamente impiegati come “automedicazione” (soluzioni per ogni cosa).
69 Un metodo consolidato nella ricerca scientifica, indi-spensabile, ma troppo spesso auto avvolgente ed auto re-ferenziante.
70 Mantenendo il parallelismo è come l’accanimento dia-gnostico con il risultato : non sappiamo, ci sono risultati con-tradditori etc.
71 Il dibattito sul restauro langue e rimane imperniato nel documento “costituzionale ?” che è la Carta del Restauro, in realtà ed in molti casi, anche la dogmatica dichiarazione che “il restauro si deve vedere”, ha lasciato segni nelle opere, che ad una lettura, come questa sui leoni, potrebbe identi-ficarsi come un intervento “presuntuoso ?” che si intromet-te nella corretta lettura dell’opera, per raccontare che si è proceduto ad un restauro. Assistiamo, nei restauri, ad un
imperversare di citazioni di intervento, rigatino che sfuma la composizione e le posture delle figure, toni neutri a fi-nire le parti mancanti anche quando sono evidentissime le conclusioni possibili, e ancora, certo esprimendo polemica-mente il pensiero, la peggiore manifestazione ed intrusione nella comunicazione visive e semantica di un’opera, sono i cosiddetti tasselli di pulizia. Quadrati sempre più grandi, talvolta su più livelli stratigrafici, che “tempestano” spalle delle sculture, angoli dei dipinto, e che ormai giustificano, poco più, di un intervento di routine, rientrato anche nel-l’immaginario collettivo, di ovvia ripulitura, della cromia, dalle ingiurie del tempo. Tecnicamente e semioticamente con questi tasselli, lasciati come testimonianza, si potrebbe invece parlare di “superfattazioni” cioè di vere aggiunte suc-cessive che concretamente disturbano la originaria possibile lettura dell’opera.
72 I Fenici commerciarono con la Sardegna, ricca di ri-sorse minerarie, di legna e di cacciagione ; con i Leoni di Sulky mostrarono la loro abilità rivolgendosi, ai Sardi, da pari, confrontandosi sul piano filosofico, rispondendo alla rappresentazione data dall’imponenza delle architetture nuragiche. Il confronto è commerciale, ma prima ancora è filosofico, la ragione dei propri pensieri e non la brutalità delle armi. Un confronto tra due grandi civiltà gestito con gli strumenti sofisticati dell’arte, della cultura, della mate-matica, della religione ; i Leoni di Sulky ne sono la più con-creta testimonianza.
I disegni, le ricostruzioni grafiche ed i modelli sono stati rea-lizzati da Laura Zucca. Grafica e fotografia ; Andrea Concas e Fabrizio Varioli.
i leoni di sulky 17
Tavola 1. Immagine dei Leoni di Sulky nella attuale esposizione al Museo Archeologico F. Barreca di San’An-tiotco (Ca).
a
b
c
d
e f
roberto concas18
Tavola 2. 2a-2 b. Rilievo disegno laterale dei Leoni di Sulky, con l’ipotetica ricostruzione del muso, realizzata per rimuovere, durante la ricerca, una condizione di disturbo visivo e semantico. 2c. Misure dei leoni.
c
b
a
roberto concas20
Tavola 4. Dimensioni elementi portata del carico. 4c. Punti di carico e controspinta del basamento e della cornice.
a
b c
i leoni di sulky 23
Tavola 7. Dettaglio della scanalatura superiore. a. Scanalatura ed angolo retto.
a
roberto concas26
Tavola 10. Ipotesi di ricostruzione del monumento “a spillo” proposta da Sabatino Moscati del mausoleo neopunico di Sabratha (Libia). 10a. Immagine del mausoleo ricostruito nel 1920.
a
i leoni di sulky 27
Tavola 11. Immagine mausoleo punico-libico di Dougga in Tunisia, iii-ii sec. a.C. 11a. Monumento funerario di Amrit, del iii sec. a.C., riproposto nella ricostruzione da E. Renan a pagina 150 del citato catalogo sui Fe- nici.
a
roberto concas30
Tavola 14. Sequenza del meccanismo costruttivo. 14e. Interno della muratura senza incastro a pettine.
a
b c
d e
i leoni di sulky 31
Tavola 15. Dettaglio, sul modello, del sistema di innesto del “pilastro” superiore.