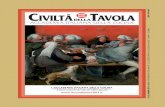Produzione e circolazione della ceramica da cucina nella Campania romana. Tradizioni formali e...
Transcript of Produzione e circolazione della ceramica da cucina nella Campania romana. Tradizioni formali e...
IMMENSA AEQUORAWorkshop
Ricerche archeologiche, archeometriche e informaticheper la ricostruzione dell’economia e dei commerci
nel bacino occidentale del Mediterraneo(metà IV sec. a.C. - I sec. d.C.)
Atti del convegnoRoma 24-26 gennaio 2011
a cura diGloria Olcese
9 788871 405407
EDIZIONI QUASAR
IMM
ENSA
AEQ
UO
RA
Workshop
ISBN 978-88-7140-540-7
€ 65,00
ESTRATTO
Ideazione e coordinamento scientifico Gloria Olcese - www.immensaaequora.com
Redazione scientificaIlaria Manzini
Progetto di copertinaGloria Olcese, Emanuele Gabellini
In copertinaMare di Ischia (fotografia di Andreas Hiener)
Ove possibile sono stati richiesti i permessi di riproduzioni di foto e disegni, si resta comunque a disposizione di eventuali detentori dei diritti che non è stato possibile contattare
ISSN 2240-9831
ISBN 978-88-7140-540-7
© Roma 2013, Edizioni Quasar di Severino Tognon srlvia Ajaccio 43 - 00198 Roma, tel. 0685358444 fax 0685833591e-mail: [email protected] – www.edizioniquasar.it
Volume finanziato grazie ai fondi del MIUR, Progetto FIRB 2005-2011 RBNE03KWMF “Ricostruire i commerci nel Mediterraneo in epoca ellenistica e romana
attraverso nuovi approcci scientifici e tecnologici”
Dipartimento di Scienze dell’Antichità“Sapienza” – Università di Roma
ESTRATTO
IMMENSA AEQUORAWorkshop
Ricerche archeologiche, archeometriche e informatiche per la ricostruzione dell’economia e dei commerci
nel bacino occidentale del Mediterraneo (metà IV sec. a.C. - I sec. d.C.)
Atti del convegno Roma 24-26 gennaio 2011
a cura di Gloria Olcese
Immensa Aequora 3
Edizioni Quasar
ESTRATTO
The study aims to compare the old and new data on the Roman kitchen ware evident in the contexts from the middle republican to the imperial age (III Century B.C.-III Century A.D.) in Campania by comparing the different areas of production and circulation. Particular attention will be paid to any differences between the patterns of production and distribution of the coastal cities and inland towns. The new data come from the available quantitative and typological contexts recently excavated and studied from Phlegreans fields area (Puteoli, Liternum, Baiae) and inland Campania (Compsa and Allifae) where local workshops have been discovered. It’s interesting to note that these workshops produce utilitarian pottery connected with local tradition, even in Imperial times. The second part will focus instead on long-range imports certified in Campania, primarily from Africa, from the end of the first century and then by Greece from the East, etc. The study also proposes to create specific typologies for each production documented in the studied area.
keywords: Roman pottery, Kitchen Ware, Roman Campania, Roman economy.
In premessa è bene sottolineare il carattere necessariamente preliminare di questa nota e delle tesi che in essa sono discusse e ciò in considerazione del numero sostanzialmente ridotto di contesti editi sia dalla Campania costiera sia dalle zone dell’interno della regione. Purtroppo in nessun comparto regionale sono documentate sequenze continue di assemblaggi ceramici tali da far risaltare tanto le trasformazioni morfologiche, nel lungo periodo, all’interno di ciascuna area produttiva, quanto le differenze morfologiche tra le diverse aree. Per questa ragione ci limiteremo in questa sede a presentare i primi dati offerti dallo studio di alcuni contesti inediti di recen-te acquisizione integrandoli con vecchi rinvenimenti rimasti inediti, consci che interventi di sintesi non possano esulare dalla disponibilità di una base documentaria che sia il più possibile ampia.Il quadro che emerge da questa analisi, seppur basata su dati “intermittenti”, ci permette di delineare alcune linee di sviluppo e di circolazione di modelli morfologici di una classe di oggetti, come la ceramica da cucina, dalla forte connotazione funzionale ma che conserva nella sua evoluzione anche forti valenze ideologiche e che rap-presenta, allo stesso tempo, l’unica traccia fossile, spesso di difficile interpretazione, di comportamenti alimentari legati alle modalità di preparazione e cottura dei cibi.
[V. Di G., G. S.]
Alcuni rinvenimenti provenienti da indagini sistematiche effettuate nell’agro di Liternum nel 2010 ci permettono di effettuare alcune interessanti osservazioni su questo materiale. Il territorio di Liternum, attualmente nel comu-ne di Giugliano in Campania (NA), si trova alle propaggini meridionali della piana campana e può essere consi-derato una sorta di territorio di confine tra quest’ultima e il comparto dei Campi Flegrei1, in una zona nevralgica tra le due entità urbane territorialmente eminenti in epoca preromana: Capua e Cuma2.I materiali provengono dagli strati di riempimento di un fossato completamente indagato, largo 90 cm, che deli-mita un’area di forma quadrangolare di circa 30 m di lato, il cui dato funzionale al momento non appare chiaro3. Da questo contesto chiuso sono stati documentati quasi cinquemila (4883) frammenti tra ceramica fine e co-mune; tranne pochi elementi residui (meno del 2%) sono tutti databili tra la fine del IV e la prima metà del III secolo a.C. È da sottolineare che i contesti da abitato pubblicati databili tra IV e III secolo a.C. con assemblaggi di ceramica quantitativamente consistenti in Campania sono piuttosto rari e che, tranne per alcune forme, es-senzialmente di impasto, attestate nei corredi tombali dell’epoca, la tradizione formale della ceramica comune e da cucina è pressoché sconosciuta. Riguardo appunto a questa classe questo contesto ci offre la possibilità di formulare alcune osservazioni riguardo alle morfologie utilizzate ed all’ambito culturale in cui questi oggetti sono stati prodotti.
Produzione e circolazione della ceramica da cucina nella Campania romana. Tradizioni formali e contesti a confronto
Vincenzo Di Giovanni*, Gianluca Soricelli*** Università degli Studi Napoli “Federico II”; ** Università del Molise
ESTRATTO
180 Vincenzo Di Giovanni, Gianluca Soricelli
Nel giacimento per la maggior parte la ceramica da fuoco è rappresentata da forme chiuse, una novantina di esemplari in tutto, circa la metà realizzate a tornio lento. Il computo statistico è fatto sul numero minimo degli individui, ma se si volesse usare il parametro numero/peso la percentuale per le attestazioni dei vasi a tornio lento risulterebbe, naturalmente, ancora più alta. Dal punto di vista tipologico i recipienti sono piuttosto omogenei, con un orlo piano, in genere diritto, talvolta lievemente inclinato, corpo sub-globulare e fondo piano; a volte compaiono due anse orizzontali ad orecchio (talvolta una sola) al di sopra del punto di massima espansione del vaso. Sotto l’orlo, quasi tutte le olle sono fornite di due, tre ed a volte anche quattro bugne o prese plastiche oriz-zontali. Il tipo sembra essere prodotto in almeno un paio di misure che però conservano sempre analoghe carat-teristiche dimensionali nel rapporto diametro bocca/altezza del vaso (Figg. 1-6). Dal punto di vista morfologico questo tipo di recipiente rientra nel ben conosciuto tipo delle “olle a bombarda” che caratterizzano la cosiddetta
Figg. 1-9: Giugliano in Campania, CF, saggio 39, US 09.
ESTRATTO
Produzione e circolazione della ceramica da cucina nella Campania romana 181
facies culturale della “Valle del Liri”. L’uso in ambito funerario di questi recipienti è documentato già a partire dal VI secolo a.C. e si protrae fino alla metà del IV scolo a.C. A ragione è ritenuto uno degli elementi di tradizione formale fortemente connotanti di questa cultura attestata per vaste aree della Campania settentrionale4. Le olle del contesto di Liternum, la cui derivazione da modelli più antichi credo sia abbastanza evidente, rappresentano le versioni più recenti di questo tipo di recipiente. Fin qui niente di strano, abbiamo attestata una produzione di lungo periodo, con aspetti culturalmente “tradizionali” che, secondo il modello che in genere si applica a queste classi di materiale, si evolve con lentezza. Nello stesso contesto però appare un’altra serie di recipienti la cui forma è molto simile alle forme realizzate a tornio lento, ma questi sono realizzati a tornio veloce: rappresentano circa un quarto del campione considerato (Figg. 7-8). Anche in questo caso è attestata la presenza di prese plastiche/bugne nella stessa identica posizione. In alcuni esemplari la superficie esterna del vaso viene resa intenzional-mente ruvida con una sorta di rusticatura (arcaicizzazione?) (Fig. 10). In un caso è stato documentato un esem-plare di recipiente ibrido in cui la parte inferiore sembra essere stata realizzata a mano mentre la parte superiore e l’articolazione dell’orlo sembrano essere state tornite con un uso piuttosto disinvolto della ruota (Fig. 9). Il resto degli esemplari sono realizzati a tornio veloce e hanno orlo sagomato e corpo a profilo continuo secondo un modello tipologico che troviamo attestato in contesti coevi, a Minturnae5, a Cuma6 ed in ceramica comune, nelle tombe di fine IV-III secolo a.C. di Capua7, e poco più tardi di Teano8 (Figg. 11-12); tutti gli esemplari sono prodotti in argilla vulcanica e possono essere agevolmente considerati di produzione campana. È evidente che questo giacimento registra straordinariamente un momento di transizione tra diverse tradizioni formali che si esprimono, probabilmente volutamente, con strumenti tecnologicamente diversificati e con tradi-zioni morfologiche ben precise, e tale transizione non sembra essere tanto lenta come normalmente si è portati a pensare9. La ceramica da fuoco relativa alla fase tardo repubblicana del sito, quando nel 194 a.C. venne dedotta la colonia romana di Liternum, presenta un modello più “ortodosso” relativo alla prima fase di produzione di ceramica ita-lica da cucina. Sono state scavate varie fosse di scarico, con materiali databili tra la fine del III ed il II secolo a.C.; il campione ammonta a diverse centinaia di frammenti ed il repertorio formale è quello noto, in cui compaiono il tegame con pareti oblique ed incasso per il coperchio (λοπάς) e la pentola con orlo a mandorla, variamente sagomato (Figg. 13-16). La tecnica di lavorazione è molto simile alle produzioni più tarde e compaiono sul fon-do, come per i tegami più tardi ad orlo bifido, contrassegni graffiti prima della cottura, spesso numerali o lettere (Figg. 13-14). Gli assemblaggi della metà del I secolo a.C. provengono in buona parte da strati di scarichi di materiale edilizio con cui vengono obliterate due cave per l’estrazione della pozzolana, ed hanno indici quantitativamente più bassi. In questi strati di colmatura sono attestati i primi esemplari di tegami ad orlo bifido (Fig. 18), che con le pentole con orlo a tesa e le olle con orlo inclinato, insieme con la ceramica a vernice rossa interna, rappresentano la mor-fologia tradizionale tipica della ceramica italica da cucina a partire dalla seconda metà del I secolo a.C. Alcune forme “transizionali” di pentole con orlo a tesa, in cui compare ancora un accentuato incasso per il coperchio, sembrano rappresentare l’anello di congiunzione tra le λοπάδες di tradizione ellenistica prodotte nella prima fase e le pentole con orlo a tesa che rappresentano la fase matura della produzione10 (Fig. 17).L’utilizzazione di questo repertorio formale, basato su una batteria divisa in tre categorie formali, pur con qual-che differenza, specialmente per le pentole, è attestata abbastanza uniformemente in tutto il versante tirrenico e, come è noto, abbiamo attestazioni di officine sia a Roma che a Pompei, anche se non escluderei l’area flegrea in relazione alle fabbriche di ceramica a vernice rossa interna a Cuma11. Sull’onda delle correnti del traffico com-merciale tra la tarda repubblica e la prima età imperiale troviamo attestazioni di questa ceramica in tutto il bacino del Mediterraneo12. L’uso di questo repertorio nella Campania tirrenica è attestato fino ad epoca piuttosto tarda, anche se con quantitativi di minor incidenza. Il contesto di Rione Terra a Pozzuoli (NA) della fine del II secolo e quello della stazione della Ferrovia Cumana a Baia (NA) della prima metà del III, pur conservando il repertorio morfologico tradizionale, segnatamente alle pentole ed ai tegami a vernice rossa interna, mostrano percentuali ridotte di ceramica italica da cucina, attestata tra il venti ed il trenta per cento sul totale della classe, mentre le produzioni africane coprono all’incirca la metà delle attestazioni e quelle orientali il rimanente13 (Figg. 23-27). È interessante notare che il repertorio della ceramica da cucina proveniente dalla parte orientale del Mediterraneo, sia dall’Egeo che dal Medio Oriente, e poi in maniera più incidente dall’Asia Minore, pur avendo delle sue specifi-cità per alcune forme molto specializzate e attardamenti in alcuni suoi sviluppi tipologici, non sembra discostarsi molto dal repertorio italico, specialmente per le forme chiuse14. Diversamente avviene invece per il repertorio africano, con poche forme e molto standardizzate, anche per prodotti realizzati da ateliers diversi e distanti tra di
ESTRATTO
182 Vincenzo Di Giovanni, Gianluca Soricelli
loro, e che sembra essere progettato per viaggiare su larga scala, come suggerisce la mancanza di orli aggettanti dal corpo del vaso, elementi che rappresentano punti di fragilità nel trasporto nella stiva di una nave15. La ceramica africana sarà, a partire dalla seconda metà del II secolo, un prodotto di successo e influenzerà anche i produttori sul suolo italiano che ne imiteranno le forme (vedi infra). È difficile dire quando il repertorio italico viene defi-nitivamente abbandonato, nella sua forma organica tripartita. Sicuramente ancora nel IV secolo si continuano a produrre pentole e olle che sembrano rifarsi alla tradizione romana16. Nelle aree interne la presenza di questa classe è piuttosto rarefatta e i mercati sembrano essere improntati piut-tosto sulla distribuzione di prodotti realizzati in base a repertori formali di tradizione locale, anche in epoca im-periale. A Conza della Campania (AV), un piccolo centro urbano in Irpinia a cavaliere tra il Tirreno e l’Adriatico, durante i lavori di scavo delle strutture del foro romano, tra il 2005 ed 2006, è stato individuato uno strato di colmatura che obliterava alcune parti del portico orientale ristrutturato in epoca augustea17. Non c’è nel contesto alcuna traccia di esemplari di ceramica italica da cucina di produzione tirrenica; è attestato un solo esemplare di piccola pentola con orlo a tesa che sembra avere una qualche somiglianza con gli esemplari costieri ma è prodotto in argilla locale. La quasi totalità della ceramica da cucina, sempre tutta in argilla locale, è costituita da tegami con piccoli orli sagomati che sembrano richiamarsi a prototipi ellenistici e che hanno confronti con esemplari
Figg. 10-12: Giugliano in Campania, CF, saggio 39, US 09; 13: Giugliano in Campania, CF, saggi 41-42, US 7, 9,10, 11; fig. 19-22: Conza della Cam-pania, Foro, scavo 2005, US 889; 23: Baia, Ferrovia cumana 2010, area B, US 111.
ESTRATTO
Produzione e circolazione della ceramica da cucina nella Campania romana 183
da altri contesti imperiali di area appenninica e da siti lucani o apuli, ad esempio Herdonia18, oppure dalle villae del territorio di Volceii19 (Figg. 19-22). Il dato interessante è che, a differenza delle ceramiche comuni, questo mercato sembra essere completamente dipendente dalle importazioni, in quanto la ceramica fine si divide quasi equamente tra sigillata italica, di provenienza centro italica, e sigillata della produzione A dalla Baia di Napoli, senza dimenticare non casuali residui di produzioni tarde di Campana A.
[V. Di G.]
Anche per la Campania settentrionale sembra possibile distinguere tra area costiera e area interna. La prima, che conosciamo attraverso i materiali editi dell’ager Falernus e dal contermine agro caleno20, presenta un repertorio tipologico affine a quello della baia di Napoli, caratterizzato, ad esempio, dalle pentole con orlo a tesa orizzontale (Figg. 28-29) la cui produzione, in area falerna, sembra perdurare almeno fino al IV secolo21. Il repertorio mor-fologico della Campania settentrionale interna presenta, invece, alcuni elementi peculiari che lo differenziano da quello della baia di Napoli ed in generale costiero, pur condividendone, come già osservato, “un’aria di fami-
Figg. 24-27: Baia, Ferrovia cumana 2010, area B, US 111; 28-29: ager Falernus, loc. Masseria Pagliare; 30-31: Alife, scavo prop. Amodeo.
ESTRATTO
184 Vincenzo Di Giovanni, Gianluca Soricelli
glia”22. I dati più articolati sono offerti da Alife ove è documentata, a partire dalla età augustea, una eterogenea produzione ceramica, sia fine da mensa (pareti sottili) che ceramica comune e da fuoco23. Per quanto riguarda quest’ultima, un quadro delle forme prodotte e circolanti intorno alla metà del I secolo d.C. è offerto da alcuni contesti di scavo urbano, omogenei nella loro composizione. Predomina tra le pentole il tipo con orlo a tesa caratterizzata, quest’ultima, da una decisa inclinazione verso il basso; spesso, all’estremità della tesa è presente una scanalatura più o meno profonda mentre all’interno l’attacco con la parete può essere, o meno, espanso24 (Figg. 30-31). Sono ugualmente documentate in argilla locale, sia pure in numero limitato, pentole con orlo a tesa (Fig. 32) che trovano analogie nel panorama tipologico della baia di Napoli25 e dell’ager Falernus.26 A questa pentola si accompagnano due tipi di olla, il primo con l’orlo estroflesso a sezione sub-triangolare, il secondo con il labbro più o meno svasato e concavo (Figg. 33-34). Il primo, comune nel territorio alifano e nella
32
3334
35
36
37
3839
40
0 10 cm
Figg. 32-36: Alife, scavo prop. Amodeo; 37-40: Alife, fornace porta Fiume.
ESTRATTO
Produzione e circolazione della ceramica da cucina nella Campania romana 185
media valle del Volturno, non sembra trovare confronti puntuali nell’area della baia di Napoli bensì nel limitrofo agro caleno27 e nell’interno, a Isernia28; le olle del secondo tipo, invece, possono essere confrontate con esemplari dall’area vesuviana e, più in generale, tirrenica29.La batteria da cucina si completa con un tegame a fondo piano (Figg. 35-36) e orlo più o meno introflesso che tende a riprendere nella forma e nel rivestimento, ridotto ad una semplice verniciatura rossa, i tegami della “rossa interna”; questo tipo di tegame avrà nelle fornaci alifane una vita lunga (diversi frammenti deformati sono stati restituiti dagli strati che obliteravano la fornace di porta Fiume30) e sarà prodotto, a giudicare dai dati disponibili, fino alla metà almeno del IV secolo d.C.31 Forme analoghe, ugualmente caratterizzate da un ingobbio rossastro all’interno, sono documentate a Isernia in contesti funerari di II secolo32. La presenza di prodotti importati nell’alifano sembra essere alquanto esigua e sembra ridursi a pochi esemplari di tegami a vernice “rossa interna” di provenienza vesuviana e/o flegrea33. Dalla metà/seconda metà del II secolo le fornaci alifane iniziano a produrre imitazioni della casseruola afri-cana Hayes 197 (Figg. 37-38), una forma destinata a rimanere in produzione in questi ateliers fino alla metà almeno del IV secolo34; è da osservare come nella città e nel suo territorio la presenza della ceramica africana da cucina sia particolarmente esigua e, in questo senso, le imitazioni del prototipo africano si potrebbero connotare come prodot-ti di sostituzione35. Tende invece ad esaurirsi la produzione delle pentole con orlo a tesa e fanno la comparsa nuove forme. In particolare è ben documentato un tipo di pentola (Figg. 39-40), il cui orlo morfologicamente evolve dagli orli a tesa del I secolo, che trova confronti nel Sannio interno (nel territorio dei Liguri Baebiani)36 e in area apula, a Ordona37. L’imitazione della casseruola Hayes 197 costituisce un fenomeno abbastanza diffuso che accomuna il territorio alifano alla Campania settentrionale costiera. Nell’ager Falernus, infatti, è ugualmente documentata già a partire dalla metà almeno del II secolo la produzione di casseruole che imitano il vasellame da cucina africano, cer-tamente la Hayes 23 e, contemporaneamente o in seguito, la Hayes 197; le officine falerne produrranno queste due forme almeno fino al IV-V secolo, producendo contestualmente anche ceramiche fini che imitano il coevo vasellame africano, in particolare, per quanto riguarda il II secolo, la forma Hayes 8 della sigillata africana A38. In termini più ge-nerali è da osservare come l’imitazione della casseruola Hayes 197 costituisca un fenomeno diffuso in Campania39 sebbene, al momento, una ricostruzione anche cronologica del fenomeno risulti difficile. Dati stratigrafici puntuali sono infatti offerti principalmente da Napoli, ma riguardano una fase ben più avanzata, poiché tali imitazioni, al momento, compaiono per la prima volta nelle stratigrafie del porto databili tra la fine del III e la seconda metà del IV secolo per poi perdurare fino alla fine del V-VI secolo40.
[G. S.]
Conclusioni
Ciò che sembra emergere nell’area presa in esame è l’esistenza di due tradizioni formali, l’una tirrenica, senz’altro più definita e standardizzata, elaborata all’interno di opifici specializzati o semi-specializzati, con prodotti che ten-denzialmente circolano anche sulla lunga distanza, l’altra – caratterizzante le aree interne – costituita da una pluralità di officine che utilizzano repertori formali diversi, sia pure con forti punti di contatto tra loro e più o meno pronte a recepire forme e modelli tirrenici. I dati relativi alla tradizione morfologica tirrenica consentono, grazie anche agli ultimi rinvenimenti da Liternum, di individuare almeno due fasi ben distinte: la prima, ormai pienamente formata nel II secolo a.C., vede le forme da cucina rappresentate essenzialmente dal tegame con incasso per il coperchio di tradizione ellenistica (la λοπάς) e l’olla con orlo a mandorla. Prima di questa fase sembra essere dominante un re-pertorio di tradizione indigena dai caratteri morfologici fortemente connotanti. Intorno alla metà del I secolo a.C. si osserva l’introduzione di un repertorio tipologico articolato in tre categorie formali: il tegame con orlo bifido, la pentola con orlo a tesa e l’olla con orlo inclinato, ciascuna con le sue limitate varianti. Questo sistema “tripartito” perdura in quest’area almeno fino a tutto il III e, forse, ancora nel IV secolo (se non nel V)41.Il repertorio delle officine alifane, ove da un lato si rielaborano in forme caratteristiche o semplicemente si ripro-ducono i prodotti tirrenici (e a partire dalla metà/seconda metà del II secolo anche quelli africani), dall’altro si fabbricano forme maggiormente ancorate al patrimonio morfologico dell’area appenninica, può esemplificare il comportamento di questa seconda tradizione formale. È da credere che questa trasmissione di manufatti e repertori formali, sulla breve e media distanza, sia avvenuta grazie ai circuiti nundinarii, reti di mercato locali interconnesse e integrate in sistemi più ampi, di cui quelli testimoniati appunto dagli indices di Allifae risultano centrati sulla baia di Napoli ed il Sannio pentro e, ancora, sull’area gravitante sull’ager Falernus e la Campania orientale - Sannio meridionale - Apulia settentrionale42.
[V. Di G., G. S.]
ESTRATTO
186 Vincenzo Di Giovanni, Gianluca Soricelli
NOTE
1 Cfr. Camodeca 2010 e Gargiulo 2008.2 Da un passo di Livio (23, 35,5) relativo agli sviluppi della guerra annibalica in questa parte della Campania antica si dedu-ce come il territorio di Liternum sia strettamente collegato con Capua. Si veda Camodeca 2010, p. 15. Sulla questione delle ter-ritorialità si vedano anche le osservazioni di Frederiksen 1984, pp. 268-271.3 Il materiale è in fase di studio e sarà pubblicato a cura del re-sponsabile scientifico dello scavo dott.ssa Patrizia Gargiulo e dallo scrivente nel volume “Ager Literninus. Ricerche Archeologi-che a Giugliano in Campania. Lo scavo per la centrale fotovoltaica a Masseria Monsignore”, in preparazione.4 Talamo 1987, pp. 115-116; Johannowsky 2000, pp. 16-19; Ca-lastri 2006, p. 193, nota 175 ed ivi bibl. Da ultimo, con maggiore precisione, Sirano 2008, p. 46. Uno dei centri di produzione di questi contenitori nel VI secolo sembra essere localizzato nei pressi di Trebula Balliensis (Albore Livadie 2009, p. 233, fig. 8, n. 2). Attestazioni dell’uso dello stesso modello morfologico per la ceramica d’impasto anche in altre aree della Campania, ad per esempio ad Avella (Cinquantaquattro 2006-2007, p. 160, fig. 20, nn. 7-8) e in Irpinia a Cairano (Bailo Modesti 1980, p. 51 e ss., tav. 40 a).5 Kirsopp Lake 1934-1935, p. 105, pl. XVII, n. 1 a, g.6 Tomeo 2008, p. 53 e ss., fig. 10, nn. 42-44.7 Benassai 2004, figg. 79-80, p. 125, terzo quarto del IV a.C.8 Di Giovanni 1995, p. 16, fig. 20.9 Tralascio per problemi di spazio l’interpretazione storica sul-le identificazioni delle varie identità culturali che interagiscono in questo momento su questa parte di territorio campano, ma è certamente da sottolineare come questo cambiamento non pos-sa non essere connesso con le fasi di romanizzazione del territo-rio e che l’innovazione morfologica, in un ambito così profon-damente tradizionale come la ceramica d’uso, possa essere stato indotto (forzato?) dal processo di acculturazione in atto. Trovo però altresì anacronistico pensare a questi processi in termini di egemonia e resistenza culturale.10 Per la discussione sulla classe cfr. Di Giovanni 1996, ed ivi bibl.11 Per le produzioni laziali cfr. Olcese 2003, p. 25 e ss.; per Pom-pei cfr. Cavassa 2009.12 Specificamente per la ceramica da cucina (in particolare per le pentole con orlo a tesa) cfr. per la Francia Pasqualini et al. 2009; per la Spagna Aguarod Otal 1991, pp. 61-94.13 Per una disamina preliminare su questi contesti si veda Di Giovanni 2003, p. 91 e ss., e Di Giovanni 2012.14 Purtroppo non esiste una tipologia unica di riferimento per questi prodotti, che hanno diversi luoghi di produzione e varia cronologia. Per la loro diffusione nei territori d’oltralpe di veda Pellegrino 2009 e per quanto riguarda alcune produzioni dell’A-sia Minore cfr. Di Giovanni 2007, p. 153 e ss.15 Per un’ampia discussione sulla classe cfr. Bonifay 2004, p. 107 e ss. Per la Campania cfr. Di Giovanni 2012.16 Carsana, Del Vecchio 2010, p. 461, fig. 6.26-27.17 Purtroppo il contesto è ancora inedito. Notizie sul rinveni-mento in Di Giovanni 2005, p. 19.18 De Stefano 2008, p. 101 e s., tav. XVI, tipo 3.
19 Dyson 1983, p. 112, fig. 39, nn. 4-7.20 Cotton 1979; Cotton, Metraux 1985; Arthur 1987.21 Gli esemplari illustrati sono stati raccolti in loc. Masseria Pa-gliare, Arthur 1991, p. 120, sito C42.22 Di Giovanni 1996, p. 72.23 Soricelli 2009.24 Di Giovanni 1996, p. 72, fig. 5, 1-3, 7; Arenella 2009, p. 9, tav. 4, 4-7.25 Bragantini 1991, p. 84, n. 414, fig. 37.26 Un esemplare molto vicino all’esemplare alifano proviene dalla villa della Gran Celsa (Arthur 1991, p. 122, sito S37), as-sociato ad imitazioni della terrina Hayes 8, in sigillata africana A, e ad altro materiale ceramico databile intorno alla metà del II secolo d.C.27 Cotton 1979, p. 163, fig. 55.11; Cotton, Metraux 1985, p. 232, fig. 59.1-2.28 Terzani, Matteini Chiari (a cura di) 1997, pp. 138-139, 73.1 (con datazione al I d.C.).29 Area vesuviana: Chiaramonte Treré 1984, pp. 162-163; Di Giovanni 1996, pp. 90-94, forme 2311 e 2312, fig. 19; Scatoz-za Höricht 1996, pp. 134-136, fig. 2, 1-5. Roma: Quercia 2008, pp. 201-202, tipi 17 e 18, fig. 2, con ulteriori confronti dall’area laziale.30 Soricelli 2009, p. 389.31 Di Giovanni 1996, p. 72, fig. 8.9; Arenella 2009, pp. 30-31, fig. 5.5-6.32 Terzani, Matteini Chiari (a cura di) 1997, pp. 90-91, 3.30, p. 103, 4.37 (datate entrambe al II d.C.).33 La presenza di tegami a vernice “rossa interna” di possibi-le provenienza cumana era già segnalata da Di Giovanni 1996, p. 72.34 Soricelli 2009, pp. 389-391.35 Si veda a riguardo Marazzi, Stanco 2010, p. 333, fig. 3: in un campione di ca. 205 frammenti da contesti scavati all’interno della città, quelli censiti come africana da cucina sono appena 3.36 La Rocca, Rescigno (a cura di) 2010, p. 285, fig. 12, A1C.37 De Stefano 2008, p. 105, tipo 11.3, tav. XVIII.38 Arthur 1987, p. 62. Imitazioni della Hayes 23 sono documen-tate tra i succitati materiali della villa della Gran Celsa (Arthur 1991, p. 122, sito S37) insieme a quelle della Hayes 197 e ad imi-tazioni delle scodelle Hayes 59, 61 e 104 in sigillata africana D a Cascano e a Masseria Dragone (Arthur 1991, pp. 118-119, siti C5, C19); l’imitazione della sola Hayes 197 e di lucerne africane della forma Hayes 1 a Masseria Starza (Arthur 1991, p. 119, sito C30); vd. anche Arthur 1998; Arthur, Soricelli c.s.39 Imitazioni della Hayes 197, in argille caratterizzate dalla pre-senza di inclusi piroclastici, sono segnalate anche a Pontelato-ne (Calastri 2006, pp. 167-168, fig. 166.7, sito n. 192), S. Maria a Vico (Carfora 2006, pp. 278-280, fig. 61.10-11, sito n. 33), Arienzo (Carfora 2006, pp. 297-303, fig. 81.27-29, sito n. 49), S. Felice a Cancello (Carfora 2006, pp. 330-331, fig. 122.5, sito n. 83). Un esemplare è segnalato da Pontecagnano (SA), come corredo in una sepoltura datata alla seconda metà del III d.C., Giglio 2004-2005, pp. 328-330, fig. 21.40 Carsana, Del Vecchio 2010, p. 461, fig. 6.26-27; Carsana 1994, p. 232, tipo 12, figg. 108-109; Ciarrocchi et al. 2010, p. 124, fig. 64.8-9.
ESTRATTO
Produzione e circolazione della ceramica da cucina nella Campania romana 187
41 Cfr. Carsana, Del Vecchio 2010, p. 461 ove si ricorda l’assen-za di questo tipo di pentola nei contesti napoletani di fine V-VI secolo.42 Ziccardi 2000, pp. 143-144. Vd. anche, in generale sul sistema delle nundinae in area campano-laziale, Storchi Marino 2000.
ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE
Aguarod Otal 1991: C. Aguarod Otal, Ceramica romana im-portada de cocina en la Tarraconense, Zaragozza.
Albore Livadie 2009: C. Albore Livadie, Un four de potier ar-chaïque prés de Treglia (Caserte - Comune di Pontelatone), in J.P. Brun (a cura di), Artisanat antiques d’Italie et de Gau-le. Mélanges offerts à Maria Francesca Buonaiuto, Naples, pp. 227-238.
Arenella 2009: A. Arenella, La ceramica da fuoco, in G. Sori-celli, E.A. Stanco (a cura di), Alife. L’anfiteatro romano, Pie-dimonte Matese.
Arthur 1987: P. Arthur, Produzione ceramica e agro falerno, in G. Guadagno (a cura di), Storia, economia ed architettura nell’Ager Falernus, Minturno, pp. 59-67.
Arthur 1991: P. Arthur, Romans in Northern Campania: Set-tlement and Land-use around the Massico and Garigliano Basin, London.
Arthur 1998: P. Arthur, Local pottery in Naples and Northern Campania in the sixth and seventh centuries, in L. Saguì (a cura di), Ceramica in Italia: VI-VII secolo, Firenze, pp. 491-510.
Arthur, Soricelli c.s.: P. Arthur, G. Soricelli, Produzione e cir-colazione della ceramica tra Campania settentrionale e area vesuviana in età tardo antica (IV-VI secolo d.C.), in Insedia-menti tardo antichi e medievali lungo l’Appia e la Traiana. Nuo-vi dati sulle produzioni ceramiche (S. Maria C. V., 23-24 marzo 2011), c.s.
Bailo Modesti 1980: G. Bailo Modesti, Cairano nell’età arcaica. L’abitato e la sua necropoli, in AION. Annali di Archeologia e Storia Antica Quad. 1, Napoli.
Benassai 2004: R. Benassai, S. Prisco: la necropoli capuana di IV e III secolo a.C., in L. Quilici (a cura di), Carta archeo-logica e ricerche in Campania (Atlante Tematico di Topografia Antica XV suppl., fasc. 2), Roma, pp. 73-226.
Bonifay 2004: M. Bonifay, Etudes sur la céramique tardive d’A-frique (BAR International Series 1301), Oxford.
Bragantini 1991: I. Bragantini, Ricerche archeologiche a Napo-li. Lo scavo di Palazzo Corigliano, Napoli.
Calastri 2006: G. Calastri, Il territorio di Trebula Balliensis, in L. Quilici (a cura di), Carta archeologica e ricerche in Campa-nia (Atlante Tematico di Topografia Antica XV suppl., fasc. 3), Roma, pp. 9-228.
Camodeca 2010: G. Camodeca, Regio I. Latium et Campania. Liternum, Supplementa Italica n.s, Roma.
Carfora 2006: P. Carfora, La valle di Ad Novas e i monti sopra-stanti, in L. Quilici (a cura di), Carta archeologica e ricerche in Campania (Atlante Tematico di Topografia Antica XV suppl., fasc. 3), Roma, pp. 229-376.
Carsana 1994: V. Carsana, Ceramica da cucina tardo antica e alto medievale, in P. Arthur (a cura di), Il Complesso Ar-cheologico di Carminiello ai Mannesi, Napoli (Scavi 1983-84), Bari, pp. 221-258.
Carsana, Del Vecchio 2010: V. Carsana, F. Del Vecchio, Il por-to di Neapolis in età tardo antica: il contesto di IV secolo d.C.,
in S. Menchelli et al. (a cura di), LRCW3. Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean: Archaeology and archaeometry. Comparison between western and eastern Mediterranean, Oxford, pp. 459-470.
Cavassa 2009: L. Cavassa, La production de céramique comu-ne a Pompéi. Un four de potier dans l’insula 5 de la regio I, in M. Pasqualini (a cura di), Les céramiques communes d’Italie et de Narbonnaise. Structure de production, typologies et contextes inédites (II siècle av. J.-C.- III siècle apr. J.-C.). Actes de la Table Ronde (Naples, 2-3 novembre 2006), Naples 2009, pp. 95-104.
Chiaramonte Treré 1984: C. Chiaramonte Treré, Ceramica grezza e depurata, M. Bonghi Jovino (ed.), Ricerche a Pom-pei: l’insula 5 della regio VI dalle origini al 79 d.C., Roma, pp. 140-193.
Ciarrocchi et al. 2010: B. Ciarrocchi et al., I materiali dai li-velli Tardoantichi a quelli Moderni, in I. Baldassarre et al. (a cura di), Il teatro di Neapolis - Scavo e recupero urbano, in AION. Annali di Archeologia e Storia Antica Quad. 19, pp. 105-150.
Cinquantaquattro 2006-2007: T. Cinquantaquattro, Rituale funerario e dinamiche di genere nel mondo indigeno della “mesogaia” campana: note di topografia, in AION. Annali di Archeologia e Storia Antica Quad. 13-14, pp. 11-134.
Cotton 1979: M.A. Cotton, The Late Republican Villa at Posto Francolise, London.
Cotton, Metraux 1985: M.A. Cotton, G. Metraux, The San Rocco Villa at Francolise, London.
De Stefano 2008: A. De Stefano, Un contesto ceramico di età repubblicana e primo/medio imperiale dall’area delle due domus, in G. Volpe, D. Leone (a cura di), ORDONA XI. Ri-cerche archeologiche a Herdonia, Bari, pp. 45-144.
Di Giovanni 1995: V. Di Giovanni, Le urne cinerarie, in G. Ga-speretti (a cura di), Da Sidicini a Romani. La necropoli di Orto Ceraso. Mostra di materiali archeologici dai nuovi scavi. Soprin-tendenza Archeologica per le province di Napoli e Caserta e Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli, pp. 15-18.
Di Giovanni 1996: V. Di Giovanni, Produzione e consumo di ceramica da cucina nella Campania romana (II a.C. - II d.C.), in M. Bats (dir.), Les céramique communes de Campanie et de Narbonnaise (Ier av. J.-C. – IIe s. ap. J.-C.). La vaisselle de cui-sine et de table. Actes des Journées d’étude organisées par le Centre Jean Bérard et la Soprintendenza Archeologica per le Province di Napoli e Caserta (Naples, 27-28 mai 1994), Naples 1996, pp. 65-103.
Di Giovanni 2003: V. Di Giovanni, Appunti sulla ceramica da fuoco, in L. Crimaco, V. Di Giovanni, F. Garcea, L.M. Proiet-ti, B.M. Sgherzi, L’impianto fognario sottoposto al settore ovest del decumano di via Duomo, in L. Crimaco, C. Gialanella, F. Zevi (a cura di), Da Puteoli a Pozzuoli. Scavi e ricerche sulla rocca del Rione Terra. Atti della giornata di studio (Istituto Germanico di Roma, 27 aprile 2001), Napoli 2003, pp. 86-91.
Di Giovanni 2005: V. Di Giovanni, Conza della Campania, L’area del Foro romano, Notiziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno, Avellino e Benevento 1, p. 19 -22.
Di Giovanni 2007: V. Di Giovanni, La ceramica romana e tardo antica di Kyme. Osservazioni preliminari sui materiali dagli scavi dell’Università di Napoli “Federico II” (Campagne 2003-2006), in L.A. Scatozza Höricht (a cura di), L’Eolide da Augusto a Costantino. Atti del Convegno (Napoli, dicem-bre 2005), Napoli 2007, pp. 141- 173.
ESTRATTO
188 Vincenzo Di Giovanni, Gianluca Soricelli
Di Giovanni 2012: V. Di Giovanni, Le dinamiche degli scam-bi economici nella Campania in età imperiale. Importazio-ni e circolazione delle produzioni africane: ceramiche fini, anfore da trasporto e ceramiche da cucina, in M. B. Cocco, A. Gavini, A. Ibba (a cura di), L’Africa Romana XIX (Sassari 2010), Roma 2012, pp. 1475-1503.
Dyson 1983: S.L. Dyson, The Roman Villas of Buccino. Wesleyan University Excavation in Buccino, Italy, 1969-1972 (BAR International Series 187), Oxford.
Frederiksen 1984: M. Fredericksen, Campania, Hertford. Gargiulo 2008: P. Gargiulo, Liternum in P. Miniero (a cura di),
Catalogo Generale del Museo Archeologico dei Campi Fle-grei, vol. 3, Napoli, pp. 9-53.
Giglio 2004-2005: M. Giglio, L’occupazione dell’Ager Picenti-nus in epoca imperiale alla luce dei nuovi dati dalla necropoli Colucci, in AION. Annali di Archeologia e Storia Antica Quad. 11-12, pp. 301-349.
Johannowsky 2000: W. Johannowsky, Presenzano. Necropoli in località Rebbia, in Studi sull’Italia dei Sanniti, Roma, pp. 16-19.
Kirsopp Lake 1934-1935: A. Kirsopp Lake, Campana Sup-pellex. The Pottery Deposit at Minturnae, in Bollettino dell’Associazione Internazionale di Studi Mediterranei 4-8, pp. 97-114.
La Rocca, Rescigno (a cura di) 2010: L. La Rocca, C. Resci-gno (a cura di), Carta archeologica del comune di Morcone e del percorso beneventano del Regio Tratturo, Salerno.
Marazzi, Stanco 2010: F. Marazzi, E.A. Stanco, Alife. Dalla co-lonia romana al gastaldato longobardo. Un progetto di lettu-ra interdisciplinare delle emergenze storico-archeologiche, in G. Volpe, R. Giuliani (a cura di), Paesaggi ed insediamenti urbani in Italia Meridionale fra Tardoantico e Altomedioevo. Atti del Secondo Seminario sul Tardoantico e l’Altomedioe-vo in Italia Meridionale (Foggia – Monte Sant’Angelo, 27-28 maggio 2006), Bari 2010, pp. 329-347.
Olcese 2003: G. Olcese, Ceramiche comuni a Roma e in aera romana: produzione, circolazione e tecnologia (tarda età reppublicana-prima età imperiale) (Documenti di archeologia 28), Mantova.
Pasqualini et al. 2009: M. Pasqualini, A. Pasqualini, C. Pasqua-lini, Cèramiques communes importées d’Italie en Provence II siécle av. n.e. / III siécle de n.e., in M. Pasqualini (a cura di), Les céramiques communes d’Italie et de Narbonnaise. Struc-ture de production, typologies et contextes inédites (II siècle av. J.-C.- III siècle apr. J.-C.). Actes de la Table Ronde (Naples, 2-3 novembre 2006), Naples 2009, pp. 283-301.
Pellegrino 2009: E. Pellegrino, Les céramiques comune d’ori-
gine orientale dans le Sud de la Gaule au Haut-Empire. Le gobelet Marabini LXVII, in M. Pasqualini (a cura di), Les céramiques communes d’Italie et de Narbonnaise. Structure de production, typologies et contextes inédites (II siècle av. J.-C.- III siècle apr. J.-C.). Actes de la Table Ronde (Naples, 2-3 no-vembre 2006), Naples 2009, pp. 251-283.
Quercia 2008: A. Quercia, Le ceramiche comuni di età romana, in F. Filippi (a cura di), Horti et Sordes. Uno scavo alle falde del Gianicolo, Roma, pp. 197-232.
Scatozza Höricht 1996: L. Scatozza Höricht, Appunti sulla ceramica comune di Ercolano. Vasellame da cucina e reci-pienti per la preparazione degli alimenti, in M. Bats (dir.), Les céramique communes de Campanie et de Narbonnaise (Ier av. J.-C. – IIe s. ap. J.-C.). La vaisselle de cuisine et de table. Actes des Journées d’étude organisées par le Centre Jean Bérard et la Soprintendenza Archeologica per le Province di Napoli e Caserta (Naples, 27-28 mai 1994), Naples 1996, pp. 129-156.
Sirano 2008: F. Sirano, Identità culturali nella Campania setten-trionale: un aggiornamento, in C. Corsi, E. Polito, Dalle Sor-genti alla foce. Il bacino del Liri Garigliano nell’antichità. Cul-ture contatti scambi. Atti del Convegno (Frosinone – Formia 10-12 novembre 2005), Roma 2008, pp. 37- 59.
Soricelli 2009: G. Soricelli, Allifae: produzione e circolazione ceramica nella prima età imperiale. Alcune note preliminari, in Oebalus. Studi sulla Campania nell’Antichità 4, pp. 385-393.
Storchi Marino 2000: A. Storchi Marino, Reti interregionali integrate e circuiti di mercato periodico negli indices nundi-narii del Lazio e della Campania, in E. Lo Cascio (a cura di), Mercati permanenti e mercati periodici nel mondo romano, Bari, pp. 93-130.
Talamo 1987: P.F. Talamo, L’area Aurunca nel quadro nell’Ita-lia centromeridionale. Testimonianze archeologiche di età arcaica (BAR International Series 384), Oxford.
Terzani, Matteini Chiari (a cura di) 1997: C. Terzani, M. Mat-teini Chiari (a cura di), Isernia. La necropoli romana in loca-lità Quadrella, Roma.
Tomeo 2008: A. Tomeo, Doni votivi e suppellettili nel comples-so cultuale a S/E del Foro di Cuma, in G. Greco, B. Ferrara, Doni agli Dei. Il sitema dei doni votivi nei santuari. Atti del Se-minario di Studi (Napoli, 21 aprile 2006), Pozzuoli 2008, pp. 49-74.
Ziccardi 2000: A. Ziccardi, Il ruolo dei circuiti di mercati pe-riodici nell’ambito del sistema di scambio, in E. Lo Cascio (a cura di), Mercati permanenti e mercati periodici nel mondo romano, Bari, pp. 131-148.
ESTRATTO