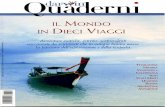Tra il dire e il fare. Pellegrino Artusi e la scienza sociale in cucina versus liste vertiginose,...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Tra il dire e il fare. Pellegrino Artusi e la scienza sociale in cucina versus liste vertiginose,...
1
Tra il dire e il fare. Simone Fagioli
Opificio Toscano di Economia, Politica e Storia – Firenze – Italia
Parole chiave: Pellegrino Artusi, Forlimpopoli, Firenze, Paolo Mantegazza, Paolo Gorini, cucina, alimentazione,
positivismo, pedagogia.
Pellegrino Artusi e la scienza sociale in cucina
versus liste vertiginose, ricette di casa e ricevute ritrovate.
Artusi, per antonomasia libro di cucina. Che gloria! Il libro che diventa nome! A quanti letterati toccò
tale sorte? Era l'Artusi di Forlimpopoli (1821-91), banchiere, cuoco, bizzarro, caro signore, e molto
benefico, come dimostrò nel suo testamento; e il suo trattato è scritto in buon italiano. E non era letterato
né professore; v. Glassare1.
A. Panzini, Dizionario Moderno, Hoepli, Milano, 1931, ad vocem.
1. Premessa
Pellegrino Artusi nel 1891 pubblica a proprie spese la prima edizione de La scienza in cucina e
l'arte di mangiar bene, che negli anni correggerà e incrementerà di edizione in edizione, sino
all'ultima, la 14ª del 1911, con 790 ricette (la prima ne aveva 475)2.
Il volume non è un ricettario come oggi se ne trovano a centinaia sugli scaffali di ogni libreria e
come già se ne trovavano nell’Ottocento3, è un trattato di scienza applicata alla preparazione del
cibo, dove le ricette sono il coronamento di analisi ben più articolate di semplici liste
d’ingredienti, seppur qui indicate con esatte dosi 4 e la loro presentazione è un progetto
pedagogico.
Artusi – Forlimpopoli, 4 agosto 1820 – Firenze, 30 marzo 1911 - è il perfetto figlio di quel
positivismo che dalla seconda metà dell'Ottocento prende sempre più campo anche in Italia,
proponendosi come religione laica in una nazione in rapido mutamento5.
Come faceva notare Panzini comunque, Artusi anziché uomo è libro, in un corto circuito che ad
esempio fa passare sotto il silenzio della stampa la sua morte a fine marzo 19116.
1 “Glassare, versione fonetica del francese glacer = gelare: verbo usato nel linguaggio culinario e significa, couvrir
de gelée, cioè cospargere dolci e carni di una specie di gelatina che li rende più vistosi: quindi il bue glassato,
coppa glassata, ecc. Pellegrino Artusi, nel citato manuale di culinaria, scritto con grazia nostrana e purezza di
lingua da far arrossire molti testi scolastici, propone in tal senso le voci crosta e crostare. Ma forse non gli soccorse
l'antica nostra parola biuta, che udii viva nel popolo”, A. Panzini, Dizionario Moderno, Hoepli, Milano, 1905, ad
vocem. 2 Si citeranno di volta in volta le edizioni utili all’analisi. L’ultima edizione curata da Artusi vivente (1910) e
utilizzata come riferimento è: La scienza in cucina e l’Arte di mangiar bene. Manuale pratico per le famiglie
compilato da Pellegrino Artusi. 790 ricette. In appendice “La Cucina per gli stomachi deboli”. Un ritratto
dell’Autore, Firenze, Landi, 1911. 3 In breve G. Nelli, Il re dei cuochi, Milano, Legros, 1868; F. Palma, Il re dei cuochi, Milano, Legros 1868, F. Palma,
Il principe dei cuochi, Napoli, Eschena, 1881; G. Belloni, Il vero re dei cucinieri, Milano, Cioffi, 1890; V. Bossi – E.
Salvi, L’imperatore dei cuochi, Roma, Perino 1894-1895. 4 Quest’aspetto che oggi appare scontato è nel lavoro di Artusi una novità metodologica, che ci mostra anche nella
minuzia delle dosi, 30 gr, 40 gr, una precisione “da laboratorio”. 5 Cfr. R. Ardigò, Il positivismo e l'identità pedagogica del nuovo stato unitario, a cura di T. Pironi, Bologna, Clueb,
2000.
2
Oggi, nel 2015 a occhio disattento le sue osservazioni intercalate alle ricette sembrano discorsi
pedanti, da saltare a piè pari o addirittura da cancellare:
Manuale pratico princeps della cucina italiana (il primo perché pubblicato nell'ormai lontano 1891, e il
principale perché a tutt'oggi insuperato per la qualità delle ricette e la semplicità e l'esattezza delle
indicazioni), il volume di Pellegrino Artusi è stato il maestro gastronomico di nonne, zie e mamme, è stato
consigliato da medici e dietisti per i precetti di igiene della tavola che fornisce e, infine, ha sempre goduto
del favore degli esperti di cucina. Tuttavia, con l'avvento delle nuove tecniche culinarie e con il
semplificarsi del gusto, l'opera aveva perduto quelle sue caratteristiche peculiari di praticità e facilità,
venendo così a poco a poco limitata (anche per il suo linguaggio "fiorito" e decisamente antiquato e per le
storielline e gli aneddoti di cui era infarcita) a una ristretta cerchia di amanti del vecchio e del curioso. In
questa edizione, pur mantenendo intatto nella sua sostanza il testo originale, gli si è voluto dare una forma
moderna, agile e scorrevole, e si è provveduto a uniformarlo alle esigenze della cucina attuale. È nato così
il Nuovo Artusi, pronto a riportare "la scienza in cucina" secondo le tecniche più aggiornate e a svelare
ancora una volta a tutti "l'arte di mangiar bene"7.
La nota evidenzia, oltre l’uso di un italiano traballante, come dell’autore si abbia una percezione
confusa e riduttiva, che lo incasella rozzamente tra pentole e fornelli quando il suo progetto di
ricerca, perché di questo si tratta, ha solide basi antropologiche e sociali8.
Senza voler scomodare a posteriori autori rilevanti che hanno approfondito i temi del cibo in
senso ampio ma in ogni caso troppo distanti dalla personalità del commerciante romagnolo9,
l’analisi della sua opera principale10 si può dipanare più sul concetto di cucina11 che su quello di
alimentazione12, cucina fisica, per Artusi laboratorio “chimico” e non luogo di distrazione o di
obbligo, in cui le materie grezze si trasformano tramite esperimenti 13 e l’alimentazione è
un’analisi fisiologica sulla linea ad esempio di Paolo Mantegazza14.
Provava le sue ricette? Tutte! E talvolta riuscivano e talvolta no. Per il cappone in vescica, per esempio,
sciupò 8 capponi. Finché un piatto non risultava quale egli lo voleva, lo manipolava, provava riprovava,
senza mai rinunziare. Ed alla fine ne conseguiva il premio desiderato: la nuova ricetta. Erano prove
6 Ho condotto ricerche su “La Nazione” di Firenze e “La Stampa” di Torino ma senza esito. 7 Dalla pagina di IBS di P. Artusi, Il nuovo Artusi. L’arte di mangiare bene, Milano, Mursia, 2007,
http://www.ibs.it/code/9788842537410/artusi-pellegrino/nuovo-artusi-arte.html [verificato 22 giugno 2015]. 8 Un primo inquadramento in questa direzione lo propone Piero Camporesi nel 1970, cfr. P. Artusi, La scienza in
cucina e l’arte di mangiar bene, a cura di P. Camporesi, Torino, Einaudi, 1970. 9 Mi vengono in mente le analisi sulla dualità crudo/cotto (e in senso più ampio su natura/cultura) di Claude Levi-
Strauss, cfr. Il crudo e il cotto, Milano, Il Saggiatore, 1966 (ed. or. 1964); Idem, Dal miele alle ceneri, Milano, Il
Saggiatore, 1970 (ed. or. 1967); Idem, L’origine delle buone maniere a tavola, Milano, Il Saggiatore, 1971 (ed. or.
1968). 10 Artusi è anche autore di due opere di critica letteraria: P. Artusi, Vita di Ugo Foscolo. Note al carme dei Sepolcri.
Ristampa del Viaggio sentimentale di Yorick tradotto da Didimo Chierico, Firenze, Barbèra, 1878; Idem,
Osservazioni in appendice a trenta lettere di Giuseppe Giusti, Firenze, G. Barbèra, 1881. 11 Cfr. J-P. Aron, Cucina, in Enciclopedia. 4. Costituzione-Divinazione, Torino, Einaudi, 1978, pp. 215-237. Cfr.
anche B. Wilson, In punta di forchetta. Storie di invenzione in cucina, Milano, Rizzoli, 2013. 12 Cfr. R. Valeri, Alimentazione, in Enciclopedia. 1. Abaco-Astronomia, Torino, Einaudi, 1977, pp. 344-361. 13 Lo sperimentalismo di Artusi in questo senso risente di un retaggio alchemico, dove la materia grezza tende
all’oro, qui il “mangiar bene”. 14 Paolo Mantegazza, Monza, 31 ottobre 1831 – San Terenzo, 28 agosto 1910, medico, fisiologo, antropologo,
divulgatore.
3
costose! Sì, molto. Ma le soddisfazioni che provava lo ricompensavano. La cucina era per lui un campo
d’azione. Un luogo di studio15.
In questo senso Artusi può essere assimilato a Paolo Gorini16, noto per aver provato nel 1872 a
“pietrificare” il corpo di Giuseppe Mazzini17. Le prime esperienze di Gorini in quest’ambito
risalgono al 1842 e sono strutturate con procedimenti certo non distanti da quelli di Artusi in
cucina. Le sue norme di conservazione dei cadaveri infatti si avvalgono di ricette (tenute segrete)
e di schemi sperimentali accuratamente pianificati18. Il modello positivista è mutatis mutandis il
medesimo - e l’opuscolo di Gorini citato in nota ne offre un chiaro esempio -: gli otto capponi in
vescica sacrificati da Artusi valgono per il bene della scienza come le teste o gli arti dei contadini
lodigiani trasformati da Gorini.
Oggi per certi aspetti il tema della sperimentazione in cucina, operazione chimica, sembra essere
stato assimilato in senso generale, giacché se ne trovano cenni anche in ambito letterario
popolare:
Il cuoco era bel mezzo di una fumata infernale, sei padelle sul fuoco contemporaneamente. Bordelli
assisteva divertito alla trasformazione della materia. Un pezzo di burro, un po’ di carne e qualche altra
cosa da nulla diventavano piacere per la lingua19.
15 Intervista a Marietta Sabatini, la fida assistente di Artusi: R. Simonetta, Parliamo di Pellegrino Artusi, “La cucina
Italiana”, A. IV, n. 2, 15 febbraio 1932, p. 1. In corsivo le domande della giornalista. 16 Paolo Gorini, Pavia, 28 gennaio 1813 – Lodi, 2 febbraio 1881, matematico e geologo, noto per le sue preparazioni
“pietrificate” di cadaveri e parti di corpi umani ed animali. 17 Cfr. La conservazione della salma di Giuseppe Mazzini. Notizie fornite da Paolo Gorini, Genova, Tipografia del
R. Istituto Sordo-Muti, 1873; per un inquadramento politico cfr. S. Luzzatto, La mummia della Repubblica. Storia di
Mazzini imbalsamato, 1872-1946, Milano, Rizzoli, 2001. 18 C. Belloni, Il corpo di Mazzini intatto: trovata la formula segreta. Così lo scienziato Gorini pietrificava le salme,
“Corriere della sera”, 1 febbraio 2007, p. 12. 19 M. Vichi, Il nuovo venuto. Un’indagine del commissario Bordelli, Parma, Guanda, 2004, p. 30. Nei numerosi
volumi del commissario Bordelli ideato da Marco Vichi la cucina è un tema portante, che torna anche con troppa
frequenza. Nel romanzo La forza del destino (Parma, Guanda, 2011) poi tra i protagonisti veri e propri c’è anche un
ricettario, con ricette postillate alla maniera di Artusi. È solo uno dei tanti casi in cui cucina e letteratura si
mescolano.
4
2. Casa dolce casa.
Non è questo il luogo per proporre una biografia di Artusi, in verità ancora da scrivere nei
dettagli, nonostante gli studi sull’autore in costante crescita20, tuttavia è utile esporre alcune
riflessioni sulla sua figura frutto di osservazione sul campo più che di analisi di documenti.
Ho visitato Forlimpopoli il 14 ed il 18 giugno 2015, a ridosso della Festa Artusiana 2015.
L’immagine che se ne ricava è che Pellegrino Artusi sta a Forlimpopoli come Dino Campana a
Marradi: due esuli che forzatamente di tanto in tanto sono riportati a casa a spiegare i propri
progetti di vita davanti ad un pubblico distratto ed attonito21.
Nacqui a Forlimpopoli il 20 agosto del 182022 da Agostino e da Teresa Giunchi nata da buona famiglia di
Bertinoro. Mio nonno, Francesco, esercitava l’arte del muratore e quale capomastro il più capace nel suo
paese godeva stima nell’arte sua e lasciò morendo due case e dei quattrinelli. Nell’arte medesima aveva
iniziato mio padre, ma egli sentendosi forse nato a fare qualcosa di meglio e una gran voglia di industriarsi
e di slanciarsi nel mondo in cerca di una fortuna, giunto all’età di 18 anni, gettò in un canto la martellina,
lo sparviere, la cazzuola ed il giornello, che conservò sempre come ricordo, e prese moglie23.
Questo sintetico ritratto di famiglia introduce due aspetti che ci permettono di valutare la sua
immagine oggi, dal 1911 riflesso di eredità non solo materiali, le case ed i “quattrinelli”, ma
anche “immagine”, nel lungo periodo.
La casa natale di Artusi a Forlimpopoli oggi non esiste più. È stata abbattuta nel marzo 1961 e
con il senno di poi questo evento è vissuto nella cittadina, che ha fatto da alcuni anni del nome di
Artusi un vanto (si definisce “Città artusiana”), come una ferita insanabile alla quale è
impossibile porre rimedio24.
Al suo posto in piazza Garibaldi oggi c’è un palazzetto di modeste pretese, con sotto il portico
una lapide in memoria di Pellegrino soffocata da un gigantesco bancomat, dove l’insegna
BANCOMAT – BANCA NON STOP è più incombente della lapide stessa in un contrasto ben
oltre il ridicolo.
La lapide vorrebbe essere aulica, scritta in caratteri latini capitali:
IV – VIII - MDCCCXX XXX- III – MCMXI
PELLEGRINO ARTVSI –INTRO
DVCENDO LA SCIENZA IN CVCI
NA – CON LE GRAZIE DEL BEL
LO SCRIVERE – NOBILITÒ L’ARTE
DI MANGIAR BENE – DI SÉ E DEL
LA VMANITÀ – TESTANDO AI PO
VERI25 – IN VITA E IN MORTE – BE
NEMERITO – I FORLIMPOPOLESI
XIV SETTEMBRE XCMLXI26
20 Il paese natale, Forlimpopoli, dal 1997, dedica al Nostro la “Festa artusiana” che comprende anche incontri dove la
sua figura è analizzata e approfondita. La maggior parte degli atti di questi incontri è disponibile on line. 21 In realtà ci sono altre similitudini tra Artusi e Campana: la loro formazione ad esempio, irregolare e autonoma. 22 In realtà il 4. 23 P. Artusi, Tutto vi dono. Autobiografia del padre della cucina italiana, a cura di A. Abruzzese e A. Pollarini,
Milano, Il Saggiatore, 2012, p. 20. 24 Sulle vicende, anche fisiche, della casa di Artusi cfr. T. Aldini, La casa natale di Pellegrino Artusi, Forlimpopoli,
Nuova Tipografia, 2002. 25 Facendo testamento in favore dei poveri.
5
Il tutto impreziosito da un ritratto del Benemerito, decori floreali a guisa di cornucopie e la
copertina nel noto libro retta da due putti.
Intendiamoci, la casa era stata venduta dagli Artusi nel 1852, quando lasciano definitivamente la
Romagna per Firenze, non era dunque nell’eredità fisica di Pellegrino. La data sulla lapide
tuttavia, 14 settembre 1961 che scritta in grevi caratteri latini sembra così lontana, così fuori
tempo, marca i cinquanta anni dalla morte dell’Artusi e dunque la liberazione dei diritti d’autore
della Scienza, lasciati alla fida assistente di cucina Marietta Sabatini ed al segretario Francesco
Ruffilli e non alla selva dei nipoti e pronipoti, in uno smacco che escludeva la città natale
parzialmente risarcita con la donazione della biblioteca e dell’archivio e di un lascito per un asilo.
La lapide, la data, ed anche un primo approccio storiografico27, segnano la riappropriazione da
parte di Forlimpopoli della memoria e dell’immagine dell’illustre figlio esule, ma marcano anche
con la demolizione della casa natale, una ristrutturazione della sua figura, un primitivo e direi
involontario progetto di marketing territoriale che vuole unire in modo permanente Artusi, la
Scienza e Forlimpopoli, anche se nel 1916 c’era già stato un illustre precedente che vedremo in
seguito.
A Firenze, dove la famiglia Artusi, è bene ribadirlo, si trasferisce definitivamente dal 1852, il loro
percorso abitativo è articolato e noto28, seppur l’abitazione più rilevante sia quella di piazza
d’Azeglio 25 (oggi 35), dove Pellegrino abita all’incirca dal 1870 e dove elabora la Scienza.
La palazzina, costruita tra il 1869 ed il 1870, nell’ambito dei progetti di espansione della città per
Firenze Capitale su disegno dell’ingegner Nemes Martelli29 è divisa in due appartamenti, uno
dove abitava Artusi e l’altro dove abitò sino al 1898 il politico Piero Puccioni, anche lui ricordato
da una lapide sulla facciata posta nel 192430.
Ed appunto anche qui naturalmente non manca una lapide per Pellegrino:
I CITTADINI DI FIRENZE
E DELLA NATIVA FORLIMPOPOLI
SI UNISCONO NEL RICORDARE
PELLEGRINO ARTUSI
CHE QUI LUNGAMENTE OPERO’
E MORI’ IL 30 MARZO 1911.
LETTERATO GASTRONOMO BENEFATTORE
IN QUESTA CITTA’ DI ADOZIONE
DETTE UNITA’ ITALIANA
ALLA VARIETA’ LINGUISTICA REGIONALE
NEL SUO CELEBRE LIBRO
“LA SCIENZA IN CUCINA
E L’ARTE DI MANGIAR BENE”
FIRENZE, 29 MAGGIO 1994
26 Il testo è opera del parroco don Ugo Venturi. 27 Cfr. “Forum Popili. Pagine di storia e di vita cittadina”, Primo quaderno, Forlimpopoli settembre 1961. 28 Cfr. P. Artusi, Tutto vi dono, cit., testo di Artusi e appendice dei curatori. 29 Ingegnere di un certo rilievo, operante soprattutto a Firenze negli anni della Capitale, autore di alcuni manuali
tecnici. 30 Piero Puccioni, Firenze 2 settembre 1833 – Firenze, 5 aprile 1898, avvocato, politico, giornalista, cofondatore e
direttore de “La Nazione”, deputato dal 1865 e senatore dal 1886.
6
IL COMUNE DI FIRENZE
IL COMUNE DI FORLIMPOPOLI
L’ACCADEMIA ARTUSIANA DI FORLIMPOPOLI
Se la lapide sulla casa natale ci pare stantia questa va completamente fuori tema, celebrando
Artusi come linguista: la Scienza è ovviamente scritta in italiano ma senza porre accento alla
diversità nazionale in cucina, uniformando dunque i gusti più che la lingua31. Se quel linguistica
fosse sostituito con culinaria le cose andrebbero a posto.
Nel 1911 il nostro Artusi muore e come tutti i grandi cittadini, grandi di censo, è sepolto al
cimitero delle Porte Sante, San Miniato al Monte, non in una cappella, era da solo32, bensì in una
tomba terragna, dove nel 1916 l’amministrazione comunale di Forlimpopoli fa porre un busto del
Nostro realizzato dallo scultore Italo Vagnetti33.
Ecco dunque che la città natale, nel suo organo più ufficiale, il Comune, inizia l’opera di
avvicinamento ad Artusi, con l’appropriazione della forma più rilevante di memoria, quella
funebre, quasi un rimando alla traslazione delle spoglie di Foscolo da Londra a Firenze, della
quale Artusi aveva scritto ed alla sua esegesi de I sepolcri.
Queste considerazioni senza dubbio ci sono utili per un inquadramento del personaggio Artusi
più che del suo libro ma ci mostrano come a posteriori, sin da un breve volgere di anni dalla sua
morte, si tenti di riequilibrare uomo ed opera, senza tuttavia riuscirci: Artusi resta libro sin
almeno agli anni Settanta ed all’analisi di Piero Camporesi.
31 Cfr. M. Montanari, L’identità italiana in cucina, Roma – Bari, Laterza, 2010, pp. 56-62. 32 La cara Marietta sarà sepolta nel più popolare cimitero di Trespiano, di Ruffilli si perdono le tracce post mortem. 33 Italo Vagnetti, Firenze, 19 luglio 1864 – Firenze, 1933, scultore, medaglista, autore del busto di Bettino Ricasoli
per il Senato, quello di Ubaldino Peruzzi (al cimitero di Antella), del monumento di Giotto a Vicchio (1901). Le
2.000 lire deliberate per il monumento, che oggi versa in condizioni non ottimali ed avrebbe bisogno di un restauro,
vennero prelevate dall’amministrazione comunale di Forlimpopoli dal lascito Artusi.
7
3. La scienza sociale in cucina.
Pellegrino Artusi nel 1865 con l’arrivo della Capitale a Firenze a cinquantacinque anni si colloca
volontariamente in pensione, cessando il commercio della seta e il banco34:
Potei allora dedicarmi più liberamente ai miei studi geniali e frequentar lezioni che allora erano pubbliche.
Così ottenevo il doppio scopo di ammazzare, come suol dirsi, il tempo e di tenere occupata la mente
essendo cosa pericolosa, dopo un’assidua occupazione di molti anni il darsi a un’inazione completa35.
Le lezioni che segue sono soprattutto quelle di Paolo Mantegazza36, che a Firenze dal 1869 tiene
la prima cattedra italiana di Antropologia, indirizzata più in ambito culturale e fonda la Società
italiana di antropologia ed etnologia, della quale Artusi era socio37.
Il Nostro nella sua biblioteca possedeva di Mantegazza il volume Elementi d’igiene, nella
seconda38 e nella terza39 edizione, ma non come si potrebbe supporre Igiene della cucina40 e il
Piccolo dizionario della cucina41, ciò non esclude tuttavia che avesse avuto la possibilità di
leggerli.
Oltre la mitologia i rapporti Artusi/Mantegazza sono di natura puramente accademica, da docente
a uditore e la loro corrispondenza è ridotta al minimo42, seppur il Mantegazza stimasse Artusi ed
il suo lavoro e viceversa:
Finalmente dopo tante bastonature, sorse spontaneamente un uomo di genio a perorar la mia causa. Il
professor Paolo Mantegazza, con quell'intuito pronto e sicuro che lo distingueva, conobbe subito che quel
mio lavoro qualche merito lo aveva, potendo esser utile alle famiglie; e, rallegrandosi meco, disse: — Col
darci questo libro voi avete fatto un'opera buona e perciò vi auguro cento edizioni.
— Troppe, troppe! –; risposi –; sarei contento di due. –; Poi con molta mia meraviglia e sorpresa, che mi
confusero, lo elogiò e lo raccomandò all'uditorio in due delle sue conferenze43.
Il tema rilevante qui tuttavia non sono in specifico i loro rapporti, ma il clima che Artusi assorbe
in una Firenze che per il breve periodo della Capitale è con ancora più forza un centro di studi e
riflessioni di ampio respiro.
34 Sull’Artusi banchiere si hanno pochi dati, in pratica quello che ci dice nella citata autobiografia: Nel suo archivio
conservato per lascito testamentario a Forlimpopoli non abbiamo documenti in merito, una lacuna senza dubbio
grave per un tema non certo secondario della sua formazione. En passant cfr. Guida civile amministrativa
commerciale della città di Firenze, Firenze, Tofani, 1862: “Sensali di sete. Artusi Agostino, canto alla Paglia”, p.
321. 35 P. Artusi, Tutto vi dono, cit., p. 101. 36 Anche se nel suo Archivio conservato a Forlimpopoli sono presenti quaderni di appunti di geologia, zoologia,
“storia naturale”, Pellegrino Artusi, C. Autografi delle opere, b. Opere scientifiche, cfr. N. M. Liverani, Inventario
dell’Archivio Pellegrino Artusi, Forlimpopoli, Cooperativa Agri Artigian Consult, 1991. 37 Cfr. ad esempio “Archivio per l’antropologia e la etnologia. Organo della Società italiana di antropologia,
etnologia e psicologia comparata”, V. XXIV, 1894, p. 14, Soci ordinari. 38 Milano, Brigola, 1865. 39 Milano, Brigola, 1867. 40 Milano, Brigola, 1866. 41 Milano, Brigola, 1882. 42 Nell’Archivio di Mantegazza, conservato a Firenze nella biblioteca dell’Istituto di Antropologia è presente solo
una lettera di Artusi, mentre in quello Artusi a Forlimpopoli non si hanno lettere di Mantegazza. 43 Si cita dalla 14ª edizione (1910), p. 7.
8
Ragionevolmente nelle lezioni di Mantegazza Artusi vedeva più un impianto pedagogico, tema
che costituisce l’ossatura del suo lavoro principale, il sostegno del suo pensiero anche trattando di
Foscolo e di Giusti, una pedagogia positivista, fisica, concreta, materiale44.
Nella sua biblioteca troviamo anche quattro volumi di un altro autore che rafforzano la sua
visione antropologica e didattica. Si tratta delle opere di Michele Lessona45 di maggior valore
divulgativo46, che probabilmente indirizzano Artusi nella parte più “scientifica” del suo lavoro,
come narrazione, esposizione di temi di non facile comprensione per un pubblico interessato alla
cucina.
E qui appare un altro tema rilevante, quello della platea alla quale Artusi s’indirizzava.
Se per i lavori su Foscolo e Giusti i suoi lettori dovevano essere i giovani, come lo dice
espressamente, per la Scienza è incidentalmente Piero Camporesi, facendo una riflessione più
generale, che ci mostra come il volume potrebbe andare nella direzione di un manuale tecnico,
non distante da quelli che pubblica negli stessi anni Hoepli a Milano:
Sono convinto che la cultura popolare senza la donna sarebbe stata molto diversa: meno articolata, più
rozza. Pensando alla ricetta di cucina o alla donna che assisteva i morenti, che curava i malati, alle maestre
di parto, ci accorgiamo che la figura femminile è il motore di trasmissione di una cultura che il maschio
non aveva o non aveva il tempo di elaborare. Il maschio dava delle tecniche, delle conoscenze di lavoro,
ma era la donna che creava la mentalità. Si pensi alla fiaba, che cosa sarebbe stata senza le donne?47
In questo senso si potrebbe supporre che la Scienza sia un manuale per uomini? La risposta
necessita approfondimenti qui impossibili da condurre, tuttavia se ci vogliamo attenere ai dati
artusiani, ad esempio l’esame seppur superficiale della corrispondenza sulla Scienza, conservata a
Forlimpopoli48, questo ci mostra come, fatte le dovute proporzioni sociali, il numero di donne
che scrive ad Artusi per richiedere il manuale, proporre ricette, discutere quelle pubblicate, non è
poi così esiguo, circa il 30% sul totale delle lettere conservate, seppur soprattutto per il periodo
post 1900 (si potrebbe dire dalla terza edizione del 1899).
Rilevante appare anche la geografia di questi scambi epistolari, che ci mostrano un’Italia di
periferia tutta la femminile che si rivolge con fiducia al vate della cucina49.
Leggendo tuttavia tra le righe e soprattutto tra le varianti della parte introduttiva che si
avvicendano e si modificano dalla prima alla 14ª edizione si vede come Artusi sin dall’inizio (o
quasi, la dedica della prima edizione è per i gatti Biancani e Sibillone) pensasse espressamente ad
44 Nel citato lavoro su Foscolo Artusi riporta ampiamente un lavoro di Mantegazza sul cranio del poeta, che ha avuto
modo di esaminare nella sua traslazione da Londra a Firenze nel 1871, l’anno in cui la Capitale lasciava
definitivamente la città, cfr. P. Mantegazza, Il teschio di Ugo Foscolo, Milano, Bernardoni, 1871. 45 Michele Lessona, Venaria Reale, 20 settembre 1823 – Torino, 20 luglio 1894, zoologo, politico, divulgatore,
senatore dal 1892. Traduce un numero rilevante di lavori di Charles Darwin. 46 M. Lessona, Conversazioni scientifiche, Milano, Editori della Biblioteca utile, 1865; Idem, Conversazioni
scientifiche. Seconda serie, Milano, Editori della Biblioteca utile, 1866; Idem, Conversazioni scientifiche. Quarta
serie, Milano, Fratelli Treves, 1874; Idem, Volere è potere, Firenze, G. Barbèra, 1911 (prima ed. idem, 1869). 47 A. Gnoli, Il pane truccato dal sogno, “Il Mattino”, 1 novembre 1980, riproposta come P. Camporesi,
Conversazione con Antonio Gnoli. Il pane truccato dal sogno, in Piero Camporesi, a cura di M. Belpoliti, “Riga”, N.
26, Milano, Marcos y Marcos, 2008, pp. 125-126. 48 Cfr. N. M. Liverani, Inventario dell’Archivio Pellegrino Artusi, cit. 49 Per un inquadramento generale sul rapporto donna/cibo cfr. A. Colella, Figura di vespa e leggerezza di farfalla. Le
donne e il cibo nell’Italia borghese di fine Ottocento, Firenze, Giunti, 2003.
9
un pubblico femminile, anche se dall’impostazione poteva apparire al contrario, per la verbosità
tecnica. Nella seconda edizione infatti compare una breve nota L’autore a chi legge (che sarà poi
del tutto modificata in seguito) che nel finale si esprime così:
Prego le Signore gentili e le brave Massaie, a cui specialmente è devoluta quest’opera mia di non poca
fatica e spesa, di studiarla con amore ché ne trarranno vantaggio; mi continuino esse il loro ambito favore
e sarò pago50.
Certo, ci sono tutta una serie di aspetti che limitano molto il range in cui l’universo femminile
immaginato da Artusi si poteva collocare: nel 1891 l’analfabetismo femminile si aggirava attorno
al 60% (quello maschile circa al 40%)51, tuttavia appunto per il suo valore pedagogico, e ne
vedremo meglio la definizione, la Scienza si orientava anche ad essere un testo formativo in
senso generale, magari invitando le “massaie” ad alfabetizzarsi seguendo il loro interesse per la
gastronomia.
Con queste premesse è utile infine chiedersi in breve cosa ci sia nella Scienza, togliendo tutto il
riempitivo di congiunzioni, articoli e avverbi verificare il lessico di Artusi, provare a far emergere
il suo pensiero recondito proponendo una lista di frequenze ed alcune considerazioni.
Pellegrino Artusi, La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene, Torino, Einaudi, 1970.
Posizione per
frequenza
Termine Presenza Percentuale frequenza
11 grammi 1421 0,8826 %
23 burro 866 0,5379 %
30 fuoco 679 0,4217 %
31 acqua 676 0,4199 %
32 zucchero 632 0,3925 %
40 sale 533 0,3310 %
41 farina 479 0,2975 %
44 latte 449 0,2789 %
46 uova 407 0,2528 %
48 pepe 381 0,2366 %
49 sugo 381 0,2366 %
58 uovo 338 0,2099 %
61 olio 334 0,2074 %
62 carne 331 0,2056 %
63 brodo 326 0,2025 %
70 mezzo 270 0,1677 %
72 odore 265 0,1646 %
74 Parmigiano 262 0,1627 %
76 limone 256 0,1590 %
77 parte 256 0,1590 %
78 tutto 248 0,1540 %
83 bollire 235 0,1460 %
50 Si cita da P. Artusi, La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene, Firenze, Salani, 1908, che riproduce senza
autorizzazione dell’autore la terza edizione dell’editore Landi (1899); questa edizione sarà stampata sino agli anni
Settanta. 51 Dati desunti da L’Italia in 150 anni. Sommario di statistiche storiche 1861-2010, Roma, Istat, 2011.
10
84 cottura 232 0,1441 %
87 persone 220 0,1366 %
89 piatto 215 0,1335 %
92 pane 209 0,1298 %
98 tavola 191 0,1186 %
Questa tabella ci evidenzia tra i primi cento termini per frequenza nell’intera Scienza come la
“preoccupazione” dell’autore stesse in primis nell’elaborare un codice, dove un’esatta
terminologia è essa stessa scienza. Non deve certo stupire al primo posto rilevante il termine
grammi, abbiamo accennato già al suo rilievo “chimico”. Il “burro”, condimento del Nord,
semplifica materia più nobile e costosa quale l’olio (al 61° posto). Lo zucchero, che si potrebbe
supporre per la sua posizione cronologica un bene già di consumo di massa è in Artusi
addomesticato come “decoro” trattandosi nella maggior parte dei casi di “zucchero a velo” e così
via, con una scelta di termini anche filosofici e duali quali acqua/fuoco, parte/tutto, ecc.
L’analisi dell’intero testo può anche essere resa in modo più evidente così:
11
4. Liste, ricette e altri incidenti.
Infine si tratta di confrontare il lavoro di Artusi con alcuni documenti in apparenza spuri ma che a
mio avviso offrono un argine alla Scienza, ne misurano i limiti sociali, mostrando come l’autore
si muova più come scienziato sperimentale, come pedagogo pedante che come gastronomo e che
dunque la sua opera sia “viziata” da questi aspetti, limiti che comunque anche oggi non
distraggono i suoi fans come vedremo empiricamente nelle conclusioni.
Se in linea di massima le fonti di Artusi sono note - rielaborazioni di ricette già pubblicate,
raccolta e revisione di narrazioni orali, frutti di scambi epistolari (in un’ottica di food blogger
ante litteram)52 – si può provare a verificare cosa ci stava oltre a questo e quali sono adesso i suoi
confini da qui derivati.
1. Le vertiginose liste di cucina di una famiglia borghese di Firenze tra il 1837 e il 1961 ci
illustrano quasi giorno per giorno in settantadue ordinati quaderni gli acquisti e i consumi
alimentari e di casa travalicando secoli, stati, guerre, cambi epocali53.
Abbiamo condotto su di esse alcune verifiche a campione per valutare le possibili trasformazioni
dei gusti alimentari in un periodo abbastanza lungo, pre e post Artusi: i risultati non sono stati
così scontati come si potrebbe supporre, non ci sono evidenti modifiche dettate da fisiologici e
culturali cambiamenti, anche se l’analisi dovrebbe tener conto maggiormente di alcune variabili
esplicite, come mutamenti stagionali, variazioni economiche e sociali sia generali che all’interno
della famiglia, ecc.
Riportiamo per elenchi alcuni alimenti acquistati, indicando anno e mese:
Gennaio 185454: vitella, uova, pane, pasta, insalata, pollo, marroni, burro, riso, carne salata,
frutta, polenta, trifole, aragosta, cervello, fichi.
Marzo 186355 : burro, manzo, prosciutto, lardo, latte, formaggio, acciughe, fagioli, capperi,
funghi, pomodori.
Gennaio 188156 : vitella, burro, latte, pasta, ortaggi, coniglio, uova, mele, prosciutto, olive,
capperi, acciughe, riso, piccione, tartufo, salume.
Gennaio 189257: carne, filetto, vitella, burro, verdure, roastbeef, prosciutto, uova, castagne,
cavolo, parmigiano, pasta, lardo, zucchero, caffè.
Maggio 1898 58 : carne, roastbeef, vitella, verdure, burro, pasta, prosciutto, quartirolo,
parmigiano.
Gennaio 190159: vitella, rigaglie, tartufo, prosciutto, carne, pasta, burro, lingua, filetto, riso,
castagne, pesce, acciughe, maiale.
Luglio 190560: carne, bistecca, vitella, verdura, burro, pasta, parmigiano, riso, zucchero, pollo,
dolce.
52 “E il libro? Le ho già detto che l’unico suo divertimento era lo scrivere. Il libro lo cominciò quasi per ischerzo. Poi
vide che gli veniva bene e vi si appassionò. A poco a poco venne ad avere una corrispondenza con persone d’ogni
ceto e d’ogni parte d’Italia. Scriveva sempre.”, R. Simonetta, Parliamo di Pellegrino Artusi, cit. 53 Si tratta dei “Giornali delle spese di vitto”, conservati nell’Archivio privato Martini-Edlmann (FME), Firenze. Si
ringraziano i proprietari per la possibilità di consultare ed usare questa documentazione. 54 FME 019 REG-004. 55 FME 019 REG-011. 56 FME 019 REG-029. 57 FME 019 REG-040. 58 FME 019 REG-043. 59 FME 019 REG-059. 60 FME 019 REG 053.
12
Giugno 193061: pesce, verdure, tonno, acciughe, sardine, burro, fragole, torta olandese, caffè,
uova, pan di spagna, lingua, prosciutto, funghi, salmone.
Come si vede, seppur con alcune voci generiche e altre più analitiche, i prodotti acquistati (la
famiglia produceva frutta e verdura ma questi sono indicati in registri a parte) sono all’incirca
sempre gli stessi. Carne, pesce, verdure, latticini, anche con prodotti molto costosi e rari, come
l’aragosta nel 1854, i tartufi, ecc. Queste liste, che riportano anche le spese, evidenziano come i
“gusti” familiari non mutino nel tempo o mutino per piccoli scarti: senza dubbio negli anni chi si
occupa della cucina o degli acquisti cambia (ed anche i membri della famiglia), tuttavia le
direttive sono sempre le stesse. L’arco di settantasei anni che ho preso in considerazione è ampio
e nel mezzo ci sta anche tutto il percorso di Artusi, che non viene preso in considerazione, in una
cucina blindata da gusti tramandati nel tempo.
2. L’elaborazione colta di una “massaia” emancipata della fine del Novecento che trova nella
cucina il piacere invece del dovere e che si mangia l’Artusi “a pezzetti cotti”62 è un esempio
generale che può scendere anche nel particolare.
Un’agenda del 1986 dal 1989 diventa negli ultimi anni della sua vita (a ottantacinque anni) la
summa culinaria di Tina Fabiani 63 , con in prima pagina la dedica “Alla mia cara nipote
Francesca, nonna Tina 25.9.1989”.
Subito dopo un appunto tecnico e una riflessione filosofica:
Da ricordare:
- Non salare l’uovo64 se dovete immergervi le bracioline da friggere65.
- Adoperare il cucchiaio di legno per mescolare66.
Una massima cinese (e che vi consiglio)
“Fa che il sole non tramonti mai sul tuo (vostro) risentimento”
(Mettetela in pratica)67
L’esame degli appunti culinari di Tina con queste premesse potrebbe già terminare: nelle due
note si concentra la profondità del suo pensiero gastronomico, la demolizione della verbosità di
Artusi, seppur frutto di una vocazione pedagogica. La massima cinese ci mostra ancora il suo
carattere d’insegnante temutissima, ma a mio avviso anche il suo ruolo in cucina: il risentimento
è dalle parole della nipote Roberta anche per Artusi, per la sua cucina verbosa, che Tina asciuga
come esperimenti di vera chimica:
[Crostini] Con fegatini
Rosolare dolcemente i fegatini di pollo in un battuto finissimo di cipolla bianca, con burro, sale e pepe.
61 FME 019 REG-054. 62 Secondo quanto mi ha raccontato la nipote Roberta Manzoni, alla quale si deve la messa a disposizione del
materiale e che ringrazio. 63 Tina Fabiani, Empoli, 1904-1997, il padre Augusto aveva il “Pastificio Augusto Fabiani – Empoli”. Laureata in
Scienza naturali insegnava matematica e scienze. 64 Parole sottolineate. 65 Appunto annotato con inchiostro nero. 66 Appunto annotato con inchiostro blu. 67 Appunto annotato con inchiostro blu ma diverso da quello precedente. Queste indicazioni ci fanno supporre che i
tre appunti siano stati scritti in periodi differenti, seppur mantenendo la stessa data.
13
Si mette poi del vino bianco e si fa evaporare. Poi si tritano finemente e per 2-3 minuti, si rimettono sul
fuoco, insieme ad un battuto di capperi e acciughe.
Artusi ci racconta la stessa ricetta indugiando, questa a mio avviso la caratteristica principale del
Nostro:
Sapete già che ai fegatini va levata la vescichetta del fiele senza romperla, operazione questa che
eseguirete meglio operando dentro a una catinella d'acqua. Mettete i fegatini al fuoco insieme con un
battutino composto di uno scalogno, e in mancanza di questo di uno spicchio di cipollina bianca, un
pezzetto di grasso di prosciutto, alcune foglie di prezzemolo, sedano e carota, un poco d'olio e di burro,
sale e pepe; ma ogni cosa in poca quantità per non rendere il composto piccante o nauseante. A mezza
cottura levate i fegatini asciutti e, con due o tre pezzi di funghi secchi rammolliti, tritateli fini colla lunetta.
Rimetteteli al fuoco nell'intinto rimasto della mezza cottura e con un poco di brodo finite di cuocerli, ma
prima di servirvene legateli con un pizzico di pangrattato fine e uniteci un po' d'agro di limone.
Vi avverto che questi crostini devono esser teneri e però fate il composto alquanto liquido, oppure
intingete prima, appena appena, le fettine di pane nel brodo68.
Tina quarantotto parole, Pellegrino centosettantacinque parole. Questo non significa che si debba
misurare quantitativamente un testo per mostrarne il valore, tuttavia come si vede qui la Scienza
slitta come ho accennato verso una manualistica tecnica che di gastronomico ha poco o nulla. La
minuzia di Artusi è la stessa di un trattato di orologeria, dove ogni minuscolo pezzo è analizzato
nei dettagli, in sé e nel contesto69.
3. Infine due liste di osteria che possiamo collocare nella Toscana del sud (Maremma) negli anni
in cui Artusi elaborava la prima edizione della Scienza, ci riportano a un “mangiare”
assolutamente popolare, “grezzo” dove appunto il cibo è solo mangiare, evento fisiologico in
apparenza non così lontano da alcuni passaggi artusiani (ed anche di Mantegazza), ma in realtà
concettualmente abissale70.
Zuppa, lesso, pesce, tonno, fagioli, sardine, minestra, pane, fegato, affettato, umido, frittata,
funghi, è un lessico che misura il desinare e la cena di un carbonaio/imprenditore, Ferdinando
Mei, di Orsigna (PT), in Maremma a dirigere compagnie di lavoratori71, frasario sgarbato, che
richiama cibi portati in tavola “con malagrazia naturale”72.
Artusi usa gli stessi termini, si trovano tutti nella Scienza, ma certo è l’intento che cambia:
Chi è che non sappia far le frittate? E chi è nel mondo che in vita sua non abbia fatta una qualche frittata?
Pure non sarà del tutto superfluo il dirne due parole.
Le uova per le frittate non è bene frullarle troppo: disfatele in una scodella colla forchetta e quando
vedrete le chiare sciolte e immedesimate col torlo, smettete. Le frittate si fanno semplici e composte;
semplice, per esempio, è quella in foglio alla fiorentina che quando un tale l'ebbe attorcigliata tutta sulla
forchetta e fattone un boccone, si dice ne chiedesse una risma. Però riesce molto buona nell'eccellente olio
toscano, anche perché non si cuoce che da una sola parte, il qual uso è sempre da preferirsi in quasi tutte.
68 Ricetta 110. Crostini di fegatini di pollo, si cita dalla 14ª edizione (1910), p. 94. 69 Si accenna che anche nel citato Archivio Martini-Edlmann abbiamo un piccolo fondo di ricette, ante, 1891, scritte
in massima parte in francese, la lingua della cucina colta pre Artusi. 70 Archivio privato Fondo Ferdinando Mei, Pistoia. 71 Cfr. S. Fagioli, Ferdinando Mei: un carbonaio imprenditore di Orsigna fra ‘800 e ‘900, “Farestoria”, A. IX
(1990), n. 14, pp. 21-28. 72 F. Guccini, Inutile (1983).
14
Quando è assodata la parte disotto, si rovescia la padella sopra un piatto sostenuto colla mano e si manda
in tavola73.
“Quest’oggi ho desinato alla trattoria, ed ho scoperto che l’uomo senza patria si può definire in
due modi: l’uomo che non ha patria è l’uomo che non ha desinare. L’uomo che non ha patria è
l’uomo che va all’osteria” scrive Niccolò Tommaseo74 e magari anche tra gli intenti di Pellegrino
c’era quello di far andare meno cittadini all’osteria, luogo di perdizione, insegnando a fare a casa
la frittata e altri piatti “popolari”:
Cammina, cammina, cammina, alla fine sul far della sera arrivarono stanchi morti all’osteria del Gambero Rosso.
- Fermiamoci un po’ qui - disse la Volpe - tanto per mangiare un boccone e per riposarci qualche ora. A mezzanotte
poi ripartiremo per essere domani, all’alba, nel Campo dei miracoli.
Entrati nell’osteria, si posero tutt’e tre a tavola: ma nessuno di loro aveva appetito.
Il povero Gatto, sentendosi gravemente indisposto di stomaco, non poté mangiare altro che trentacinque triglie con
salsa di pomodoro e quattro porzioni di trippa alla parmigiana: e perché la trippa non gli pareva condita abbastanza,
si rifece tre volte a chiedere il burro e il formaggio grattato!
La Volpe avrebbe spelluzzicato volentieri qualche cosa anche lei: ma siccome il medico le aveva ordinato una
grandissima dieta, così dové contentarsi di una semplice lepre dolce e forte con un leggerissimo contorno di pollastre
ingrassate e di galletti di primo canto. Dopo la lepre, si fece portare per tornagusto un cibreino di pernici, di starne, di
conigli, di ranocchi, di lucertole e d’uva paradisa; e poi non volle altro. Aveva tanta nausea per il cibo, diceva lei, che
non poteva accostarsi nulla alla bocca.
Quello che mangiò meno di tutti fu Pinocchio. Chiese uno spicchio di noce e un cantuccio di pane e lasciò nel piatto
ogni cosa. Il povero figliuolo, col pensiero sempre fisso al Campo dei miracoli, aveva preso un’indigestione
anticipata di monete d’oro75.
73 Si cita dalla 14ª edizione (1910), p. 108. 74 G. Rabizzani, Bozzetti di letteratura italiana e straniera, Lanciano, Carabba, 1914, p. 172, si tratta di un brano di
una lettera a Gino Capponi del 1833. 75 C. Collodi, Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino, Firenze, Bemporad, 1899, pp. 62-63.
15
5. Infine.
Per concludere Artusi oggi, l’originale, non le varie rielaborazioni che nel tempo si sono
succedute76, ha uno zoccolo duro di fans, che se lo comprano o più facilmente lo trovano in casa
come regalo di nozze a nonne e madri lo usano sino allo sfinimento fisico del volume, anche
postillando le ricette, modificandole, migliorandole, in un work in progress che era il marchio di
fabbrica dell’autore, seppur con un dialogo ora a senso unico.
Ma per contro la Scienza è anche uno status simbol, un testo classico e snob che è impossibile
non aver letto, al pari di Omero o Dante, ma poi alla verifica dei fatti neppure aperto: accanto alle
edizioni in brossura da 4,60 euro si hanno ristampe più attraenti, in grossi volumi rilegati in
cofanetto di cartone decorato, che tuttavia non aggiungono nulla, criticamente, all’edizione del
1910, l’ultima curata dal Nostro e dunque definitiva, e ossessivamente ristampata, se non magari
un banale quanto inutile apparato iconografico.
La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene di Pellegrino Artusi è un testo molto difficile letto
nel 2015, ben più difficile che se letto nel 1891. La sua verbosità, la sua ridondanza, la sua
minuzia, il suo indugiare erano nel 1891 formativi mentre oggi appaiono noiosi e incomprensibili
alla maggior parte degli italiani: “per il suo linguaggio ‘fiorito’ e decisamente antiquato e per le
storielline e gli aneddoti di cui era infarcita”. “Vedi giudizio uman come spesso erra.” dice
Pellegrino in esergo alla sua opera: per pignoleria anche Dante nella sua Commedia ha
linguaggio fiorito e antiquato ma nessuno vi mette mano per ridurlo, anzi le letture integrali
diffuse in televisione fanno audience.
In verità c’è un altro testo pedagogico al quale sin quasi dai suoi esordi è stata messa meno,
cucinandolo in mille salse differenti, il già citato Pinocchio di Carlo “Collodi” Lorenzini77.
La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene di Pellegrino Artusi è un manuale pedagogico, un
libro di scuola fuori dalla scuola, un’antologia che sfrutta un tema, la cucina, “di moda” e che
Artusi utilizza come grimaldello per entrare in quella società letteraria, colta, elegante, che per
ben due volte lo aveva respinto, con Foscolo e Giusti ma allo stesso tempo nella testa di tutti gli
italiani. E per questo appare a occhio modesto fuori tempo, illeggibile, ammuffito, sdolcinato
quanto Cuore di Edmondo De Amicis78. È fuori contesto non perché siano cambiati i canoni
76 Si cita Dall’Artusi con sapore, Bologna, Malipiero, 1975; Il nuovo Artusi. Manuale pratico per le famiglie. 781
ricette di Pellegrino Artusi adattate alla cucina di oggi, Milano, Mursia, 1978; G. Sangiorgi, A. Toti, Artusi 2000.
Con i consigli del dietologo. 775 ricette originali di Pellegrino Artusi analizzate da due dietologi amanti della buona
cucina, Firenze, Giunti, 1991; L. Artusi, L’artusino, Cesena, Bis, 2008; P. Artusi, Il nuovo Artusi. L’arte di mangiar
bene, Milano, Mursia, 2009; R. Fosco, L’Artusi dei piccoli. Ricette e filastrocche. La cucina e il mondo dei bambini,
Roma, Editori Riuniti, 2010; Margharet Evangelisti, L’Artusi senza glutine. 150 ricette selezionate, Cesena, Il Ponte
Vecchio, 2013; S. Strozzi, L’Artusi “senza”. L’arte di mangiare bene senza glutine, latte, zucchero, Parma, Monte
Università editore, 2014; Artusi 2015. Le più famose ricette della tradizione italiana scelte e organizzate secondo
natura e calendario, Firenze, Sarnus, 2014; Donpasta, Artusi remix. Viaggio nella cuciva popolare italiana. Ricette e
racconti, Milano, Mondadori, 2014. Si segnala anche, seppur non attinenti all’Artusi, il proliferare di trasmissioni
che hanno per oggetto la cucina, di carattere spettacolare, come sfide, che convergono poi in pubblicazioni. Infine
anche la letteratura si è impossessata di Pellegrino, prima con un testo sperimentale (M. Maiocchi, Artusi S+n,
Roma, Stampa alternativa, 1995), poi con un giallo (M. Malvaldi, Odore di chiuso, Palermo, Sellerio, 2011). 77 Sin dai primi anni del Novecento si assiste globalmente a una serie di rielaborazioni del testo di Lorenzini,
soprattutto negli Stati Uniti, dove si hanno anche dei veri a propri stravolgimenti del testo addirittura sin dal 1892,
cfr. R. Wunderlich - P. Morrisey, The Desecration of Pinocchio in the United States, “Children's Literature
Association Quarterly - 1981 Proceedings”, pp. 106-118. 78 Non ho citato Cuore a caso: nel 1887 Paolo Mantegazza ne pubblica una continuazione ideale, dove la ragione e
dunque un approccio maggiormente positivista, indirizza le gesta dei protagonisti: P. Mantegazza, Testa, Milano,
Treves, 1887.
16
gastronomici, come alcuni accennano – tema lungo, complesso e impossibile qui da sviscerare e
che ho solo accennato – ma soprattutto perché i libri di cucina (e certa letteratura) non sono più
manuali tecnici pedagogici, sono oggi strumenti di spettacolo, dove gli autori (soprattutto di sesso
maschile, cantanti, DJ, sportivi, giornalisti, narratori) sono solo marginalmente cuochi, e se anche
lo sono ciò che maggiormente è evidenziato è il loro essere “altro”79.
Anche Artusi non era cuoco professionista tuttavia appunto il suo approccio va in una direzione
etica e non estetica.
Pellegrino era un educatore, i suoi saggi, Foscolo, Giusti, Scienza, vanno in questo senso.
Educare alla moralità, anche in cucina, ma qui per un pubblico più ampio, un pubblico che
andava mutando il volto della nazione, con un’istruzione pratica, concreta, fisiologica, per il
miglioramento fisico degli italiani. L’introduzione Alcune norme di igiene va senza dubbio in
questa direzione, è una prefazione scientifica, che vuole dimostrare come il mangiar bene sia
appunto scienza, che porta ai lettori “felicità e lunga vita”80.
Artusi pedagogo anche per Marietta:
– A parte la cucina e lo scrivere, che vita faceva?
– Leggeva molto... Aveva pochi amici, ma buoni. Il commendatore Bemporad è stato uno dei migliori.
Accettava qualche invito a pranzo, ma assai di rado. Era un terribile giudice delle pietanze sapeva al solo
assaggio riconoscere gli ingredienti e trovare qualsiasi difetto, immediatamente. A parte la cucina gli
piaceva leggere. Invecchiato però, gli si era molto indebolita la vista e per non farlo stancare ero io che
leggevo per lui.
– Non le era fastidioso leggere ad alta voce?
– No. Per lui nulla poteva essermi di peso. E poi lèggere mi piaceva. Ma mi ci sono logorata gli occhi.
Quando morì stavamo leggendo l’Eneide...
– Libri classici dunque?
– Sì. Ma anche altri. Romanzi no. Non gli piacevano. Era un uomo coltissimo, ed amava istruire anche
me. Ed io gli ero tanto riconoscente per questo81.
Per chiudere davvero ci si potrebbe chiedere cosa manchi in Artusi, cosa sfugga alla sua analisi.
A mio avviso l’aspetto più rilevante in questo senso è l’assenza della fame, come disvalore
sociale da colmare82. E se ancora il capitolo Alcune norme di igiene introduce di sfuggita un
mondo che stava lontano dalla Firenze artusiana, lodandolo83, l’antropologia della fame non è
materia per Pellegrino, che in un tripudio di burro, uova ed altri ricchi ingredienti va verso una
nazione sana e satolla:
79 Negli anni Settanta il commento più eretico all’Artusi poteva essere quello di Ave Ninchi, attrice ma anche
gastronoma, che firma una prefazione di un’edizione (P. Artusi, La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene,
Roma, Newton Compton, 1975) e l’attore più famoso che si occupava di cucina in Italia era Ugo Tognazzi, che ha
pubblicato anche alcuni ricettari. 80 14ª edizione (1910), p. 20. 81 R. Simonetta, Parliamo di Pellegrino Artusi, cit., p. 1. 82 Per un inquadramento cfr. in particolare M. L. Betri, L’alimentazione popolare nell’Italia dell’Ottocento; F.
Taddei, Il cibo nell’Italia mezzadrile fra Ottocento e Novecento; G. Ciampi, L’alimentazione popolare a Roma e
nell’Agro romano, tutti in L’alimentazione, a cura di A. Capatti, A. De Bernardi, A. Varni, Torino, Einaudi, 1998. 83 “S’intende bene che io in questo scritto parlo alle classi agiate, ché i diseredati dalla fortuna sono costretti, loro
malgrado, a fare di necessità virtù e consolarsi riflettendo che la vita attiva e frugale contribuisce alla robustezza
del corpo e alla conservazione della salute.”, si cita dalla 14ª edizione (1910), p. 14; nel 1910 l’aspettativa di vita
media in Italia era di 50 anni.
17
Dopo la guerra questo volume non è più stato ristampato; si temeva che le ricette sembrassero troppo
costose.
Ma l’esperienza ha dimostrato che tutti i piatti risultano ottimi anche diminuendo il numero delle uova e la
quantità di burro, specialmente nei budini e negli sformati. Chi sa fare un po’ da cucina saprà senza
difficoltà togliere quello che non è indispensabile.
Ristampiamo perciò il volume, certi che verrà accolto con gioia da tutti i veri buongustai e dalle padrone
di casa che amano offrire un pranzo veramente buono ai loro ospiti84.
84 Nota dell’Editore, in P. Artusi, La scienza in cucina, ed. Salani 1908, cit., stampa 1954, p. 10.