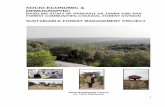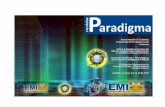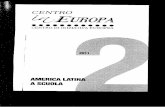IL PARADIGMA SOCIO COGNITIVO E L'IPNOSI
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of IL PARADIGMA SOCIO COGNITIVO E L'IPNOSI
IL PARADIGMA SOCIO COGNITIVO E L’IPNOSI
Di Raffaele Tuccillo
Il paradigma socio cognitivo ha avuto vasta risonanza in tutti gli ambiti della
psicologia, inclusa l’ipnosi, a partire dagli anni 60 del secolo scorso. Scopo di questo
capitolo è identificare i cambiamenti nella pratica e nella teoria dell’ipnosi dagli anni
’60 ad oggi e i punti di contatto e gli scambi reciproci tra l’ipnosi e altri ambiti della
psicologia, come la psicologia sociale e la psicologia di personalità grazie al nuovo
approccio socio cognitivo.
Prima di incominciare è giusto però accennare brevemente agli sviluppi
dell’approccio socio cognitivo nel corso degli anni e identificarne i temi propri che
saranno importanti anche nella ricerca sull’ipnosi.
La social cognition, orientamento concettuale che ha prevalso nell’ambito della
psicologia sociale dagli anni ’60, ha portato all’introduzione di concetti fondamentali
per questa materia. Il concetto di schema, introdotto da Bartlett nel 1932, che è stato
largamente utilizzato nell’ambito socio cognitivo, è definito come filtro organizzatore
e guida dell’esperienza e ha come obiettivo l’esemplificazione della grande mole di
informazioni che arrivano alla coscienza per far si che il soggetto possa fare una
scelta (Amerio 1995). Lo schema quindi è fondamentale perchè da un lato indica cosa
dobbiamo attenderci in una determinata situazione e dall’altro fornisce delle regole e
degli attributi per pensare allo stimolo le quali ci facilitano la comprensione di esso
anche se l’informazione relativa allo stimolo è indisponibile o ambigua (Tesser
1988). Esistono schemi di persona che si riferiscono a prototipi di persone, schemi di
ruoli che si riferiscono a ruoli professionali o sociali e schemi di eventi come gli
script. Il concetto di script (copione), introdotto da Abelson nel 1976, si riferisce ad
una sequenza di eventi attesi da un individuo nei quali agisce come partecipante o
come osservatore; gli script di solito sono modalità di comportamento che
riguardano situazioni specifiche, tipico esempio è lo schema del ristorante.
Altro concetto fondamentale è quello dell’euristica di Tversky e Kahneman
(1973)cioè la regola per formulare un giudizio in maniera rapida ed efficiente, sono
stati individuati svariati tipi di euristiche: euristica della disponibilità, della
rappresentatività e dell’ancoraggio o accomodamento. Dallo studio di queste
caratteristiche del pensiero sociale delle persone è nata l’idea dell’individuo come
cognitive miser cioè economizzatore di risorse cognitive, il soggetto è visto come un
risparmiatore di energia che utilizza scorciatoie mentali ogni volta che può. In realtà
il profilo del cognitive miser è uscito fuori grazie a esperimenti di laboratorio spesso
artificiosi e che staccano i soggetti da riferimenti contestuali, quest’idea è stata
criticata da coloro che seguono l’ottica ecologica inaugurata da Gibson e che
pongono maggiormente l’accento sulle motivazioni e sugli scopi. Osservato da
questo punto di vista il comportamento dell’individuo non è da risparmiatore ma da
motivated tactician cioè tattico motivato. Le persone infatti si comportano come
“pensatori sociali flessibili che quando la posta in gioco è insignificante, possono
mostrare «avarizia», nel senso che si affidano a quelle scorciatoie mentali che
garantiscono il minimo indispensabile; quando però affrontano decisioni più
importanti, adottano strategie diverse, più efficaci” (Aronson, Wilson, Akert, 1997,
97).
Nell’ambito della psicologia di personalità assume molto valore il concetto di Sè.
Iniziamo col dire che gli studi sui tratti o disposizioni personali cedono il passo agli
studi sull’individuo inserito all’interno di un tessuto sociale, ci si rende conto infatti
che il comportamento delle persone risulta molto più variabile a seconda dei contesti
piuttosto che stabile come era stato evidenziato dalle ricerche sulla personalità avulsa
dal contesto (Cervone e Williams, 1992). L’obiettivo non è più quello di individuare
dei tipi comuni di personalità con delle caratteristiche e dei comportamenti uguali in
ogni situazione, ma quello di studiare le competenze, le prestazioni, gli obiettivi e gli
standard degli individui in relazione con il contesto sociale, col loro ambiente di vita,
e individuarne le influenze reciproche.
Fondamentali sono i contributi di Markus e Nurius (1986) sui sé possibili cioè le idee
che ogni persona ha su quello che può diventare, vuole diventare e ha paura di
diventare, sono in sostanza gli obiettivi, gli scopi, le minacce che colorano l’esistenza
di una persona e orientano le sue scelte e i suoi comportamenti. Altro contributo
fondamentale è quello di Rosenberg (1985) che parla delle identità sociali multiple,
cioè i vari sé che un individuo ha e che sono connessi con le posizioni e i ruoli che
gioca nella vita; come ricorda lo stesso Rosenberg però “le identità personali possono
consistere anche di insiemi di caratteristiche e di messe in atto non associate a
particolari posizioni sociali” (Rosenberg e Gara, 1985, 88).
Altri importanti concetti sono quelli introdotti da Carver (1981/2003) delle self-
regulation e da Bandura della self-efficacy (1977). Il primo concetto che può essere
definito in italiano autoregolazione o autocontrollo si riferisce alla capacità
dell’individuo di esercitare autocontrollo su funzioni, stati e processi interni e quindi
portare il sé in linea con gli standard prefissati (Baumeister e Vohs, 2004). Le
emozioni sono un tramite fondamentale per capire quanto il comportamento emesso è
discrepante rispetto a ciò che l’individuo si era anteriormente prefissato. Il concetto
della self-efficacy o auto efficacia invece si riferisce alla capacità di un individuo di
emettere giudizi specifici sulla propria capacità di gestire particolari eventi. I giudizi
di auto efficacia sono emessi grazie a quattro fonti di informazioni: il risultato
positivo di una prestazione, le esperienze vicarie (l’osservazione dei risultati di altre
persone o modelli), la persuasione verbale e l’attività fisiologica.
Theodore Roy Sarbin
Gulotta (Gulotta 1980) nel suo esauriente manuale italiano di ipnosi, citando a sua
volta J. P. Sutcliffe e rifacendosi a una distinzione da tempo esistente nell’ambito
dell’ipnosi, definisce due approcci a questa materia diametralmente opposti, il primo
Credulo o che potremmo chiamare anche dello Stato, come lo definiremo in seguito
nel capitolo, il secondo Scettico o del Non stato. Il primo approccio vede come
fondamento dell’ipnosi lo stato di trance e ritiene che la testimonianza del soggetto
circa il proprio stato ipnotico sia veritiera e incontrovertibile. L’ipnosi è quindi uno
stato alterato di coscienza, i fenomeni che si evidenziano sono propri di questo stato e
si verificano come abbiamo già detto grazie alla trance. L’approccio opposto, cioè
quello definito Scettico o del Non stato, mette innanzi tutto in discussione il concetto
di trance e afferma che i fenomeni che si manifestano durante l’ipnosi sono
evidenziabili anche in soggetti non ipnotizzati. L’ipnosi non è uno stato alterato di
coscienza ma uno stato normale. Del secondo approccio fanno parte tutti quegli
studiosi dell’ipnosi che si sono ispirati nelle proprie ricerche al paradigma socio
cognitivo.
Theodore Sarbin è stato uno dei primi esponenti della teoria del Non stato. Gli
studiosi che intendono l’ipnosi come uno stato alterato di coscienza giustificano il
proprio punto di vista citando i test fenomenologici e cioè le risposte dei soggetti
ipnotizzati a suggestioni test, i comportamenti quindi suggeriti al soggetto
dall’ipnotizzatore come: rigidità muscolare, analgesia, allucinazione visiva e uditiva,
regressione di età, sordità o cecità ai colori, amnesia, risposte post-ipnotiche. Le
suggestioni test sono state standardizzate e raccolte nei cosiddetti test di profondità
ipnotica come: Stanford Hypnotic Susceptibility Scale (SHSS; Weitzenhoffer e
Hilgard, 1959, 1962); Harvard Group Scale of Hypnotic Susceptibility (HGSHS;
Shor e Orne, 1962); Barber Suggestibility Scale (BSS; Barber, 1969); Hypnotic
Induction Profile (HIP; Spiegel e Spiegel, 1978), solo per citare i più famosi.
Sarbin afferma che i test fenomenologici che hanno l’obiettivo di stabilire
l’effettività e la validità della trance falliscono e incappano in un ragionamento
circolare e tautologico (Sarbin e Coe, 1972), infatti vengono assunti sia come causa
dello stato ipnotico, sia come evidenza di esso, cioè come prova dell’effettiva
presenza di uno stato alterato di coscienza in ipnosi.
“Dobbiamo essere sensibili al contesto sociale e culturale all’interno del quale
facciamo le nostre osservazioni” (Sarbin e Slagle, 1979, 275) è il monito che
evidenzia l’apertura dell’ipnosi al paradigma socio cognitivo, e che mette in risalto
quanto importante sia per lo sviluppo di una teoria scientifica e quindi anche per
l’ipnosi l’uso delle metafore o di modelli presi in prestito da altre discipline. Se
all’inizio dell’ipnosi venivano presi a prestito metafore desunte dalla fisica
(magnetismo) e dalla geologia (profondità ipnotica), in seguito si è fatto uso
massiccio di metafore e di termini (allucinazioni, cataplessia, amnesia, dissociazione,
paralisi, ecc.) provenienti dalla psicopatologia. Mentre questi termini stavano a
significare stati psicopatologici gravi nell’ambito della psichiatria, nell’ipnosi stanno
invece a significare lo stato di trance. Con Freud poi diviene importante il paragone
tra disturbi neuropatologici dovuti a cause funzionali e disturbi psicogenici dovute a
cause psichiche come l’isteria. Proprio all’isteria viene accostata l’ipnosi da Charcot;
diventa però difficile distinguere coloro che fingono o simulano la malattia da coloro
che realmente ne soffrono, la questione viene risolta dai post-Charcotiani
domandandosi se la finzione sia cosciente o inconscia. Come per la psicogenesi
dell’isteria anche nell’ipnosi l’amnesia è importante solo che mentre nella prima è
spontanea nella seconda, l’amnesia post ipnotica, è indotta. Tutte queste similitudini e
scambi di termini da un contesto all’altro se da un lato servivano per spiegare meglio
i fenomeni a volte incomprensibili che si osservavano, dall’altro hanno fatto si che le
metafore fossero prese alla lettera divenendo dei falsi miti. Sarbin quindi tenta di
scevrare il campo da questi miti proponendo nuove metafore come cita il titolo di un
suo importante articolo (Sarbin e Coe, 1972).
Il concetto di ruolo diviene fondamentale, l’individuo infatti ha un copione da seguire
e il copione non dipende solo dal contesto ma il soggetto prende il ruolo di persona
ipnotizzata con i limiti imposti dalle sue aspettative, dai compiti che si è imposto e da
ciò che la situazione richiede, tenendo conto dell’importanza delle richieste e delle
aspettative delle persone presenti (Sarbine e Slagle, 1979). Mentre afferma che le
alterazioni fisiologiche quindi non sono specifiche della trance ipnotica, sottolinea
che i processi simbolici possono produrre cambiamenti nei processi biologici (Sarbin
e Coe, 1972). Il gioco di ruolo è la variabile indipendente. Il partecipare a qualsiasi
ruolo può essere concettualizzato in termini di maggiore o minore intensità ed è unito
a differenti livelli di dispendio di energia dell’organismo. Si può dire quindi che certi
cambiamenti fisiologici sono associati a certi gradi di coinvolgimento dell’organismo
in un ruolo particolare. Descrive quindi 8 livelli di coinvolgimento dell’organismo
nei diversi ruoli, da un nullo coinvolgimento nel primo livello, ad un coinvolgimento
“meccanico” in azioni che incomincia a divenire, con un aumento della tensione e
del ritmo della respirazione nel terzo livello, un vero e proprio coinvolgimento nel
quarto livello; si osserva qui il classico comportamento che prima veniva definito
sonnambolico, il soggetto è definito profondamente ipnotizzato. Il quinto è il livello
che raggiungono i soggetti con nevrosi istrionica o con reazioni di conversione,
l’intensità di partecipazione al ruolo è maggiore di quella presente in ipnosi, si
osserva il comportamento “come se”. Dal sesto fino all’ultimo livello si ha
sospensione delle azioni volontarie come si evidenzia in situazioni di conversione
religiosa, stati mistici, possessione. Le performance psicofisiologiche presenti in
questi livelli non possono essere mantenute a lungo senza danneggiare l’organismo è
anche presente un fallimento dei meccanismi di equilibrio; esempio caratteristico
degli ultimi livelli sono i casi di morte a causa del voodoo descritti da Cannon.
Theodore Xenophon Barber
E’ considerato, dagli studiosi che si occupano di ipnosi, il maggiore esponente della
teoria Scettica o del Non stato. Barber ha dato una forte spinta all’approccio del Non
stato con numerosi studi che a partire dagli anni ’60 dello scorso secolo sono stati
non solo illuminanti per le scoperte fatte ma hanno anche segnato, agli studiosi
dell’ipnosi, la strada da percorrere. Nel 1969 esce un suo famoso libro, forse
decisamente il più famoso e cioè “Ipnosi: un approccio scientifico”; in quest’opera
sistematica e illuminante confuta le ragioni che sostengono il punto di vista
dell’ipnosi come stato alterato di coscienza, affermando che: 1) “i presupposti dello
stato ipnotico sono coinvolti in un ragionamento circolare” (concetto come abbiamo
visto sostenuto anche da Sarbin) ; 2) “le formulazioni teoriche imperniate sui concetti
di ipnosi o di trance ipnotica mancano di soddisfare i criteri essenziali per una teoria
scientifica utile” (Barber, 1972, corsivo dell’autore), non potendo essere né
confermate né respinte.
Barber arriva ad affermare tutto ciò analizzando come lo stato ipnotico sia dedotto,
dagli studiosi che intendono l’ipnosi come uno stato alterato di coscienza, in base a:
1) risposte dei soggetti ipnotizzati a suggestioni test (l’abbiamo già visto in Sarbin)
2) aspetto ipnotico cioè modificazioni nel portamento e nei movimenti come
rilassamento, mancata spontaneità, sguardo di trance, rallentamento psicomotorio;
3) relazioni di esperienze non comuni cioè resoconti da parte di soggetti che sono
stati ipnotizzati di provare esperienze insolite come sensazione di cambiamento delle
dimensioni del corpo o senso di irrealtà;
4) testimonianza di essere stato ipnotizzato cioè il fatto che i soggetti riferiscano,
dopo la fine della loro esperienza, di essere entrati in uno stato ipnotico.
Questi quattro tipi di comportamenti dei soggetti in ipnosi sono utilizzati dagli
studiosi che accettano la teoria dello Stato, sia come variabili dipendenti, cioè come
causa dello stato ipnotico, sia come evidenza di esso, cioè come prova dell’effettiva
presenza di uno stato alterato di coscienza in ipnosi; Barber quindi come Sarbin
descrive la teoria dello Stato come essenzialmente circolare. L’affermazione circa
l’ascientificità della teoria dello Stato alterato è invece dovuta al fatto che gli studiosi
pongono come causa del comportamento ipnotico lo stato di trance stesso, che se non
si ricorresse a spiegazioni circolari come quelle precedenti, dovrebbe essere preso per
buono senza che si abbia alcuna possibilità di verificarlo.
Barber intende quindi definire con esattezza quelle che sono le variabili dipendenti,
che devono essere spiegate, le variabili indipendenti che sono antecedenti alle prime
e le possibili relazioni funzionali tra di esse cioè tra variabili dipendenti e
indipendenti. Prese come buone le variabili dipendenti prima elencate, definisce una
lista di possibili variabili indipendenti che hanno relazioni con le prime e che sono:
1) variabili procedurali cioè istruzioni e suggestioni che a loro volta si dividono in:
a) variabili procedurali nel procedimento di induzione ipnotica:
- definire la situazione come ipnosi
- istruzioni motivanti
- suggestioni di rilassamento, sonnolenza e sonno
- affermazione che è facile rispondere alle suggestioni
b) altre variabili procedurali:
- parole specifiche delle suggestioni
- tono di voce in cui sono presentate le suggestioni
- metodo di presentazione delle suggestioni (viva voce, nastro registrato, ecc..)
- parole delle domande usate per provocare la testimonianza di essere stati ipnotizzati
2) variabili del soggetto come: caratteristiche di personalità, motivazioni,
atteggiamenti e aspettative riguardanti l’ipnosi o la situazione sperimentale in
generale
3) variabili dello sperimentatore come: le sue caratteristiche di personalità, il
prestigio, le motivazioni, gli atteggiamenti e le aspettative
4) variabili che riguardano l’interazione tra soggetto e sperimentatore.
Dall’interazione quindi delle variabili indipendenti sopra elencate con le variabili
dipendenti o conseguenti nascono una lista di 70 “generalizzazioni empiriche” con le
quali, nel suo libro “Ipnosi: un approccio scientifico”, Barber tenta di fornire una
base solida e sperimentale alla teoria dell’ipnosi come stato non alterato di coscienza.
Per meglio comprendere che cosa è il procedimento ipnotico lo scinde in quattro
componenti fondamentali che prese separatamente hanno tutte quante efficacia
nell’aumentare la riposta a suggestioni test e queste sono: definizione della situazione
come ipnosi, suggestioni di rilassamento, istruzioni a collaborare ed a tentare “ ascolti
attentamente ciò che le dico … Tutto ciò che le chiedo è la sua collaborazione, il suo
interesse” (Barber, 1972), dichiarazione che è facile rispondere alle suggestioni
“Chiunque abbia tentato, è riuscito in questi test … può facilmente immaginare e
realizzare le cose interessanti che le dirò” (ibid.). Queste sono le variabili
indipendenti chiamate variabili procedurali della situazione ipnotica elencate in
precedenza.
Innanzi tutto è importante dire che soggetti a cui vengono somministrati i test di
profondità ipnotica senza nessun tipo di procedimento di induzione e senza nemmeno
definire la situazione come ipnosi, “a livello basale” come si dice, manifestano già un
buon livello di risposta: nella serie di esperimenti condotti da Barber e Calverly
(Barber e Calverly, 1962, 1963, 1963) con la scala di suggestionabilità ipnotica BSS i
soggetti a livello basale superarono tre delle otto suggestioni test, nello studio di
Hilgard e Tart (Hilgard e Tart, 1966) con la scala di suggestionabilità ipnotica
Stanford i soggetti superarono tre delle dieci suggestioni test.
Dai dati sperimentali che Barber fornisce si attesta poi che i comportamenti ipnotici
esibiti dai soggetti sono dovuti in parte alla definizione della situazione. Si hanno
maggiori punteggi infatti in risposta a suggestioni test quando la situazione viene
definita test di immaginazione piuttosto che quando viene definita negativamente test
di credulità, e ancora si hanno punteggi più elevati quando ai soggetti si dice che
stanno partecipando a una ipnosi piuttosto che quando si dice loro che stanno
partecipando ad un esperimento con test di immaginazione.
I soggetti che partecipano a sedute di ipnosi si sono formati un’idea di cosa sia
l’ipnosi e sono consapevoli di ciò che significa essere ipnotizzati, si trovano quindi in
una situazione in cui ci si aspetta che collaborino e ci si aspetta che rispondano a
suggestioni tipo quelle presenti nei test di profondità ipnotica. Altra consapevolezza
dei soggetti è quella che suggestioni di rilassamento e di sonno inducono ipnosi,
quindi queste suggestioni informano il soggetto che il procedimento che si sta
utilizzando può essere un’ipnosi e che ci si aspetta da loro la massima partecipazione
e collaborazione come detto in precedenza.
Infine le istruzioni motivanti al compito e le dichiarazioni che è facile rispondere alle
suggestioni, impartite ai soggetti, risultano aumentare la responsività a molte
suggestioni test, a suggestioni che hanno come obiettivo ridurre la reattività al dolore,
a quelle che tendono ad aumentare le capacità di apprendimento, a quelle che
tendono a produrre allucinazioni e sogni e a quelle che hanno come obiettivo di
indurre amnesia.
Per quanto riguarda la seconda serie di variabili indipendenti definite come altre
variabili procedurali, Barber dimostra che suggestioni dirette di per sé stesse bastano
a volte per provocare la risposta dei soggetti alle suggestioni test, così come
producono o riducono in individui allergici una risposta allergica, provocano in
individui miopi un miglioramento dell’acutezza visiva o un aumento o riduzione del
ritmo cardiaco in soggetti normali. Osserva per giunta che le parole esatte delle
suggestioni ma anche il tono di voce hanno una loro importanza. Le suggestioni di
amnesia infatti hanno un effetto differente se date con tono di voce permissivo
“cerchi di dimenticare” o perentorio “lei non ricorderà” , un tono di voce fermo poi
produce un livello superiore di responsività rispetto ad un tono di voce indifferente,
in questo secondo caso infatti il soggetto potrebbe pensare che allo sperimentatore
non importa che il soggetto accetti la suggestione. E’ abbastanza indifferente poi,
almeno a livello sperimentale , se le suggestioni vengono presentate personalmente
dall’ipnotista-sperimentatore o se vengono presentate in modo relativamente
impersonale attraverso per esempio un nastro registrato, in entrambi i casi infatti si ha
una percentuale di risposte alle suggestioni test (alla scala BSS) uguale.
Infine le parole e il tono dell’interrogatorio sono fondamentali per sollecitare nei
soggetti la testimonianza di aver provato esperienze insolite, di essersi sentiti
ipnotizzati e di non essere stati capaci di resistere alle suggestioni. Una variazione di
esse può indurre una variazione nei resoconti dei soggetti che sono stati ipnotizzati, il
soggetto infatti secondo Barber; a) “è acquiescente a quanto è implicito nelle
domande dello sperimentatore” b) trovando le sue esperienze complesse e ambigue
non sa come definirle e “ per conseguenza è disposto ad accettare, per classificare le
sue esperienze, le categorie che gli sono state implicitamente offerte dalle specifiche
parole delle domande dello sperimentatore” (Barber, 1972).
Passiamo adesso ad analizzare l’influenza che per Barber esercitano le ultime due
variabili indipendenti, cioè la variabile soggetto e quella ipnotista.
Le attitudini positive sono descritte da Barber et al. (Barber, Spanos e Chaves, 1980)
come: acquisizione durante il corso della vita del concetto che essere ipnotizzato e
rispondere alle suggestioni è stimolante, utile e degno di considerazione; le
motivazioni positive rappresentano il desiderio di essere ipnotizzato o di provare le
esperienze suggerite, le aspettative positive in fine rappresentano la convinzione,
sempre da parte del soggetto, di poter essere ipnotizzato e provare le esperienze
suggerite.
Come è stato evidenziato anche da Hilgard et al. (Melie e Hilgard, 1964), le
attitudini, le motivazioni e le aspettative nei confronti dell’ipnosi sono fondamentali
per capire se un soggetto eseguirà i comportamenti suggeriti dall’ipnotista e se
riferirà una volta finita l’ipnosi di aver provato esperienze insolite e di essersi sentito
ipnotizzato. Indurre attitudini positive nei confronti dell’ipnosi infatti, come dimostra
Barber, produce un miglioramento in questi domini, mentre l’induzione di attitudini
negative produce un netto peggioramento. Già White (White, 1941) evidenziava
l’importanza della manipolazione delle motivazioni per produrre un una risposta
migliore in individui inizialmente poco motivati alla situazione ipnotica, Spanos
Barber e Chaves identificano quindi un programma di eliminazione delle aspettative
negative e di rinforzo di motivazioni e aspettative positive. Tale programma si
compone anche di manovre conoscitive e cioè di modalità quanto più dettagliate
possibili per descrivere la suggestione che il soggetto deve provare e di riduzione
delle indicazioni incoerenti con l’effetto suggerito. Le indicazioni incoerenti
rappresentano “sollecitazioni in contraddizione con il reale effetto che la suggestione
sta cercando di provocare” (Barber, Spanos e Chaves, 1980).
L’ultima variabile indipendente da considerare è quella che riguarda l’ipnotista. Al di
là delle caratteristiche personali che sembrano poco interessanti, fatta eccezione per
la fama e il prestigio che ha l’ipnotista e il fascino che esercita sul soggetto,
importante è considerare le sue proprie aspettative e quindi le variazioni che può
inconsciamente apportare nel tono di voce, nella somministrazione delle suggestioni
ecc. al variare di queste.
Barber propone un altro concetto molto interessante e foriero di implicazione
importanti nello studio dell’ipnosi, e cioè se questo fenomeno non è dovuto, come
egli dimostra, a uno stato alterato di coscienza, gli elementi che lo generano cioè le
variabili indipendenti, e le loro conseguenze cioè le variabili dipendenti potrebbero
essere utilizzate per spiegare altri fenomeni psicologici. D’altro canto molte branche
della psicologia, una fra tutte la psicologia sociale, potrebbero interessarsi di questi
aspetti ed esaminarli secondo propri paradigmi.
Eliminando completamente il concetto di trance ipnotica e cercando di apportare una
considerazione più ampia alle capacità di ogni soggetto, Barber mette in pratica un
programma di sviluppo delle potenzialità umane in cui, facendo egli stesso da
modello e poi invitando i soggetti a provare le suggestioni di controllo del dolore,
miglioramento dell’apprendimento, regressione di età e rilassamento, mette in pratica
tutti i punti in cui verte la sua teoria dell’ipnosi. Egli riesce a dimostrare la sua tesi e
cioè ancora una volta che l’ipnosi è uno stato normale di coscienza, che non si
discosta da altri fenomeni psicologici come quelli studiati dalla psicologia sociale e
che risultati simili a quelli indotti in un contesto ipnotico possono essere indotti in un
altro contesto che pur non avendo la stessa connotazione si serve di variabili
indipendenti simili come la motivazione, gli atteggiamenti, le aspettative e l’uso
preciso e consapevole delle suggestioni.
L’ultimo punto da trattare, facendo una disamina degli importanti studi di Barber sul
fenomeno ipnosi, è perfettamente introdotto dall’affermazione: “individui che
rispondono in maniera positiva a suggestioni difficili differiscono da quelli che
rispondono negativamente, in quanto essi tendono ad essere coinvolti in attività che
comprendono l’immaginazione associata ad un «arresto volontario della credulità»”
(Barber, Spanos e Chaves, 1980). Questa frase fa da corollario agli studi sulle
propensioni o insieme di tratti tipici (sembra più giusto parlare in questi termini
infatti più che citare vere e proprie caratteristiche di personalità) correlati con la
maggiore facilità a manifestare fenomeni ipnotici e lasciarsi andare a suggestioni.
Vengono individuati infatti tre tipologie di soggetti Fantasy-prone, Amnesia-prone,
Positively-set person.
Il primo tipo è costituito da soggetti aventi una lunga storia di credenze fantasiose,
memorie personali vivide che si estendono prima dei tre anni, “labilità o plasticità
psicosomatica (mind affecting body) e riportano storie molto enfatizzate di eventi
paranormali” (Barber, Kirsch et al., 1998) come esperienze di premonizione,
impressioni telepatiche, sogni rivelatori, esperienze extra corporee e contatti con
spiriti o fantasmi. Tipicamente da piccoli vivevano in un mondo di fantasia e le loro
immaginazioni vengono descritte come “reali come la realtà”, da adulti continuano ad
avere una vita profondamente influenzata dalle fantasie.
Gli amnesia-prone ,chiamati così perché mostrano amnesia spontanea per gli eventi
ipnotici (cosa non molto comune), esibiscono tutti una amnesia post ipnotica quando
viene loro suggerita, che spesso persiste anche dopo forti contro-suggestioni di
ricordare l’evento. Sono generalmente amnesici riguardo ai fatti accaduti prima dei 5
anni e il 40% di essi non ricorda nulla prima dei 6/8 anni. Spesso non sono in grado
di rammentare sogni o fantasie e durante la vita è capitato loro di vivere momenti di
“blanck state” periodi simili amnesici, privi di qualsiasi ricordo. C’è una qualche
indicazione che porta gli studiosi a ritenere che molti di questi amnesia-prone hanno
subito abusi fisici o psicologici durante l’età infantile.
L’ultimo tipo, i positively-set person, non permette che pensieri irrilevanti entrino
nella propria mente, ma concentra l’attenzione sulle suggestioni, allo stesso tempo
questi soggetti non sono passivi spettatori di quello che sta accadendo ma cercano il
modo di costruire attivamente l’esperienza che viene loro suggerita. Hanno positive
attitudini circa il concetto di ipnosi, circa la specifica situazione di test e nei confronti
dell’ipnotista, hanno motivazioni positive di fare bene quello che è stato loro
suggerito e aspettative positive riguardo al fatto che saranno ipnotizzati con successo
e che proveranno le esperienze per le quali vengono suggestionati.
Irving Kirsch
Il punto di vista teorico di Irving Kirsch in tema di ipnosi è fortemente influenzato
dalle ricerche che egli stesso ha condotto sulla teoria dell’aspettativa di risposta e
sull’effetto placebo, due campi della psicologia fortemente interconnessi.
Il primo concetto quello dell’aspettativa di risposta, che si ricollega alle teorie
“dell’azione ragionata” di Fishbein e Ajzen (Ajzen e Fishbein, 1980; Fishbein e
Ajzen, 1975), è definito come: “aspettativa circa le nostre reazioni non volontarie agli
eventi” (Kirsch 1990, 9). Mentre nella teoria dell’azione ragionata il ruolo
dell’intenzione è di produrre delle azioni volontarie, l’aspettativa di risposta invece
concerne la probabilità soggettiva che una riposta sarà stimolata. L’aspettativa di
risposta infine è auto confermante, quando infatti ci aspettiamo con molta
convinzione che qualcosa avvenga, ciò che attendiamo avverrà; questo meccanismo
è stato definito profezia che si autoadempie (Merton, 1948) ed è stato confermato, tra
gli altri, dall’ormai classico studio di Rosethal e Jacobson (Rosenthal e
Jacobson,1968).
L’effetto placebo è l’esempio di aspettativa di risposta più conosciuto e più studiato
e per Kirsch il fulcro stesso della teoria sull’ipnosi ma ancor più della teoria sulla
terapia psicologica. Secondo Kirsch “un placebo può essere definito come un
trattamento o una componente di un trattamento che produce effetti alterando le
aspettative delle persone” (Kirsch, 1990, 43), per questo motivo ci si è chiesti se tutte
le terapie psicologiche basano la loro efficacia sull’effetto placebo. Naturalmente non
è così, ci sono differenze notevoli, circa la validità tra i vari tipi di terapie
psicologiche e queste differenze non sono tutte da ascrivere alle aspettative delle
persone riguardo la bontà della terapia e la possibilità di guarigione. Tuttavia studiare
l’effetto placebo è un modo per capire come modificare le aspettative dei pazienti e
per studiare gli ingredienti di cui è composta una terapia psicologica. Frank nel suo
libro Persuasion and Healing (1973) individua almeno 4 ingredienti specifici di una
terapia:
1) La relazione terapeutica tra un paziente e una terapeuta che è una persona che ha
una certa esperienza e possiede dei mezzi e delle tecniche che possono guarire il
paziente.
2) Il setting nel quale avviene la terapia come: ospedali, cliniche, uffici ecc..
3) La struttura teorica sulla quale è basata la terapia, ci sono infatti differenti teorie
per differenti tipi di terapie
4) I rituali o procedure terapeutiche che sono correlati alla struttura teorica.
Ritornando ai placebo preme dire che non sono tutti ugualmente efficaci ma che
alcuni lo sono più di altri, come evidenziato nello studio di Bäckman, Kalliola e
Östling (1960). Un placebo iniettato alcune volte potrebbe essere più efficace di un
placebo somministrato per via orale, come ad esempio, ritornando al campo della
psicoterapia, tecniche di rilassamento, o di immaginazione potrebbero essere più
efficaci se presentate al paziente come tecniche ipnotiche o viceversa. Infine dati
ricavati da una meta-analisi di Barker, Funk e Houston (1988), che riguarda
solamente gli studi in cui il gruppo di controllo riceve una terapia credibile e
plausibile, che quindi non mina la validità dell’effetto placebo, evidenziano che non
soltanto il placebo ha una sua validità sul 47% delle persone (che quindi guarisce solo
grazie al placebo), ma che questa validità aumenta nel follow-up con il 76% delle
persone che guarisce.
Kirsch definisce l’ipnosi un placebo non ingannevole in quanto, fugare i miti
riguardo alle sue caratteristiche magiche e modificare in questo modo le aspettative
delle persone, tende ad aumentare, piuttosto che diminuire l’efficacia della tecnica.
Ritiene l’ipnosi uno stato normale di coscienza, e appoggia quanto già detto da Hull e
cioè che “differenze tra uno stato normale e ipnotico sono quantitative più che
qualitative. Non c’è nessun fenomeno prodotto in ipnosi che non potrebbe essere
prodotto ad un livello più basso da suggestioni date in una normale condizione di
veglia” (Hull 1933, 39, in Kirsch, 1990).
Kirsch, valutata l’evidenza che le suggestioni da sole, senza essere precedute da
un’induzione ipnotica, bastano a far apparire tutti i fenomeni visibili nell’ipnosi,
aggiunge però che la tecnica ipnotica serve ad aumentare la suggestionabilità.
Distingue tre componenti fondamentali per l’aspettativa di risposta ipnotica:
1) percepire la situazione come ipnosi che determina quando l’aspettativa di risposta
ipnotica verrà emessa. Classico esempio è l’esperimento della commissione reale del
1784, allorquando una commissione di studiosi (tra i membri incaricati c’erano
Baily, Laurent de Jussieu, Frenklin e Lavoisier) si riunì per volere del re di Francia
per esaminare la validità del mesmerismo. Fu dimostrato che l’immaginazione senza
magnetismo produce convulsioni, ma il magnetismo senza immaginazione non
produce nulla. Secondo Kirsch “nessuna procedura specifica è necessaria per elicitare
i fenomeni ipnotici. In questo caso, le induzioni ipnotiche sono simili ai placebo”
(Kirsch, 1990, 148)
2) percezioni di ruolo che determina che tipo di riposte ipnotiche verranno emesse.
Questo tipo di aspettative di ruolo sono state indagate ampiamente, come abbiamo
già visto, da Sarbin e riguardano le credenze delle persone circa il proprio ruolo
durante un’ipnosi, ma riguardano anche i significati e le metafore che si utilizzano
per spiegare i fenomeni ipnotici.
3) auto percezione di ipnotizzabilità, quanto una persona si ritiene suggestionabile
che determina se le risposte ipnotiche avverranno o meno. Le caratteristica di
personalità generalmente associata all’ipnosi come la absorption, la capacità nel
lasciarsi assorbire da attività immaginative, non è direttamente correlata
all’ipnotizzabilità ma alle aspettative di risposta che sono invece fortemente e
direttamente correlate all’ipnotizzabilità così come evidenziato dallo studio di
Council, Kirsch e Hafner (1986). Allo stesso modo le strategie immaginative non
aumentano in maniera diretta l’ipnotizzabilità ma rendono i soggetti più
suggestionabili modificandone le aspettative come dimostrato dallo studio di Kirsch,
Council e Mobayed (1987). Le aspettative delle persone possono essere modificate
in molti modi ma bisogna anche ricordare che l’induzione ipnotica stessa è una
procedura che causa la modifica di tali aspettative.
Vediamo adesso come spiega Kirsch la percezione di involontarietà dei
comportamenti emessi in ipnosi. Come spiegato da Norman e Shallice (Norman e
Shellice, 1986), il comportamento pianificato e non è controllato da schemi sensori
motori organizzati gerarchicamente. In cima a questa gerarchia c’è un sistema di
supervisone attenzionale che seleziona l’azione che deve essere intrapresa. Questo
alto livello gerarchico può essere identificato con la coscienza e l’intenzionalità,
mentre quando è attivata la gerarchia degli schemi comportamentali a meno che non
ci siano complicazioni non è richiesto un alto livello di coscienza e di attenzione,
questo tipo di automatismo rende quindi possibile lo svolgimento di un grande
numero di azioni contemporaneamente. Bisogna anche dire che una volta innescata la
gerarchia, ciascuno dei suoi componenti può anche essere attivato da stimoli
ambientali. Il concetto di implementation intention, azione implementatrice di
Gollwitzer (1993, Kirsch et al., 1999 ) riguarda invece la decisione conscia di mettere
in pratica un atto in specifiche situazioni ambientali, questa intenzione è formata
prima che venga iniziata praticamente l’azione ma al momento stesso della
performance non richiede che intervenga una scelta cosciente, intenzionale o
consapevole. Il comportamento tuttavia è da classificare come intenzionale dal
momento che è diretto ad uno scopo ed è preceduto da una decisione cosciente.
Spesso viene detto che un comportamento è automatico quando è una routine, quando
è stato praticato molte volte in passato e non rappresenta più una novità, tuttavia
possiamo ritrovarci di fronte a comportamenti che “possono essere descritti con
molto difficoltà come routine” (Kirsch et al., 1998, 56) che vengono eseguiti
automaticamente in una maniera molto flessibile. Classico esempio è il linguaggio, ci
troviamo di fronte ad una azione che viene eseguita volontariamente, decidiamo di
parlare e di dare un determinato messaggio, ma molte delle azioni che vengono
intraprese non sono sotto il diretto controllo cosciente e vengono eseguite
automaticamente come i movimenti delle labbra, della lingua e di tutto l’apparato
fonatorio. Quindi la questione da porci è “non quale comportamento è automatico e
quale è volontario ma a che livello una particolare azione è volontaria” (Valacher,
Wegner 1987; Kirsch 1998, 56). Il sistema di supervisione attenzionale, oltre a stare
alla cima della gerarchia di schemi, potrebbe anche variare la sua posizione a seconda
della difficoltà dell’azione intrapresa, delle abilità di colui che la intraprende e
naturalmente degli ostacoli che si incontrano.
Ritornando all’ipnosi bisogna considerare che la valutazione di involontarietà data
dai soggetti sotto ipnosi riguardo alle loro azioni non è un errore ma sicuramente è
una valutazione post facto ed è dovuta al raggiungimento o meno dell’obiettivo
stabilito previamente, nel considerare questo tipo di valutazione non bisogna però
dimenticare ciò che è stato discusso in precedenza ovvero il peso dell’aspettativa di
risposta nell’economia dell’azione stessa. Quindi anche l’esperienza della
involontarietà come altre esperienze fatte in ipnosi è dovuta all’auto conferma di una
aspettativa culturalmente determinata, gli script che contengono al loro interno le
suggestioni informano i partecipanti che le risposte stanno accadendo senza la loro
volontà e ancora questa sensazione di involontarietà e accresciuta dal fatto che gli
stati soggettivi sono spesso ambigui e che il vocabolario riguardante le sensazioni
corporee e le emozioni corporee è imperfetto. Come nota Trope (1986, Kirsch, 1999)
quindi se le sensazioni o i segnali del corpo sono ambigui, il contesto nei quali sono
sentiti può influenzare l’etichetta che viene data e la comprensione del significato.
Nell’ipnosi quindi possiamo osservare che in due modi le risposte sono elicitate
direttamente dalla suggestione: il primo per cui le risposte sono iniziate
automaticamente come parti di un piano di azione premeditato. Questo è dimostrato
dalla correlazione tra responsività e attitudine verso l’ipnosi e dall’influenza del
rapporto ipnotista-ipnotizzato sulle risposte ipnotiche con i vari gradi di compliance
con le istruzioni che precedono le suggestioni come chiudere gli occhi o estendere le
braccia. Il secondo invece ha a che vedere direttamente con l’implementation
intention di Gallowitzer e riguarda il modo in cui le risposte sono stimolate
direttamente dalle suggestioni. Gallowitzer come detto in precedenza dice che
l’azione implementatrice porta a iniziare automaticamente un’azione che era prevista,
quando gli appropriati segnali ambientali sono rilevati. In questo caso quindi durante
l’ipnosi si ha una generale azione implementatrice, per cui anche se non conosciamo
esattamente quello che dovremmo fare ci lasciamo guidare dall’ipnotista, e così le
nostre azioni sono indotte automaticamente dalle suggestioni.
BIBLIOGRAFIA:
-Amerio, P. (1995). Fondamenti teorici di psicologia sociale. Bologna: Il Mulino.
-Ajzen, I., Fishbein,M. (1980). Understendig attitude and prediciting social
behavior. Englewood Cliffs, NJ:Prentice Hall. Tesser, A. (1988). Toward a self-
evaluation maintenance model of social behavior, in L. Berkowitz (a cura di),
Advances in experimental social psychology, vol XXI. New York: Academic Press.
-Aronson, E., Wilson, T., D. e Akert, R., M. (1997). Psicologia Sociale. Bologna: Il
Mulino.
-Bäckman, H., Kalliola, H., Östling, G. (1960). Placebo effect in peptic ulcer and
other gastroduodenal disorders. Gastroenterologia, 94, 11-20.
-Barber, T., X. e Calverley, D., S. (1962). Hypnotic behavior as a function of task
motivation. Journal of Psychology, 54, 363-389.
-Barber, T., X. e Calverley, D., S. (1963). The relative effectiveness of task
motivating instructions and trance induction procedure in the production of
“hypnotic-like” behaviors. Journal of Nervous and Mental Disease, 137, 107-116.
-Barber, T., X. e Calverley, D., S. (1963). Toward a theory of hypnotic behavior:
Effects on suggestibility of task motivating instructions and attitude toward
hypnosis. Journal of Abnormal and Social Psychology, 67, 557-565.
- Barber, T., X. (1965). Measuring “hypnotic-like” suggestibility with and without
“hypnotic induction”; psychometric properties, norms and variables influencing
response to the Barber Suggestibility Scale (BSS). Psychological Reports,16, 809-
844.
-Barber, T., X. (1972). Ipnosi: un approccio scientifico. Roma: Astrolabio-Ubaldini.
-Barker, S., L., Funk, S., C. e Houston, B., K. (1988). Psychological treatment
versus nonspecific factors: A meta-analysis of conditions that engender comparable
expectations for improvement. Clinical Psychological Review, 8, 579-594.
-Baumeister, R., F. e Vohs, K., D. (2004) Handbook of self-regulation. New York,
London: The Guilford Press.
-Cervone, D. e Williams, S., L. (1992). La teoria socio-cognitiva e la personalità in
Caprara, G., V., e Van Heck, G., L. Moderna psicologia della personalità. Padova:
Esedra
-Council, J., R., Kirsch, I. e Hafner, L., P. (1986). Expectancy versus absorption in
the prediction of hypnotic responding. Journal of Personality and Social
Psychology, 50, 182-189.
-Fishbein, M., Ajezn. I., (1975). Belief, attitude, intention and behavior: An
introduction to theory and research. Reading, MA: Addison-Wesley.
-Frank, J. D. (1973). Persuasion and Healing: A comparative study of
psychotherapy Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.
-Gulotta, G. (1980). Ipnosi. Milano: Giuffrè editore.
-Hilgard, E., R. e Tart, C., T. (1966). Responsiveness to suggestions following
waking and imagination instructions and following induction of hypnosis. Journal of
Abnormal Psychology, 71, 196-208
-Kirsch, I., Council, J., R. e Mobayed, C. (1987). Imagery and response expectancy
as determinants of hypnotic behavior. British Journal of Experimental and Clinical
Hypnosis, 4, 25-31.
-Kirsch, I., (1990). Changing Expectations.A key to effective psychotherapy.Pacific
Grove, California: Brooks/Cole Publishing Company.
-Kirsch , I., Capafons, A., Cardeña-Bulena, E., Amigò, S. (1999). Clinical Hypnosis
and Self-Regulation: cognitive-behavioral perspective. Washinghton D.C.:
American Psychological Association.
-Melie, J., P. e Hilgard, E., R. (1964). Attitudes toward hypnosis, self-prediction,
and hypnotic susceptibility. International Journal of Clinical and Experimental
Hypnosis, 12, 99-108.
-Merton, R., K. (1948). The self-fulfilling prophecy. Antioch Review, 8, 193-210.
-Norman, D., A. & Shallice, T. (1986) Attention to action: willed and automatic
control behavior. In Davison, J., Schwartz, G., E. & Shapiro, D. (Eds),
Consciousness and self-regulation (vol.4 pp. 1-18) New York: Plenum Press.
-Rosenberg, S. e Gara, M. (1985). The multiplicity of personal identity, in P. Shauer
(a cura di), Self situations and social behavior. London: Sage.
-Rosenthal, R., Jacobson, L. (1983). Pigmalione in classe. Milano: Angeli.
-Sarbin, T., R., e Coe, W. C. (1972). Hypnotism: The social psychology of influence
communication. New York: Holt, Rinehart, & Winston.
-Sarbin, T., R. e Slagle, R., W. (1979). Hypnosis and Psychophysiological
Outcomes in Fromm, E. e Shor, R., E. Hypnosis: Developments in Research and
New Perspectives. New York: Aldine Publishing Company.
-Sarbin, T., R. e Coe, W., C. (1979). Hypnosis and Psychopathology: Replacing old
miths with fresh metaphors. Journal of Abnormal Psychology 88, 506-526.
-Shor, R. e Orne, E., C. (1962). Harvard Group Scale of Hypnotic Susceptibility.
Palo Alto, CA: Consulting Psychologist Press.
-Spiegel, H. e Spiegel, D. (1978). Trance and Treatment. Clinical uses of Hypnosis.
New York: Basic Books.
-Weitzenhoffer, A., M. e Hilgard, E. R. (1959). Stanford Hypnotic Susceptibility
Scale, Forms A and B. Palo Alto, CA: Consulting Psychologist Press.
-Weitzenhoffer, A., M. e Hilgard, E. R. (1962). Stanford Hypnotic Susceptibility
Scale, Form C. Palo Alto, CA: Consulting Psychologist Press.
-White, R., W. (1941). A preface to the theory of hypnotism. Journal of Abnormal
and Social Psychology, 36, 477-505.




























![Complexitat i fenomen (socio)lingüístic [Complexity and (socio)linguistic phenomenon]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63130623c32ab5e46f0c3b37/complexitat-i-fenomen-sociolingueistic-complexity-and-sociolinguistic-phenomenon.jpg)