Costantino il Grande e la Chiesa
Transcript of Costantino il Grande e la Chiesa
COSTANTINO IL GRANDE E LA CHIESA:UNA COMPLESSA RELAZIONE
TRA DOGMA, DIRITTO E POLITICAdi Vito Sibilio
Come giudicare il rapporto tra CesareFlavio Valerio Costantino Augusto ilGrande, primo del nome (307-337)1 e laChiesa?2 È un quesito che gli studiosi sisono posti e si porranno sempre, in quantoè difficile ricondurne l’interpretazione adun solo criterio ermeneutico. Il grandeimperatore, cui nell’immaginario comune sideve il connubio più che millenario trafede e politica, agì su molti livelli epose le premesse per molteplici, differentie a volte contrastanti sviluppi.
1. L’impero cristiano.
In una famosa terzina, Dante individuavanel Constitutum Constantini la fonte dellacorruzione della Chiesa:
Ahi, Costantin, di quanto mal fu matre,non la tua conversion, ma quella doteche da te prese il primo ricco patre! 3
A parte l’ovvio rilievo sull’equivocostorico in cui caddero tutti gli uomini delMedioevo, va evidenziato che Costantino,inserendo la Chiesa nel sistema del potereimperiale, non fece niente dirivoluzionario né per la religione nédell’impero.
1 Ampia è la bibliografia sull’imperatore. Cito come esempi: VOGT J., Constantinder Grosse und sein Jahrhundert, Monaco 19602; SAMPOLI F., Costantino il Grande, s.d.;DÖRRIES J., Constantin der Grosse, Stoccarda 1958; PIGANIOL A., L’empereur Constantin,Parigi 1932.2 Sul rapporto tra Costantino e la Chiesa cfr. tra gli altri ALFÖLDI A.,Costantino tra paganesimo e cristianesimo, Bari 1976; BAYNES N.H., Constantine the Great andChristian Church, Londra 1929; DORRIES H., Constantin and the Religious Liberty, New Haven1960.3 DANTE ALIGHIERI, Divina Commedia – Inferno, XIX, 115.
Quando si stigmatizza che, legandosiallo stato, il cristianesimo abbia traditole proprie origini, si dimentica cheCostantino restaurò quella monarchia didiritto divino, descritta nell’AnticoTestamento, in cui il sovrano è unto delSignore e suo eletto.
Ciò è invece posto in evidenza dagliscrittori ecclesiastici contemporaneidell’imperatore: non per propaganda, comespesso si crede, ma per intima coerenza conla propria formazione religiosa. La Chiesa,nuovo Israele, aspettava sin dalle originidi rivivere l’esperienza dell’antico popoloebraico: le persecuzioni, che duravano dapiù di tre secoli, erano destinate adessere provvisorie, e dovevano esseresuperate nella realizzazione del regno.Tale realizzazione, seppur in ogni casoescatologica, poteva essere intesa tanto insenso estremo, ossia interpretando allalettera l’Apocalisse (la liberazionesarebbe venuta con la distruzione di Roma edel mondo) quanto in senso moderato(sarebbero stati distrutti solo i valoridel paganesimo).
Nel corso dei tre secoli della suastoria, il cristianesimo aveva imparato adapprezzare i vantaggi della cultura greco-romana e dell’unificazione dell’ecumene:superando i germi di diffidenza asceticaattestati, tra l’altro, anche nella Letteraa Diogneto, si sviluppavano i semi direalismo politico presenti sin dalmagistero apostolico, specie paolino, cosìda concepire il sogno e il desiderio di unbattesimo dell’impero. In questo modo isentimenti di rancore e di disprezzoespressi nell’Apocalisse erano andatiattutendosi e stemperandosi in una sfiduciaradicale nei confronti del poterecostituito, in attesa di ricostituirlodiversamente.
Ciò che Costantino propose alla Chiesaera quello che la Chiesa stessa era giàpredisposta ad accettare, non per aviditàdi potere o per tradimento dei propriprincipi, ma per esplicitare uno degliaspetti del proprio retroterra spirituale.Il contrasto tra il Christus passus el’Imperator victor, posti entrambi al verticedella Chiesa, si supera nella dicotomiasquisitamente cristiana del Christus passus etgloriosus. Essa trova proprio nel sovrano unadelle sue epifanie più significative:Cristo, re e sacerdote secondo il modo diMelchisedek, realizza temporalmente ilproprio sacerdozio nell’ordine sacro e lapropria regalità nell’impero, anch’essosacralizzato.
In quanto imperatore, Costantino nonruppe realmente con la tradizione, ma silimitò a modificare i contenuti delloschema che in essa riuniva fede e potere,sacralizzando il secondo. Era dai tempi deifaraoni che i sovrani mediterranei sifacevano dèi per affondare nel cielo leradici del potere, perché l’ordineterrestre delle cose rispecchiasse quelloultraterreno; soluzione alternativa aquesto problema era lo schema mesopotamicodel sovrano mediatore tra gli dèi e l’uomo,presente anche nella cultura ebraica ecomune a quella ariana. La teologia delpotere era un’esigenza culturale avvertitada sempre, e rispecchia il bisognolegittimo di una fondazione del potere.
Roma era solo l’ultima grande potenza aporre il problema del rapporto tra religio eimperium. Dall’età di Augusto l’ambiguitàdei rapporti tra il sovrano e la divinitàaveva oscillato tra la soluzioneindoeuropea dell’imperatore comes divorum(Ottaviano aveva autorizzato i templi peril suo Genius) e quella egizia, riciclatadall’ellenismo, del monarca dio egli stesso
(lo stesso Augusto non aveva disdegnato difarsi divinizzare in vita sulle rive delNilo). La crisi del potere imperiale,maturata nel III secolo, aveva spinto acercare una soluzione ideologicanell’ambito delle teologie orientali;Diocleziano aveva superato del tutto laconcezione del principato a favore deldominato, incentrando il suo schema disacralizzazione del potere sull’equazioneche faceva infallibilmente dell’imperatoreun dio.
Ma questa soluzione cozzava proprio conil senso comune di cristiani e di alcunipagani, come i neoplatonici o i mistici,ossia di una parte significativadell’opinione pubblica imperiale.
La persecuzione dioclezianea fu laconseguenza logica di questa situazione, ela svolta costantiniana l’altrettantologica mutazione di rotta, che riportò lateologia imperiale nell’alveo ariano,coonestandola con la più ricca e anticatradizione giudaica, proseguita nelcristianesimo.
Lo schema per cui la divinità fonda lamonarchia e questa domina in suo nome vienecristianizzato da Costantino, senza alcunamodifica; anzi, con maggiore precisione, inquanto ad un solo monarca in terracorrisponde un solo Dio in cielo. Questomodello di dominato resse Roma non solofino al tramonto della pars Occidentis nel 476,ma anche fino al crollo di quella Orientisnel 1453; fu inoltre il modello di tutte lemonarchie universali e nazionalisuccessive, fino al 1848 in Europaoccidentale e fino al 1917 in quellaorientale.
Ma come visse Costantino, concretamente,questa esigenza di sacralizzazione delpotere? Come divinò la difficile esigenzadei suoi tempi di trovare un nuovo
fondamento all’esercizio della sovranità?Sicuramente adoperò – né poteva altrimenti– le sue categorie mentali di romano: essediedero alle sue suggestioni mistiche – e aquelli dei circoli che gli si radunaronoattorno – una veste teoretica salda,trasferendo nell’ambito del diritto dellecategorie antropologiche. Considerando lareligio come un momento dello ius publicum, egliritenne normale arrogarsi i poteri dicontrollo su di essa, non solo perché gliimperatori erano stati tradizionalmentepontefici massimi, ma perché erano la fontedel diritto, almeno dall’età adrianea. Ilcristianesimo coonestò questa sua ambizionecon l’ideale biblico della teocrazia. E inpoco tempo si arrivò alla concezionedell’episkopos tōn ektos, che in qualchegenerazione si evolvette – senza voler dareal termine necessariamente un’accezionepositiva – in quella dell’isoapostolo, odel tredicesimo apostolo.
Nonostante l’imperatore non fosse piùdivus, nonostante non fosse più invictus comeil Sole ma più modestamente victor,nonostante non fosse più raffigurato con lacorona radiante ma solo con un nembo,sebbene non si sacrificasse più in suoonore e i templi eretti per lui fosseromeri monumenti, l’ideologia del potere diCostantino fu la compiuta, pienarealizzazione del sogno del dominatodioclezianeo ed illirico. L’imperatoredivenne il vicarius Dei, come era stato primavicarius Deorum. E fu la concezione che dominòtutte le teocrazie cristiane,impropriamente chiamate cesaropapismi,dall’età carolingia a quella ottoniano-salica, alla impossibile revanche della CasaSveva e fino allo zarismo.
In quali ambiti si esplicò l’azione diCostantino I in relazione alla religione?
L’imperatore svolse una duplice attività,l’una nel campo giuridico, l’altra inquello dogmatico.
2. L’ambito giuridico.
In ambito giuridico, non si puòprescindere dal cosiddetto editto di Milanodel febbraio 313 – che in realtà editto nonfu –4 concertato tra Costantino e Licinio(308-324).
Esso diede esecuzione all’editto ditolleranza pubblicato sul letto di morte daGalerio ([293] 305-311) nel 311 (col qualel’antico persecutore dimostrò di avercompreso l’inanità degli sforzianticristiani e si sforzò di inserire nelpantheon romano anche Gesù Cristo) e servì arisolvere anche dal punto di vistateoretico la questione. I due augusti,dichiarando sin nel preambolo di volerpraticare la tolleranza, attestarono di nonvoler escludere neanche i cristianidall’esercizio di questa virtù pubblica,allo scopo di procacciare all’imperoun’ulteriore benevolenza della summadivinitas: la suprema divinità, cioè, dasempre considerata nel paganesimo la piùgrande di tutte, oltre che la menoconoscibile.
Questa concezione religiosa era stata diCostanzo I Cloro ([293] 305-306),5 ecostituisce la preistoria spirituale diCostantino. Forse per adeguarsi a questavaga ispirazione monoteista, già dal 306Costantino, divenuto augusto al posto delpadre, aveva emanato un editto di
4 Cfr. PALANQUE J.R., A propos du prétendu édit de Milan, in “Byzantinische Zeitschrift”10 (1935), pp. 607-616.5 EUSEBIO, Vita Constantini (= EUSEBIO, Vita Const.), 1, 17.
tolleranza.6 Questa spiritualità irenica diuna generica iperlatria da tributarsi alladeità suprema si andò poi specificando nelculto del sole invitto; culto che giànell’antico zoroastrismo era stata lamanifestazione visibile dell’unico diosupremo, Ahuramazda, principio del bene, eche persino nel remoto Egitto faraonico erastato, sia pure per breve tempo, imposto alrecalcitrante pio popolo politeista daAkhenaton.
Costantino si mosse su questa scia,accettando un dio solare sincreticamenteesprimibile da più ipostasi divine, escelse per suo nume tutelare quelladell’Apollo gallico.7 Questa ispirazione eraancora dunque riscontrabile nell’editto diMilano, sebbene Costantino fosse diventatocristiano già dalla campagna controMassenzio (306-312) nel 312, quando vinse aPonte Milvio (28 ottobre), avendo avuto ilcelebre sogno che lo invitava ad assumerecome labaro il monogramma cristiano, edella cui storicità non è il caso didubitare.8 Evidentemente i due augusti,facendo un richiamo alla teologia del sommodio, pensavano di fornire una corniceideologica in cui fosse accettabile, ancheper i pagani, inserire il nuovoatteggiamento verso la religione cristiana.
Ma l’editto milanese andava molto al dilà di questo. La tolleranza di Galerio erastata concessa con rammarico, quella deidue augusti si condiva di raccomandazionibenevole ed energiche ad un tempo, con cuiinvitavano a restituire gratuitamente allaChiesa i loca sacra, di cui essa è l’unicalegittima proprietaria: chiese e cimiteri,anche se in mano a privati (evidentemente
6 LATTANZIO, De mortibus persecutorum (= LATTANZIO, De mort. pers.), 24, 9.7 Cfr. KARAYANNOPOULOS J., Konstantin der Grosse und der Kaiserkult, in “Historia” 5(1956), pp. 341-357.8 LATTANZIO, De mort. pers., 44; EUSEBIO, Vita Const., 1, 27-32.
l’esproprio persecutorio era considerato aposteriori un’empietà, contraria al fas eallo ius) dovevano tornare alla comunità,riconosciuta come persona giuridica.
Tali riconoscimenti scaturiscono dallatangibile potenza della protezione diCristo esperita dai due imperatori –chiaramente più da Costantino che daLicinio.9 Con questa asserzione pubblica,entrambi danno un chiaro connotato a quelmisterioso Dio alla cui protezioneCostantino aveva dovuto la vittoria controMassenzio e nel cui onore aveva omesso letradizionali cerimonie religiose del suotrionfo in Roma dopo la sconfitta delrivale. 10
Da quanto detto, l’Editto milaneserisulta essere un punto di arrivo, speciedella legislazione costantiniana, il cuivissuto religioso e la cui esperienzapolitica contribuiscono decisivamente atracciare la fisionomia del testo.Peraltro, forte è l’attenzione al cultocome fulcro dell’esercizio della libertàreligiosa. A Costantino e a Liciniointeressa che Dio sia opportunamenteglorificato, cosicché si storni dalla terrail suo castigo, scongiurato dal sacrificiorituale. Vi è, in filigrana, ancora unaconcezione piuttosto superstiziosa dellafede, in cui Dio è continuamente dapropiziare e da placare. Tra i due augusti,Licinio era più superficiale in relazioneal cristianesimo: ancora nella guerra che,
9 LATTANZIO, De mort. pers., 48, 7-9; 11, 45-47.10 Tali provvedimenti riecheggiavano, del resto, quelli già presi da Costantinonel 312 per la Chiesa africana scrivendo al prefetto Anullino, e la lorofinalità era la garanzia dell’esercizio del culto, come già per la questioneafricana l’imperatore aveva avuto modo di specificare in una lettera aCeciliano, in cui stanziava una forte somma proprio per esentare il clero daogni attività lavorativa che lo distogliesse dalle celebrazioni liturgiche. Intal senso si era ancora mosso l’imperatore quando aveva esentato i sacerdoticartaginesi da ogni ufficio pubblico. EUSEBIO, Historia Ecclesiastica (= EUSEBIO, Hist.Eccl.), 10, 5, 15-17; 6, 1-5; 7, 1-2.
di lì a poco, lo contrappose a MassiminoDaia (305-312), egli manifesta una fedegenerica nel sommo Dio, appena temperata daelementi cristiani estrinseci.11 In ognicaso, la vittoria sull’ultimo persecutore –che nell’ultima fase della lotta avevaconcesso una tolleranza assoluta ai suoisudditi cristiani –12 diede a Licinio,nell’autunno del 312, la sovranità su tuttol’Oriente, in cui si poterono estendere ibenefici effetti della tolleranza sancita aMilano, almeno fino a quando la rinfocolataostilità tra i due augusti indusse Licinioa ridimensionarla, temendo che la Chiesafungesse da quinta colonna costantiniananel suo dominio.
Nel lasso di tempo che divide l’edittomilanese dalla definitiva riunificazionedell’impero sotto lo scettro costantinianonel 324, quello che è stato definito ilprimo imperatore cristiano ha peraltrosviluppato in modo coerente un corpolegislativo ispirato alla religione e voltoa garantirne la sicurezza.13 Fu ad esempioabolita la marchiatura a fuoco sul voltodei condannati ad metalla o ai giochigladiatorii, per l’esplicita motivazionebiblica che l’uomo, imago Dei, non può esseresfigurato.14 Inoltre fu riconosciuto aicristiani il diritto di affrancare glischiavi in presenza del proprio vescovo;al clero fu persino concesso di farloverbalmente e senza testimoni.
Ciò sottintende la volontà di fare deipresuli cattolici non solo dei “prefetti invioletto” – per usare anacronisticamente ladefinizione riservata ai vescovi nelperiodo napoleonico – ma anche una fonte dilibertà per gli schiavi, considerati dal
11 LATTANZIO, De mort.pers., 45-47.12 EUSEBIO, Hist. Eccl., 9,10. 7-11.13 Cfr. EHRHARDT A.A.T., Some aspects of Constantine’s Legislation, in “Studia Patristica” 2(1957), pp. 114-121.14 Codex Theodosianus (= Cod. Theod.), 9, 40, 2.
cristianesimo uomini esattamente come iloro padroni. Concedere poi al clero lafacoltà di affrancarli con una procedurastraordinaria significava cercare diseparare al massimo due istituti – quellosacerdotale e quello schiavile –evidentemente inconciliabili tra loro.15
Successivamente, l’equiparazione delvescovo al procuratore avvenne anche alivello giudiziario. Costantino stabilì chedue parti potessero, di comune accordo,adire al tribunale episcopale al posto diquello civile: un privilegio destinato adurare per più di un millennio.16
Evidentemente, per l’imperatore era assurdoche i ministri di Dio, da lui scelti pergiudicare in spiritualibus, fossero esclusi daigiudizi in temporalibus.
La legislazione flavia dimostrò inoltredi saper apprezzare i valori cristianidella castità e dell’ascesi, abolendo leleggi contro i celibi e contro coloro chenon avevano figli.17
La legge del marzo-luglio 321 rendefestivo il primo giorno settimanale, conl’obbligo del riposo per i lavoratoriservili e per i magistrati, oltre che conl’invito a promulgare in essol’emancipazione degli schiavi –all’occorrenza protocollato ufficialmente –e a compiervi opere pie. Il cicloebdomadario giudaico-cristiano entra cosìnella scansione del tempo civiledell’Europa cristiana;18 per nessun’altrafede c’è, nell’impero, una legge analoga.Il tempo profano, che riunifica le azionidel secolo, viene appaltato ad una fede esacralizzato. Siamo qui ad uno stadiomolto profondo della cristianizzazione
15 Cod. Theod., 4, 8, 1.16 Cod. Theod., 1, 27, 1.17 Cod. Theod., 8, 16, 1.18 Cod. Theod., 2, 8, 1.
dell’uomo romano. Per un gesto dialtrettanta radicalità, ma opposto e odiosoper le modalità in cui maturò, bisognasaltare direttamente alla rivoluzionefrancese e alla sua sovversione dellasettimana in decade, e alla sostituzionedella domenica col decadì.
Altrettanto privilegiante fu ildispositivo legislativo che permetteva dilasciare qualsiasi cosa in testamento allaChiesa, anche da parte di un non-cristiano.19
Costantino volle inoltre separarenettamente la tolleranza per i cristiani daquella per i non cristiani. Ilcristianesimo era la verità, e andavaprotetto; ad esempio, dall’ostilità degliEbrei. E così i convertiti ex circumcisione chefossero perseguitati dai loro ex-correligionari erano oggetto di unaprotezione speciale:20 erano il piccoloresto del vero Israele. Nel maggio 323inoltre l’imperatore reagì a violenzespontanee compiute contro i cristiani,comminando fustigazione e multa a chicostringesse i fedeli al sacrificiolustrale.21
In questi impianti legislativi illessico denotativo del cristianesimo (cultusDei, pia religio ecc.) e quello del paganesimo(superstitio) non lascia dubbi sulla pienaadesione dell’imperatore alla nuova fede,che nelle sue premure trovava la nemesistorica di tre secoli di cruentepersecuzioni. Lo spazio di libertà delpaganesimo è ristretto. E l’ispirazionemosaica della legislazione imperiale èpalese nel duplice divieto dell’aruspicinaprivata (319-320), il cui scopo è ilmassimo controllo possibile –appunto
19 Cod. Theod., 16, 2, 4.20 Cod. Theod., 16, 8, 1. 21 Cod. Theod., 16, 2, 5.
pubblico – su questa forma di divinazione.22
Siamo sulla scia che porterà Teodosio ilGrande (379-395) alla proibizione delpaganesimo. Ma per ora Costantino èsinceramente tollerante, anche nella suaveste di pontefice massimo.
Questi dispositivi legislativiscaturiscono senz’altro dalla profonda eprogressiva cristianizzazione morale delsovrano, ma sono anche – in una società incui il potere politico si ipostatizza nelsovrano di diritto divino – lamanifestazione di un connubio politicosempre più forte.
La personalità più scialba e menoreligiosa di Licinio doveva reagire insenso opposto, traducendo in altri terminireligiosi la volontà egemonica che loaccomunava e contrapponeva a Costantino.Tra il primo scontro nel 316 e ladefinitiva resa dei conti nel 324, Licinioandò coronando di spine lo status di religiolicita da lui stesso concesso al cristianesimonel 313. L’interdizione del culto nellecittà e nei luoghi chiusi, l’obbligo diassemblee separate per uomini e donne, ildivieto al clero di catechizzare le donnestesse, la proibizione di assistere icarcerati, oltre a casi specifici diesenzione dal servizio militare e diallontanamento dalla pubblicaamministrazione furono le meschine misureche Licinio prese capovolgendo la suaprecedente politica di reappeasement.23 Cifurono casi di violenze anche mortali suvescovi, e alcune chiese furono demolitenel Ponto, senza che l’augusto orientaleintervenisse per fermarli.24
22 Cod. Theod., 9, 16, 1; 16, 10, 1. Cfr. KARPP H., Konstantins Gesetze gegen die privateHaruspizin aus den Jahren 319 bis 321, in “Zeitschrift für die NeutestamentlicheWissenschaft” 41 (1942), pp. 145-151.23 EUSEBIO, Hist. Eccl., 10, 2; 10, 8, 10-11; Vita Const., 1, 51, 53, 54.24 EUSEBIO, Hist. Eccl., 10, 8, 13-17.
Una volta che ebbe trionfato sul rivale,Costantino rimediò a queste vessazioni conun editto di riparazione25 che tuttaviagarantiva ancora ai pagani la libertà dicoscienza. La legislazione flavia facevadell’autodeterminazione spirituale unlimite invalicabile della sua competenza:lo stato poteva favorire la professionedella vera fede, ma non poteva forzarel’adesione ad essa. La fede rimanevaancora, non solo formalmente ma anchematerialmente, un atto di volontà.
E tuttavia le leggi di riparazionefurono una restitutio in integrum: sospensione diogni sentenza dannosa o infamante (come laprivazione dei pubblici uffici e lariduzione in schiavitù), restituzione deibeni alle chiese e ai singoli, anche seincamerati dallo stato o se venduti aterzi, e addirittura agli eredi.26 E di lì apoco l’uguaglianza religiosa, faticosamenteraggiunta dalla cristianità, viene superatain un primato formale che si configuraquasi come una nemesi storica delpaganesimo: i funzionari pubblici noncristiani non possono professareesternamente la loro fede, a differenza diquelli battezzati.27
Del resto, se Flavio Costantino dimostròalta considerazione per il misticismoneoplatonico – affine a quella religiositàdel Sommo Dio a cui lui stesso era statovicino – e deferenza per le antichefamiglie senatoriali, il cui paganesimo eratradizionale, non mancò di presentarsi nécome debellatore dell’antica religione nécome sovrano che la tollerava solo per iprincipi di umanità della sua fede.28 Eanche nel plasmare la classe dirigente il
25 EUSEBIO, Vita Const., 2, 4, 42.26 EUSEBIO, Vita Const., 2, 30-41.27 EUSEBIO, Vita Const., 2, 44.28 EUSEBIO, Vita Const., 3, 66; 2, 44, 48-60.
monarca si rende conto di dover selezionaregente che sia disposta a seguire questapolitica: ragion per cui i funzionarinominati sono quasi tutti cristiani.Inoltre prosegue l’osmosi tra episcopato eburocrazia, in quanto Costantino celebra ivicennalia tra i presuli radunati a Nicea e fapronunciare il panegirico a uno di loro.29
A tale politica di diminuzione socialedel paganesimo si accompagna una serie dimisure restrittive: se ai collegisacerdotali delle divinità tradizionalisono lasciati i loro templi, un numeroimprecisato di essi – che sia i cristianiper trionfalismo che i pagani pervittimismo avevano interesse ad aumentareagli occhi dei posteri – viene privatodelle rendite o delle immagini, se non rasoal suolo. A onore di Costantino va ladistruzione dei templi pagani disseminatida Adriano sulle memorie giudaico-cristianedopo la repressione della rivolta di BarKokheba: il Calvario, la casa della Verginea Gerusalemme, i luoghi dell’infanzia diCristo e del Battista furono liberati dallesacrileghe costruzioni e adornate dimonumenti. Peraltro, il monarca ha cura disopprimere forme particolarmente licenziosedi culto pagano, specie quelle di Afrodite,o quelle sfacciatamente animistiche come lavenerazione del Nilo affidata a una castaclericale di eunuchi, o ancora dicontenere le religioni di Cibele e diMitra.30 Un significato di particolaredisprezzo ma anche una chiara intenzione dicolpire la potenza economica del cultopagano hanno le requisizioni di oggettisacri dei templi per adornare la costruendaCostantinopoli. Essa, come le sontuosechiese costruite nelle capitali imperiali(Nicomedia, Treviri, Sirmio, Milano) e come
29 EUSEBIO, Vita Const., 2, 44; 1, 1.30 EUSEBIO, Vita Const., 3, 26-27; 55-56; 58; 4, 25.
le basiliche patriarcali a Roma sullememorie degli apostoli, rientra in unprogetto di sacralizzazione dello spazio edi inserimento dell’impero nell’ordinecosmico voluto da Dio e restaurato inCristo.
In questa fase di dominio incontrastato,l’imperatore si ispira sempre di più allareligione, e il diritto romano è la formacon cui egli ordina la materia giuridicache può trarre dalla tradizione cristiana:31
il divorzio non è abrogato, il matrimoniorimane un contratto, ma il suo scioglimentodiventa più difficile, conformementeall’importanza dell’accordo stipulato;inoltre appare logico vietare ilconcubinato, che non prevede né sacramentoné contratto.
Le unioni degli schiavi sonoriconosciute naturaliter simili a quelle deiliberi: due sposi non possono essere divisitra loro o dai figli in caso di un’ereditàripartita tra più persone.32 In ossequioalla dignità della vita umana vengonoaboliti i giochi gladiatori, mentre laproscrizione della crocifissione è unomaggio a Cristo stesso.33
Dopo aver ripromulgato per tuttol’impero i dispositivi legislativiprecedenti in ordine al foro ecclesiasticoe alla difesa dei neofiti, Constantino fauna puntualizzazione importante: solo icattolici possono godere di questiprivilegi, mentre eretici e scismatici nesono esclusi:34 alla Verità sola spetta laprotezione provvidenziale dell’Impero,mentre coloro che traviano le coscienze nondebbono essere certo agevolati, anzi vannoostacolati.
31 Cfr. sull’arg. DORRIES, Constantin..., cit., pp. 82-84; 197-199; 203.32 Cod. Theod., 9, 7, 2; 3, 16, 1; 2, 25, 1; Codex Iustiniani, 5, 26, 1. 33 Cod. Theod., 15, 2, 1; SOZOMENO, Historia Ecclesiastica (= SOZOMENO, Hist. Eccl.), 1, 8, 13.34 Cod. Theod., 16, 5, 1.
In quest’ottica va letto il decretoantiereticale pubblicato dopo la sconfittaliciniana: ai novaziani, agli gnostici, aipaoliani e ai catafrigi vengono interdettele adunanze sia pubbliche che private –perché culto non gradito a Dio – vengonoconfiscati tutti i beni comunitari, vengonosottratte le chiese che vanno restituite aicattolici, vengono tolti i libri sacri.Rimane loro solo la libertà di coscienza,nonostante un monito generico per laconversione al cattolicesimo.35 Soltanto ainovaziani, in virtù della loro adesione alSimbolo niceno, l’imperatore lascia chiesee cimiteri,36 sperando di ricucirne loscisma.
3. L’ambito dogmatico.
Se la valutazione dell’operatocostantiniano in campo legislativo non puòessere che univoco e positivo (almeno perchi veda nella cristianizzazione deldiritto un progresso dell’humanitasclassica, e riconosca nel connubio traimpero e fede una tappa significativa delcammino verso le forme future dellaciviltà), più complesso è il giudizio sulmodo in cui il fondatore della secondadinastia Flavia ingerisce in interna corporisdella Chiesa, spontaneamente o indottovi aforza.
3.1. Lo scisma donatista.
Il primo caso affrontato è lo spinososcisma donatista,37 (dal nome del massimoteorico della disputa, il presule africanoDonato).
35 EUSEBIO, Vita Const., 3, 64-66.36 Cod. Theod., 16, 5, 1.37 Cfr. sull’argomento GRASMÜCK E.L., Coercitio. Staat und Kirche im Donatistenstreit, Bonn1964.
L’occasione venne dalla valutazione diun traditor, di chi cioè aveva, durante lapersecuzione dioclezianea, consegnato iLibri sacri e sacrificato agli dei,ottemperando ai decreti imperiali. Nel 312,alla morte del vescovo cartagineseMensurio, il popolo e il clero scelserocome successore Ceciliano; questi però erafortemente avversato dai donatisti perché,quando ancora era diacono, aveva umiliatouno dei loro più influenti capi,rimproverandolo aspramente per il cultofanatico dei martiri. Per impugnarnel’elezione, i donatisti obiettarono aCeciliano un presunto difetto nellaconsacrazione, compiuta tra gli altri dalvescovo Felice di Aptungi, che era statoappunto traditor.
Questa obiezione trovò terreno fertilenon solo nella particolare sacramentariaafricana, ma anche nella malcelata ostilitàdell’episcopato numida verso la sedeprimaziale cartaginese: il vescovo diTigisi Secondo, inferiore di rango solo aCeciliano, radunò un Concilio di settantavescovi che, in linea con la tradizionaleautonomia della Chiesa della Proconsolare,risolse la questione in modo sfavorevole aCeciliano, che fu deposto e rimpiazzatoprima da Maiorino e poi da Donato stessonel 313.
Un nodo della questione era certo iltrattamento da riservare agli apostatipentiti: i rigoristi oscillavano dallavolontà di escluderli per sempre dallaChiesa alla richiesta di umilianti eprolungate penitenze, che comportasserosoprattutto la riduzione allo statolaicale; i moderati si accontentavano diimporre una congrua riparazione.
Questo nodo non era però l’unico: sullosfondo si agitava la questione classicadella teologia sacramentale africana, la
validità del sacramento ex opere operando e nonex opere operato (come nela teologia romanaprima e universale poi). Tale questione eraparticolarmente importante proprio perchémolti vescovi, presbiteri e diaconi eranostati traditores.
Costantino fu precocemente informatosugli sviluppi della crisi ecclesiasticaafricana da Osio di Cordova, il vescovoconsigliere imperiale fino al Concilio diNicea. L’imperatore non comprese certo laportata dogmatica della disputa – lesottigliezze teologiche non furono mai ilsuo forte – ma si avvide della suapericolosità disciplinare, e ne valutò laportata in relazione alla confusione in cuiera caduto il culto liturgico. Egli scrissedunque a Ceciliano, riconoscendolo qualevescovo legittimo e offrendogli l’ausiliodelle truppe imperiali per il ripristinodell’ordine, considerando così i donatistidei semplici – e pericolosi – perturbatoridella pace pubblica.38
I donatisti accusarono il colpo escrissero al stesso sovrano tramite ilprefetto Anullino, spiegandogli il propriopunto di vista e domandando di esseregiudicati da un tribunale imparziale edesterno, formato da vescovi gallici.39
L’imperatore accettò: una decisione questain linea con la tradizione ecclesiastica,solita affrontare le questioni rimasteirrisolte in un sinodo interprovinciale inuna assise ancor più prestigiosa.
Costatino deferì questione al papa,l’africano san Milziade (311-314),incaricandolo di allestire un tribunale conpresuli gallici. Il pontefice, mostrandoautonomia di giudizio, allargò lacommissione – che Costantino aveva
38 Lettera in VON SODEN H., Urkunden zur Entstehungsgeschichte des Donatismus (=SODEN),Berlino 19502 , n. 8.39 SODEN, nn. 10-11.
composto, oltre che col papa, coi vescovidi Autun, Colonia e Arles – ad altriquindici presuli italiani. Dinanzi a questaassise, secondo i deliberati imperiali,dovevano costituirsi dieci ceciliani colloro capo e dieci donatisti. I decretisinodali dovevano appurare se Cecilianoavesse rispettato la tradizioneecclesiastica facendosi consacrare da untraditor pentito, e sarebbero stati vincolantiper tutti.40
Il comportamento di Costantino verso ilpapa è significativo: il pontefice è sìautonomo, ma in seno all’impero, che è ilguscio protettivo della Chiesa. È lo stessorapporto sussistente tra la statio principis equella del sommo pontificato pagano, con ladifferenza che due magistrature, primaappartenute ad una sola persona, nel nuovoordinamento romano-cristiano erano perforza scisse.
Chiamando Milziade a presiedere iltribunale da lui istituito con presuligallici in base alla richiesta degliappellanti, che però del pontefice nonavevano fatto menzione, l’imperatoremostrava dunque di non voler prescinderedal primato petrino e, accettando cheMilziade ampliasse il tribunale in unsinodo, gli riconobbe autodeterminazionenella scelta dei mezzi di giurisdizione.
Ma i donatisti si appellarono contro lasentenza, che fu di assoluzione perCeciliano e di condanna per Maiorino eDonato. Sia Milziade che Costantino furonoirritati dall’ostinazione donatista. Ilpapa offrì la comunione canonica ai vescovidissidenti, perché non corressero ilrischio di perdere la sede ma anche perisolare Donato. L’imperatore si risolse a
40 SODEN, n. 12.
convocare ad Arles (estate 314) un sinododi tutti i vescovi occidentali.41
Il primo agosto il sinodo, presieduto daMarino di Arles e organizzato da Cresto diSiracusa, si aprì. Milziade era morto, e ilnuovo papa, san Silvestro (314-335), inviòuna piccola delegazione a rappresentarlo,non volendo lasciare Roma dopo la suaelezione. La sentenza di Arles confermòpraticamente quella romana, e i Padriconciliari chiesero a papa Silvestro, conuna deferente lettera, di comunicare ideliberati sinodali a tutto il mondocristiano. Il primato non era indiscussione: l’imperatore stesso, nelconvocare un concilio più ampio dopo unappello per vizio procedurale, non avevaaffatto disprezzato la decisione papale, maseguito una prassi ovvia giuridicamente econforme alla tradizione ecclesiastica.
I donatisti però non si sottomisero alconcilio. L’imperatore allora intervennepersonalmente, ma non ebbero effetto né ildivieto ai donatisti di lasciare Arles perl’Africa, né il tentativo di sostituireCeciliano con un nuovo vescovo, né leminacce di scendere personalmente in Africaper risolvere la questione.42 Non gli restòche scoprire le carte (316) dichiarandosifautore di Ceciliano,43 e prendere duriprovvedimenti contro i donatisti (317): glifurono tolte molte chiese e i loro vescovifurono obbligati all’esilio.
Erano misure coerenti col dirittocanonico, ma troppo simili a quelle delleancora recenti persecuzioni, e crearono neidonatisti solo una forte vocazione almartirio. Nemmeno l’esercito li ridussealla ragione, in quello che fu il primo
41 SODEN, nn. 14, 15, 18.42 SODEN, n. 23.43 SODEN, n. 25.
caso di uso delle truppe statali per unobiettivo religioso.
Alla fine Costantino si ritirò dallalotta. Fu una sconfitta per la sua politicaecclesiastica, ma anche una traccia segnataper il futuro: gli scismi non sarebberostati più una semplice lacerazione dellaChiesa, ma anche una questione politica.Solo che il significato di quest’ultimoaggettivo copriva una gamma di significatimolto vasti, che potevano andare da unnobile interesse per la religione checostituiva la sostanza etica dello stato edella società, fino a un deprimenteasservimento delle cose spirituali allestrategie del potere.
3.2. La controversia ariana.
Una prima avvisaglia di tutto questo siebbe proprio con la controversia ariana.44
Non è certo questa la sede per ripercorrerele fasi della formazione della cristologiaeterodossa di Ario. Basti ricordare cheessa, aumentando drasticamente iltradizionale subordinazionismo delladogmatica trinitaria, creava una cesura tral’essenza del Padre e quella del Figlio evanificava il valore dell’Incarnazione edella Redenzione, che non erano più operadi Dio. L’eresiarca alessandrino mostravala necessità di chiarire la questionecristologica, da tempo esposta alleincursioni dei più svariati pensatori.
Chiaramente la cristologia evangelica –in primis giovannea – non poteva accordarsicon quella ariana: l’idea di una Sapienzacreata prima di ogni altra creatura non siaddiceva ad un Verbo che in principio erapresso Dio e Dio egli stesso. Già Giovanni
44 Cfr. tra gli altri sull’arg. DE URBINA L., La politica di Costantino nella controversiaariana, in “Studi Bizantini e Neoellenici” 5 (1939), pp. 284-298; IDEM, Nicée etCostantinople, Parigi 1963; SIMONETTI M., La crisi ariana nel IV secolo, Roma 1975.
aveva, nel suo prologo appunto, fatto unacernita delle dottrine sapienziali chepotevano essere adattate a Cristo – comequella che ne faceva il mezzo dellaCreazione – e di quelle che andavanoappunto rigettate – come la sua creazionenel tempo. La terminologia filonianaadoperata dal quarto evangelista era usatacon un significato molto diverso da quelloche aveva negli scritti del filosofoalessandrino. E già la modesta cristologiadei primi secoli aveva concesso abbastanzaalla cultura extrabiblica accettando aldistinzione tra logos endiathetos e proforikos. Oral’eresia di Ario spezzava la corda, tesa dasecoli, e passava all’estremo opposto delmodalismo, che quella cristologiasubordinazionista precedente aveva volutosempre scongiurare.
Su questo troncone teologico,aggrovigliato e complesso, si sarebbeinnestato il dibattito di politicaecclesiastica e civile, da cui lo stessoCostantino, sensibilissimo al temadell’unità cattolica ma di certo incapacedi comprendere le implicazioni dogmatichedella discussione in tutta la loroampiezza,45 sarebbe stato irretito.
Quando l’imperatore fu informato delladisputa, Ario aveva già collezionato unarbitrato sfavorevole del suo vescovoAlessandro, la sua scomunica e la rinnovatacondanna di un concilio generale della sedealessandrina nel 319.46 Il fatto chel’eresiarca si fosse messo sotto ilpatrocinio dei due Eusebi – vescovi diNicomedia e di Cesarea – aveva inasprito lacontesa, condendola delle gelosieecclesiastiche di cui l’epoca era ricca.Certo che il conciliabolo bitino di Eusebio
45 Cfr. ad es. OPITZ G.H., Urkunden zur Geschichte des arianischen Streites (318-328) =Athanasius, Werke III, 1 (=OPITZ), Berlino 1934, n. 17.46 OPITZ, nn. 1, 2, 4b.
di Nicomedia spalleggiò lo scomunicatocaldeggiandone l’assoluzione, mentre la suaautodifesa continuava imperterrita.47 Dirincalzo Alessandro continuava acontestarlo, informando anche papaSilvestro.48
Costantino inviò una lettera adAlessandro e ad Ario per tramite di Osio diCordova, il suo già ricordato consigliereecclesiastico. Ma il tenore della missiva,che invitava ad un accordo, erasproporzionato alla posta in gioco, e Osio,una volta giunto ad Alessandria d’Egitto,se ne rese conto: era impossibile farcessare ogni discussione sull’argomento,come voleva l’imperatore.
Alessandro persuase Osio della necessitàdi una soluzione della controversiadogmatica; il legato imperiale tornò aNicomedia, allora sede del sovrano, senzaaver nemmeno potuto incontrare Ario e conuna netta propensione per la fazioneortodossa.49
Costantino alla fine si convinse che ladisputa poteva risolversi solo con unconcilio di tutti i vescovi, chepronunziasse una sentenza vincolante. Laprassi ecclesiastica aveva da semprefavorito queste decisioni collegiali;tuttavia un’adunanza di tutti i presulidell’ecumene non si era mai realizzata,anche a causa del regime di precarietàgiuridica della Chiesa nei primi secoli divita. L’unico precedente in tal senso erail concilio neotestamentario diGerusalemme.
Costantino però non innovava in sensoassoluto: altri sinodi erano stati radunatisulla questione cristologica. La veranovità stava nella sua scelta di arrogarsi
47 OPITZ, nn. 3, 6, 7. 48 OPITZ, nn. 11, 12, 14, 15, 16.49 OPITZ, n. 18.
la potestà di riunire i vescovi: nonnegoziò con nessuna autorità ecclesiasticaquesta riunione, tantomeno col papa. Cosìaveva del resto agito anche per il sinododi Arles, e papa Silvestro – la cuipersonalità era troppo scialba percompetere col grande sovrano – non avevamotivo per dolersi della decisioneimperiale, anzi dovette considerarlaottima.
Costantino fissò la sede sinodale aNicea in Bitinia, e ordinò che nel maggiodel 325 i presuli vi convenisseroservendosi dei mezzi pubblici di trasporto.Durante la loro permanenza sarebbero statiospiti del sovrano.50 La grande assiseradunò trecentodiciotto presuli, il cuinumero permise poi una misticaequiparazione con i servi di Abramo.51 Inessa la presenza di confessori come Paolodi Neocesarea e di Pafnuzio diede assolutoprestigio alla discussione, peraltroguidata sapientemente dalla minoranza chegià aveva preso posizione contro Ario,sotto l’egida di Alessandro di Alessandriae di Eustazio di Antiochia, di Marcello diAncira e di Macario di Gerusalemme.52 Unruolo importante ebbero i periti di questipresuli, come Atanasio di Alessandria,diacono di Alessandro, che più volte presela parola e che va considerato la veramente del sinodo.53 All’opposizione Eusebiodi Nicomedia, vescovo della capitaledell’impero, già collucianista, e poi –come abbiamo visto – protettore di Ariodopo la scomunica di Alessandro, e Eusebiodi Cesarea, mediocre teologo ma retoreabilissimo che si conquistò la fiducia
50 EUSEBIO, Vita Const., 3, 6.51 Cfr. AUBINEAU M., Les 318 serviteurs d’Abrahan et le nombre des Pères au Concile de Nicée, in“Revue d'Histoire Ecclésiastique ” 61 (1966), pp. 5-43.52 Cfr. SOZOMENO, Hist. Eccl., 1, 17, 2.53 TEODORETO, Historia Ecclesiastica ( = TEODORETO, Hist. Eccl.), 1, 11, 4.5; SOZOMENO, Hist.Eccl., 1, 17, 3; 1, 17, 7-18; 1.
dell’imperatore. Attorno a questi duepartiti si disposero quei dotti laici cheda subito avevano con calore abbracciato ladisputa e che andarono ad assistere allesedute conciliari.54
A questa disputa più greca che latinal’Occidente partecipò con soli quattrovescovi, per la sua estraneità a questodibattito e per le difficoltà del viaggio.Osio di Cordova, presidente dell’assemblea,Ceciliano di Cartagine e altri due colleghirappresentavano tutto l’episcopato latino,assieme ai due legati pontifici, Vito eVincenzo, che rappresentavano il troppoanziano Silvestro.55
Nonostante uno sfondo di intrighi, a cuil’onestà di Costantino non diede alcunseguito,56 il dibattito – a tratti duro esempre serrato – si sviluppò attorno allaquestione dottrinale in modo netto. Gliariani cercarono di far passare subito unsimbolo che veicolasse le loro convinzioni,sdegnosamente respinto dagli ortodossi;Eusebio di Cesarea propose invece un Credo,quello della sua diocesi, che tuttigiudicarono corretto, anche se apparveopportuno introdurvi correttiviantiariani.57 La correzione fondamentalevenne dal termine omoousios, inaccettabileper gli ariani e per alcuni ortodossi,perché ne ricordavano l’uso monarchiano diPaolo di Samosata biasimato (ma noncondannato) dal II Concilio di Antiochia(268). Il termine poteva tuttaviainterpretarsi come perfettamente ortodosso,distinguendo la consustanzialità dallaidentità personale, secondo la lezioneatanasiana e la tradizione romana, espressada papa Dionigi (259-268) già prima del
54 TEODORETO, Hist. Eccl., 1, 11, 4.5; SOZOMENO, Hist. Eccl., 1, 17, 3; 1, 17, 7-18; 1.55 SOZOMENO, Hist. Eccl., 1, 17, 2.56 SOZOMENO, Hist. Eccl., 1, 17, 4-5.57 OPITZ, n. 22, 4.7.
concilio antiocheno. E infatti i latinifurono i più entusiasti fautori dellaterminologia proposta, che era latraduzione greca del lessico trinitariodella patristica occidentale da Tertullianoin poi. Lo stesso Costantino, latinissimo –aveva parlato in questa lingua ai padriconciliari – caldeggiò l’uso del termine eperorò presso i greci la causa di una suaretta, univoca e vincolanteinterpretazione.58
La compattezza della grandiosa teologiadogmatica di Atanasio s’imposeall’assemblea nicena, e l’idea che ladivinità fosse solo dell’Esse ingeneratum,propria di Ario, fu riconosciuta pagana, esostituita da quella evangelica che latrasmette dal Padre al Figlio e poi alloSpirito.
La teologia di Nicea ha avuto il pregiodi sintetizzare opposti impossibili:l’unità divina e la pluralità delleipostasi o persone:59 Costantino stesso,sedotto dalla forza intellettuale del Credoniceno, lavorò senza soste per l’adesionedi tutti i presuli alla sua dottrina. Isoli Ario, Secondo e Teonato non lasottoscrissero e andarono in esilio; alcunipresuli però chinarono il capo solo pertimore della corona e continuarono (tra diloro Eusebio di Nicomedia e Teognide diNicea) a parteggiare per l’eresiarcacaduto. Risolto anche il secolare problemadella data della Pasqua, fissata alladomenica dopo il 14 nisan, il concilio sisciolse solennemente.
58 OPITZ, n. 22, 7; EUSEBIO, Vita Const., 13, 3.59 Non a caso, dando un’idea dinamica della fissità divina, ha avuto i caldielogi di un idealista come Guido De Ruggiero che peraltro ha acutamentedenunciato la ragione che rese impossibile una conciliazione anche coisemiariani: era essa stessa infatti una teologia compromissoria, che ben rendevaintelligibili i contorni del dogma più alto, quello per cui Dio è uno e moltiinsieme. Cfr. DE RUGGIERO G., Storia della Filosofia, III, Bari 1920, pp. 260-271.
Ma Costantino mutò presto posizionerispetto al dogma niceno. Dapprima esiliò esostituì con presuli ortodossi Eusebio diNicomedia e Teognide di Nicea, che avevanopresto ritrattato la firma al Credoniceno;60 in seguito tuttavia richiamòEusebio di Nicomedia dall’esilio, spintodalla cortigiana influenza di Eusebio diCesarea – coonestata dall’ingenuo pareredella madre dell’imperatore, Elena,ammiratrice di quest’ultimo – e dellasorellastra Costanza.61 Reintegrato nellesue funzioni, il metropolita imperiale fuabile nell’ostentare deferenza per ideliberati niceni e nel dispensare velenocontro i loro fautori: con una proceduratipica del clima torbido dei dispotismi alcrepuscolo, Eusebio plagiò l’imperatoreaccusando di immoralità, litigiosità eirriverenza verso Elena il suo rivaleEustazio di Antiochia, la cui pennaaffilata aveva sarcasticamente commentatole azioni di Ario e ora stigmatizzaval’opportunismo politico del vescovo diNicomedia.
Eustazio fu deposto in un conciliaboload Antiochia (331 ca.), ai cui anatemiCostantino aggiunse l’esilio in Tracia.62
Ben presto la condanna toccò ad altri ottovescovi, mentre Eusebio cominciava amanovrare contro Atanasio, ora vescovo diAlessandria. È curioso osservare con qualefacilità l’imperatore abbia prestato fedealle accuse contro di lui: l’assassinio delvescovo Arsenio in qualità di fautore delloscisma di Melezio – presule ordinato senzail consenso del metropolita alessandrino maperdonato a Nicea – la fustigazione dialtri presuli suoi fautori, la profanazione
60 OPITZ, nn. 27. 28.61 FILOSTORGIO, Historia Ecclesiastica, 2, 7. 62 TEODORETO, Hist. Eccl., 1, 21, 4-22.
di un calice sono accuse chiaramentedenigratorie.
Forse il dispotismo alterònell’imperatore la percezione della realtà:certo è che egli accolse alla propria corteEusebio, nemico giurato della sua politicadogmatica, ne fece il proprio consigliere,al posto di Osio di Cordova, e lo assecondònella demolizione del partito fautore delCredo niceno. Il primo imperatore cristianodivenne, almeno nei fatti, anche il primofiancheggiatore dell’eresia. Probabilmente,constatando come il concilio non avessesanato i contrasti, era tornato allaprimitiva valutazione superficiale dellacontroversia, sotto il fatuo influsso diEusebio di Cesarea, e cercava un nuovocompromesso nel semiarianesimo.
In ogni caso, l’imperatore accolse leaccuse contro Atanasio e lo deferì alconcilio di Tiro (335), dove tutti iprelati (e persino il suo delegato FlavioDionigi) erano ariani. Atanasio non potevanaturalmente sperare in un giudizio equo e,forse temendo la morte, fuggì aCostantinopoli.
Costantino non volle però riceverlo;l’indomito vescovo lo avvicinò alloradurante un’uscita a cavallo, denunciando ifatti di Tiro, dove frattanto era statodeposto in contumacia. L’imperatore alloraconvocò a sé i presuli di Tiro: soloquattro, tra cui i due Eusebio, sipresentarono, accusando Atanasio disabotare i rifornimenti di grano egiziano aCostantinopoli. Evidentemente però ilcampione dell’ortodossia nicena risultavascomodo: data la natura palesementestrumentale dell’accusa mossagli, non fucondannato a morte ma solo esiliato.
Se Ario fosse vissuto ancora nel luogodel suo esilio, avrebbe fatto in tempo adessere riabilitato. Costantino, che ancora
nel 333 lo aveva condannato,63 nell’annosuccessivo lo aveva incontrato a corte dopoaverlo ripetutamente invitato.64
L’eresiarca gli presentò una professione difede elusiva che diede all’imperatore ildestro per aprire la procedura diriabilitazione, da sancire in un sinodogerosolimitano che però non si compì per lamorte dell’imputato.65 Tuttavia il conciliofece in tempo a chiedere l’assoluzione e lareintegrazione nel presbiteratodell’eresiarca, prima della sua morte,adducendo come pretesto proprio la nuovaprofessio fidei.
Di lì a poco morì anche l’imperatore,senza dubbio entrato in una fase misticadopo il battesimo, ma certamente tutt’altroche consapevole degli esiti della suacontraddittoria politica, che anticipatutte le opzioni dispotiche che poi isovrani bizantini svilupparono nei secoli.
Il modello di comportamento sancito aNicea per affrontare le crisi dogmatiche fuduraturo: confutazione degli errori,precisazione e ampliamento delle formuledottrinali contestate, uso appropriato dellessico filosofico. Inoltre con la difesadel Simbolo niceno la Chiesa dimostrò chel’abbraccio con l’impero non l’avevaanestetizzata, ma che sapeva difendersiancora all’occorrenza. La prosecuzionedella lotta sotto Costanzo II dimostrò siale possibilità di perversione del rapportostato-Chiesa insito nel sistemacostantiniano sia la possibilità diindipendenza morale della Chiesa stessa.
Creando un modello di relazioni traimpero e sacerdozio, Costantino fornì perun millennio scarso le coordinate in cui
63 OPITZ, n. 33, 4.64 SOCRATE, Historia Ecclesiastica, 1, 25.65 SOZOMENO, Hist. Eccl., 2, 27, 7 sgg.; 13-14; ATANASIO, Apologia contra Arianos, 84;IDEM, Epistola de morte Arii ad episcopos Aegypti et Libyae, 19.
impostare il problema. Nelle controversiecristologiche e trinitarie successive gliortodossi poterono contestare il ruolo deisingoli imperatori ma non delegittimarloper principio. Per arrivare a questo civorrà la mente geniale di Gregorio VII, ebisognerà che oapato e impero litighinofino al ‘200 per affermarladefinitivamente, facendo della libertàdella Chiesa un principio dellaspiritualità cattolica e un cardine dellaciviltà occidentale, anche nella suaversione laica. Per contro, la legislazioneimperiale creò un precedenteautorevolissimo per la cristianizzazionedel diritto, e segnerà profondamente ilmodo di concepire la libertà di coscienza,di religione, il diritto di famiglia,quello penale, e quello di successione,assegnando alla Chiesa un posto dipreminenza che l’ha aiutata non poco aformare l’anima dell’Occidente. Giudicaretutto ciò alla luce delle moderne categoriedi pensiero sarebbe assurdo e ingiusto.Inoltre Costantino, con certe scelte – comela sacralizzazione dei conflitti – creò lepremesse per le forme materiali della pietàdi moltissimi secoli a venire.
Questo imperatore può a giusto titoloessere considerato il genio politico checongiunse la più veneranda eredità diciviltà classica alla forza più giovane chetrainava il mondo verso il futuro, cheancora continua.






























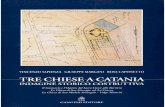







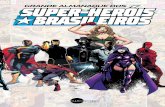




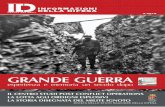


![Chiesa dell'Annunziatella [Roma]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631ebadf4c5c8fb3a00e5599/chiesa-dellannunziatella-roma.jpg)

![[Salis M.] Ittiri, chiesa di San Pietro](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63235bf65f71497ea9044b23/salis-m-ittiri-chiesa-di-san-pietro.jpg)


