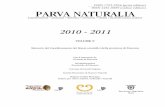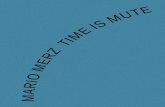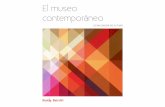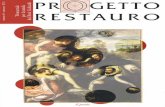Capua e il Museo Campano
Transcript of Capua e il Museo Campano
40 41
Dalla presenza etrusca sannitica e romana sino a Federico II e oltre la complessa storia di questa vivace metropoli
della Campania antica rivive nelle sale di un ricchissimo museo fondato subito dopo l’Unità d’Italia
e ora riaperto in forma smaglianteCAPUA
CAMPANIA FELIX
E IL MUSEO CAMPANO Testi Maria Luisa Nava Foto Luigi Spina
42 43
Quante volte “Campania illa felix”, “Capua altera Roma”... ci è balzato all’occhio, dalle pagine di un testo scolastico, da una tra-duzione del liceo, dal passo di un moderno autore “colto”... La
forza evocativa di queste espressioni non si è mai affievolita, sostenuta dalle testimonianze storiche e dai monumenti che nell’ager Campa-nus confermano la grandezza del passato. È vero, la Campania e soprattutto il Casertano nel tempo hanno modificato il loro aspetto; la fer-tile e dolce campagna è invasa da industrie e centri commerciali, attraversata da grandi assi viari; le città, popolose quanto in antico, si sono strette anche troppo intorno alle vestigia storiche, circondandole con palazzoni incom-benti. Ma il ricordo rimane ed è là, ben presente nel maestoso anfiteatro campano di Santa Ma-ria Capua Vetere (il centro che propriamente
occupa il sito della metropoli antica), nell’ar-moniosa solennità della basilica di Sant’Angelo in Formis, erede del santuario di Diana Tifatina (cioè la Diana del vicino monte Tifata, all’epoca coperti di boschi), oltre che nella città medievale e moderna che porta il nome di Capua e, logica-mente, nel museo che da centoquarant’anni tra-manda la storia del territorio, e che ora si rimette in gioco riaprendo dopo i lavori di ristrutturazio-ne e riallestimento.
Quella terra era una vera miniera archeologica
I nfatti, il Museo Provinciale Campano è anch’esso portatore dei valori di una tutta sua straordinaria tradizione, fondato grazie
all’opera illuminata di quella che allora era l’Amministrazione Provinciale di “Terra di La-voro”, come, all’indomani dell’Unità d’Italia
(1861), era indicata l’attuale provincia di Caser-ta, secondo una denominazione che risaliva a epoca normanna e che sopravvisse sino alla se-conda guerra mondiale. In quegli anni postuni-tari l’Italia viveva un momento di particolare fervore, speranze, iniziative, del quale Terra di Lavoro era in special modo partecipe: proprio a Teano, sempre su suolo campano, nel campus Stellatis dell’ager Falernus, Garibaldi aveva con-segnato l’Italia ai Savoia... Ma, pur nell’entusia-smo della neonata Unità, Terra di Lavoro con-servava fortissimo il senso della propria storia e il desiderio di un luogo dove conservare le me-morie, soprattutto quelle archeologiche, che co-me un fiume in piena sgorgavano a ogni aratu-ra, da ogni buca per piantare olivi o alberi da frutto, dagli scavi per nuove costruzioni, come in presenza di una «miniera di inestimabili do-vizie dell’archeologia» (Atti della Commissione Conservatrice, 1872).
Nel 1870 era stata appunto istituita la “Com-missione Conservatrice dei Monumenti ed Og-getti di Antichità e Belle Arti nella Provincia di Terra di Lavoro”, destinata non solo a raccoglie-re le testimonianze, ma anche a individuare il sito dove dar vita al museo destinato a ospitar-le. La scelta finale cadde su Capua, unanime-mente ritenuta la sede più degna per il suo ruo-lo nell’antichità. Il luogo dove allocare le rac-colte e il Museo (aperto già nel 1874) venne in-dividuato nell’antico Palazzo Antignano, cedu-to dai Duchi di San Cipriano al Comune che a sua volta lo devolse alla Provincia. Ma v’è di più: con grande lungimiranza, nei suoi lavori la Commissione Conservatrice non aveva inteso porsi in concorrenza con il Museo Archeologico di Napoli, ormai storicizzato custode di capola-vori d’arte antica, ma completarne l’opera, ac-cogliendo invece nel Museo Campano le testi-monianze della storia.
pp. precedenti SCHOLA CANTORUMParticolare dello splendido mosaico cosiddetto “Schola cantorum” (II-III sec. d.C.) proveniente dal tempio di Diana Tifatina. L’attributo di questa, che era una delle principali divinità capuane, derivava dal boscoso (all’epoca) monte Tifata presso Capua. Il santuario di Diana Tifatina ebbe vita lunga: dal periodo etrusco-sannitico di Capua (VI-IV sec. a.C.) fino alla cristianizzazione avvenuta sullo scorcio del III secolo.
SACRO A DIANAParticolare di affresco con cervo (II sec. d.C.) ➝
➝ dal tempio di Diana Tifatina. Il santuario,
divenuto un luogo di culto cristiano,
fu inglobato nella basilica
di Sant’Angelo in Formis, consacrata
nel VI secolo alle pendici dello
stesso monte Tifata.
PAGANI E CRISTIANILa basilica
di Sant’Angelo in Formis, presso Capua, alle falde del monte Tifata.
Si vede bene il terrazzamento
originario del santuario di Diana Tifatina
su cui è stato eretto l’edificio cristiano.
(Foto Francesco Rinaldi)➝ a p. 46
44 45
CAPUA: L’ANTICA E LA NUOVA Città etrusca in Campania. La seconda Roma, «Altera Roma», così Cicerone nel I sec. a.C. defi-nisce l’antica Capua, corrispondente all’attuale S. Maria Capua Vetere (5 km dall’attuale Capua sulla via Appia per Napoli). Il sito fu abitato a partire dal IX sec. a.C. da popolazioni protoetru-sche, insediatesi nella piana campana. In età ar-caica (VII-VI sec. a.C.) il territorio della città era compreso tra i fiumi Volturno a ovest, antico Cla-nis (oggi Regi Lagni) a sud e il monte Tifata (604 m) a nord. Le fonti letterarie indicano Capua come capitale della “dodecapoli” etrusca in Campania. Sempre per il VII e VI sec. a.C. la florida economia della città, basata sull’agricoltu-ra, produsse anche un artigianato artistico di bronzi e oggetti in ceramica. L’egemonia etrusca nell’area venne meno in seguito alla sconfitta di Aricia (505 a.C.) a opera dei Latini fiancheggiati dai Greci di Cuma. Fra Sanniti e Romani. Nel V e IV sec. a.C. a Ca-pua crebbe l’importanza dei Sanniti, come in gran parte della Campania, e furono attivi i san-tuari extraurbani di Diana Tifatina, celeberrimo nell’antichità, e quello scoperto sul fondo Patturel-li, da cui provengono le famose matres matutae. Nel 343 a.C. l’attacco delle genti delle monta-gne del Sannio provocò l’intervento di Roma in difesa della città, a cui seguì (338 a.C.) la con-cessione della civitas sine suffragio (cittadinanza
senza diritto di voto). La costruzione (iniziata nel 312 a.C.) della via Appia permise l’intensificarsi dei rapporti con l’Urbe. Poi Capua appoggiò An-nibale e questo comportò (211 a.C.) la privazio-ne dello stesso diritto di cittadinanza e la confisca del territorio. La definitiva romanizzazione di Capua data dal 59 a.C., quando vi fu dedotta una colonia di veterani di Cesare. Nel IV secolo Capua era ancora fiorente, tanto che il poeta la-tino Magno Ausonio la enumerò tra le otto mag-giori città dell’impero.Sul Volturno nasce la nuova Capua. Nel 456 l’antica Capua fu saccheggiata e rasa al suolo dai Vandali di Genserico. Quattro secoli più tar-di, nell’841, un’incursione saracena costrinse la popolazione a rifugiarsi su una collina presso Triflisco, fondando la città di Sicopoli (in onore del principe longobardo Sicone). Poco dopo (856) anche Sicopoli fu abbandonata e gli abi-tanti si trasferirono nel sito dell’antico porto flu-viale di Casilinum, sul Volturno, dove venne fon-data la nuova Capua. La città medievale, erede dei fasti dell’antica, nacque come principato longobardo indipendente, per divenire in segui-to un importante centro normanno e svevo, con Federico II e la sua porta monumentale, e in se-guito angioino e aragonese. Infine, i viceré spa-gnoli ne ampliarono il sistema difensivo e costru-irono il castello di Carlo V.
CAPUA OGGI. Il centro storico all’interno di un’ansa del fiume Volturno. È evidenziato Palazzo Antignano, sede del Museo Campano, da poco restaurato. La città che porta il nome di Capua è in realtà un centro di origine altomedievale fondato dai discendenti della Capua antica distrutta e abbandonata. (Foto Francesco Rinaldi)
nelle foto d’epocaMATRES MATUTAEDue foto di fine Ottocento con l’originario allestimento in Palazzo Antignano delle statue in tufo da poco rinvenute nel Fondo Patturelli di Curti. In una si vede la statua della cosiddetta “dea Matuta”, circondata dalle matres e dalle terrecotte architettoniche del santuario. Nell’altra si notano meglio i particolari di alcune matres matutae: la tipologia delle capigliature e delle vesti, oltre che la resa dei tratti del volto, riportano le sculture a età ellenistica (IV sec. a.C.). (Archivio Museo Campano)
qui sottoSANNITIUna delle sale di Palazzo Antignano, che conserva l’allestimento storico degli anni Trenta. In primo piano un cratere di produzione capuana con guerrieri sanniti e donne in costume campano (IV sec. a.C.).
46 47
MADRI E FIGLIStatua in tufo di mater matuta con infante in fasce: è una delle ben 160 sculture simili provenienti dal santuario in cui era venerata la dea della fertilità rinvenuto nel Fondo Patturelli di Curti. Vediamo poi il suggestivo allestimento nel Museo Campano delle sale dedicate alle matres matutae (IV sec. a.C.): alla sommità della scala è collocata la statua della cosiddetta Dea, così come ipotizzato nella ricostruzione di questo importante luogo capuano di culto da parte dell’archeologo tedesco Herbert Koch (1907).
POLICROMIEAntefissa nimbata a
testa gorgonica di tipo orrido (VI sec. a.C.)
dal santuario di Matuta nel Fondo Patturelli.
(Archivio Museo Campano)
TANAGRINETerrecotte votive
dal santuario di Fondo Patturelli: figure panneggiate
e danzanti (VI-IV sec. a.C.),
cosiddette “tanagrine”
(ma il termine ottocentesco è desueto)
perché ritrovate per la prima volta
in Grecia a Tanagra.
DEDICA IN OSCOJovila in terracotta
(IV sec. a.C.) con immagine di
porcellino e iscrizione
in lingua osca dal santuario individuato
nell’Ottocento nel Fondo Patturelli. Le jovile (cosiddette dal ripetersi nelle
iscrizioni del termine juvila, “ciò che viene
consacrato”) dovevano costituire dediche dei devoti
alla divinità ed essere infisse
nel terreno verticalmente,
all’interno del santuario.
Il grande Mommsen per il Museo Campano
E d è così che a Capua giungono dal grande santuario scoperto sul fondo Patturelli (nel vicino comune di Curti), unitamente
alle terrecotte architettoniche e votive, le note statue di tufo delle matres matutae, espressioni della devozione indigena a Matuta come dea della fertilità, oltre a una messe di altra docu-mentazione, dai vasi ai bronzi, ai mosaici anti-chi, oltre a tele e tavole, stemmi e rilievi da chie-se, conventi e palazzi, per finire con le statue e le decorazioni superstiti della Porta di Federico II: tutto arriva al Campano, nella sua funzione di custode e garante della memoria storica di Terra di Lavoro. Si legge ben chiaro questo intento ne-gli atti che regolano i lavori della Commissione
IL SANTUARIO DI MATUTARinvenimento casuale nel fondo Patturelli. Nel 1845 Carlo Pattu-relli, durante lavori edilizi nel suo terreno lungo la via Appia, fuo-ri le mura dell’antica Capua, scoprì i resti di un edificio sacro e le sculture in tufo oggi note come matres matutae. Le Madri, così lonta-ne dall’iconografia classica, destarono impressione negli scopritori e
nei primi studiosi: «tozze e mostruose sì che sembran rospi» («Il Giornale di Pompei»,
1846). Comunque, a evitare che i lavori venissero inter-rotti dalle autorità, il Pattu-
relli reinterrò tutto. Gli scavi furono ripresi nel 1873 con l’intento di rivendere gli og-getti più belli, mentre elemen-
ti architettonici del santua-rio furono lasciati sparsi intorno al Casino Pattu-relli, fino a quando nel 1876 una parte fu tra-sferita nel Museo Cam-pano, unitamente alle madri e agli altri reperti. In assenza di ogni docu-
mentazione, poco si conosce degli edifici e delle fasi del santuario, ma la grande quantità di terrecotte architettoniche raccolte testimonia una continuità di vita dell’area sacra dal VI al II sec. a.C.
Sfingi alate lungo la gradinata che portava all’altare. L’archeologo tedesco Herbert Koch, che nel 1907 aveva affrontato lo studio dei materiali e delle strutture conservate, ipotizzò che nell’area fosse pre-sente un altare monumentale in tufo, costituito da un podio rettango-lare, cui si accedeva da una gradinata di dodici scalini, fiancheggia-ta da pilastrini sormontati da sfingi alate. Sulla sommità si collocava un’edicola, contenente un altare e una statua di culto. Saggi eseguiti nel 1995 hanno permesso di identificare con certezza il sito del san-tuario, che risulta distrutto da un incendio in età romana.
Immagini di madri offerenti. All’interno dell’area del santuario, dispo-ste in modo da essere visibili solo frontalmente e collocate forse una accanto all’altra lungo pareti, erano le oltre centosessanta matres rinvenute. Scolpite nel tufo grigio del monte Tifata, le matres riprodu-cono una figura femminile seduta su un sedile più o meno elaborato, recante in grembo uno o più bambini in fasce. In queste statue è stata riconosciuta la figura della donna offerente che dona alla dea la propria immagine accompagnata dai figli. La dea venerata nell’a-rea sacra viene identificata con Matuta, sebbene dibattuto e incer-to ne sia tutt’oggi il riconoscimento.
e nell’intensa corrispondenza che lega à fil rouge l’opera di Gabriele Iannelli, primo direttore del museo, al più grande storico del tempo. Proprio a Theodor Mommsen (1817-1903), fondatore della scienza epigrafica, Iannelli si rivolge per l’allestimento del lapidario; il grande studioso è pronto a rispondere e, grato, Iannelli gli dedica questa stessa sezione (inaugurata nel 1876).
La stagione di gloria del Campano continua: se ne interessano i più grandi archeologi e storici e nelle sue sale lavorano tutti, da Amedeo Maiuri a Paolino Mingazzini a Massimo Pallottino, af-fiancati dai colleghi stranieri, che, come Karl Ju-lius Beloch e Jacques Heurgon, sulle orme di Herbert Koch, si appassionano all’enigma delle scoperte del Fondo Patturelli e della sue matres, di cui – siamo nel 1939 – Achille Adriani pubbli-ca il catalogo.
STORICO ORDINAMENTO
Scorcio del Lapidario Mommsen con una
straordinaria raccolta di iscrizioni soprattutto
funerarie, dedicatorie e celebrative,
dall’ager capuanus. Nel tempo è stata
conservata la disposizione
originaria voluta dallo stesso Mommsen
a fine Ottocento, pur con qualche
integrazione successiva a opera soprattutto di Amedeo Maiuri.
➝ a p. 48
48 49
La guerra fu un disastro e poi i politici disattenti...
E il 1939 è anche l’anno in cui il Paese en-tra in guerra. Gli effetti saranno terribili per la Campania, terreno di scontri duris-
simi proprio al culmine del conflitto, e per Ca-pua: la città è da sempre punto nevralgico per il controllo del territorio, lo sanno tutti – fin dall’antichità, dagli Etruschi ai Sanniti, ad An-nibale, per arrivare a Federico II e ai viceré spa-
gnoli che la fortificarono e vi stanziarono l’ec-cellenza delle loro truppe – e lo sanno bene an-che gli Alleati, che ne fanno un obiettivo prima-rio. Il 9 settembre 1943, subito dopo l’Armisti-zio, la città subisce un violentissimo bombar-damento, che causa oltre mille morti tra i civili e la quasi totale distruzione dell’abitato. Anche il Museo Campano ne esce pesantemente muti-lato nella struttura e nelle collezioni: un’ala è completamente distrutta, così come sono per-dute quelle raccolte che il direttore di allora,
Luigi Garofano Venosta, non riuscì a mettere al riparo. Il dopoguerra segna la ripresa del Mu-seo, che, ricostruita l’ala distrutta, viene riaper-to nel 1956. Si rinnovano gli interessi verso le antichità della Campania. Punto focale è l’edi-zione della collana di studi “Capua Preroma-na”, voluta da Massimo Pallottino e condotta da Maria Bonghi.
I decenni successivi registrano la disattenzio-ne della politica nei confronti del Campano, e il conseguente disamore del grande pubblico
verso un’esposizione non più rinnovata e una gestione sempre più auto referenziata e locale, in un declino inarrestabile, che sempre più vede restringersi l’utenza del Museo – e della sua ric-ca biblioteca – agli eruditi locali. Tuttavia, per Amedeo Maiuri a Capua aveva sede il museo «più significativo della civiltà italica della Cam-pania» e infatti proprio nei contenuti delle rac-colte risiede il suo fascino evocativo di questa istituzione, già in passato in grado di attirare vi-sitatori da ogni parte del mondo.
PALAZZO ANTIGNANO: RINASCIMENTO A CAPUA Prestigiosa sede del Museo Campano. Palazzo Antignano è uno dei più pregevo-li edifici rinascimentali di Capua, esempio di architettura nobiliare del periodo aragonese (XV sec.). Il prospetto su via Roma presenta un elegante portale di ispirazione tardogotica catalana, concepito come un arco addobbato trionfal-mente di stoffa; la cornice, intagliata nel piperno (roccia vulcanica), si sviluppa a volute desinenti in tre cuspidi alla sommità dell’arco, nelle quali sono incasto-nati tre scudi gentilizi in marmo bianco: al centro quello della famiglia Antigna-no, ai lati gli stemmi con l’arme delle casate Antignano e d’Alagno, imparentate tra loro. Sopra allo scudo centrale è incisa con caratteri gotici la F di Francesco Antignano, che ampliò il palazzo tra 1450 e 1454.
Ambienti su due piani intorno a due cortili. Il primo cortile, in forma di quadrila-tero, manifesta peculiarità d’ispirazione catalana che lo accomunano ai palazzi spagnoli. Il secondo, a pianta trapezoidale, era destinato alle scuderie. Nel primo cortile, uno scalone coperto con archi rampanti conduce al piano nobile; il pianerottolo di arrivo è arricchito da un portale in pietra con una larga cornice, decorata a bassorilievo con motivi naturalistici. Da questo portale si entra in grandi ambienti di rappresentanza, che, distrutti dai bombardamenti subiti da Capua nel 1943, sono stati fedelmente ricostruiti. Altri vani del palazzo, che si svolgono a cavalcavia su via Duomo, inglobano importanti strutture pubbliche preesistenti alla fabbrica rinascimentale: s’individuano i resti della chiesetta lon-gobarda di S. Lorenzo ad Crucem ( IX sec.) e i locali originari del Seggio nobi-liare di Capua, detto degli Antignano. Nel 1956 la sede museale si è estesa anche negli attigui spazi dell’ex Convento della SS. Concezione.
STILE CATALANOIl bellissimo portale di Palazzo Antignano (XV sec.), sede del Museo Campano. Nelle cuspidi le armi delle nobili famiglie Antignano e d’Alagno, due antiche e potenti famiglie di Capua durante il periodo dei viceré spagnoli nel Meridione. (Archivio Museo Campano)
OTTIMA PRODUZIONE DI TERRACOTTECapua centrale negli scambi. Capua etrusca e sannita si distinse nella produzione di terracotte architettoni-che, utilizzate, secondo un uso derivato dai Greci, per la copertura dei tetti degli edifici e anche per la loro decorazione. Le fabbriche, accanto a varianti dei tipi greci, hanno una produzione che s’ispira al patrimo-nio mitico e simbolico locale. La città conferma, anche in questo settore, lo stretto legame con le colonie greche e la sua centralità nello scambio di prodotti e forse di maestranze tra Italia meridionale, area etrusco-laziale e le zone più interne. Dai santuari fuori le mura. Importanti sono le serie di terracotte che decoravano i due santuari extraurbani di Matuta (rinvenuto a Curti nel fondo Patturelli) e di Diana Tifatina (a S. Angelo in Formis). Alla prima metà del VI sec. a.C. risalgono numerosi reperti di soggetto animalistico: acroteri con protomi di grifo e a testa equina, decorazioni di coppi con protomi di arieti e cavalli, gocciolatoi ornati da teste di ariete e con testi-ne femminili e protomi di felino. In quest’epoca furono marcati gli influssi corinzi e laconici, evidenti soprat-tutto nelle antefisse con testa umana e pettinatura “dedalica”, in quelle con busto femminile in atteggiamen-to da orante, nelle altre ancora con la “Signora degli Animali” (Potnia Theron), con gli alati gemelli Boreadi in corsa, con sfinge bisoma (raffigurata con due teste - ndr). Fioritura di età arcaica. Nella seconda metà del VI sec. a.C. compaiono nelle antefisse tipi come l’Artemide a cavallo e come Eracle e il leone nemeo. Ricche sono le serie di antefisse con testa femminile inserita in un fiore di loto e sormontata da un nimbo di foglie, quelle con raffigurazione del dio fluviale Acheloo e altre con palmette diritte e rovesce. Ben attestata è anche la serie delle antefisse con testa di Gorgone (gorgone-ion), caratterizzata dalla forte policromia del nimbo baccellato, del volto e della fascia sottostante. Tra le teste femminili di epoca arcaica, molte delle quali sembrano ribadire forti contatti con l’area etrusco- lazia-le, vi sono vari esemplari di dimensioni ridotte; una testa di Atena-Minerva con elmo si colloca nel pieno V sec. a.C. Dopo la fioritura arcaica la produzione continua molto attiva nel corso dei secoli successivi, fino al tardo ellenismo (III sec. a.C.).
SFINGI ARCAICHEElemento acroteriale
con tre teste femminili (forse sfingi) di età arcaica
(fine VII sec. a.C.) sempre dal santuario di Fondo Patturelli.
nelle due foto TERRACOTTE
ARCHITETTONICHE Due splendide
antifesse (VI sec. a.C.) dal santuario
di Matuta scoperto nel Fondo Patturelli
di Curti: Apollo con devota che offre
un porcellino e figura nimbata
a torso femminile.
UNO SGUARDO AL CORTILE... All’interno del primo cortile allestito con stele funerarie e rilievi di età romana. Nella foto qui sopra, al centro è la chiave di volta di un arco dell’Anfiteatro Campano di Capua con la protome scolpita del dio Volturno, che reca una corona di foglie d’acqua.
➝ a p. 52
50 51
VASI E VASAI A CAPUA E DINTORNIRicca collezione del Museo Campano. Si ripercorre la storia dell’antica Capua, con uno sguardo anche sulle vicine città di Cales, Teanum Sidicinum (Teano), Calatia. Le ceramiche provengono in gran parte da tombe e coprono un arco cronologico riferibile alle fasi preromane della città, dal IX al III sec. a.C. I vasi d’impasto (in argilla non depurata e lavorati a mano senza tornio - ndr) della prima età del Ferro (IX-VIII sec. a.C.) includono i biconici con ciotole-coperchio, destinati a contenere le ceneri dei defunti secondo il rituale villanoviano. Per il VII sec. a.C. si segnalano importazioni, soprattutto di balsamari prodotti a Co-rinto. Alla fine del VII sec. a.C. dall’Etruria giunge in Campania il bucchero, che nel VI sec. a.C. si afferma nelle officine locali come prodotto di larga diffusione (il bucchero di Capua si distingue per un maggiore spessore delle pareti, pover-tà degli elementi decorativi e superficie opaca).Da Corinto e dall’Attica. Nel corso del VI sec. a.C. all’importazione di ceramica corinzia si sostituisce quella della ceramica attica a figure nere, presente nel Museo Campano con vasi di buona qualità. Da questa produzione si stacca verso il 500 a.C. una categoria di ceramica a figure nere realizzata in Campa-nia, nella quale sono stati riconosciuti diversi gruppi di pittori. A partire da fine VI sec. a.C. si diffondono in Campania e a Capua i primi prodotti nella tecnica della ceramica attica a figure rosse, rappresentata nel museo da eccellenti esemplari, come i vasi attribuiti al “Pittore di Polignoto” (metà V sec. a.C.).Si sviluppa una tradizione locale. Nel IV sec. a.C. troviamo una ceramica a fi-gure rosse prodotta in Campania, in centri come Cuma, Paestum e Capua stessa. Nelle botteghe, accanto a pittori di formazione greca, operano artigiani che prediligono soggetti locali, come i guerrieri con armamento sannitico e le donne in costume campano. È quasi certo che le officine del “Pittore di Issione” e del “Pittore di Capua”, operanti dopo la metà del IV sec. a.C., siano state a Capua. Le scene mitologiche dipinte sui vasi testimoniano la qualità della cultu-ra letteraria presente nella classe sannitica all’epoca dominante in città.Imitazione di vasi metallici. Negli ultimi decenni del IV sec. a.C. la ceramica a figure rosse tende a scomparire e comincia ad affermarsi un tipo di produzione che imita le forme e la decorazione del vasellame metallico: la ceramica a ver-nice nera con baccellature e altri ornamenti a rilievo, che avrà grande fortuna per tutto il III sec. a.C.
DALLE NECROPOLI CAPUANE. Un elaborato aryballos corinzio (VII sec. a.C.) configurato a quattro melograne, avvolte
da un serpente e una rana, e anfora a figure rosse di produzione campana (IV sec. a.C.) con il “supplizio
di Issione”, attribuita al pittore di Issione.
MEMORIE DI FEDERICO II A CAPUALa magnifica porta dell’imperatore. Le scul-ture federiciane conservate al Museo Cam-pano appartengono tutte alla monumentale Porta di Capua (o Porta delle due Torri), che Federico II fece costruire tra il 1234 e il 1239 sul Volturno, ispirandosi ai modelli degli antichi archi di trionfo. Il monumento costituisce una tappa fondamentale del per-corso dell’arte federiciana che culmina in Castel del Monte (Puglia) e, al tempo stes-so, si configura come il più esplicito manife-sto politico del sovrano, che sfida il vicino Stato Pontificio con un programma icono-grafico basato sul tema della Giustizia.
Trionfo della giustizia imperiale. Opera dell’architetto capuano Niccolò de Cicala, la Porta constava di due torri collegate da mura e aveva alla sommità un appartamen-to riservato a Federico II. Ornavano la fac-ciata la statua dell’imperatore “in maestà”, con corona sul capo e globo nella destra, e sopra l’iscrizione “Misero renderò ch’io sappia la voglia mutare”; a destra era il bu-sto di Pier della Vigna, con l’iscrizione “En-trino sicuri quelli che bramano vivere puri”, a sinistra quello di Taddeo da Sessa, ac-compagnato dalla frase “Tema l’infido di essere bandito e cacciato in carcere”. Sotto la statua dell’imperatore, in un clipeo cen-trale posto sopra l’arcata d’ingresso della porta, campeggiava una testa di donna simboleggiante la Iustitia imperialis (deno-minata impropriamente Capua fidelis) che recava il motto: “Per comando di Cesare io garantisco la custodia del Regno”.
Dalla distruzione al museo. Nel 1557 il con-te di Santafiore, su ordine del viceré duca d’Alba, abbatté il monumento per costruire nuove fortificazioni. Nel 1799, al passaggio dei Francesi, la statua dell’imperatore fu mu-tilata del capo. Appena fondato il Museo Campano, le sculture vi furono trasportate. Tra le statue realizzate per la Porta e oggi conservate nel museo sono anche sei proto-mi decorative delle basi poligonali delle torri
(cinque teste umane e un motivo vegetale); alcune mensole figurate, un leone simile a quelli presenti nei portali di Castel Maniace (a Siracusa) e Castel del Monte; un laterale o bracciolo del trono imperiale in forma di grifo e vari capitelli. Non è del tutto certa l’effettiva appartenenza alla Porta della testa virile barbuta considerata tradizionalmente una raffigurazione di Giove (o del dio Silva-no), forse adibita a chiave di volta.
CITTÀ IMPERIALEDisegno a china (1928)
di Andrea Mariano con ricostruzione della
Porta delle due Torri, edificata da Federico II.
Nelle statue che ne ornavano la facciata era espresso il programma
politico dell’imperatore che, raffigurato in
maestà, era attorniato dei suoi consiglieri,
Pier delle Vigne e Taddeo da Sessa.
(Archivio Museo Campano)
SCULTURE FEDERICIANE
Scorcio della sala del Museo Campano
dedicata alle sculture dalla Porta delle due
Torri. Sulla destra si vedono il busto di Pier delle Vigne (in primo piano),
la Iustitia Imperialis e Federico II.
52
Una rinnovata realtà museale per la Campania
E bbene, in una regione che sempre più si rivolge al turismo e alla valorizzazione dei suoi monumenti, le potenzialità del Mu-
seo Campano non potevano rimanere ignorate. Ma prima è stata necessaria una presa di coscien-za da parte dei vertici della Provincia. I lavori di restauro e il riallestimento delle collezioni più importanti, iniziati nel 2009, sono ultimati. An-cora una volta, come la Fenice, il Campano è ri-sorto nel rispetto della sua storia e della sua tra-
AQUILA E SERPENTEParticolare di un mosaico (II sec. d.C.) con aquila che ghermisce un serpente, rinvenuto negli scavi di fine Ottocento al di sotto della cattedrale di Nola e relativo al raffinato tappeto musivo di una ricca domus. Il Museo Campano, come suggerisce il nome, raccoglie testimonianze archeologiche da gran parte della regione.
sopra al centroPORTAGIOIEUno dei reperti più rari e preziosi conservati nel Museo Campano: un cofanetto (II sec. d.C.) con rivestimento in bronzo e avorio, probabilmente per la custodia dei gioielli di una matrona.
VISITA INTERATTIVA AL MUSEOAttesi nel sito web. Il Museo Campano è presente sul web, dove è “percor-ribile” con una visita interattiva che consente di spaziare nelle varie sale con immagini ad alta definizione (www.museocampano.it). Inoltre il museo è attivo con proprie pagine, aggiornate quotidianamente con notizie ed eventi, su Facebook e Twitter e si è dotato, sempre sul web, di una propria radio (Radio Matermatuta), che trasmette un palinsesto musicale e culturale 24 ore al giorno.
Entrando invece nel museo reale... Un sistema di totem e apparati informa-tizzati consente di compulsare collezioni e contenuti attraverso un sistema interattivo e multimediale. Nelle sale sono collocati apparecchi che illustrano i più importanti reperti, presentati con immagini in movimento e didascalie multilingue. Particolare attenzione è riservata alla didattica per i giovanissi-mi: le collezioni sono presentate con la possibilità di “scoprire” gli oggetti attraverso una serie di giochi contenuti nei singoli totem, destinati a invoglia-re all’identificazione dei reperti e al loro riconoscimento nell’esposizione. Info: [email protected] 0823. 630076
dizione: dotato di un apparato didascalico inte-rattivo, ha riaperto i battenti per accogliere tutti coloro che, studiosi, appassionati e amanti dell’arte, del patrimonio culturale e di tutti i va-lori che hanno fatto la storia della nostra Nazio-ne, vorranno scoprire o riscoprire testimonianze uniche del nostro comune passato.
Maria Luisa Navadirettore Museo Provinciale Campano
Tutti i reperti e le opere documentate nell’articolo sono esposti al Museo Campano di Capua.
RE D’ITALIA. La sala dedicata ai ritratti dei reali di casa Savoia nella pinacoteca del Museo Campano: (da sx) Umberto I e Margherita; Vittorio Emanuele III ed Elena. Il Museo Campano, oltre alle ricche collezioni archeologiche, è dotato di una significativa pinacoteca che documenta artisti, vicende e personaggi storici dal Trecento fino al secolo scorso.