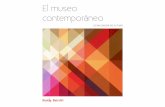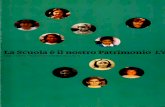Le collezioni del Museo di Centuripe
Transcript of Le collezioni del Museo di Centuripe
Syndesmoi 3
Quaderni del corso di laurea in Archeologia- opzione internazionale,Università degli studi di Catania
Il corso di laurea magistrale in Archeologia dell’Università di Catania ha formalizzato dal 2009 una proiezione internazionale che si è concretizzata, oltre che nell’organizzazione di mostre, convegni e seminari in collaborazione con istituzioni estere, in convenzioni per il conseguimento del doppio titolo di laurea, valide attualmente per l’Università di Varsavia e l’università di Selcuk, Konya. Da queste collaborazioni sono nati attività di ricerca e progetti di cui i Quaderni intendono essere espressione.
Direttore
Pietro Militello (Università di Catania)
Comitato sCientifiCo
Lucia Arcifa (Università di Catania)Asuman Baldiran (University of Konya)Euanghelos Kyriakidis (University of Kent)Massimo Frasca (Università di Catania)Iwona Modrzewska Pianetti (Uniwersytet Warsawski)Francesco Tomasello (Università di Catania)
reDazione
Marco Camera
Questo volume è stato pubblicato con i fondi del progetto Corso di laurea internazionale in Archeo-logia, opzione internazionale, finanziato dal programma Cooperlink per l’anno 2012.
Syndesmoi 3
RiceRche e attività del coRso inteRnazionalizzato
di aRcheologia
catania, vaRsavia, Konya
2009-2012
(a cuRa di)PietRo Militello - MaRco caMeRa
ISBN 978-88-6485-062-7
Copyright © 2012 by Officina di Studi MedievaliVia del Parlamento, 32 – 90133 Palermoe-mail: [email protected]
www.officinastudimedievali.it - www.medioevo-shop.net
Editing: Alberto Musco
Franco Pianetti, geologo e geoarcheologo
Nato a Venezia Mestre è scomparso il 25.01.2012. Figlio dell’ingegnere Federico Pianetti e di Filomena Giugliani, ha studiato geologia all’ Università di Padova, dove ha lavorato succes-sivamente nel campo dell’idrologia. Fu primo ricercatore presso l’ Istituto di Dinamica delle Grandi Masse (ISDGM) del CNR di Venezia ove si è dedicato alle ricerche sul Quaternario, alla sedimentologia e alla subsidenza dell’area veneziana e all’idrologia. Si è anche occupato dell’ana-lisi delle immagini con i suoi colleghi del CNR e la moglie, Iwona Modrzewska.
Ha pubblicato vari lavori sul percorso di fiume Sile, che sono a tutt’oggi bibliografia di riferimento. Dagli anni ‘80 del XX secolo ha coordinato vari progetti tra cui il programma italo-polacco sugli scavi archeologici nelle isole della laguna di Venezia, condotto dall’Uni-versità di Venezia e dal PAN di Varsavia, dedicandosi anche a ricerche di archeometria e geo-archeologia.
Per molti anni ha diretto il progetto italo-polacco sui materiali provenienti dagli scavi di Murano e Torcello. È stato co-autore, con la moglie I. Modrzewska, di numerose pub-blicazioni sul territorio altoadriatico e sull’archeometria applicata alle ceramiche antiche. I suoi interessi scientifici negli ultimi anni sempre di più si sono rivolti verso l’archeologia e la geoarcheologia come dimostrano le pubblicazioni in riviste polacche, italiane, spagnole quali Saguntum, Pyrenae, Archivo Espaňol de Archeologia, Archeologia e Calcolatori, Światowit. Due articoli postumi sono in corso di stampa presso Études et Travaux (Varsavia), e nel volume in onore di R. Brulet (Université Catholique de Louvain).
Franco Pianetti ha saputo unire lo studio delle scienze della terra con quello delle discipli-ne storiche, nella migliore tradizione interdisciplinare, arricchita da profondi doti umane e morali.
inDiCe
P. militello
Il corso internazionalizzato di Archeologia dell’Università di Catania. Bilancio di un triennio 2009-2012 ........p. 9
i- seminari e riCerChe
a. lasota-moskalewska, k. szymCzak
Neolithic Nomads From Ayakagytma ‘The Site’, Uzbekistan .........................................................................p. 23
G. hoelbl
L’architettura e lo spazio nell’arte egiziana ......................................................................................................p. 35
f. blakolmer
Spazio pittorico e prospettiva nell’età del Bronzo in Grecia ...............................................................................p. 59
o. Palio
Materiali ceramici dalla Grotta Petralia (CT) .................................................................................................p. 89
m. frasCa
Greci a Monte San Mauro di Caltagirone .....................................................................................................p. 107
m. Camera
Greci e Indigeni nella Sicilia sud-orientale. Una lettura attraverso la documentazione ceramica .......................p. 121
e.C. Portale
L’arte di Siracusa greca: scultura e arti minori ...............................................................................................p. 129
f. busCemi
Processi di contatto e interazione culturale nel mondo romano. Per un riesame delle posizioni teoriche...............p. 141
e.C. Portale
Le arti figurative nella Sicilia romana: la scultura ..........................................................................................p. 153
f. busCemi
Ab Apolline Syracusas. A note on the Itinerarium Antonini (per maritima loca) ...........................................p. 167
m. sGarlata
Un secolo di ricerche sui cimiteri cristiani del suburbio e del territorio di Siracusa ............................................p. 177
a. balDiran
An Ostotech with Hunting Scene in Çumra-Sirçali Hoyuk ............................................................................p. 193
ii – sCavi e attività
m. frasCa
Scavi e ricerche archeologiche dell’Università di Catania nella Collina Sud di Kyme Eolica (Turchia) ..............p. 209
m. sGarlata, i. GraDante, s. siruGo
Genesi e sviluppo del cimitero del Predio Maltese a Siracusa ...........................................................................p. 223
a. ulanowska
Odtwarzanie dawnych technik tkackich w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego poprzez arche-ologię doświadczalną ............................................................................................................................p. 239
r. Patané
Le collezioni del Museo di Centuripe: formazione ed esposizione .....................................................................p. 263
note
m. fiGuera
Un workshop per la produzione del bronzo ad Haghia Triada? Il caso del Complesso della Mazza di Breccia .................................................................................................p. 277
a. liCCiarDello
Per un’analisi degli schemi di circolazione nelle case del TM I a Kommos ........................................................p. 289
a. Catania
Divinità o eidola? Per una interpretazione di alcune larnakes minoiche .......................................................p. 297
m. balDi
L’Edificio 101/XL del complesso Nord-Est di Festòs. Per un’analisi planimetrica e tipologica ....................p. 305
k. zebrowska
Between Sicily and the Aegean: Some Considerations on Sicilian Rock-Cut Tholos Chamber Tombs ..............p. 313
Abstracts .....................................................................................................................................................p. 321
263
RosaRio P. a. Patané1
Le coLLezioni deL Museo di centuRiPe: foRMazione ed esPosizione
La formazione delle collezioni e i criteri museografici che stanno alla base dell’espo-sizione costituiscono un argomento interessante non solo per la particolare storia del Museo di Centuripe, ma anche per il contesto, storico, culturale ecc. Tra l’altro una costante che si riesce a vedere è proprio il convergere di forze diverse, che spesso riescono virtuosamente a sommarsi, contribuendo a svolgere un ruolo importante per l’identità della comunità locale. Dopo un riasset-to gestionale, è passato dall’amministrazione comunale a quella regionale, il Museo si è avviato ad una nuova vita, mantenendo certe caratteristiche che lo avevano contrassegnato.2 Perché ci sia un museo, dev’esserci una collezione, esposta in una certa maniera. Un museo non è un magazzi-no in cui tutto quanto è graziosamente disposto in vetrine ben illuminate e corredato di cartellini con nomi e date; ogni operazione museale ovviamente risponde a un preciso progetto culturale. Per lungo tempo, il possesso di antichità come sacre reliquie da esibire come status symbol è stato un elemento di prestigio. D’altra parte il patrimonio culturale non è un semplice insieme di oggetti fisici, opere d’arte, monumenti, reperti storici; è l’insieme di questi oggetti e dei significati simbolici che la comunità attribuisce loro.3 Nel 1794 con la Rivoluzione Francese, la madre di tutte le attuali democrazie, si stabiliva il diritto della società sul patrimonio culturale: «Voi siete soltanto i depositari di beni di cui la grande famiglia del popolo potrà chiedervi conto».4 Il ruolo sociale del patrimonio culturale e delle istituzioni che lo custodiscono deve rimanere centrale; la conservazione e la comunicazione del complesso di oggetti e dei loro significati simbolici sono essenziali per l’identità di una comunità.5 Nella maggior parte dei Paesi in cui vige un’economia di libero mercato si è affermata l’idea - ampiamente dimostrata dai fatti - che la gestione delle istituzioni culturali non è redditizia in termini di guadagno diretto,6 mentre è molto alto il valore sociale in termini di identità.
1 Museo Interdiscipinare Regionale Giuseppe Alessi – Enna.2 L’argomento è stato oggetto di una conferenza al Museo Archeologico Regionale di Centuripe il 18.4.2010, per la XII Giornata della Cultura. Ringrazio la dott. Beatrice Basile, Soprintendente per i BB.cc.aa. di Enna, per l’invito a trattare il tema in quella sede. Il testo è stato subito divulgato sul sito di SiciliAntica (http://www.sacenturipe.altervista.org/blog/?p417). Viene qui ripreso con gli opportuni aggiornamenti. Ringrazio l’arch. Francesco Santalucia, Direttore responsabile del Museo Interdisciplinare Regionale Giuseppe Alessi di Enna, del quale fa parte il Museo Archeologico di Centuripe, per l’attenzione rivolta a questo lavoro e per la linea di sostanziale continuità.3 Negli ultimi decenni si è discusso parecchio sulla funzione del museo, anche in seguito alla grande diffusione della cultura di massa e al significativo aumento delle persone interessante al cosiddetto turismo culturale. Nel caso partico-lare del museo archeologico, lo stesso significativo aumento di visitatori sempre meno dotati di una comune base cul-turale, ma anche una più matura concezione dell’archeologia, hanno contribuito al ripensamento degli allestimenti. de Rita 1987; GuLLini 1987; Binni, Pinna 1989; MeLucco VaccaRo 1989; VeRGo 1989; MottoLa MoLfino 1991; GaiMsteR 1994; LuGLi 1994; stone, MoLyneaux 1994; RuGGieRi tRicoLi, VaciRca 1998; fRancoVich, ziffeReRo 1999; RuGGieRi tRicoLi 2000; schuBeRt 2000; Rauti 2001; JaLLa 2003; PoMian 2003; toMea GaVazzoLi 2003; antinucci 2004; MaRini cLaReLLi 2005; Mazzi 2005; RiBaLdi 2005; antinucci 2007; ManacoRda 2008, pp. 233-244; PouLot 2008; d’aGata, aLauRa 2009; La ReGina 2009; MottoLa MoLfino 2010; PRuneti, Ronc 2011; faLLetti, MaGGi 2012.4 Poulot 1997; Vlad Borelli 2003, p. 93.5 Su archeologia e identità, particolarmente stimolante: caLcani 2007, pp. 101-155. Cfr. anche VLad BoReLLi 1987.6 A titolo di esempio, al J.P. Getty Museum il costo per visita (budget / visitatori) nel 2009 ha sfiorato i duecento dollari. faL-Letti, MaGGi 2012, p. 90. Praticamente, gli incassi coprono circa il 10% delle spese; il resto viene ripianato dalla fondazione.
264
RosaRio P. a. Patané
La nostra storia comincia poco più di un secolo fa. In una conferenza tenuta a Centuripe nel novembre del 1906 si parlava di ambiente e beni culturali come volano per l’economia; di mo-numenti come risorsa economica non rinnovabile. Luigi Sagone, parlando di “Centuripe di fronte al movimento moderno”, precisava di non essere nato né di vivere a Centuripe e diplomaticamente diceva: «La mia conferenza (...) non conterrà alcun che di originale: in ciascun argomento che tratterrò voi riscontrerete una vostra idea, una vostra proposta in un tempo qualunque, un pro-gramma da voi ideato». Doveva anche avere delle buone conoscenze, se il testo della conferenza fu subito stampato in fascicolo “per cura del Municipio”.7
Si riteneva che Centuripe avesse tutte le carte in regola per diventare un importante centro turistico, bastava prenderne atto e darsi da fare. Importante il riferimento al patrimonio archeologico, alla costituzione di un museo, alla salvaguardia dei monumenti: «Centuripe ha notato sempre quanto ella possedesse di antico, ha presenziato l’esodo di tutto ciò che sarebbe onore e gloria per la sua storia, ha trascurato tutto quanto potesse essere ragione di nuovo commercio e di nuovo richiamo».
Per la «formazione di un museo» non sembrava ci fossero problemi insormontabili. Per «il contenuto» si contava sulla disponibilità di due volenterosi cittadini, i signori Luigi Campagna e Pietrangelo Mammana. Per i locali: «quand’anche l’Amministrazione non vorrà per questo provvedere, quando l’entusiasmo sarà unanime troveremo sempre un cittadino facoltoso che of-frirà una stanza».
L’episodio ovviamente va visto nel suo contesto. Poche settimane prima a Catania Luigi Rava, Ministro della Pubblica Istruzione, aveva inaugurato l’anfiteatro romano (fig. 1). Agli inizi del ’900 l’accoppiata Corrado Ricci e Luigi Rava, direttore generale e ministro, ha una grande impor-tanza per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale.8 Proprio i concetti di risorsa non rin-novabile, di vincolo tra patrimonio culturale e luogo, tornano di continuo nel dibattito che in quegli anni ferveva in Italia sulla protezione di quello che oggi si definisce appunto patrimonio culturale; dibattito che porterà poi all’approvazione della legge n° 364 del 1909 “Per le antichità e le belle arti”.9 Lo scavo e la presentazione di una parte dell’anfiteatro, a piazza Stesicoro e con i cunicoli illuminati elettricamente, era opera di Filadelfo Fichera, direttore dell’ufficio tecnico municipale; nella città importante più vicina, proprio in quel momento si prestava attenzione alla valorizzazione del patrimonio archeologico, anche per un progetto complessivo di sviluppo della città.10
Ma è di grande interesse anche il confronto con quanto, contemporaneamente (1907-1909), scriveva Paolo Orsi. Grande archeologo e personaggio che ha profondamente lasciato il segno nell’archeologia della Sicilia; in quegli anni, cosa più importante ai nostri fini, rappresentava localmente le istituzioni, lo Stato con i suoi poteri di tutela.11 Si vede tra l’altro il mutare di atteggiamento del civil servant Orsi prima e dopo la legge di tutela: prima cercava di seguire gli scavi del proprietario terriero e di acquistare quel che poteva per il Museo;12 mentre dopo cerca di imporre il divieto di scavi non autorizzati, ovviamente con tutti i problemi delle comunicazioni dell’epoca. Nel dare notizia dei primi scavi sistematici a Centuripe, osservava: «Ma pria di tutto
7 saGone 1907; ringrazio la dott. Mariagrazia Spina per avermi segnalato il fascicolo. Per una articolata discussione, cfr. Patané R., L’industria dei forestieri. Sogni di sviluppo economico a Centuripe, agli inizi del XX secolo, di prossima pubblicazione.8 eMiLiani 1997; BoLoGnesi 2002; iMPeRa 2003.9 BaLzani 2003.10 ficheRa 1904; ficheRa 1905; GiaRRizzo 1986, pp. 172-173; Rizza 1999, pp. 82-83; PaGnano 2007, p. 207; uRsino 2012, pp. 179-183.11 Per la gestione dei beni culturali in Sicilia tra ’800 e ’900: PeLaGatti 2001.12 Sull’attività di contrasto svolta da P. Orsi a Centuripe nei confronti di tombaroli e falsari, cfr. anche BusceMi feLici 2012.
265
Le coLLezioni deL Museo di centuripe: forMazione ed esposizione
era necessario che una buona volta si tentasse quello scavo ufficiale e sistematico che mai sin qui erasi effettuato per conto ed a cura del Governo. Negletta completamente per quasi un secolo, Centuripe vide esulare dalle sue terre un immenso e prezioso materiale, soprattutto di terrecotte plastiche, in gran parte disperse nei Musei esteri». E più avanti: «La crisi dell’industria vinicola, durata quasi un ventennio, aveva lasciato in un certo riposo le terre centuripine, più feraci di antichità che di prodotti agricoli; ma nell’ultimo tempo le migliorate condizioni economiche hanno spinto alla ricostituzione dei vigneti da tempo perduti. E poiché tutte le contrade prossime alla città sono una ricca miniera archeologica, ripetute scoperte di terrecotte avvenute nel 1906-07, delle quali purtroppo solo una piccola parte io riuscii a porre in salvo, richiamarono seriamente la mia attenzione sulla inesplorata città. Sorvolando sopra altri punti del mio programma archeologico, decisi di seguire colà una campagna di scavi, che nel maggio-giugno u.s. ebbe la durata di quaranta giorni, né fu condotta invano».13 I ritrovamenti ovviamente prendevano la strada di Siracusa, del Museo Nazionale. Di passaggio notiamo che l’etichetta “Nazionale” stava a indicare museo di proprietà della Nazione, a disposizione dell’intera Nazione; ma stava anche a indicare il ruolo che i musei dovevano svolgere nel contribuire a definire l’identità nazionale.14 Era in questi termini che la cultura dell’epoca si poneva il problema delle identità locali.15
Evidentemente le proposte di L. Sagone per la costituzione di un’associazione, per la promozione di un museo locale, non ebbero grande successo; qualche anno dopo la collezione Mammana pervenne per acquisto al Museo di Siracusa.16
Nel 1926 Guido Libertini pubblicava il libro su Centuripe, sistemazione organica della ricerca archeologica nella città; da lì prende le mosse tutta la ricerca successiva.17 Nello stesso periodo viene organizzato un museo locale, in un’ala del palazzo municipale (fig. 2). Direttori onorari sono stati illustri professori di archeologia nell’Università di Catania: lo stesso Guido Libertini prima, Giovanni Rizza poi. L’allestimento era quello tipologico, di regola all’epoca (fig. 3). Il gruppo di sculture e iscrizioni di epoca romana; le vetrine di legno lineari, luminose, con le terracotte di epoca ellenistica (quelle per le quali Centuripe è universalmente nota nella bibliogra-fia archeologica); i vasi greci a figure rosse; la ceramica locale di età greca; la collezione numi-smatica. Con gli stessi criteri, e con le stesse vetrine, negli anni Trenta lo stesso Libertini allestiva a Catania il Museo Civico di Castello Ursino, di cui era pure Direttore onorario.18 Alla fine degli anni Settanta la sede del Museo fu oggetto di un grosso furto, che lasciò il segno sulle collezioni.19
Nel 1968 iniziarono le sistematiche campagne di scavo alla necropoli di Piano Capitano, ad opera della Soprintendenza di Agrigento, all’epoca competente per territorio, e con la direzione scientifica dell’Università di Catania; l’intenzione dichiarata era duplice: combattere le razzie dei tombaroli e affrontare dall’interno lo studio di una città indigena in via di ellenizzazione.20 Da allora i materiali da scavo sono rimasti a Centuripe, accanto alla vecchia collezione del museo locale. Soprintendente di Agrigento era il prof. Ernesto De Miro. Direttore dell’Istituto di Ar-cheologia era il prof. Giovanni Rizza, che era anche Direttore Onorario del Museo di Centuripe. Nella vecchia sede quei materiali non sono stati mai esposti. Semplicemente non c’era spazio. E
13 oRsi 1907. Cfr. anche orsi 1909a; oRsi 1909b; oRsi 1912; oRsi 1913.14 eMiLiani 1973; JaLLa 2003, pp. 48-83.15 Cfr. ad esempio la mostra archeologica e la mostra etnografica realizzate nell’ambito delle manifestazioni del 1911 per il cinquantenario della proclamazione dell’unità d’Italia. Guida 1911; BaRBaneRa 1998, pp. 104 ss.; caLcani 2007, p. 137.16 LiBeRtini 1926, p. 101 ss.17 LiBeRtini 1926; MaRotta d’aGata, Rizza 1987.18 Rizza 2000, pp. 386-389; tuRco 2011, pp. 187-188.19 Degli oggetti scomparsi ovviamente rimane la documentazione delle schede inventariali. Per la collezione numisma-tica: GaRRaffo 1979.20 Di recente: MaRotta d’aGata, Rizza 1987; Rizza 2002, pp. 21-39.
266
RosaRio P. a. Patané
l’attuale sede non era ancora disponibile.Ho avuto l’onore di dirigere il Museo Civico di Centuripe dal 1990 al 2005. Nel 2000 mi
sono occupato del trasloco e dell’allestimento nella sede attuale (figg. 4-6). È stata una bella av-ventura. La squadra del Museo è stata grande: tanta voglia di lavorare; la professionalità, affinata in quell’occasione, è rimasta un patrimonio comune. Grazie alla collaborazione di tutti, compresa la Polizia Municipale che ha garantito le scorte al trasferimento dei pacchi dal contenuto accura-tamente elencato, l’ingente mole di materiale è stata spostata conservando sempre la connessione con i dati di scavo. Era come pescare nel cilindro del prestigiatore: gli angusti locali della vecchia sede sembravano non svuotarsi mai.
Per il nuovo allestimento si è seguito il principio di fare storia attraverso la presentazione di oggetti e di risultati di scavi, con un percorso organico che possa fare da filo conduttore e una esposizione che permetta una corretta fruizione dell’opera d’arte, ma che permetta anche di sug-gerire il contesto in cui vanno visti i diversi oggetti.21 In collaborazione con la Soprintendenza, si è sempre cercato di rendere evidente il collegamento tra le cose esposte e il sito archeologico (in questo senso si è anche orientata l’attività di informazione per il pubblico svolta dal Museo). Niente disposizioni da Wunderkammer: l’esposizione è stata inaugurata negli ultimi giorni del XX secolo. Un museo per il pubblico, organizzato secondo l’esigenza di proporre una possibile chiave di lettura; non un museo enciclopedia che fornisca risposte già pronte ad un pubblico eli-tario e dalla cultura omogenea.22 Diversi fili conduttori si intrecciano dando vita a un percorso di visita che venga incontro alle esigenze dei visitatori; percorso non rigido quindi, ma articolabile secondo le esigenze di ognuno. Un filo conduttore che può sembrare scontato è quello cronologi-co; in realtà non sempre è perfettamente funzionale alle esigenze della comunicazione. Il filo dello sviluppo cronologico si intreccia con quello tematico e anche con quello della successione cro-nologica delle scoperte (della quale spesso bisogna tenere conto nella lettura dei contesti).23 L’e-sposizione museale deve essere gradevole, ma non è fatta solo di soluzioni tecniche: il messaggio dipende da un progetto culturale. Come un ipertesto, un’esposizione offre una carrellata di oggetti che raccontano una storia, ma contemporaneamente dà diverse possibilità di approfondimenti; è il visitatore a scegliere come muoversi. E non è necessario fare ricorso a tecnologie avanzate.24
21 È ovvio che gli allestimenti museali si fanno per il pubblico, per la funzione ‘comunicazione’: per rispondere alle funzioni di conservazione e ricerca basterebbe disporre di magazzini ordinati e accessibili agli studiosi. Cfr. WeiL 1990; schuBeRt 2000, pp. 80-97; MaGGi 2003. Ma cfr. anche l’annoso dibattito esistenziale al Pergamonmuseum di Berlino già dai primissimi anni del XX secolo, e ancora ripreso nel riordino della Museuminsel dopo la caduta del muro di Ber-lino: si è vista la contrapposizione tra concezione classificatoria e concezione in cui ci si propone di ricreare la reazione emotiva che l’opera suscitava nello spettatore originario; un oggetto da percepire così come lo ha voluto il suo creatore; oppure un oggetto dato all’analisi. antinucci 2004, pp. 82-88.22 Nel 1947 in Italia i visitatori di musei e gallerie erano poco meno di 600 mila, meno degli attuali visitatori degli Uffi-zi. Le cose cominciano a essere molto diverse nel 1970: nello stesso anno apparve il Boeing 747, l’aereo con cui inizia il viaggio di massa a basso costo, e a Parigi si bandì il concorso per il progetto di quello che poi si sarebbe chiamato il Centre Pompidou e che segnava la nascita del museo contemporaneo. Da qualche anno negli USA avvenivano espe-rienze come quella dell’Anacostia Neighborhood Museum, nata come estensione della Smithsonian Institution. KaRP, LaVine 1995; schuBeRt 2000, pp. 67-72, pp. 80-81; KinaRd 2005, 68-72; faLLetti, MaGGi 2012, pp. 68-69.23 Non perché gli archeologi vogliono innalzare un monumento a se stessi, come pure è stato ipotizzato; ma per il fatto che nel comunicare l’archeologia un problema di fondo è costituito dalla frammentarietà, dai dati di contesto, da tutta una serie di conoscenze che non si possono dare per scontate nei non addetti.24 Nell’ottica dei diversi livelli di lettura, da tempo si studiano percorsi in cui è possibile limitarsi a una linea generale, ma anche seguire singoli approfondimenti: è il visitatore a decidere cosa approfondire, semplicemente spostandosi nelle “nicchie” relative. Nella museografia dei decenni successivi alla seconda guerra mondiale si parlava di “seconda scelta”, non come giudizio di merito ma riferendosi a quelle cose da esporre per gli approfondimenti di studiosi e/o di un pubblico particolarmente interessato. BeRnaBò BRea, Minissi, 1964; RoyaL ontaRio MuseuM 1985, pp. 142-144;
267
Le coLLezioni deL Museo di centuripe: forMazione ed esposizione
Il percorso ha seguito una divisione di comodo tra siti dell’abitato, distribuiti su un piano, e necropoli nell’ammezzato (l’altro piano di esposizione non era ancora utilizzabile). Più che seguire rigorosamente la sequenza cronologica della città, si è fatta una presentazione per siti; all’interno di questi si è seguito lo sviluppo cronologico. Per contestualizzare le cose esposte, ci si è affidati all’u-so di ricostruzioni, plastici, disegni. L’esposizione delle necropoli non è una carrellata di oggetti bel-li, un noioso campionario di vasi e vasetti, ma mira a fornire un approccio alla storia dei vivi (figg. 7-9).25 L’allestimento è piaciuto ai visitatori, che si sono infatti accollato l’onere della pubblicità.26
Nel 2007 l’esposizione è stata ampliata su un altro piano, aggiungendo novità lungo tutto il percorso.27 Fondamentalmente si è rispettata l’impostazione del percorso per siti e con divisione tra abitato e necropoli. Nei nuovi spazi, l’esposizione relativa alle necropoli è stata arricchita di ricostruzioni, per dare l’idea di come la ricerca archeologica, indagando sui riti, ricostruisce certi aspetti sociali. I materiali della collezione comunale, privi di contesto di scavo, sono stati esposti tematicamente. Una sezione si propone di far vedere i danni causati dalle razzie dei tombaroli, esponendo falsi di inizi XX secolo28 e oggetti archeologici che nulla hanno a che fare con l’anti-chità di Centuripe per il semplice fatto di essere stati razziati altrove.29 Il procedere della ricerca arricchisce le collezioni di nuove cose, ma carica anche di un nuovo valore aggiunto quello che materialmente già esisteva. Non è certo il caso di illustrare qua il percorso di visita, e i relativi problemi espositivi. Solo qualche rapido esempio.
Il complesso dal cosiddetto edificio degli Augustali occupa il centro del piano terra (fig. 10), per chiari motivi logistici: l’ingombro e il peso delle sculture. Ma la rilettura del complesso ne fa un momento importante per la comprensione della Sicilia romana. Le statue-ritratto di com-ponenti di una famiglia locale assurta ai vertici dell’Impero erano messe a confronto con compo-nenti della famiglia imperiale, in una visione che simbolicamente richiamava le mitiche radici di Centuripe e le mitiche radici di Roma.30 A buon diritto costituisce il centro focale attorno al quale si sviluppa l’intera esposizione.
Le terracotte di III-I secolo a.C., maschere teatrali, figurine di danzatrici, ma anche le ceramiche a colori della stessa epoca, sono tra le cose che hanno reso più nota l’archeologia di Centuripe a livello internazionale.31 Purtroppo sono anche tra le cose più imitate dai falsificatori tra ’800 e inizi ’900.32 Le conoscenze su questi capolavori dell’artigianato artistico ellenistico a Centuripe stanno crescendo a livello esponenziale, anche grazie a scavi che ci hanno fatto mettere le mani su siti chiave per la comprensione del fenomeno. Queste cose hanno un loro peso nella collezione (dove pure sono poco rappresentati i “vasi centuripini”); hanno anche un ruolo note-vole nell’esposizione (figg. 11-12).
Si diceva dell’esposizione relativa alle necropoli; una grossa parte della collezione deri-va dagli scavi a Piano Capitano. Grossi corredi funerari dalle tombe a camera di VIII-VI secolo a.C. consentono di ricostruire la storia della città dei vivi (della quale tra l’altro non conosciamo
faLLetti, MaGGi 2012, pp. 80-81.25 Patanè 2002b; Patané 2003; Patané 2004; Patanè cds. a.26 L’azione dei servizi informativi del Museo e il “passaparola” dei visitatori soddisfatti hanno costituito il miglior contatto con l’esterno, nella non particolare brillantezza di servizi al turismo.27 È stato un piacere in quell’occasione fare parte della squadra diretta dal Soprintendente, la dott. Beatrice Basile.28 Falsari di Centuripe li diffondevano per il mondo, assieme ad oggetti estratti di contrabbando dal suolo di Centuripe.29 Oggetti recuperati localmente, ma provenienti da scavi clandestini in altre aree; l’attività delle forze dell’ordine porta a recuperi anche consistenti, ma il contesto originario è ormai irrimediabilmente perduto.30 Per una rilettura del monumento e del complesso scultureo cfr. di recente Patané 2010; Patané 2011; ivi bibliografia precedente.31 Bonacasa, JoLy 1985; Patané 2002a, p. 127; MusuMeci 2010; Patané cds. b.32 JoLy 1980, pp. 1246-1247, nota 14: ivi bibliografia precedente; feRRetti 1981, pp. 191-192; BaRBaneRa 2003.
268
RosaRio P. a. Patané
resti relativi a quest’epoca): si possono seguire le diverse fasi dei contatti della città sicula con i Greci; si possono ricostruire cose come i commerci, ma anche riti funebri, credenze, aspetti più squisitamente culturali o legati alle strutture sociali.33 L’esposizione ovviamente è in funzione di tutto ciò (figg. 13-15).34
Infine, vado a concludere, mi pare meriti un cenno l’apparire nelle collezioni del Museo di cose appartenenti a un orizzonte cronologico più recente dell’antico. Nel corso degli anni No-vanta si è costituito il nucleo principale di una Collezione di Antropologia Culturale, poi inglobata nell’attività del Museo Civico; il riordino museografico ha portato ad una scelta del taglio storico: i cosiddetti “musei della civiltà contadina”, pur svolgendo un importante ruolo di conservazione, sono spesso realtà troppo vaghe. Si è preferito a un certo punto puntare su una esposizione che, nella sede decentrata dell’ex Macello, portasse avanti il concetto di museo della città per le fasi storiche successive alla fondazione del 1548 (figg. 16-19).35 In fondo, la museografia etnografica in Italia è nata negli anni a cavallo tra XIX e XX secolo, con personaggi come G. Pitré in Sicilia e L. Loria a Firenze e poi a Roma: oggetto dell’indagine era la società circostante, in un momento in cui si stava definendo l’identità della ancor giovane Italia.36 Se l’esposizione riguarda la società del passato, anche se recente, sarebbe meglio parlare di museo storico più che di museo etnogra-fico. «Via via che si avvicinano, musei di archeologia e musei di storia finiscono per confondersi in un sistema di periodi a contenuti complessi, dalle origini ai nostri giorni».37 Si parla ormai di archeologia post-medievale; nei Paesi di lingua inglese ‘historical archaeology’ indica l’archeo-logia relativa a periodi per i quali si dispone di fonti scritte (non dimentichiamo che nel continente americano la scrittura è cosa abbastanza recente, successiva alla “scoperta dell’America” da parte degli Europei).38 Il Codice dei Beni Culturali “apre” all’attribuzione dell’etichetta “archeologia” a collezioni di cose risalenti a più di cento anni:39 a questo punto si mette l’attenzione sul metodo archeologico più che sull’antichità dell’oggetto.
D’altra parte, nell’esplorazione archeologica del territorio di Centuripe, ci si cominciò ad imbattere in cose di datazione un po’ particolare; il metodo dell’indagine archeologica di superficie applicato ai resti relativi alla seconda guerra mondiale cominciò a far vedere lo scenario dei combat-timenti del 1943.40 Le collezioni del Museo cominciarono ad arricchirsi di una nuova tipologia.
aBBreViazioni BiBliografiche
antinucci F. 2004, Comunicare nel museo, Roma-Bari.antinucci f. 2007, Musei virtuali, Roma-Bari.
33 Di recente: Patané 2009.34 Su alcuni problemi relativi all’esposizione delle necropoli: Patané cds. a. Per un lusinghiero apprezzamento dei cri-teri museografici: MottoLa MoLfino 2010, pp. 197-199.35 Patané 2002b, p. 12; Patané 2003, pp. 198-199.36 La mostra nell’occasione della Esposizione Nazionale di Palermo nel 1891-92, la mostra a Roma nel 1911 costitui-scono dei punti fermi. Guida 1911; Esposizione 1988; Puccini 2005; Puccini 2011, pp. 562-565.37 RiVièRe 2005.38 Battisti 2001; toGnaRini, nesti 2003; taMPone 2004; ManacoRda 2008, 21-29; MytuM 2008.39 D.Lgs. 42/2004, Allegato A.40 Biondi 2008; Patané 2008; Biondi 2010.
269
Le coLLezioni deL Museo di centuripe: forMazione ed esposizione
BarBanera M. 1998, L’archeologia degli italiani, Roma.BarBanera M. 2003, False impressioni. La polemica sui “Tondi di Centuripe” tra Giulio Ema-
nuele Rizzo e Carlo Albizzati, in BdA, 125-126, pp. 79-98.Battisti e. 2001, Archeologia industriale, Milano.BernaBò Brea l., Minissi f. 1964, The Syracuse National Archaeological Museum, in Museum,
17, 3, pp. 114-126.Binni L., Pinna G. 1989, Museo. Storia e funzioni di una macchina culturale dal ’500 a oggi,
Milano.Biondi g. 2008, Evidence for the Battle of Sicily (1943) from archaeological survey, in Antiquity,
82, n. 317, http://www.antiquity.ac.uk/projgall:biondi317/.Biondi g. 2010, Il contributo della ricerca archeologica di superficie alla ricostruzione di feno-
meni bellici recenti. Il caso Centuripe: materiali, criteri metodologici e prospettive, in Biondi G. (ed.), Centuripe. Indagini archeologiche e prospettive di ricerca (Monografie dell’Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali – C.N.R., 4), Catania, pp. 149-155.
Bolognesi c. 2002, Belle arti, patrimonio e legislazione: Ricci, Rosadi e la stagione giolittiana, in Varni A. (ed.), A difesa di un patrimonio nazionale. L’Italia di Corrado Ricci nella tutela dell’arte e della natura, Ravenna, pp. 7-52.
Bonacasa n., e. Joly e. 1985, L’ellenismo e la tradizione ellenistica, in Pugliese carratelli G. (ed.), Sikanie, Milano, pp. 277-358.
BusceMi felici G. 2012, Paolo Orsi e Guido Libertini collezionisti. Tra proprietari di fondi, com-mercianti antiquarî e falsari centuripini, in Topografia Antica, 2, Acireale-Roma, pp. 155-182.
calcani G. 2007, Storia dell’archeologia. Il passato come ricerca di attualità, Roma.d’agata A.L., alaura S. (edd.) 2009, Quale futuro per l’archeologia?, Roma.de rita G. 1987, Le ragioni del successo dei beni culturali nella società post-industriale, in
Memorabilia: il futuro della memoria. 1. Tutela e valorizzazione oggi, Roma-Bari, pp. 267-269.
eMiliani a. 1973, Musei e museologia, in Storia d’Italia, V, 2, Torino, pp. 1613-1655.eMiliani a. 1997, Corrado Ricci: la ricerca positiva, l’animo idealistico e la nascente politica
dell’arte in Italia, in Accademia Clementina, Atti e Memorie, n. 37, s.n., pp. 23-69.La Esposizione Nazionale 1891-1892, Palermo 1988.falletti V., Maggi M. 2012, I musei, Milano.ferretti M. 1981, Falsi e tradizione artistica, in Conservazione, falso, restauro (Storia dell’arte
italiana, X), Torino, pp. 111-195.fichera F. 1904, Scavi dello anfiteatro di Catania, in Archivio Storico per la Sicilia Orientale, 1,
pp. 119-121.fichera F. 1905, Per lo anfiteatro di Catania, in Archivio Storico per la Sicilia Orientale, 2, 1905,
pp. 66-72.francoVich r., zifferero a. (edd.) 1999, Musei e parchi archeologici, Firenze.gaiMster D. (ed.) 1994, Museum Archaeology in Europe, Oxford.garraffo s. 1979, Monete greche e romane dell’Antiquarium di Centuripe, in CronCatania, 18,
pp. 182-186.giarrizzo G. 1986, Catania, Roma-Bari.Guida Ufficiale delle Esposizioni di Roma, Roma 1911GuLLini G. 1987, Le nuove frontiere della fruizione come antidoto all’incoltura di massa, in Memo-
rabilia: il futuro della memoria. 1. Tutela e valorizzazione oggi, Roma-Bari, pp. 278-283.iMPera r. 2003, Le origini del Bollettino d’Arte e il ruolo di Corrado Ricci, in BdA, allegato al
fasc. 125-126, p. 7.
270
RosaRio P. a. Patané
KarP I., laVine S.D. (edd.) 1995, Culture in mostra. Poetiche e politiche dell’allestimento museale, Bologna.
Kinard J. 2005, Intermediari tra il museo e la comunità, in riBaldi 2005, pp. 64-72 [Intermedi-aries between the museum and the community, in Papers from the Ninth General Con-ference of ICOM “The museum in the service of man today and tomorrow / Actes de la Neuvième Conférence Générale de l’ICOM “Le musée au service des homes aujourd’hui et demain”, Oxford 1972, pp. 151-156].
Jalla D. 2003, Il museo contemporaneo, Torino.Joly e. 1980, Teorie vecchie e nuove sulla ceramica policroma di Centuripe, in FilίaV Cάrin,
Roma, pp.1241-1254.la regina A. (ed.) 2009, L’archeologia e il suo pubblico, Firenze.lugli A. 1994, Museologia, Milano.Maggi M. 2003, Visitatori, pubblico, comunità, in Nuova Museologia, 9, pp. 10-11.Marini chiarelli M.V. 2005, Che cos’è un museo, Roma.Manacorda D. 2008, Lezioni di archeologia, Roma-Bari.Marotta d’agata a.r., rizza g. 1987, s.v. Centuripe, in Bibliografia topografica, V, Pisa-Ro-
ma, pp. 234-243.Mazzi M.C. 2005, In viaggio con le muse. Spazi e modelli del museo, Firenze.Melucco Vaccaro a. 1989, Archeologia e restauro, Milano.Mottola Molfino A. 1991, Il libro dei musei, Torino.Mottola Molfino A. 2010, Viaggio nei musei della Sicilia. Guida ai luoghi, Palermo.MusuMeci A. 2010, Le terracotte figurate dalla necropoli di contrada Casino in Centuripe, in
Biondi G. (ed.), Centuripe. Indagini archeologiche e prospettive di ricerca, Monografie dell’Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali - C.N.R., 4, Catania, pp. 39-114.
MytuM H. 2008, Directions in historical archaeology, in Antiquity, 82, pp. 789-791.orsi P. 1907, Centuripe, in NSc, 1907, pp. 491-492.orsi P. 1909a, Centuripe. II e III campagna nella necropoli del Casino, in NSc, 1909, pp. 382-383.orsi P. 1909b, Reliquie di Centuripe sicula, in RM, 24, pp. 90-99.orsi P. 1912, Nuove indagini nella necropoli, in NSc, 1912, pp. 419-420.orsi P. 1913, Sepolcri siculi di Centuripe (Catania), in BPI, 39, pp. 92-98.Pagnano G. 2007, La costruzione dell’identità di Catania dal secolo XVI al XX, in ayMard M.,
giarrizzo G. (edd.), Catania. La città, la sua storia, Catania, pp. 181-237.Patané r. 2002a, Centuripe in età ellenistica: i rapporti con Roma, in rizza G. (ed.), Scavi e
ricerche a Centuripe, Studi e Materiali di Archeologia Mediterranea, 1, Catania, pp. 127-167.
Patané r. 2002b, Qui si rivive l’antica città, in Centuripe, Suppl. a Kalós, 14, 4, ottobre-dicembre 2002, pp. 10-13.
Patané r. 2003, Il Museo Civico di Centuripe: tecniche espositive e modi di comunicazione, in Quagliuolo M. (ed.), La Gestione del Patrimonio Culturale (VII Colloquio Internaziona-le. Accessibilità ai Beni Culturali e Ambientali, Cesena 4-8.12.2002), Roma, pp. 192-200.
Patané r. 2004, Banchetto al museo, in Quagliuolo M. (ed.), La Gestione del Patrimonio Cul-turale (VIII Colloquio Internazionale. Il Patrimonio Inconsueto, Corigliano Calabro 4-8.12.2003), Roma, pp. 148-157.
Patané r. 2008, Bivacchi di guerra a Centuripe. Quando un archeologo classico s’imbatte in tracce dello sbarco in Sicilia del 1943, in La Sicilia, 27.11.2008.
Patané r. 2009, Centuripe dall’VIII secolo a.C. Una città sicula di età greca, in PanVini R., sole L. (edd.), La Sicilia in età arcaica. Dalle apoikiai al 480 a.C. Contributi dalle recenti indagini archeologiche, Palermo, pp. 111-114.
271
Le coLLezioni deL Museo di centuripe: forMazione ed esposizione
Patané r. 2010, Sui Colli Albani all’ombra della catachanna: imprenditoria ed emigrazione d’élite nell’Impero Romano, in Forma Urbis, 15.1, pp. 23-29.
Patané R. 2011, Impero di Roma e passato troiano nella società del II secolo. Il punto di vista di una famiglia di Centuripe, Quaderni del Museo Civico Lanuvino, 3, Roma.
Patané R. cds. a, Il ruolo del simposio nei contatti tra Siculi e Greci. Aspetti della comunicazione nel museo, in Cibo per gli uomini Cibo per gli dei. Archeologia del pasto rituale (Atti del Convegno, Piazza Armerina, 4-8 maggio 2005), in c.d.s.
Patané R. cds. b, Danzando nell’aldilà. Un contributo alla conoscenza della cultura ellenistica, in Sikelikà Hierà. Approcci multidisciplinari allo studio del sacro nella Sicilia greca (Atti del Convegno, Catania, 11-12 giugno 2010), in c.d.s.
PeLaGatti P. 2001, Dalla Commissione Antichità e Belle Arti di Sicilia (CABAS) alla amministra-zione delle Belle Arti nella Sicilia post-unitaria: rottura e continuità amministrativa, in Antiquités, archéologie et construction nationale au XIXe siècle, Mélanges del l’école Française de Rome. Italie et Méditerranée, 113, pp. 599-621.
PoMian K. 2003, Dalle sacre reliquie all’arte moderna, Milano.PouLot D. 1997, Musée, nation, patrimoine: 1789-1815, Paris.PouLot D. 2008, Musei e museologia, Milano.PRuneti P., Ronc M.C. (edd.) 2011, Restituire la memoria. Modi e forme dei linguaggi museali
(Atti del Convegno internazionale promosso dall’Assessorato Istruzione e Cultura della Regione Autonoma Valle d’Aosta, Aosta, 4-5 giugno 2010), Firenze.
Puccini S. 2005, L’itala gente dalle molte vite. Lamberto Loria e la mostra di Etnografia italiana del 1911, Roma.
Puccini S. 2011, A casa e fuori: antropologi, etnologi, viaggiatori, in cassata F., PoGLiano C. (edd.), Scienze e cultura dell’Italia unita, Storia d’Italia. Annali, 26, Torino, pp. 547-573.
Rauti I. 2000, La fruizione finalizzata nel museo archeologico, in QuaGLiuoLo M. (ed.), La ge-stione del patrimonio culturale (Atti del III Colloquio Internazionale. Turismo e Beni Culturali e Ambientali, Cagliari 4-8 dicembre 1998), Roma, pp. 166-175.
Rauti I. 2001, Musei di archeologia, in naRdi E. (ed.), Leggere il museo. Proposte didattiche, Formello (RM), pp. 43-80.
RiBaLdi C. (ed.) 2005, Il nuovo museo, Milano.RiVièRe G.H. 2005, Rôle du musée d’art et du musée de sciences humaines et sociales, in Museum
International UNESCO, XXV, 1973, 1-2, pp. 26-43; trad. it.: RiVièRe G.H. Il ruolo del museo d’arte e del museo di scienze umane e sociali, in RiBaLdi C. (ed.), Il nuovo museo, Milano 2005, pp. 87-102, 285-287.
Rizza G. 1999, Un trentennio di archeologia a Catania (1890-1920), in doLLo C. (ed), Per un bi-lancio di fine secolo. Catania nel Novecento (Atti del Convegno di Studio). I primi venti anni, Catania, pp. 65-90.
Rizza G. 2000, Guido Libertini e l’archeologia a Catania fra le due guerre, in doLLo C. (ed.), Per un bilancio di fine secolo. Catania nel Novecento (Atti del II Convegno di studio). 1921-1950, Catania, pp. 381-419.
Rizza G. 2002, Scavi e scoperte a Centuripe nell’ultimo cinquantennio, in G. Rizza (ed.), Scavi e ricerche a Centuripe, Studi e Materiali di Archeologia Mediterranea, 1, Catania, pp. 9-40.
RoyaL ontaRio MuseuM 1985, Allestimento e comunicazione. Criteri per la progettazione, in Basso PeRessut L. (ed.), I luoghi del museo. Tipo e forma fra tradizione e innovazione, Milano, pp. 131-148.
RuGGieRi tRicoLi M.C., VaciRca M.d. 1998, L’idea di museo, Milano.RuGGieRi tRicoLi M.C. 2000, I fantasmi e le cose. La messa in scena della storia nella comunica-
272
RosaRio P. a. Patané
zione museale, Milano.saGone L. 1907, Centuripe di fronte al movimento moderno, Centuripe.schuBeRt K. 2000, Museo. Storia di un’idea. Dalla Rivoluzione francese a oggi, Milano.stone P.G., MoLyneaux B.L. (edd.) 1994, The Presented Past. Heritage, museums and education,
London-New York.taMPone L. 2004, Il patrimonio archeologico postmedievale in Italia, in QuaGLiuoLo M. (ed.), La
Gestione del Patrimonio Culturale (VIII Colloquio Internazionale, Il Patrimonio incon-sueto, Corigliano Calabro 4/8 dicembre 2003), Roma, pp. 118-125.
toGnaRini I., nesti A. 2003, Archeologia industriale, Roma.toMea GaVazzoLi M.L. 2003, Manuale di Museologia, Milano.tuRco M. 2011, 1934: le collezioni archeologiche nel nuovo Museo Civico di Castello Ursino, in
aPRiLe I.D. (ed.), Catania 1870-1939. Cultura Memoria Tutela, Palermo, pp. 187-193.uRsino M. 2011, L’archeologia a Catania tra il 1870 e il 1939: gli uomini e le ricerche, in aPRiLe
I.D. (ed.), Catania 1870-1939. Cultura Memoria Tutela, Palermo, pp. 173-185.VeRGo P. (ed.) 1989, The New Museology, London 1989.VLad BoReLLi L. 1987, Archeologia e qualità della vita, dopo il declino dell’assalto edilizio e
l’insorgenza dei nuovi rischi, in Memorabilia: il futuro della memoria. 1. Tutela e valo-rizzazione oggi, Roma-Bari, pp. 148-154.
VLad BoReLLi L. 2003, Restauro archeologico. Storia e materiali, Roma.WeiL S.E. 2004, Rethinking the Museum: An Emerging New Paradigm, in Museum News, mar-
zo-aprile 1990; ora in andeRson G. (ed.), Reinventing the Museum. Historical and con-temporary Perspectives on the Paradigm Shift, Lanham-Oxford, pp. 74-79.
273
Le coLLezioni deL Museo di centuripe: forMazione ed esposizione
Fig. 5. Arrivo di statue
Fig. 4. La nuova sede del Museo Archeologico
Fig. 2. Il vecchio Museo
Fig. 1. Catania – Piazza Stesicoro con l’anfiteatro
Fig. 6. Saletta introduttiva
Fig. 3. Il vecchio Museo
274
RosaRio P. a. Patané
Fig. 9. Corredo di tomba a camera: i disegni trasparenti sul vetro indicano la funzione di oggetti esposti
Fig. 8. Complesso di oggetti con plastico del sito e im-magini d’epoca per illustrare le azioni
Fig. 7. Ricostruzione grafica, basata sui dati di scavo
Fig. 12. Clipeo centuripino
Fig. 11. Laboratorio da ceramista: gli oggetti antichi spic-cano nei colori reali sulla ricostruzione grigia; alla parete è una pittura pompeiana della stessa epoca raffigurante un laboratorio
Fig. 10. Le sculture dell’edificio degli Augustali
275
Le coLLezioni deL Museo di centuripe: forMazione ed esposizione
Fig. 13. Ricostruzione di tomba a camera, con gli oggetti disposti secondo i dati di scavo. Le vetrine accanto ospitano altri corredi dello stesso tipo
Fig. 14. Terracotta locale, fine VI secolo a.C.
Fig. 15. Urne cinerarie romane: l’espositore riprende, stilizzando, il volume di un colombario
276
RosaRio P. a. Patané
Fig. 18. Attrezzi per l’aratura Fig. 19. Imballatrice, fine XIX secolo
Fig. 16. Carretto siciliano e mantello da carrettiere (la vetrina è stata recu-perata dal vecchio museo archeologico) Fig. 17. Torchio da olio