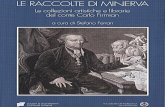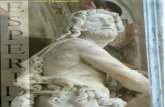L'eredità del passato : Vito Capialbi e le collezioni Cannella e David a Vibo Valentia (in...
Transcript of L'eredità del passato : Vito Capialbi e le collezioni Cannella e David a Vibo Valentia (in...
161Non tutti coloro che si trovano a percorrere la Via Ruggero il Normanno – nel
centro storico di Vibo Valentia, ai piedi del castello svevo – sanno che dietro
quel portale di granito bugnato di un sobrio palazzo ottocentesco si cela l’anti-
ca dimora di Vito Capialbi1. (fig.1)
Eloquente figura di nobile, vissuto a cavallo di due secoli – era nato il trenta di
ottobre del 1790 e morì nel 1853, sempre il trenta di ottobre, nella stessa città
che allora si chiamava ancora Monteleone2 – la personalità del conte si impose
molto presto all’attenzione degli studiosi del tempo quale arguto ed appassio-
nato conoscitore di antichità greche, romane e medievali, oltre che bibliofilo
impareggiabile. Proprio per la sua capacità di distaccarsi dai consueti atteggia-
menti campanilistici e provinciali, misurandosi con i più interessanti uomini di
scienza antica dell’epoca – attraverso un fitto scambio epistolare che a tutt’oggi
costituisce la principale testimonianza della vivacità intellettuale e culturale
del Capialbi – la sua figura si distingue tra i collezionisti del tempo.
Il suo modo di essere studioso di un certo spessore e, quindi, la sua vera natura
di fine ricercatore solo di recente vanno delineandosi e stagliandosi nettamente
sullo sfondo di un contesto storico molto confuso e di un travagliato periodo di
transizione che costituivano lo scenario della Calabria di allora. Quando Mon-
teleone divenne capoluogo della Calabria Ulteriore, durante il decennio france-
se3, il Capialbi ricoprì cariche pubbliche che assorbirono gran parte del suo
tempo, allontanandolo temporaneamente dalle sue antichità, dal suo “museolo
domestico”, come era solito definire la sua collezione, e solo successivamente
riuscì a ritornare ai suoi principali interessi4.
“Studioso locale” ed “erudito” è stato definito spesso ed in più di un’occasio-
ne! In realtà di locale vi erano senz’altro le tematiche e gli argomenti che gli
stavano a cuore, in quanto scaturiti dalla realtà che lo circondava e che andava
indagando, mentre non era assolutamente provinciale il suo modo di avventu-
rarsi ed addentrarsi nei diversi campi della conoscenza, il contatto con altre fi-
gure e personalità di scienziati, il cercare il confronto ed il conforto di studiosi
che lo proiettavano di volta in volta in un’altra dimensione, trasformandolo in
una personalità anomala nell’accezione più positiva del termine.
Alla sua morte l’eredità spirituale e culturale non venne raccolta da nessuno, né
tra i familiari né tanto meno tra i cittadini monteleonesi. Eppure la biblioteca, ric-
ca di rarissimi documenti e libri sottratti tempestivamente all’oblio, ed il suo mu-
seo personale, traboccante di materiale archeologico, erano lì ad indicare la strada
da lui tracciata, la varietà degli interessi di ricerca e la passione profusa nel rac-
cogliere materiale archeologico, nel tentativo di interpretarne le vicende.
Parte della sua collezione, generosamente donata dagli eredi alla Soprinten-
denza Archeologica della Calabria, costituirà la base, il nucleo di partenza, gra-
zie al quale sarà possibile allestire le prime vetrine del museo che a lui stesso
sarà, appunto, intitolato5. Non vi è dubbio che una collezione di oggetti antichi
rifletta gli interessi ed i gusti personali di chi, in maniera appassionata e meti-
L’eredità del passato: Vito Capialbi e le collezioni Cannella
e David a Vibo Valentia
Maria D’Andrea
Rubbettin
o
162
colosa, li ha selezionati nel corso degli anni, così come è comprensibile che
l’intervento, successivo, di terzi possa modificare quella che era l’intenzione
iniziale e le preferenze del collezionista. Dall’analisi dei materiali archeologici
donati anni or sono all’istituendo museo cittadino, infatti, sembra delinearsi il
profilo di un collezionista attratto esclusivamente da materiali di produzione
greca in genere, ceramica a figure nere e figure rosse e coroplastica in testa, ri-
spetto ad altre pur numerose classi di produzione antiche. In effetti quando gli
eredi di Vito Capialbi decisero di donare parte della collezione furono selezio-
nati ed estrapolati i materiali che sembravano rivestire maggiore attrattiva e
rientrare nella tipologia di interessi del costituendo museo cittadino.
Scorrendo gli elenchi dei materiali stilati di volta in volta per valutare numeri-
camente i reperti custoditi nella collezione, si evidenzia in maniera palese l’in-
teresse provato dagli studiosi nei confronti degli oggetti di produzione greca o
classica in genere. L’attenzione degli studiosi si è parimenti concentrata sui
bronzetti6 e sulle monete7. Nella realtà, i materiali raccolti dal Capialbi duran-
te la sua vita rispecchiano i vivaci interessi dell’erudito, che vanno appunto dal
materiale greco a quello romano, dalle produzioni tardo antiche fino a quelle
medievali e rinascimentali8.
Tutto ciò si è potuto verificare anche recentemente durante i lavori di scheda-
tura presso la casa dello studioso. A partire dal 1992, infatti, si è dato corso ad
un grande progetto definito “Operazione Emergenza”, tramite il quale l’Istituto
Centrale del Catalogo9 voleva completare “l’anagrafe” di tutti i materiali sotto-
posti a vincolo fino a quella data. A lavoro ultimato si sarebbe ottenuta una ri-
cognizione completa dei beni custoditi presso biblioteche, banche e privati, co-
me pure dei vincoli apposti dal ministero stesso.
E le sorprese, nell’attuare tale progetto, non sono mancate. Nella fattispecie,
proprio a proposito della collezione del conte monteleonese, si è avuta la netta
impressione che ancora oggi non si ha un quadro preciso dei materiali presenti
nella raccolta Capialbi.
Come si accennava in precedenza gli elenchi dei reperti redatti nel corso degli
anni, durante i sopralluoghi presso la dimora del conte, comprendevano soltan-
to materiali classici e numerosi bolli romani10 mentre esludevano, ad esempio,
un importante gruppo di oggetti in vetro11 prodotti in epoca romana, (fig. 3-4)
oppure un consistente nucleo di lucerne12, anch’esse ascrivibili a questo perio-
do, o ancora numerosissimi frammenti di ceramica di età medievale e rinasci-
mentale13. (fig. 5-6)
Per la verità alcune delle lucerne rimaste in deposito, presso gli eredi dello stu-
dioso, recano la numerazione pertinente ad una schedatura condotta dalla So-
printendenza che, probabilmente, non prevedeva l’esposizione presso il museo
archeologico.
Degno di attenzione anche il carteggio tra Paolo Orsi, all’epoca Soprintendente
archeologico per la Calabria con sede provvisoria in Siracusa, ed il Ministero,
nella persona del Ministro del tempo, al quale l’archeologo trentino chiedeva di
intercedere per ottenere in visione il catalogo dei materiali, redatto in prece-
denza, al fine di non rendere vano il lavoro prodotto da altri funzionari statali.
Il famoso archeologo aveva chiesto reiteratamente – per la terza volta si legge
in una nota – di poter accedere al documento approntato dal Gabrici per poter
istruire la pratica dell’acquisto14.
Rubbettin
o
163
La controversia riguardava l’acquisizione in blocco di tutta la raccolta Capial-
bi, per il nascente “Museo regionale Calabro” con sede a Reggio Calabria, ov-
vero – tesi sostenuta da Napoli – l’estrapolazione dei pezzi ritenuti dalla dire-
zione di un certo valore, rinunciando così, a giudizio dell’Orsi, ad un’importan-
te parte della storia della Calabria. Infatti, oltre ai pezzi archeologici faceva
parte della collezione un’importante raccolta numismatica costituita da circa
4.000 monete. L’Orsi, in una lettera del marzo 1911 indirizzata al Ministro del-
l’Istruzione Pubblica, paventa la possibilità di una vendita all’estero dell’intera
collezione.
Ed insiste nel dire che la collezione «merita di essere salvata per le raccolte
pubbliche, prima che prenda il volo per oltre mare…»15.
L’archeologo, sempre considerando quanto scrive nel documento, aveva avuto
qualche contatto con Cesare Capialbi Afan de Rivera; quest’ultimo, a parere
dello studioso, sembrava abbastanza ben disposto a trattare per l’acquisizione
della collezione16. E Paolo Orsi non aveva pregiudizi di sorta rispetto alla com-
posizione della collezione avendo intuito, da informazioni assunte da persone
che avevano avuto la fortuna di vedere qualche cosa, che la peculiarità della
raccolta era determinata proprio dalla varietà tipologica e cronologica dei re-
perti. Quasi a dimostrazione di questa sua sensibilità l’archeologo prese in con-
siderazione, per una brevissima pubblicazione, alcuni frammenti di ceramica
medievale rinvenuti nel corso degli scavi di una nuova ala di palazzo Capialbi.
I motivi per i quali non aveva potuto prendere visione degli oggetti della colle-
zione erano imputabili a problemi logistici che, di volta in volta, venivano ad-
dotti dagli eredi per impedire allo studioso trentino di esaminare la raccolta.
Ma nonostante le limitazioni l’archeologo riuscì a far disegnare dal fedele col-
laboratore Rosario Carta alcuni dei materiali decorati da motivi a bande rosse.
È possibile affermare senza scadere nella retorica che si tratta di uno studio,
seppur breve, che può essere considerato antesignano dei moderni studi sulla
ceramica medievale17.
Nonostante non gli fosse stato consentito l’accesso alla raccolta18, egli spese la
sua autorevolezza ed il suo interessamento, presso le sedi opportune, per pero-
rare la causa di acquisizione della collezione nella sua integrità, mantenendo
così vivo l’interesse verso quell’ingente patrimonio di cultura che Capialbi ave-
va messo insieme, valorizzando così anche l’intraprendenza dello studioso mon-
teleonese, anche in considerazione dei tempi durante i quali aveva esplicato la
sua attività di collezionista e ricercatore. L’impegno di Paolo Orsi può quindi
essere interpretato come un incentivo verso quanti, a vario titolo, si sarebbero
dovuti occupare della vicenda “collezione”. Quando Vito Capialbi si preoccu-
pava di salvare e salvaguardare quanto rimaneva del passato raccogliendo nel
vibonese, ma non solo19, ceramiche, vetri e bronzi negli scavi che i contadini
praticavano nei suoi possedimenti, ma anche nelle campagne circostanti, l’at-
tuale concetto di “bene culturale” era inesistente, così come non vi erano leggi
dello Stato a sua tutela20. Sussisteva, quindi, una certa libertà nel praticare sca-
vi, detenere, vendere o donare reperti archeologici, nonostante l’esigenza di
norme a tutela del ricco patrimonio artistico ed archeologico italiano affondas-
se le radici nel Rinascimento21.
Prima dell’unificazione del Regno d’Italia, ogni Stato in cui era suddivisa la pe-
nisola aveva proprie leggi e regole per tutelare i monumenti e gli oggetti22. Si
Rubbettin
o
164
trattava di leggi che fondamentalmente cercavano di limitare i danni provocati
dalle esportazioni del patrimonio artistico, soprattutto in seguito al dilagare del-
la moda e del gusto del collezionismo antiquario in voga a partire dal XVI seco-
lo. Le leggi emanate dallo Stato Pontificio furono quelle più interessanti e lungi-
miranti tanto che, come strumenti legislativi, vennero prese a modello anche da
altri Stati. L’editto Pacca, promulgato nel 1820 dall’omonimo cardinale, viene
considerato come il primo tentativo di fornire un reale strumento di tutela dei
beni artistici ed archeologici23. Bisognerà arrivare però al 1939 per avere la pri-
ma legge di tutela che, con qualche modifica ed integrazione successiva, conti-
nua a rappresentare ancora oggi lo strumento fondamentale per esercitare con-
trollo e protezione dei beni culturali, nonostante necessiti di miglioramenti ed
affinamenti per rispondere alle diverse esigenze che nel frattempo sono sorte.
Nel 1928 Monteleone sostituì il nome medievale con quello di Vibo Valentia in
ricordo del glorioso passato romano della colonia latina al quale guardavano
con rimpianto ed orgoglio i politici fascisti24. Il periodo che va dagli anni Tren-
ta agli anni Sessanta costituisce un momento poco fecondo, per motivi contin-
genti, sia per quanto riguarda la ricerca archeologica che per coltivare gli inte-
ressi specifici connessi a questo argomento25.
Ma, a poco più di un secolo dalla morte del conte Capialbi in città viene avvia-
to un profondo processo di rinnovamento urbanistico che avrà ripercussioni di
un certo rilievo nel tessuto non solo civile e sociale, ma soprattutto culturale.
Sul finire degli anni Sessanta del secolo scorso, infatti, vengono riprese le ri-
cerche archeologiche nella città che, come appena riferito, non si chiama più
Monteleone, come ai tempi di Vito Capialbi e delle imprese di scavo di Paolo
Orsi, bensì Vibo Valentia.
Quella di intraprendere ricerche archeologiche non fu sicuramente una scelta
determinata da interessi scientifici quanto piuttosto una conseguenza degli ster-
ri praticati per la realizzazione di nuovi edifici. È così che all’interno dei can-
tieri edili cittadini allestiti per la costruzione di fabbricati e quartieri moderni,
tra l’incessante lavoro delle ruspe ed i cumuli di grassa terra nera, cominciano
ad affiorare ed essere recuperate le testimonianze, spesso mute perché decon-
testualizzate, del passato antico della città che consentiranno e favoriranno, di
lì a poco, la nascita ed apertura al pubblico del primo nucleo del museo archeo-
logico intitolato proprio a chi, grazie ad una personalità fuori dal comune, ave-
va inciso profondamente nella storia culturale della città.
Tra la metà e la fine degli anni Sessanta, e per tutto il decennio successivo, la
parte bassa della città di Vibo – dal Municipio fino al quartiere Affaccio – è un
pullulare di cantieri edili; qui affiorano i resti della vasta area di necropoli gre-
ca in uso ai coloni dalla fine del VII fino alla fine del IV secolo a.C. Ma anche
altre zone della città, che avevano ricevuto l’attenzione dei costruttori, svelano
preziose tracce che riconducono inevitabilmente al passato più antico di Vibo
Valentia, quando si chiamava Hipponion in epoca greca o quando i romani, do-
po avervi fondato una colonia, le cambiarono il nome in Valentia. In ambedue i
casi il passato che ritornava prepotentemente a mostrarsi ai moderni – vuoi at-
traverso un mosaico, oppure attraverso le tombe degli antichi greci, o ancora
attraverso gli oggetti votivi dedicati alla divinità titolare del tempio cittadino –
costituiva un incentivo, uno stimolo nei confronti di chi aspirava a conoscere
gli aspetti più macroscopici collegati al passato della città.
Rubbettin
o
165
Così da una parte il Museo archeologico allestito nel 1969 proprio per ospitare
i numerosi reperti emersi nel corso delle tante intensive campagne di scavo,
dall’altra l’attività degli studiosi che con le loro ricerche e studi restituivano di-
gnità ai “cocci”, hanno risvegliato l’interesse nei confronti del proprio passato,
che poteva essere interpretato e decifrato per mezzo dei materiali che affiora-
vano abbondanti nei cantieri della città.
Dalla metà degli anni Sessanta fino ai primi anni Settanta era considerato nor-
male transitare per viale Kennedy, via D’Annunzio, il quartiere Affaccio, per
quella che allora era la periferia urbana della città e vedere archeologi ed ope-
rai intenti allo scavo di sepolture, attività che nell’immaginario collettivo susci-
ta partecipazione e curiosità. In questo clima, di fervore ed esaltazione nei con-
fronti della ricerca e dei suoi risultati, si sono formate a Vibo diverse piccole
raccolte che, comunque, definire collezioni è sicuramente eufemistico. Si trat-
tava, infatti, di nuclei di frammenti raccolti nei cantieri edili della città dopo il
passaggio della ruspa che spianava il terreno lasciando sul campo i resti dei re-
sti. In altri casi erano doni dei costruttori che, dopo essere riusciti ad edificare,
tiravano fuori dalle buste depositate in cantina i trofei del passato. Diversa co-
sa sono le raccolte Albanese, oppure la Cannella o la David: queste ultime due
sono state notificate ma lasciate in custodia presso i collezionisti stessi mentre
la prima, ad un certo punto, è stata consegnata alla direzione del Museo archeo-
logico statale di Vibo Valentia.
Anche queste raccolte, nonostante la consistenza, sono da considerarsi atipi-
che: intanto per il breve lasso di tempo entro il quale si sono formate, e poi per-
ché includono esclusivamente materiali reperiti in loco. Per i numerosi oggetti
della raccolta del sacerdote Francesco Albanese26 è possibile determinare con
esattezza la provenienza in quanto peculiari di un luogo o di un’area con parti-
colari caratteristiche. In molti, infatti, ancora oggi a Vibo Valentia ricordano
monsignor Albanese aggirarsi per i cantieri edili nei pressi della fontana sette-
centesca di Scrimbia, da dove proviene un prezioso cratere a figure rosse ed
una lekythos attribuiti entrambi alla feconda mano del pittore di Berlino o alla
sua cerchia27. Il sacerdote si recava presso detti cantieri dotato di una grossa
sporta dove, dopo esserseli fatti consegnare dagli operai, custodiva i papuni,termine con il quale gli operatori indicavano le statue tubolari di divinità fem-
minili. Questi rinvenimenti, e conseguentemente i recuperi, costituiranno al
momento opportuno il fossile guida per la localizzazione della famosa stipe vo-
tiva di Scrimbia28, che ha restituito migliaia di reperti connessi ad un tempio
non individuato ma sicuramente localizzabile tra via Romei, strada che taglia
alla base la collinetta dove è collocato il “ripetitore”, e la zona sottostante29.
L’ipotesi di lavoro è avvalorata dal fatto che, sempre in questa parte della città,
Paolo Orsi agli inizi del secolo passato aveva portato alla luce resti di un tem-
pietto arcaico30.
L’area viene individuata, soprattutto nelle carte più antiche, con il nome di Con-
tura o Coltura del Castello e lo studioso trentino aveva intuito che la località,
anche per la particolare collocazione topografica era sede, probabilmente, di
un’ulteriore area sacra pertinente alla colonia greca di Hipponion31. In quest’a-
rea lo scavo di Paolo Orsi portò alla luce frammenti architettonici vari ricondu-
cibili ad un piccolo edificio di culto, un naiskos, conservatosi solo parzialmen-
te, di 4,50 X 5,70 metri, mentre ulteriori resti architettonici, attribuibili questa
Rubbettin
o
166
volta a un monumento di proporzioni più vaste, furono individuati dall’archeo-
logo presso il convento dei Cappuccini, dove erano stati reimpiegati nelle strut-
ture conventuali. L’Orsi riportò in luce i resti di un gorgoneion di grandi dimen-
sioni che fungeva da chiusura del coppo di colmo del tetto di un edificio sa-
cro32.
Recentemente i terreni ubicati lungo Via Romei, lottizzati, sono stati oggetto di
indagine archeologica resasi necessaria in seguito a sbancamenti per la costru-
zione di nuove abitazioni. Gli scavi hanno restituito importanti informazioni re-
lative alla presenza dell’area sacra cittadina di epoca greca, confermando che
la zona era riservata ad edifici di culto33.
Monsignor Albanese, proprio sull’onda emotiva dell’interesse nato intorno alle
ricerche archeologiche degli anni Sessanta, ha pubblicato due volumi sulla sto-
ria, l’arte e le tradizioni della città che ancora oggi, nonostante le varie impre-
cisioni ed il tenore non propriamente scientifico ma piuttosto divulgativo, con-
tinuano ad essere utilizzati come base di partenza per le ricerche sul passato
antico della città34. I materiali raccolti dal sacerdote, ad un certo punto, sono
andati ad incrementare quelli già esposti nel Museo archeologico “Vito Capial-
bi”, creando così un valore aggiunto per il museo cittadino.
La genesi delle collezioni Cannella e David è molto diversa tra di loro, sebbene
il denominatore comune possa essere individuato nell’incremento delle ricer-
che archeologiche in città alla fine degli anni Sessanta del secolo appena tra-
scorso.
La raccolta Cannella35 si presenta varia per quel che riguarda la forma dei ma-
teriali, mentre la provenienza è sicuramente da ascrivere a rinvenimenti effet-
tuati nei cantieri edili cittadini e più precisamente nelle aree di necropoli gre-
ca. Anni addietro, sempre nell’ambito dell’“Operazione Emergenza” alla quale
si è fatto cenno in precedenza, la collezione è stata sottoposta a schedatura36.
Dall’analisi dettagliata degli oggetti emerge molto chiaramente che i contesti di
provenienza potrebbero essere individuati nella stipe votiva greca scoperta in
via Scrimbia, nella necropoli occidentale della greca Hipponion37, nel quartiere
S. Aloe, area pertinente all’insediamento di epoca romana con la presenza di
qualche reperto. Altri dati sono desumibili dall’osservazione più attenta dei ma-
teriali: ad esempio è possibile notare che in massima parte i reperti provenienti
da contesti tombali si datano tra il V ed il IV sec. a.C.; si tratta, infatti, di olpaiacrome38, di bolsaal39 a v.n., lekythoi aryballiche, olpai a v.n. Il pezzo più anti-
co sembrerebbe essere un lydion di tipo ionico, ma di probabile produzione lo-
cale40. Sempre pertinenti a sepolture potrebbero essere considerate due piccole
lekythoi di cui una a f.n. ed un’altra a v.n.41. La coroplastica, anche se non nu-
merosissima, sembra riconducibile, come si diceva prima, alla favissa votiva di
Scrimbia. I tipi di statuette sono piuttosto conosciuti anche perché simili agli
esemplari esposti nel museo cittadino. Ad esempio possiamo segnalare il tipo
di statuetta fittile di tipo arcaico che rappresenta una figura femminile con la
capigliatura resa da due trecce, riccioli sulla fronte e grossi orecchini a pasti-
glia applicati alle orecchie; si segnala, inoltre, qualche piccola protome fittile
femminile, un tipo di reperto anch’esso ben conosciuto e rappresentato nel mu-
seo di Vibo dove è definito con il nome improprio di “mascheretta”42. Ci sem-
bra interessante far notare che tra tanto materiale coroplastico, che riproduce
fattezze femminili, esiste una testina fittile dalle sembianze maschili; in parti-
Rubbettin
o
167
colare i tratti somatici indicherebbero le intenzioni dell’artigiano di riprodurre
le fattezze di un filosofo (fig. 7). Il manufatto presenta il volto con un’ampia
fronte stempiata, il viso nel tipico atteggiamento di pensatore ed una corta bar-
ba ben curata. Ancora tra la coroplastica vi è da mettere in evidenza la testa di
un toro pertinente ad una statua più grande, anche questa tipologicamente ben
documentata da Scrimbia (fig. 8).
La presenza di statuette rappresentanti il toro è stata interpretata come il surro-
gato di un animale vero e proprio per il sacrificio: nel momento in cui l’offeren-
te non disponeva di un animale vivo, anche per il prezzo probabilmente molto
alto per il suo acquisto, veniva offerto alla divinità il torello fittile. Tra l’altro
questa testa della collezione Cannella può ritenersi, a ragione, fra le riprodu-
zioni realizzate con maggiore cura, anche perché dalla stipe provengono sta-
tuette il cui modellato appare sommario e poco attento ai dettagli. L’esemplare
della Cannella era stato prodotto con la tecnica della doppia matrice e con i
particolari anatomici, narici, contorno occhi, bocca ecc., rifiniti a stecca43.
Ancora provenienti da Scrimbia pensiamo possano essere i numerosi oggetti
miniaturistici tra i quali notiamo krateriskoi acromi, (fig. 9) anche se non man-
cano minuscole patere umbilicate, e qualche kotyle fabbricata prendendo a mo-
dello quelle prodotte a Corinto in Grecia. Anche le patere umbilicate sono am-
piamente rappresentate nella piccola collezione44 e sono confrontabili con quel-
le provenienti dagli scavi ufficiali ed esposte nel Museo (fig. 10). Spesso questi
oggetti presentavano due forellini in prossimità del bordo; il particolare con-
sente di ipotizzarne un uso in sospensione e cioè applicate ad una parete liscia
oppure agli alberi all’interno del temenos, il recinto sacro. Ancora l’osservazio-
ne attenta dei manufatti ha portato alla scoperta dell’uso del colore che veniva
utilizzato per rendere più gradevoli e forse più visibili, da una certa altezza,
queste patere. Il colore più usato era il rosso porpora o mattone anche se non
manca l’uso di altri colori come, ad esempio, l’azzurro. Due reperti in bronzo
appaiono degni di nota: si tratta di un’applique conformata a testa femminile e
di un’ansa, forse di un grande bacile, o anch’essa un’applique che impreziosiva
un calderone (figg. 11-12). Entrambi i pezzi appaiono in buono stato di conser-
vazione generale, tenuto conto che non hanno subito nessun intervento conser-
vativo da quando sono venuti alla luce.
Per un oscillum – peso da telaio di forma circolare – è difficile indicare la pro-
venienza, mentre sicuramente da contesti funerari provengono le numerose lu-
cerne, di cui qualcuna con evidenti tracce di combustione, che ne attestano un
uso in sepolture ad incinerazione secondaria45; mentre due kylikes attiche, di
cui una su alto piede, sembrano poter essere riconducibili ad ambito sacro.
Se la collezione Cannella è caratterizzata da una certa omogeneità, la David46
si compone, invece, di due settori ben distinti: quello prettamente archeologico
e quello numismatico. Il materiale archeologico risulta essere in qualche modo
assai ripetitivo per le forme, mentre la raccolta numismatica appare molto inte-
ressante per il numero dei pezzi e la varietà tipologica delle monete (fig. 13).
Dovendo dare un giudizio sembrerebbe quasi che nelle intenzioni di chi ha ra-
dunato i reperti ci sia stata, ad un certo punto, la precisa volontà di privilegiare
la raccolta numismatica piuttosto che quella archeologica. Anche per questi
materiali che compongono la collezione è possibile, almeno per la maggior par-
te, individuare i luoghi di provenienza che, orientativamente, sembrano essere
Rubbettin
o
168
quelli canonici della città antica, e cioè le aree sacre e quelle di necropoli. Dal-
le aree sacre ipponiate sembrerebbero provenire alcuni frammenti pertinenti a
statuette fittili femminili. Infatti sono presenti numerosi pezzi riconducibili ad
un unico tipo di statuetta. Si tratta di Demetra con il porcellino e fiaccola a cro-
ce. Il tipo, molto conosciuto nell’antichità, è ben documentato nel santuario del
Cofino dove sono presenti statuette della divinità sia con la fiaccola normale
che a croce. La dea trattiene in braccio, all’altezza dei seni, un porcellino (fig.14).
Demetra così rappresentata è documentata presso il santuario del Cofino, men-
tre non sono attestati esemplari che rappresentano questa divinità in quello di
Scrimbia. Anche l’argilla, giallina ed assai farinosa, sembra indicare la città di
Vibo come luogo per questa produzione coroplastica. I pezzi attualmente ap-
paiono assai consunti anche se è possibile che, già in origine, le matrici fossero
usurate o, come si dice in gergo, “stanche”. Assai ben conservata è, al contra-
rio, una testina fittile femminile che tradisce anch’essa la provenienza dal Cofi-
no, e indica come luogo di produzione la vicina città di Medma (fig. 15). Infatti
la tipica argilla, rossiccia e con molti inclusi micacei e litici, riconduce senza
ombra di dubbio alla consorella Medma – attuale Rosarno – come workshop-of-
ficina, poiché la colorazione dell’argilla e gli inclusi del materiale usato per
modellare il reperto sono tipici della colonia che con Hipponion condivideva
origini, cultura e vicende politiche. Singolare, inoltre, la presenza di una pic-
cola testa che rappresenta in maniera molto puntuale il volto di un personaggio
maschile, riconducibile quasi sicuramente ad un filosofo (fig. 16). Presenta, in-
fatti, la fronte stempiata con evidenti rughe d’espressione, capelli con ai lati
corposi ciuffi, barba molto lunga caratterizzata da profonde incisioni. Sulla nu-
ca un foro che si ritiene possa essere stato praticato in un momento successivo
alla sua realizzazione. Ancora tra la coroplastica si mettono in evidenza due te-
stine fittili: una maschile, l’altra femminile. Si tratta di un suonatore di doppio
flauto e della parte superiore di una statuetta fittile femminile. Per quanto con-
cerne la ceramica possiamo dire che, invece, si presenta piuttosto ripetitiva, in
quanto sono rappresentate un numero considerevole di coppette a vernice nera,
di diversa forma e datazione47; una lekythos a vernice nera di piccole dimensio-
ni che, solo ad un’attenta analisi, si è rivelata a figure nere in quanto per un di-
fetto di cottura, della figura maschile, forse un guerriero in ginocchio, rimane
soltanto la silhouette. Sicuramente dalla stipe Scrimbia proviene un torello mi-
niaturizzato e realizzato in maniera assai accurata (fig. 17). La stipe, molto fa-
mosa per aver restituito materiale di notevole valore artistico, tra le tante pecu-
liarità presenta anche la consuetudine di offrire ad una divinità, non bene iden-
tificata, anche dei tori fittili. Le schedature, condotte nel corso degli anni tra i
reperti immagazzinati nel Museo archeologico, hanno evidenziato la presenza
di diversi tipi e forme: da quelli modellati approssimativamente a quelli realiz-
zati a matrice con particolari rifiniti a stecca. Anche le argille sono molto di-
verse tra di loro e denotano, quindi, una produzione assai diversificata, forse
per soddisfare le richieste che dovevano essere molto numerose48. L’esemplare
della raccolta David costituisce un modellino assai particolare proprio per il ti-
po di lavorazione che, ad un attento esame, si dimostra molto curato49. Ancora
da un’area sacra pensiamo possano provenire alcuni recipienti miniaturizzati:
krateriskoi e hidryskai. Tipologicamente questo materiale50, molto semplice e
pertanto economico ed accessibile a tutti, veniva prodotto in grande quantità
Rubbettin
o
169
proprio per l’uso che ne veniva fatto. Semplice, privo di decorazione e pratico
costituiva il corredo di cui tutti, indistintamente, si potevano dotare per andare
a richiedere benevolenze agli dei51. Dalle necropoli cittadine potrebbero prove-
nire invece alcune lucerne sia acrome che a v. n. e due unguentari lacunosi da-
tabili al III sec. a.C. (fig. 18), forse dall’area cimiteriale di Piercastello52, oppu-
re da quella in contrada Olivarelle53.
Infine quattro piccole lucerne completano il gruppo dei materiali ceramici pre-
senti nella raccolta. Si tratta di oggetti databili ad epoca medievale (fig. 19) e,
tenuto conto del fatto che tutti gli altri manufatti si dispongono in un arco cro-
nologico che va dal periodo greco e quello romano, appare quantomeno anoma-
la la presenza di questi reperti che solo di recente sono stati oggetto di studio
da parte degli archeologi. La forma atipica degli oggetti ed il fatto che si pre-
sentino integri hanno forse incuriosito il collezionista, inducendolo all’acquisto
e quindi all’immissione nella collezione.
Un capitolo a parte meriterebbe la collezione numismatica alla quale il dottore
Francesco David ha dedicato maggiore attenzione. Si tratta di monete, in mas-
sima parte d’argento, riconducibili alla monetazione brettia, ma anche a quella
del periodo romano-imperiale. Non mancano monete in bronzo ascrivibili ai pe-
riodi successivi. Purtroppo, a differenza di quanto accade per i materiali cera-
mici, è molto difficile esprimere giudizi sulla provenienza, in quanto risalire
alla località di rinvenimento appare quasi impossibile. Le uniche ipotesi si ri-
feriscono genericamente ad aree di pertinenza all’epoca greca o romana, anche
se nulla esclude che possano essere state recuperate nel territorio intorno alla
città.
Durante la ricognizione, effettuata ormai quasi quindici anni or sono, è stato
possibile solamente compilare la scheda ministeriale già predisposta allo scopo
ottenendo, quindi, una sintesi della singola moneta, così come richiesto appun-
to dal modello predefinito. Per la verità sarebbe auspicabile uno studio ap-
profondito da parte di un numismatico che, esaminando i materiali nel com-
plesso, potrebbe pervenire ad interessanti conclusioni. E comunque qualora
non fosse possibile raggiungere questi risultati, quantomeno si avrebbero noti-
zie dettagliate sulla singola moneta anche se ormai priva di contesto. Le mone-
te classificate complessivamente ammontano a 52 e, almeno allora, apparivano
in ottimo stato di conservazione.
Mettendo a confronto le due piccole raccolte è possibile notare sostanziali dif-
ferenze. Nella prima esaminata, la Cannella, sono presenti esclusivamente ma-
teriali ceramici mentre la seconda, al cinquanta per cento, include anche re-
perti numismatici. D’altra parte le collezioni, è innegabile, riflettono inevitabil-
mente la personalità di chi mette insieme gli oggetti e le motivazioni che spin-
gono il singolo individuo ad accumulare materiale antico variano da soggetto a
soggetto. Questa riflessione ha però una validità generica e può essere ritenuta
legittima soltanto in linea di massima; nello specifico, per quello che ci riguar-
da, possiamo affermare che è indubbio un forte ascendente esercitato dal pas-
sato antico della città, dalla ripresa delle ricerche, dalla tradizione culturale,
ma anche da una sorta di spirito di emulazione nei confronti dell’archeologo e
studioso ante litteram Vito Capialbi. La storia millenaria del centro antico di
Hipponion e Valentia, con le sue stratificazioni archeologiche, ha suscitato sin-
cero interesse e curiosità nei confronti delle vicende storiche relative alla città
Rubbettin
o
170
e, pertanto, anche per i suoi manufatti che costituiscono, oggi, il segno tangibi-
le e la testimonianza di eventi, situazioni, culture stratificate. Ancora una volta
vi è una sovrapposizione ed un’osmosi tra antico e moderno dove l’antico si con-
cretizza nella passione per il proprio passato ed il moderno è dato invece dai
tempi in cui è possibile esplicitare l’esperienza del collezionismo. Soprattutto
questo tipo di collezionismo tutto concentrato e vissuto nella cittadina di Vibo
Valentia. È ancora “antico” il modo di interessarsi del passato rifacendosi ai
collezionisti ottocenteschi quando esclusivamente i ceti intellettuali calabresi
si occupavano di antichistica pur nella loro scarsa obiettività, determinata so-
prattutto dall’isolamento culturale nel quale erano costretti ad operare. Inizial-
mente la raccolta di reperti archeologici nei terreni dei ricchi possidenti terrie-
ri da parte dei contadini era motivata da una dimostrazione di possesso che,
con malcelato orgoglio, esibivano all’esterno, rappresentando un segnale con-
creto e tangibile del proprio potere. Così erano nate le prime collezioni, quelle
collezioni ottocentesche servite spesso da stimolo per l’apertura dei musei ca-
labresi54.
Appendice Documentaria
Qui di seguito vengono proposti alcuni documenti custoditi presso l’Archivio
Centrale dello Stato di Roma a completamento e commento di circostanze ri-
chiamate nell’articolo55.
Il carteggio riguarda la collezione Capialbi ed i tentativi di acquisto da parte di
alcuni soggetti pubblici – Museo di Napoli e di Reggio Calabria – per conto,
entrambi, dello Stato.
Scorrendo alcuni di questi atti e decifrando, spesso faticosamente, il linguaggio
burocratico e la scrittura vergata a mano da alcuni dei protagonisti – il ministro
Corrado Ricci56, il soprintendente Paolo Orsi57, l’ispettore archeologo Ettore
Gabrici58 ed il Soprintendente napoletano Spinazzola59 – abbiamo la sensazio-
ne che l’intera collezione non si trovi a Napoli solo per lungaggini burocrati-
che. In realtà il mancato frazionamento della storica raccolta si deve, invece,
alla tenacia di Paolo Orsi, allora Soprintendente a Siracusa con delega sulla
Calabria, alla sua autorevolezza ed alla sua concezione moderna dell’archeolo-
gia. Dalla lettura della documentazione si intuisce, dietro le parole misurate e
di circostanza dei protagonisti, una sorta di rivalità discreta, che mette spesso
in risalto un aspetto ed un problema che condiziona pesantemente ancora oggi
le amministrazioni periferiche dello Stato: la mancanza di finanziamenti utili
per la buona gestione e la fruizione dei beni culturali in genere, sia che si tratti
di aree archeologiche, di restauri di dipinti, o ancora di acquisizioni di oggetti
antichi da privati.
Nel documento n.1, spedito da Siracusa il 4 marzo del 1911, Paolo Orsi riassu-
me la questione “Capialbi” e chiede, in maniera garbata ma determinata, la pe-
rizia redatta anni addietro dall’ispettore Gabrici60 e perora la causa dell’acqui-
sizione delle monete per il Museo Regionale Calabro che, essendo stato depre-
dato, non possedeva una raccolta numismatica61.
In riferimento a questa richiesta il ministro Corrado Ricci scrive – documenti
nn. 2 e 3 – sia al Soprintendente ai Musei e agli scavi d’Antichità di Napoli che
Rubbettin
o
171
al Soprintendente ai Musei e agli scavi di Antichità di Siracusa. Al primo solle-
cita il reperimento dell’inventario degli oggetti della collezione, mentre con il
secondo si congratula per il meritevole progetto intrapreso.
L’educata risposta dello Spinazzola – documento n. 4 – andava, però, in un’al-
tra direzione: dopo aver puntualizzato che non si trattava di un inventario né
tantomeno del catalogo – quasi a sminuirne l’importanza e la consistenza – il
Soprintendente napoletano evidenziava come si trattasse, in realtà, di un reso-
conto approntato da quell’amministrazione e finalizzato all’acquisizione, per
conto del Museo Nazionale di Napoli, di un lotto di materiali che interessava il
suddetto Museo dopo le trattative intercorse con un erede dello studioso otto-
centesco.
Non avendo avuto riscontro, Paolo Orsi inviò al Ministro un’altra breve missiva
– documento n. 5 – nella quale, come sua consuetudine e da perfetto uomo del-
lo Stato, evidenziava l’aspetto pratico finalizzato a risparmiare le energie già
impiegate dall’Ispettore Gabrici, precisando che sollecitava l’invio della peri-
zia per la terza volta62.
Il ministro Ricci, però, comportandosi da politico, se in un primo momento si
congratula con Paolo Orsi a proposito della sua intenzione di acquisire per con-
to dello Stato la collezione Capialbi, ad un certo punto, senza prendere in con-
siderazione quella che poteva essere la soluzione più congrua per questi mate-
riali, sostiene la causa del Museo napoletano e dello Spinazzola dichiarando, in
una lettera indirizzata ad Orsi – documento n. 6 – , che quel Museo per primo
aveva intrapreso le trattative per acquistare una parte della collezione. Pertan-
to qualora la trattativa dell’Orsi fosse andata a buon fine, quest’ultimo doveva
tenere in considerazione l’esigenza dell’istituzione napoletana.
Quindi ad un primo riscontro positivo, da parte del ministro, a far confluire la
raccolta nel costituendo Museo Reggino della Magna Grecia, seguono una se-
rie di ripensamenti dovuti alle formali ma caparbie osservazioni dello Spinaz-
zola a proposito del fatto che i reperti dovevano essere acquisiti per il Museo
di Napoli visto che erano stati loro, i napoletani, ad intraprendere per primi le
contrattazioni. Ma Orsi non demorde e con la testardaggine che lo contraddi-
stingue – mutuata forse dai calabresi con i quali aveva quotidianamente a che
fare – scrive ancora al Ministro dell’Istruzione Pubblica Direzione Generale An-tichità e Belle Arti – documento n. 7 – mettendo in chiaro subito che il suo com-
portamento era stato legittimato dall’autorizzazione concessa dal Ministro, e
pertanto il tentativo del direttore del Museo di Napoli di selezionare alcuni tra
gli oggetti più importanti – monete e bronzi – per la propria istituzione non ave-
va ragione di essere. L’archeologo trentino osserva, inoltre, che gli eredi Ca-
pialbi avevano espressamente manifestato la volontà di una cessione dell’im-
portante raccolta in blocco e che ad ogni modo non avrebbe avuto senso desti-
nare a Napoli i pezzi migliori della collezione penalizzando così pesantemente
Reggio Calabria.
Orsi richiama inoltre alla memoria del Ministro la Legge 386 del 27 giugno
1907 che «istituiva le Soprintendenze ed i musei regionali allo scopo di racco-
gliere e studiare i materiali delle regioni»63.
La partita si giocava tra Napoli e Siracusa, cioè tra Spinazzola e Orsi, perché il
ministro Ricci, almeno dalla lettura delle carte, appare come un semplice arbi-
tro al quale più che altro sta a cuore che tutto venga fatto nel pieno rispetto del-
Rubbettin
o
172
la prassi burocratica, così come si evince dal telegramma espresso di Stato che
viene inviato dallo stesso Ricci allo Spinazzola per sollecitare l’invio del fami-
gerato inventario del Gabrici – documento n. 8.
Questa posizione si arguisce ulteriormente da due brevi successive missive,
inviate al Soprintendente Orsi, nelle quali Ricci ribadisce che non esiste un
inventario completo della raccolta neppure presso il Ministero – documento n.
9 – e, con una decisione salomonica, dopo averne considerato le osservazioni
ribadisce al Soprintendente Orsi di continuare nella trattativa, mentre relati-
vamente alla situazione prospettata dallo Spinazzola, riferisce che «a suo tem-
po sarà interpellato il consiglio superiore per le antichità e belle arti» […].Ma quasi undici anni prima dell’avvio del carteggio appena commentato, tra Or-
si, Spinazzola ed il ministro Ricci, in una lettera al cui oggetto si legge Venditadella collezione Capialbi, il direttore Petra relaziona al ministro dell’arrivo a Na-
poli degli eredi Capialbi, «parenti di quel Capialbi amante delle patrie anti-
chità» –, che aveva messo insieme una cospicua raccolta di materiali, costituita
da circa 3500 monete ma anche da vasi, bronzi figurati, iscrizioni e pietre inci-
se – con l’intenzione di cedere, dietro pagamento, la collezione dell’avo. Tenuto
conto dell’importanza della suddetta raccolta viene prospettata l’ipotesi di una
vendita all’estero dei reperti. Se Petra aveva espresso questo timore è logico im-
maginare che i discendenti dello studioso monteleonese avevano paventato que-
sta eventualità; pertanto, in relazione a questo pericolo veniva suggerito l’invio
a Monteleone di un funzionario in grado valutare il valore commerciale dell’in-
tera collezione – documento n. 11. In una missiva di luglio – documento n. 12
– è ancora Petra a rivolgersi al ministro per metterlo al corrente del fatto che
l’ispettore Gabrici aveva compiuto un sopralluogo presso gli eredi dello studio-
so e, in particolare, li aveva interpellati a proposito delle intenzioni di cedere
allo Stato soltanto una parte dei materiali, quelli ritenuti più interessanti, in
quanto il Museo di Napoli non aveva le risorse finanziarie per acquisire tutti gli
oggetti. Ma soprattutto era stato stilato un sommario inventario degli oggetti no-
tevoli in seguito alla ricognizione effettuata dal Gabrici – documento n. 1364.
Del 7 agosto è una missiva – documento n. 14 – a firma del direttore Sogliano,
il quale riferisce al ministro di aver domandato ai Capialbi se erano disponibili
alla vendita parziale della collezione e di avere ottenuto risposta negativa «af-
finché essa continui a rimanere unita sotto il nome del loro avo».
Il ministro, in una lunga lettera datata 6 settembre ed indirizzata al direttore
degli scavi di Napoli – documento n. 15 – , articola una serie di osservazioni
nel tentativo di trovare una soluzione alla controversa questione “Capialbi” e,
prendendo a pretesto l’art. 3 del Regio Decreto del 13 maggio 1832 in vigore
nelle regioni meridionali, ricorda al Direttore del Museo che non è possibile
per gli eredi Capialbi alienare alcuno degli oggetti ritenuti di notevole valore
ed inseriti nel catalogo compilato dal Gabrici e cioè: Protome d’ariete in bron-
zo, quattro statuette arcaiche sempre in bronzo, la statuetta di giovane su te-
stuggine, la figura di leone, l’iscrizione osca a Giove Versore, lo scarabeo con
la figura di Perseo. «Può darsi che in seguito a tale vincolo i Signori Capialbi si
decidano a vendere i detti oggetti separatamente dalla intera raccolta […]».
Questa strategia intimidatoria, messa in atto dal ministro, doveva teoricamente
indurre gli eredi ad una trattativa con il Museo napoletano al fine di raggiunge-
re lo scopo prefissato.
Rubbettin
o
173
Due guerre e varie vicende contingenti hanno impedito la soluzione del proble-
ma; ad esclusione della laminetta di Giove Versore di tutti gli altri bronzi si so-
no perse le tracce e dovranno trascorrere cinquant’anni prima che il sogno di
Paolo Orsi si possa avverare. E poco male se gli oggetti della collezione non so-
no andati al Museo di Reggio Calabria. Sono rimasti a Vibo Valentia in un Mu-
seo dedicato opportunamente proprio al conte “rigattiere di memorie” come
qualcuno lo ha definito di recente65. Sono rimasti a Vibo in un Museo che, iro-
nia della sorte, si trova a pochissimi passi dalla casa dove Capialbi li aveva cu-
stoditi amorevolmente, forse pensando prima o poi di metterli a disposizione
dei vibonesi.
Documento 1
Rubbettin
o
175
Documento 2 l R. Soprintendente ai Musei e agli scavi d’antichità Napoli,
addì 30 marzo 1911
Oggetto: raccolta antiquaria Capialbi in Monteleone Calabro
Il R. Soprintendente ai Musei e agli scavi di antichità per la Calabria ha propo-
sto a questo ministero l’acquisto della pregevole raccolta numismatica ed ar-
cheologica della famiglia Capialbi di Monteleone Calabro. Egli per iniziare le
trattative di acquisto di quella raccolta, desidera che gli sia inviato il catalogo
completo compilato dall’ispettore Gabrici or sono alcuni anni, per conto della
Direzione del museo di Napoli. Prego quindi la S.V. di mandare al nominato So-
printendente prof. Paolo Orsi in Siracusa il detto catalogo.
Il ministro Ricci
Rubbettin
o
176
Documento 3Al R. Soprintendente ai Musei e agli scavi d’antichità Siracusa
addì 30 marzo 1911
Oggetto: raccolta antiquaria Capialbi in Monteleone Calabro
Comprendo la importanza che ha la raccolta antiquaria della famiglia dei conti
Capialbi di Monteleone Calabro e, dalle ragioni da S.V. esposte si rileva l’uti-
lità che quella raccolta arrecherebbe al Museo di Reggio.
Consento quindi che la S.V. inizi le trattative colla famiglia per il relativo ac-
quisto, ed intanto ho invitato la direzione del Museo di Napoli a mandarle in
esame il catalogo degli oggetti compilato dall’ispettore Dott. Gabrici. A suo tem-
po attenderò le proposte di V.S. per sottoporle al parere del Consiglio Superiore
per le antichità e belle arti.
Il ministro Ricci
Rubbettin
o
179
Al R. Soprintendente dei Musei e agli scavi Siracusa
Roma addì 24 aprile 1911
Oggetto: raccolta antiquaria Capialbi in Monteleone Calabro
Il Soprintendente dei Musei e degli Scavi in Napoli mi ha avvertito di avere in-
viato alla S.V. la relazione dell’ispettore Prof. Gabrici sulla collezione antiqua-
ria Capialbi di Monteleone Calabro.
Egli fa notare che quella relazione fu compilata per servire all’acquisto, a favo-
re del Museo Nazionale di Napoli, di alcuni oggetti indicati nell’elenco qui uni-
to. E aggiunge il medesimo Soprintendente che le trattative d’acquisto degli og-
getti elencati ebbero lungo corso e si chiusero con una lettera del Capialbi, nel-
la quale egli chiedeva alla direzione del Museo di Napoli quali oggetti credesse
necessari alle raccolte napoletane; e con una risposta della direzione medesi-
ma, in cui venivano indicati i detti oggetti. Il nominato Soprintendente quindi,
dati questi precedenti, non dubita che procedendosi all’acquisto della raccolta
Capialbi, gli oggetti notati nell’elenco, e per i quali si era entrati in trattative
vengano destinati al Museo Nazionale di Napoli.
Prego quindi la S.V. di tener presente quanto sopra, qualora l’acquisto della
raccolta Capialbi abbia a verificarsi.
Il ministro Ricci
Documento 6
Rubbettin
o
183
Telegramma espresso di Stato
Oggetto: raccolta antiquaria Capialbi in Monteleone Calabro
Soprintendente Musei e Scavi di Napoli
Urge avere inventario Gabrici raccolta Capialbi di Monteleone, chiesto alla S.V.
con lettera 30 marzo decorso. Prego inviarlo con cortese sollecitudine al So-
printendente Prof. Orsi in Siracusa.
Il ministro Ricci
Documento 8
Rubbettin
o
184
Al R. Soprintendente per i Musei e gli scavi Siracusa
Oggetto: Monteleone Calabro Collezione Capialbi
Urgente
Con nota del 27 aprile 1911 9503 partecipai alla S.V. che il Soprintendente per
i musei e per gli scavi in Napoli avea avvertito questo ministero di aver …….la
relazione dell’Ispettore prof. Gabrici sulla raccolta Capialbi di Monteleone Ca-
labro, ed ella già deve averla ricevuta.
Il medesimo Soprintendente poi mi ha avvertito che non fu mai compilato un
inventario né il catalogo completo di quella raccolta; una perizia qualsiasi di
essa non esiste neppure presso questo Ministero.
Il ministro Ricci
Documento 9
Rubbettin
o
185
Al R. Soprintendente per i musei e gli scavi Siracusa
Oggetto: Raccolta antiquaria Capialbi Monteleone Calabro
Ho considerato le osservazioni fatte dalla S.V. relativamente alla raccolta anti-
quaria Capialbi di Monteleone Calabro: Intanto Ella proceda alle trattative di
acquisto dell’intera raccolta e sulla questione mossa dal direttore del Museo
nazionale di Napoli, sarà a suo tempo interpellato il Consiglio Superiore per le
antichità e per le belle arti.
Il ministro Ricci
Documento 10
Rubbettin
o
186
Napoli 18 giugno 1900
Oggetto: Vendita della Collezione Capialbi
A S.E. Il Ministro della Istruzione Pubblica
Direzione Generale antichità e Belle Arti Roma.
Si sono presentate a questa Direzione i Signori Capialbi di Monteleone di Cala-
bria, eredi di quel Vito Capialbi che verso la metà del nostro secolo fu cultore
di studi archeologici e dai suoi contemporanei avuto nella debita stima. Aman-
te delle patrie antichità, il Capialbi era riuscito a formarsi una cospicua raccol-
ta di oggetti antichi e monete, che gli eredi hanno dichiarato di voler alienare.
Da cataloghi sommari, che questi hanno mostrato, e dalle notizie, che per boc-
ca loro ho raccolte, il piccolo Museo Capialbi contiene una collezione di circa
3500 monete rappresentanti il nucleo più importante dell’intiera raccolta, una
serie di bronzi figurati di vasi greci, di iscrizioni e pietre incise.
Parecchi di questi oggetti e monete furono già pubblicati ed illustrati dal primo
possessore, ed oggi sono conosciuti dai dotti sotto il nome di lui.
Data l’importanza di tale raccolta di antichità, io mi permetto di richiamare su
di essa tutta l’attenzione dell’E.V. affinché gli odierni possessori non abbiano a
venderla a negozianti esteri.
E perché l’E.V. possa avere un concetto più o meno preciso di tale cospicua rac-
colta, sarebbe opportuno che inviasse sopra luogo un funzionario, incaricato di
studiarne l’importanza ed il valore commerciale.
Il direttore Petra
Documento 11
Rubbettin
o
189
Direzione dei Musei e scavi di antichità in Napoli
Relazione intorno al Museo Capialbi.
A S.E. il Ministro della Pubb. Istr.
Direzione Generale per le Antichità e belle Arti Roma.
Mando a V.E. la qui acclusa relazione intorno al piccolo Museo del Conte Vito
Capialbi di Monteleone di Calabria, scritta dal prof. Gabrici, al termine della
missione, che egli ha compiuta lodevolmente, dietro mio incarico. Nel medesi-
mo tempo Le partecipo di avere già interrogato il Capialbi, se intenda vendere
solo quegli oggetti, che questo Istituto presceglierebbe, in base alle proposte
fatte dal prof. Gabrici, poiché assolutamente non è possibile spendere una in-
gente somma per l’acquisto della intera raccolta.
Il direttore Petra
Documento 12
Rubbettin
o
190
Direzione dei Musei e scavi di antichità in Napoli
Illustrissimo Signor direttore del Museo Nazionale di Napoli
Adempio il gradito ufficio di riferire a V.S. sul risultato della missione, da me com-
piuta a Monteleone di Calabria, dove mi recai nei passati giorni, per esaminare
gli oggetti antichi e le monete che formano la collezione del conte Vito Capialbi.
Questa collezione comprende un certo numero di vasi figurati, bronzi, vetri, iscri-
zioni, monete e pietre incise. Tralasciando di parlare degli oggetti di secondaria
importanza, mi limiterò a fare una sommaria descrizione dei più rilevanti.
VASI. Nella serie dei vasi non vidi nulla di notevole; richiamò la mia attenzio-
ne solo un aryballos alto 5 centimetri privo del collo, e fatto di un impasto di
terra nerastra. Su di esso vedesi a rilievo figurato un mostro alato, finente in co-
da di pesce, di stile arcaico. Questo vasettino può essere prodotto della M.Gre-
cia e non è necessario ricorrere all’idea di una importazione dall’Etruria.
Il maggior numero di vasi di questa raccolta consiste in piccole lekythoi attiche
alte dai 12 ai 22 centimetri, a figure nere col contorno graffito. La produzione di
questi vasi nell’Attica era abbondante e destinata al commercio di esportazione
verso molti paesi del mondo antico. Altri piccoli vasi di fabbrica campana o luca-
na, molto comuni e di epoca tarda non meritano alcuna speciale menzione.
BRONZI. Fra i bronzi invece richiamano l’attenzione alcune statuette arcaiche
e qualche figura di animale. Primeggia fra tutti la protome di un ariete di stile
arcaico, di esecuzione molto accurata e di disegno perfetto. È lunga cm. 10 e
mezzo e rappresenta l’animale col capo rivolto in giù e gli arti anteriori ripiega-
ti quasi come se fosse nell’atto di correre a precipitosa fuga. Il pezzo metallico
presenta saldature di piombo a due parti, cioè sulla testa e alla parte dove il
corpo è troncato.
Il suo atteggiamento concitato e gli avanzi della saldatura rendono possibile la
ipotesi, che fosse destinato ad ornare la parte anteriore del bracciale di qual-
che trono.
Seguono per importanza quattro statuette anch’esse arcaiche. La prima alta cen-
timetri 9,1/2 rappresenta una figura muliebre in piedi, che porta in avanti le
braccia ed è vestita di chitone. Le pieghe di questo sono aderenti al corpo e la
chioma è racchiusa in una fitta retina, ornata di stellette, come vediamo spesso
rappresentato il capo di Kora sugli antichi tetradrammi di Siracusa. La seconda
(alta cm. 10) è una figura maschile, con piccole ali alle calcagna, le braccia di-
stese in direzione opposta e il capo rivolto in su. È notevole che dietro alle brac-
cia, per tutta loro lunghezza ha le ali, con cui è per spiccare il volo. La figura è
di certo di un Eros adulto. La terza statuetta alta cm. 18, 1/2 rappresenta una
figura muliebre (Afrodite) collocata sopra una base circolare. È coperta di chi-
tone e manto sovrapposto. Col braccio sinistro si solleva un lembo della veste,
ed ha l’antibraccio destro in avanti con la palma della mano rivolta in giù. È da
notare lo stile arcaico di questa figura che posa su entrambe le calcagna ed ha
la parte superiore del braccio destro aderente al busto.
La quarta è una figura maschile con barba acuminata in piedi, ha il braccio de-
stro abbassato con la palma della mano in avanti, ed il sinistro sollevato, come
per lanciare qualcosa.
Sono a notare altresì alcune statuette formanti manici di specchi, quasi tutti gre-
che, di stile arcaico. La migliore fra tutte è alta cm. 25 e rappresenta una figura
maschile nuda in piedi sopra una testuggine con le braccia in avanti. Lo stile è
Documento 13
Rubbettin
o
191
arcaico, il corpo è lungo e svelto e i capelli calamistrati. Questo è senza dubbio
uno dei migliori bronzi della collezione. È ammirevole per la conservazione e
per lo stile severo ed arcaico una piccola figura di leone, lunga centimetri 9, con
gli arti anteriori abbassati, come per spiccare un salto, e la bocca aperta. Vi è
poi un numero considerevole di piccoli bronzi consistenti in fibule, maschere di
Sileni, animali, chiavi, punte di lance, tripodi serventi di base ad oggetti di bron-
zo, anelli, ecc. Merita di essere ricordata fra questi una bellissima maschera di
Sileno a bocca aperta, di bello stile meravigliosamente modellata e saldata ad
un’altra protome muliebre, che le sta sotto il mento. Entrambe sono armonica-
mente congiunte. L’uso di questo pezzo ci viene indicato dallo scalda vivande
pompeiano di questo Museo, che ad un certo punto ha una maschera di Sileno
somigliantissima a questa; se non che qui vi è aggiunta la protome muliebre.
VETRI. In questo genere di monumenti la collezione Capialbi è scarsa ma pu-
re sono da ammirare due vasettini greci di vetro bleu, intarsiati di disegni geo-
metrici fatti con vetro di colore giallo e celeste.
MONETE. Numerosa, relativamente alle altre serie di questo piccolo Museo, è
la raccolta delle monete, che ammontano a circa 4000 e comprendono le roma-
ne, le greche dell’Italia e della Sicilia, le bizantine, le medioevali, le moderne.
Fra le monete le romane, medioevali, e moderne non v’è nulla di notevole. Pre-
gevole invece è la serie di monete della Magna Grecia, nella quale si trovano
rappresentate alquanto largamente le zecche di Hipponium e di Vibo Valentia,
di Mesma, Terina Rhegium, Croton, Metapontum, Thurio e in generale le zec-
che delle città appartenenti all’antico Bruttium. Questa specialità del medaglie-
re Capialbi trova la sua spiegazione nel fatto che il suo raccoglitore aveva stan-
za nel territorio dove anticamente circolarono a preferenza le monete delle indi-
cate città. Onde accade spesso di notare che un tipo monetale sia rappresentato
in notevoli esemplari, alcuni di una rara conservazione. Non mancano in queste
serie le monete rare, come a dire i didrammi di Thurium con la firma dell’arti-
sta [per la trascrizione cfr. documento originale] bronzi di Mesma con la testa
della ninfa, di prospetto, i didrammi di Metaponto del quarto secolo, con la te-
sta di Apollo e la leggenda [per la trascrizione cfr. documento originale] sotto il
collo, nonché quello con la testa muliebre accompagnato dalla legenda NIKA
ed altre monetine, che qui non è il caso di citare. Ma se da una parte diciamo di
essere compresi, fra le monete greche, dei pezzi rari e di ottima conservazione,
non possiamo tacere che grandissimo è il numero dei pezzi comuni e logori.
ISCRIZIONI. Le varie epigrafi greche e romane furon pubblicate dapprima dal
Capialbi nell’opuscolo intitolato Specimen inscriptionum Vibonensium, poscia
dal Momsen nel vol. X del Corpus e del Kaibel nelle Inscriptiones graecae Si-
ciliane et Italiae. Merita speciale menzione la seguente epigrafe osca scritta in
caratteri greci su laminetta di bronzo lunga cm. 9 con due fori alle estremità:
[per la trascrizione cfr. documento originale]
Questa iscrizione, pubblicata anche essa per la prima volta dal Capialbi, ripor-
tata dal Momsen in Unteritalischer Dialekte pag. 191 Taf. XII n.37, è di una
singolare importanza ed è certamente una delle cose più interessanti dell’intera
raccolta.
PIETRE INCISE. L’archeologo Capialbi aveva raccolto anche buon numero di
pietre incise, di diverse qualità, provenienti dai dintorni di Monteleone. Quasi
tutte sono di arte romana e di bassa epoca; solo una mi è parsa molto interes-
Rubbettin
o
192
sante, non tanto per la rappresentazione, quanto per la leggenda che l’accom-
pagna. È uno scarabeo di finissima corniola, sotto la cui base è incisa la figura
di Perseo che tiene nella sinistra la testa di Gorgone, nell’altra abbassata l’har-
pe, intorno leggesi in caratteri greci arcaici [per la trascrizione cfr. documentooriginale]. Il lavoro è pregevole.
Ecco così, in breve, esposto a V.S. il risultato del mio esame intorno alle anti-
chità della collezione Capialbi. In essa sono al certo cose non dispregevoli da-
gli studiosi di arte e di antichità; anzi io credo necessario richiamare l’attenzio-
ne di V.S. sopra la protome d’Ariete, le quattro statuette arcaiche di bronzo, la
statuetta anch’essa di bronzo, rappresentante la figura virile nuda sulla testug-
gine, la figura di leone e principalmente l’iscrizione osca a Giove versore e lo
scarabeo con la figura di Perseo. Fra le monete sarebbero pure degli esemplari
degni di essere gelosamente custoditi nel medagliere di questo Museo. Ma è a
temere che gli odierni possessori del piccolo museo descritto pretendano di ven-
derlo com’è, e non siano disposti a privarlo delle cose migliori. Sarebbe perciò
opportuno, che Ella li interrogasse in proposito, prima di far loro alcuna offer-
ta, circa il valore venale delle loro antichità.
Ettore Gabrici
Rubbettin
o
203
Direzione dei Musei e scavi di antichità in Napoli
Oggetto: Museo Capialbi
A S.E. il Ministro della Istruzione Pubblica
Direzione Generale Antichità e belle Arti Roma.
Nella mia nota del 29 luglio con la quale trasmisi a V.E. la relazione del prof.
Gabrici intorno alla raccolta della famiglia Capialbi, di Monteleone partecipa-
vo altresì a V.E. di avere invitato i possessori a dichiarare, se intendessero ven-
dere solo una parte della suddetta raccolta, riserbandomi la facoltà di scegliere
quegli oggetti e monete, che potessero utilmente accrescere la suppellettile
scientifica di questo Museo. Al mio invito hanno già risposto i Signori Capialbi,
manifestando il desiderio di vendere tutta intera la loro raccolta, affinché ella
continui a rimanere unita sotto il nome del loro avo.
Tanto avea il debito di riferire.
Il direttore
A. Sogliano
Documento 14
Rubbettin
o
205
Al Direttore del Museo Nazionale e degli Scavi Napoli
Oggetto: Raccolta antiquaria Capialbi
Poiché i Signori Capialbi non vogliono addivenire ad un accordo con questo mi-
nistero, rifiutando di vendere quei soli oggetti della loro raccolta antiquaria, e
questi potrebbero utilmente accrescere la suppellettile scientifica di questo
Museo Nazionale, non rimane altro a fare che ad applicare la legge. Quindi la
S.V. vorrà partecipare ai Signori Capialbi che a temere dell’articolo 3 del R. de-
creto 13 maggio 1822, tuttora vigente nelle province meridionali, non possono
essere asportati od alienati gli oggetti seguenti, indicati come i più importanti
nel catalogo redatto dal prof. Gabrici, per ordine della S.V.
1. Protome d’ariete, in bronzo; 2. le quattro statuette arcaiche di bronzo; 3. la
statuetta rappresentante una figura virile, ignuda, sulla testuggine; 5. La figura
di leone; 6. L’iscrizione osca a Giove Versore; 7. Lo scarabeo con la figura di
Perseo.
Può darsi che in seguito a tale vincolo i signori Capialbi si decidano a vendere
i detti oggetti, separatamente dalla intera raccolta. In caso contrario per conci-
liare la cosa vegga la S.V. se le riuscisse di ottenere in dono la iscrizione osca,
documento di somma importanza per l’epigrafia italica e una delle statuette ar-
caiche facendo capire che in seguito a detto dono questo Ministero potrebbe
permettersi la vendita di tutti gli altri oggetti della collezione.
Voglio credere che i Signori Capialbi non opporranno un rifiuto a tale proposta
e lascio alla S.V. di trattare la cosa con tutta prudenza e con ogni cautela.
F. Fiorilli
Documento 15
Rubbettin
o
212
Bibliografia
ALBANESE F., Vibo Valentia nella sua storia, I-II, Vibo Valentia Grafica Calabrese, Vibo Valentia
s.d. [1975].
ALIBRANDI T.-FERRI P., I Beni culturali ed ambientali, Giuffrè, Milano 1985.
ARIAS P.E., “Bronzetti inediti di provenienza italiota”, in «Crd’A», 1940.
ID., Cinquant’anni di ricerche archeologiche sulla Calabria (1937-1987), Marra, Rovito 1988.
BARBATI C., CAMMELLI M., SCIULLO G. (a cura di), Il diritto dei beni culturali, il Mulino, Bologna
2003.
BARBIERI G., “Due vasi del pittore di Berlino da Vibo Valentia”, in «Bollettino d’Arte», 15, 1982,
anno LXVII, serie VI, pp. 61-66.
BARRA BAGNASCO M., Protomi in terracotta da Locri Epizefiri. Contributo allo studio della scultu-ra in Magna Grecia, Il Quadrante, Torino 1986.
BARRA F., L’amministrazione degli spazi locali: Dal decennio francese all’Italia liberale, in BEVI-
LAQUA P., Storia della Calabria 4, Dal 1650 al 1900, Laterza, Roma-Bari 2001.
BENCIVENNI M.-DALLA NEGRA R.-GRIFONI P., Monumenti e istituzioni. Parte prima. La nascitadel servizio di tutela dei monumenti in Italia: 1860-1880, Ministero per i Beni culturali ed
ambientali e architettonici per le province di Firenze e Pistoia sezione didattica, Alinea, Fi-
renze 1987.
BONOCORE M., “Note di epigrafia latina vibonese”, in «Klearchos», XXVI, 1984, pp. 53-71.
CRIMACO L.-PROIETTI L.M., “Vibo Valentia necropoli in località Piercastello”, in «ASNP», n.s.,
II, XIX, 2, 1989, pp. 787-810, tavv. CXII-CXIX.
D’AGOSTINO B., Le strutture antiche del territorio, in C. De Seta (a cura di), Storia d’Italia, Einau-
di, Torino 1985.
D’ANDREA M., “Necropoli occidentale di Hipponion”, in «ASNP», serie III, vol. XIX, Pisa 1989,
p. 785, Tavv. CVIII e CX.
D’ANDREA M., Hipponion città greca d’occidente, Storia, archeologia, Miti, Apoikia, Vibo Valen-
tia 2002.
FOTI G., “Museo archeologico Statale di Vibo Valentia”, in «Invito al Sud», 1973.
GARGANO G., La collezione numismatica “Vito Capialbi” di Vibo Valentia, in SETTIS S.-PARRA C.
(a cura di), Magna Graecia, Archeologia di un sapere, Electa, Napoli 2005.
IANNELLI M.T.-GIVIGLIANO G.P., “Hipponion-Vibo Valentia la topografia (carta archeologica)”, in
«ASNP», s. III, XIX, 2, 1989, pp. 627-681.
IANNELLI M.T.-CERZOSO M., Stipi votive nella sub-colonia di Hipponion: l’area sacra alla CavaCordopatri, in COMELLA A.-MELE S. (a cura di), Depositi votivi e culti dell’Italia antica dall’età ar-caica a quella tardo repubblicana, Edipuglia, Bari 2005.
ISINGS C., Roman Glass from dated Finds, Archaeologica traiectina, Gröningen-Djakarta 1957.
LATTANZI E., Problemi della chora coloniale dall’occidente al Mar Nero, Atti del quarantesimo
convegno di studi sulla Magna Grecia, Taranto 29 settembre-3 ottobre 2000.
ORSI P., Le chiese Basiliane della Calabria, Vallecchi, Firenze 1929.
ID., Monteleone Calabro. Nuove scoperte, Notizie degli Scavi di Antichità, 1921.
PAOLETTI M. (a cura di), Vito Capialbi. Scritti, Sistema bibliotecario Vibonese, Vibo Valentia 2003.
ID., “Il giornale degli scavi di Monteleone”, in «ASNSP», s. III, vol. XIX, 2, 1989, pp. 499-500,
Tav. XIV.
ID., “Medaglie, monete e vasi di gran pregio”, la collezione Capialbi di Vibo Valentia, in SETTIS S.-
PARRA M.C. (a cura di), Magna Grecia, archeologica di un sapere, Electa, Napoli 2005.
PROCOPIO G., “Il Medagliere della Collezione Capialbi a Vibo Valentia Catanzaro”, in «AnnIst-
Num II», 1955.
PUCA A., La Calabria nel decennio francese, in PLACANICA A. (a cura di), Storia della Calabriamoderna e contemporanea, Il lungo periodo, Gangemi, Roma-Reggio Calabria 1992.
RAMONDINO F., Mons. Francesco Albanese, in FLORIANI G.-LUCIANO G.-NAMIA G. (a cura di), Um-berto Zanotti Bianco e la provincia di Vibo Valentia, Monteleone, Vibo Valentia 2005.
ROMANO M.A. (a cura di), L’Archeologia di Paolo Orsi a Monteleone Calabro 1912-1915, Quale-
cultura, Vibo Valentia 2006.
SABBIONE C., Hipponion il deposito votivo in località Scrimbia, in LATTANZI E. (a cura di), Santua-ri della Magna Grecia in Calabria, Electa, Napoli 1996.
ID., Ceramica a v.n., in AA.VV., Locri Epizefiri I, Sansoni, Firenze 1977.
ID., “Ricerche archeologiche a Locri e nelle sue subcolonie”, in «ACT», 1978, Taranto 1979.
SETTIS S., Capialbi Vito in Dizionario Biografico degli Italiani, Enciclopedia Italiana, Roma 1975,
vol. XVIII, pp. 52-525.
ID., Archeologia in Calabria, Gangemi, Roma-Reggio Calabria 1987.
Rubbettin
o
213
SPADEA R. , Archeologia e percezione dell’antico, in BEVILACQUA P.-PLACANICA A. (a cura di), Sto-ria d’Italia, Le regioni dall’unità a oggi, La Calabria, Einaudi, Torino 1985.
ZUNTS G., Persephone. Three Essays on Religion and Thought in Magna Grecia, Oxford 1971.
1 Sulla figura di Vito Capialbi si veda innanzi tutto S. SETTIS, Capialbi Vito in Dizionario Biogra-fico degli Italiani, Roma 1975, vol. XVIII, pp. 52-525; dello stesso autore, la raccolta di scritti
calabresi, Archeologia in Calabria, Gangemi, Roma-Reggio Calabria 1987, pp. 13-23. Recentis-
simo, il lavoro pubblicato su impulso del Sistema bibliotecario Vibonese e curato da M. PAOLETTI
dal titolo Vito Capialbi. Scritti, Sistema bibliotecario Vibonese, Vibo Valentia 2003, si rimanda a
quest’ultimo studio per una selezione degli scritti più interessanti del collezionista ed una bi-
bliografia aggiornata sullo studioso. Ancora sul conte, sempre dello stesso autore, Il Conte rigat-tiere di memorie. La collezione Capialbi, in V. AMMENDOLIA-M.T. IANNELLI ( a cura di), I volti diHipponion-Vibo Valentia Museo archeologico Capialbi di Vibo Valentia, Rubbettino, Soveria Man-
nelli 2000, pp. 95-99; inoltre, M. PAOLETTI, “Medaglie, monete e vasi di gran pregio”: la collezio-ne Capialbi di Vibo Valentia, in S. SETTIS-M.C. PARRA (a cura di), Magna Graecia, Archeologia diun sapere, Electa, Napoli 2005, pp. 150-151, con bibliografia ragionata sulla raccolta. 2 La cittadina di Vibo Valentia nel corso della sua storia secolare ha avuto diversi nomi. Subcolo-
nia locrese con il nome di Hipponion mantenne quest’ultimo fino al 194-192 a.C. anno della de-
duzione della colonia latina quando, fu sostituito con quello benaugurale di Valentia. Dall’epoca
medievale fino al 1927 venne chiamata Monteleone riappropriandosi in quell’anno dell’antico
nome latino; vedi a questo proposito F. COZZETTO, Da Monteleone a Vibo Valentia, in F. MAZZA (a
cura di), Vibo Valentia, Storia cultura Economia, Rubbettino, Soveria Mannelli 1995, pp. 214-
215.3 Il decennio francese, che va dal 1806 al 1815, decretò la fine dell’ancien régime nel Mezzo-
giorno d’Italia. La riforma per eccellenza è costituita dalla legge del 2 agosto del 1806 con la
quale veniva affrontata e risolta la problematica della feudalità. Con un decreto dell’8 dicembre
del 1806 il regno fu diviso in province e distretti; in Calabria vennero mantenute le due province
di Calabria Citeriore ed Ulteriore. Della prima Cosenza rimase come capoluogo mentre a Catan-
zaro venne preferita Monteleone (Vibo Valentia) per la sua posizione più centrale e pertanto più
facilmente collegabile con altri importanti centri ma soprattutto con Napoli. Cfr. F. BARRA, L’am-ministrazione degli spazi locali: Dal decennio francese all’Italia liberale, in P. BEVILAQUA, Storiadella Calabria 4, Dal 1650 al 1900, Laterza, Roma-Bari 2001, p. 84; A. PUCA, La Calabria neldecennio francese, in A. PLACANICA (a cura di), Storia della Calabria moderna e contemporanea,Il lungo periodo, Gangemi, Roma-Reggio Calabria 1992, pp. 413-444.4 Si veda a questo proposito: M. PAOLETTI, Vito Capialbi. Scritti, cit., p. XVIII, con bibliografia
pregressa.5 Il Museo archeologico Statale di Vibo Valentia, nasce nel 1969, per volontà dell’allora Soprin-
tendente archeologo Giuseppe Foti che, appoggiato e sostenuto strenuamente da Vincenzo Nu-
sdeo e dal Lions Club di Vibo Valentia, ottenne dal Comune di Vibo l’autorizzazione ad utilizzare
l’ultimo piano di palazzo Gagliardi, nella centralissima piazza Garibaldi, per l’esposizione mu-
seale. Sistemati i locali da parte dell’ufficio tecnico dello stesso comune ed ottenuta l’approva-
zione della Direzione Generale delle Antichità e belle arti del ministero della Pubblica Istruzione(Precedentemente all’istituzione del Ministero per i beni culturali ed ambientali le competenze
spettavano al Ministero della pubblica istruzione che era provvisto di una Direzione generale pergli scavi archeologici ed i monumenti), in un arco di tempo assai breve furono allestite le sale
grazie anche a numerosi piccoli nuclei di materiale archeologico generosamente donati da citta-
dini Vibonesi. G. FOTI, Museo archeologico Statale di Vibo Valentia, in Invito al Sud, 1973, pp.
24-26. 6 Sui bronzi purtroppo a parte un articolo di P.E. Arias non esistono pubblicazioni scientifiche.
Pare infatti che dei materiali, anche notevoli, di bronzo non si ha più notizia e pertanto lo scritto
dell’Arias costituisce l’unica testimonianza relativa agli oggetti anche se si tratta di una selezio-
ne e non dell’edizione completa di tutti i reperti. Cfr. a questo proposito P.E. Arias, Bronzetti ine-diti di provenienza italiota, in Crd’A, 1940, pp. 1-5; successivamente inseriti anche in una rac-
colta di scritti dedicata allo studioso: P.A. ARIAS, Cinquant’anni di ricerche archeologiche sullaCalabria (1937-1987), Marra, Rovito 1988, pp. 79-89.7 Le vicende relative al monetiere Capialbi costituiscono un capitolo a sé stante nella storia del-
la collezione. Infatti mentre una cospicua parte dei materiali ceramici è stata consegnata tramite
il Ministero al Museo archeologico Statale di Vibo, le monete viceversa sono entrate a far parte
del patrimonio statale solo di recente e tramite acquisto nel 1989. Le trattative con gli eredi del-
lo studioso per entrare in possesso della preziosa raccolta si sono protratte per lungo tempo. Ri-
Rubbettin
o
214
sale al 1954, una ricognizione delle monete facenti parte del medagliere Capialbi: l’ispettore
Giuseppe Procopio si preoccupò di espletare l’operazione tenuto conto che Cesare Capialbi, an-
che a nome del fratello Antonio, nel frattempo defunto, chiedeva di poter regolarizzare la posi-
zione al fine di un eventuale acquisizione da parte dello Stato. Le monete – 3.500 circa – esami-
nate dal Procopio erano ancora contenute in una cassettina raggruppate in «cartocci contenenti
entro pacchetti di dieci pezzi ciascuno, un totale di 60 monete»; erano state così occultate per
proteggerle durante eventi bellici. I cartocci, precedentemente, erano stati aperti in due occasio-
ni distinte: la prima volta quando erano state esaminate dal marchese Gagliardi e successiva-
mente da Ettore Gabrici agli inizi del ’900. La ricognizione del Procopio diede luogo ad una pub-
blicazione che, seppur assai semplificata costituisce a tutt’oggi l’unico studio sul monetiere. Cfr.
G. PROCOPIO, Il Medagliere della Collezione Capialbi a Vibo Valentia Catanzaro, in AnnIstNum
II, 1955, pp. 172-181. Recente, la breve sintesi proposta da G. GARGANO, La collezione numi-smatica “Vito Capialbi” di Vibo Valentia, in S. SETTIS-M.C. PARRA (a cura di), Magna Graecia,Archeologia di un sapere, Electa, Napoli 2005, pp. 156-164 con la raccolta della bibliografia spe-
cifica.8 Un primo approccio per lo studio degli interessanti frammenti ceramici di epoca medievale e
rinascimentale sono contenuti in una più ampia pubblicazione sulle produzioni antiche in Cala-
bria, G. DONATONE (a cura di), Monteleone oggi Vibo Valentia, in La ceramica in Calabria. Storiacritica. Ceramica antica di Calabria, Ed. ISVEIMER Di Mauro, Cava dei Tirreni 1983, pp. 45-
50. Si tratta di uno studio di tipo sintetico e non analitico per questo motivo i reperti vengono
esaminati nel complesso con conclusioni piuttosto generiche. 9 Istituito nel 1969 nell’ambito della divisione Musei dell’ex Direzione generale delle Antichità
e belle arti, dell’allora Ministero della Pubblica Istruzione, l’organismo divenuto nel frattempo
“Istituto Centrale per il Catalogo e la documentazione” (ICCD), si occupa della schedatura del
materiale archeologico, artistico paesaggistico e monumentale. 10 I bolli pertinenti in massima parte a laterizi e presenti nella collezione furono editi inizial-
mente dallo stesso Capialbi che ne diede notizia attraverso una sua pubblicazione V. CAPIALBI,
Inscriptionum Vibonensium Specimen, Porcelli, Napoli 1845; successivamente anche nell’instru-mentum domesticum del CIL, vol X, ma anche E. PEROTTI, “Bolli rinvenuti a Vibo Valentia”, in
«Klearchos», XVI, 61-64, 1974, pp. 77-104. Nella prima sede del Museo archeologico, a Palaz-
zo Gagliardi, alcuni esemplari erano stati esposti dopo essere stati applicati su supporti di legno
nella sala allestita con i reperti della raccolta.11 Si tratta di un cospicuo numero di oggetti in vetro tipologicamente assortiti: sono presenti in-
fatti alcune bottiglie in vetro soffiato dal corpo quadrato che si datano tra la seconda metà del I
ed il II sec. d.C. (Forma Isings 50 B, cfr. C. ISINGS, Roman Glass from dated Finds, Gröningen-
Djakarta 1957, pp. 66-67), oppure alcuni balsamari tra i più diffusi e comuni riconducibili alla
forma ISINGS 28°, o ancora un piccolo gruppo, sempre di balsamari con il corpo dalla forma tron-
coconica, realizzati con la tecnica della soffiatura a canna libera e databili tra la fine del I ed il
II sec. d.C. (forma ISINGS 28b). Del gruppo fa parte anche un’olpe dal corpo globulare, collo ci-
lindrico e ampio labbro imbutiforme. Di questi pezzi ad esempio non si trova traccia negli elen-
chi redatti in precedenza. Per la verità in quello di Gabrici del 1900, si citano soltanto conteni-
tori in vetro che dalla descrizione possono essere sicuramente attribuiti ad una produzione più
antica ottenuta con una tecnica conosciuta come “nucleo friabile” e tipica del periodo greco clas-
sico e poi in un breve appunto di tre righe si parla di “sette unguentari romani, due vasi di vetro
verdastro”.12 Risale al 1989 l’elaborazione da parte della Soprintendenza archeologica della Calabria di un
progetto di pubblicazione dei materiali della Capialbi – sia quelli in deposito presso il Museo ar-
cheologico statale Vibonese che quelli conservati presso la dimora del collezionista. Il lavoro do-
veva sopperire alla mancanza di una edizione critica della collezione allo scopo di fornire agli
studiosi un quadro coerente e completo dei reperti. Infatti escludendo quanto divulgato dallo
stesso Capialbi nei suoi lavori – si veda a questo proposito nota 1 –, per il resto erano stati estra-
polati gruppi di materiali editi singolarmente. Alle note 6-7 è stata fornita ad es. la bibliografia
relativa a brevi articoli scientifici sia sulle monete che sui bronzetti. Per la ceramica medievale e
rinascimentale cfr. nota 8. Nella raccolta erano inoltre custodite anche alcune gemme pubblicate
dal Capialbi e successivamente studiate (senza però un esame autoptico) da A. CRISPO, Antichitàcristiane della Calabria prebizantina, in Archivio Storico per la Calabria e la Lucania XIV, 1944,
p. 3-18, 119-141, 209-220; a questo lavoro seguirà una sorta di replica molto critica da parte di
G. PUGLIESE CARRATELLI, Gemme magiche in Calabria, in Archivio Storico per la Calabria e la
Lucania XXII, 1953, pp. 23-30. Tra i materiali della collezione, sostanzialmente inediti, alcuni
frammenti di terrecotte architettoniche a testimonianza degli interessi variegati del Capialbi che
non apprezzava soltanto il materiale integro e di bell’aspetto ma anche ciò che con la sua specifi-
Rubbettin
o
215
cità contribuiva ad allargare le conoscenze. Databili al VI sec. a.C. un frammento di sima di tipo
siceliota ed una antefissa circolare con volto di sileno (C 260-265) quest’ultima pubblicata nel
catalogo Magna Graecia cit.p. 154, 1.98.; un frammento di tegola di gronda ed un frammento di
sima decorata a rilievo, della fine del VI sec. a.C. (C 3320-259), mentre al V sec. a.C. si datano
un frammento di sima decorato a rilievo con anthemion ed una antefissa a forma ellittica con vol-
to di sileno (C 263-3382). Della fine del V-inizi del IV sec. a.C. un ulteriore frammento di sima
decorato a rilievo con anthemion ricostruibile (C 358). Ritornando al progetto della Soprinten-
denza, le lucerne, piuttosto numerose, erano state assegnate alla dott. A.M. Rotella, mentre la
ceramica a v.n. che costituisce un lotto consistente alle dott.sse M.T. Iannelli-M. D’Andrea. La
coroplastica, con la presenza di reperti notevoli e la ceramica attica a f. n. rispettivamente delle
dott.sse M.V. Benelli-M. De Cesare. Vetri e ceramica medievale erano stati affidati al dott. M.
Paoletti. Purtroppo il progetto di lavoro non è stato portato a compimento e così, nel 1991 la ce-
ramica attica a f.n. è stata pubblicata nel CVA si veda in proposito M. DE CESARE, CVA (CorpusVasorum Antiquorum) Vibo Valentia, Museo Statale “Vito Capialbi”, Fasc. 1, Italia LXVII, Roma
1991. Alcuni reperti coroplastici sono stati di recente inseriti nel catalogo della mostra MagnaGraecia, cit., a cura di M.V. Benelli; si tratta di una placca con recumbente, un frammento di an-
tefissa a maschera silenica, una statuetta femminile di danzatrice, testa femminile di Artemis-Bendis, frammento di placca con Zeus Fulminante, pp. 154-155, n.ri di catalogo rispettivamente
1.97; 1.98; 1.99; 1.100; 1.101.13Ad esempio, nell’inventario compilato dall’ispettore Ettore Gabrici tra il 1910 ed il 1911, ven-
gono menzionati solamente un gruppo di materiali giudicati dal funzionario degni di essere im-
messi nelle raccolte del Museo di Napoli e cioè: una protome d’ariete, quattro statuette arcaiche
in bronzo, una statuetta rappresentante figura maschile nuda su testuggine un piccolo leone, ma
soprattutto come si raccomanda il Gabrici l’iscrizione osca con dedica a Giove Versore; a questo
proposito si veda nell’appendice documentaria il doc. n° 3. Sulla laminetta datata al III-II sec.
a.C., A. DE FRANCISCIS-O. PARLANGELI, Gli Italici del Bruzio nei documenti epigrafici, Arte tipo-
grafica, Napoli 1960, p. 15, fig. 6; in precedenza era stata analizzata da T. MOMMSEN, Die unteri-talischen Dialekte, Leipzig 1850, pp. 191 e ss.; un vasetto “fatto di impasto di terra nerastra”, in
realtà un aryballos in faience decorato con volto di una sfinge alata aveva attirato l’attenzione
dello studioso delegato dal Museo di Napoli. L’oggetto, conservato oggi al Museo archeologico
di Vibo (n.inv. C 7) è commentato in M. PAOLETTI, “Il giornale degli scavi di Monteleone”, in
«ASNSP», s. III, vol, XIX, 2, 1989 1989, pp. 494-495, tav. XIV, 1-3. Grazie alle notizie recupe-
rate dalle epistole, è stato possibile risalire alla località del rinvenimento che era la contrada Af-
faccio di Vibo Valentia, ampiamente conosciuta come area di necropoli di epoca greca. Forse il
piccolo reperto era stato trovato all’interno di una sepoltura di cui però non si dà conto. Di un al-
tro singolare reperto conosciamo la provenienza sulla base della pubblicazione del «Giornale de-
gli scavi» pubblicato dal Capialbi. Si tratta di un vasetto venuto alla luce in una località detta
Feudo Marzano nei pressi di Trappeto Vecchio dove si estendono le mura di epoca greca. Per un
commento alla scoperta cfr. M. PAOLETTI, Il giornale degli scavi di Monteleone, cit., pp. 499-500,
Tav. XIV.14 Appendice documentaria doc. n° 5.15 Lettera del 4 marzo 1911 spedita da Paolo Orsi da Siracusa e indirizzata al Ministro dell’Istru-zione pubblica, Direzione Generale Antichità e Belle Arti Roma, Archivio Centrale di Stato di Ro-
ma, Cfr. doc. n° 1 nell’Appendice documentaria. 16 Le informazioni sono state desunte dal carteggio intercorso tra Orsi, il ministro allora in carica
Corrado Ricci e Vittorio Spinazzola. I documenti cui si fa riferimento, sono conservati presso
l’Archivio Centrale di Stato di Roma, e saranno successivamente oggetto di studio da parte della
scrivente. 17 P. ORSI, “Le grandi ceramiche del castello di Monte Leone Calabro”, in «Faenza», XII, II,
1934, pp. 34-41, ora riproposto in M.A. ROMANO (a cura di), L’Archeologia di Paolo Orsi a Mon-teleone Calabro1912-1925, Qualecultura, Vibo Valentia 2006, pp. 193-199. Ma a Paolo Orsi, ol-
tre agli studi di tipo classico prodotti nel corso della sua lunga militanza negli apparati dello Sta-
to, siamo debitori anche della (ri)scoperta di numerosi monumenti di epoca medievale che grazie
al suo interessamento scientifico sono divenuti anche in tempi recenti imprescindibili punti di
riferimento per lo studio di un periodo storico fino a poco tempo fa misconosciuto e scarsamente
studiato. Le osservazioni scaturite dalle sue indagini conoscitive confluirono in una ampia mono-
grafia sull’architettura medievale calabrese dal titolo Le chiese Basiliane della Calabria, Firenze,
Vallecchi 1929.18 Anche al famoso viaggiatore francese F. Lenormant non fu possibile visitare la raccolta, F. LE-
NORMANT, La Magna Grecia: paesaggi e storia, versione dal francese con note di Armando Luci-
fero, Chiaravalle C., Frama Sud 1976, pp. 140-141-143.
Rubbettin
o
216
19 Il conte possedeva una villa a Stilo (RC) e quindi questo particolare induce ad ipotizzare
una sua attività in quella zona, mentre sono attestati scavi da parte sua a Nicotera e Rosarno.
Provenienti sicuramente da Locri circa “60 pezzi di vasellame” come dichiara egli stesso in
una missiva indirizzata a Pietro Bellotti commissario onorario dell’Istituto di corrispondenza
Archeologica, Napoli. V. CAPIALBI, Opuscoli varii, III, Stamperia di Porcelli, Napoli 1849, pp.
385-386. 20 Il termine non compare neppure nella famosa legge di tutela n. 1089 dell’1-6-1939 dove si
parla «di cose immobili e mobili che presentano interesse artistico […]» (art. 1).21 In questo periodo infatti l’interesse nei confronti delle antichità classiche fece emergere la ne-
cessità di avviare un discorso sulla tutela dei beni artistici: primi conservatori incaricati, con
brevi papali, furono Raffaello e successivamente Michelangelo nominati conservatori delle anti-
chità di Roma. B. D’AGOSTINO, Le strutture antiche del territorio, in C. DE SETA (a cura di), Storiad’Italia, Giulio Einaudi editore, Torino 1985, p. 5.22 In generale, per un’ampia trattazione sulla storia della tutela nell’Italia pre-unitaria: T. ALI-
BRANDI-P. FERRI, I Beni culturali ed ambientali, Giuffrè, Milano 1985, ma anche M. BENCIVENNI-
R. DALLA NEGRA-P. GRIFONI, Monumenti e istituzioni. Parte prima La nascita del servizio di tuteladei monumenti in Italia: 1860-1880, Ministero per i Beni culturali ed ambientali e architettonici
per le province di Firenze e Pistoia sezione didattica, Alinea, Firenze 1987.23 L’editto del cardinale Bartolomeo Pacca (Benevento 1756-1844) viene ancora oggi considerato
innovativo per quei tempi poiché, tra l’altro, istituiva una struttura amministrativa per la tutela
delle belle arti, organizzata in commissioni formate da esperti e residenti nelle principali città.
Veniva inoltre prevista la catalogazione delle opere d’arte custodite da soggetti pubblici; una tas-
sa doganale per l’esportazione di opere d’arte; norme sul vincolo, sul restauro, e sul finanziamen-
to dei lavori. Per una ricostruzione storica cfr. il recente C. BARBATI-M. CAMMELLI-G. SCIULLO (a
cura di), Il diritto dei beni culturali, il Mulino, Bologna 2006.24 Il rapporto tra regime fascista, archeologia ed antichità fu per diverso tempo assai saldo. Fa-
mose le campagne archeologiche finanziate dal governo fascista all’estero. Probabilmente, lo sca-
vo archeologico era un tipo d’impresa in grado di conferire al regime una parvenza di cultura.
Famosi gli scavi condotti a Butrinto in Albania oppure quelli di Leptis Magna in Africa, o ancora
quelli in Libia. In Italia e precisamente a Roma, gli sventramenti nella città eterna per la costru-
zione di via dell’Impero, rivelano ed evidenziano il fine strumentale dell’archeologia nella retori-
ca del regime. Il connubio fascismo e archeologia ovvero cultura classica e regime, è stato inda-
gato da diversi studiosi a questo proposito è utile la sintesi offerta da B. D’Agostino che oltre a
fornire un sunto sull’argomento offre molti spunti bibliografici: B. D’AGOSTINO, Le strutture anti-che del territorio, in C. DE SETA (a cura di), Storia D’Italia, Einaudi, Torino 1985, pp. 8-12, note
13-16. 25 Questo non significa però che nel corso di lavori edili che comunque ci sono stati in questo
periodo non sono venute alla luce tracce di vestigia antiche pertinenti al passato della città gre-
co-romana. Per un excursus sui rinvenimenti fortuiti in città, M.T. IANNELLI-G.P. GIVIGLIANO, “Hip-
ponion-Vibo Valentia la topografia (carta archeologica)”, in «ASNP», s. III, XIX, 2, 1989, pp.
627-681.26 Un ritratto del sacerdote, originario di un piccolo paese del reggino, è stato tracciato di recen-
te da F. Ramondino. a questo proposito vedi F. RAMONDINO, Mons. Francesco Albanese, in G. FLO-
RIANI-G. LUCIANO-G. NAMIA (a cura di), Umberto Zanotti Bianco e la provincia di Vibo Valentia,
Vibo Valentia, Monteleone 2005, pp. 43-45. Purtroppo dal breve profilo del prelato non sono de-
sumibili informazioni circa l’attività di collezionista di materiale archeologico che pure sarebbe
stato interessante avere.27 G.BARBIERI, “Due vasi del pittore di Berlino da Vibo Valentia”, in «Bollettino d’Arte», 15,
1982, anno LXVII, serie VI, pp. 61-66.28 La stipe è detta di Scrimbia per via della vicina fontana settecentesca che porta il nome di una
ninfa la cui vicenda mitica è particolarmente amata dai vibonesi. La tradizione popolare ricorda
una leggenda riferibile a questa divinità che per un amore non corrisposto si sarebbe trasformata
in una fonte di acqua limpidissima. Non esistono però riferimenti bibliografici precisi se si esclu-
de un piccolo paragrafo dedicato da Mons. Albanese alla storia della fontana cfr. quindi F. ALBA-
NESE, Vibo Valentia nella sua storia, I-II, Grafica Calabrese, Vibo Valentia s.d. [1975], pp. 139-
141.29 Gli scavi nella stipe Scrimbia sono stati intrapresi a partire dal 1979 a cura della Soprinten-
denza archeologica della Calabria. Purtroppo non esiste un’edizione critica né degli scavi né tan-
tomeno dei preziosi ed abbondanti materiali lì rinvenuti. Notizie relative alle indagini condotte e
per una breve storia degli scavi, si veda, oltre alle annuali rassegne archeologiche di cui il so-
printendente della Calabria da conto negli Atti di Taranto, C. SABBIONE, Hipponion il deposito vo-
Rubbettin
o
217
tivo in località Scrimbia, in E. LATTANZI (a cura di), Santuari della Magna Grecia in Calabria,Electa, Napoli 1996, pp. 155-161. Le schede relative ad alcuni oggetti (coroplastica e bronzi),
sono redatte sempre a cura di C. SABBIONE, e consultabili in G. PUGLIESE CARRATELLI (a cura di),
I Greci in occidente, Bompiani, Milano 1996, pp. 641-642. Nell’ottobre del 1996 il crollo della
sede stradale in via Scrimbia ha portato alla scoperta di uno scavo clandestino. Questo veniva
perpetrato da molto tempo al di sotto della carreggiata che era stata puntellata in maniera profes-
sionale, proprio per agevolare l’asportazione dei materiali antichi che lì giacevano ancora nume-
rosi. Infatti gli scavi della fine degli anni Settanta-primi anni Ottanta, non avevano completa-
mente recuperato quanto seppellito nella stipe ma erano rimasti in situ molti frammenti oggetto
appunto delle attività clandestine. In seguito a questo evento, sono stati condotti anche se per un
periodo limitato di tempo indagini archeologiche funzionali al salvataggio del materiale archeo-
logico superstite.30 P. ORSI, Monteleone Calabro. Nuove scoperte, Notizie degli Scavi di Antichità, 1921, pp. 473-
485.31 Nella cartografia ottocentesca l’area è segnalata come “Cava Cordopatri”, poiché il luogo si
prestava bene alla raccolta di materiale di recupero di epoca antica. La località, compresa tra il
castello cosiddetto normanno-svevo e il convento dei Cappuccini, si estende nella parte alta del-
la città dove, in antico, doveva essere ubicata l’acropoli dell’insediamento greco.32 Della gorgone, il cui diametro è stato fissato in un metro e 10 cm, possediamo solo due grossi fram-
menti relativi alla parte superiore con i riccioli ad “esse”, porzione dell’occhio destro con la palpe-
bra cordonata ed una dell’orecchio sinistro. Stilisticamente è stata accostata ai tipi tarantini databili
alla prima metà del V sec. a.C.; P. ORSI, Monteleone Calabro. Nuove scoperte, cit., figg. 9-10.33 Sintetiche informazioni sulle indagini qui condotte in E. LATTANZI, Attività della Soprintenden-za archeologica della Calabria in Problemi della chora coloniale dall’occidente al Mar Nero, Atti
del XXXX convegno di studi sulla Magna Grecia, Taranto 29 settembre-3 ottobre 2000, p. 998;
Il contesto di scavo con il rinvenimento di reperti riconducibili ad un’area sacra dove veniva pra-
ticato il culto di Dioniso nell’accezione ctonia in M.T. IANNELLI-M. CERZOSO, Stipi votive nellasub-colonia di Hipponion: l’area sacra alla Cava Cordopatri, in A. COMELLA-S. MELE (a cura di),
Depositi votivi e culti dell’Italia antica dall’età arcaica a quella tardo repubblicana, Edipuglia,
Bari 2005, pp. 689-70234 F. ALBANESE, Vibo Valentia nella sua storia, cit.35 I pezzi sono stati messi insieme, appassionatamente, da Giacomo, Giuseppe e Maria Cannella,
oggi stimati professionisti, all’epoca della raccolta ragazzi entusiasti e curiosi di conoscere le vi-
cende storiche della propria città. In quella che allora costituiva la periferia urbana con molti
cantieri aperti, i giovani Cannella si introducevano per salvare cocci apparentemente insignifi-
canti che messi assieme, spesso, prendevano la forma di un vaso completo. 36 Colgo l’occasione per ringraziare i genitori dei fratelli Cannella presso la cui abitazione, la
collezione, dopo la donazione, è rimasta in deposito. Gli sono riconoscente per essere stata ac-
colta benevolmente durante una prima schedatura effettuata su incarico della Soprintendenza ar-
cheologica della Calabria e per aver sopportato pazientemente, successivamente, le mie visite
per gli approfondimenti necessari al presente lavoro. 37 Con il nome di necropoli greca occidentale, si è soliti indicare un complesso di sepolture che
pur facendo parte originariamente di un unico complesso è stata indagata per lotti, in seguito agli
sbancamenti per le nuove costruzioni. 38 L’olpe acroma di tipo miniaturizzato costituisce quasi una costante nelle sepolture della ne-
cropoli greca, anche se non è possibile precisare se veniva utilizzata esclusivamente sepolcri di
tipo femminile o maschile. Presenta generalmente un fondo piano il corpo ovoide, il collo corto
con labbro estroflesso ed un’ansa a nastro ingrossato, sormontate. Nella famosa sepoltura 19 del-
la laminetta orfica, oltre al prezioso reperto in oro era stato deposto un congruo corredo ceramico
composto da un’olpe, due hydriskai acrome, due lekythoi ariballiche a v.n., tre bolsal e due lu-
cerne a v.n. oltre ad un campanellino in bronzo un anello in oro e ovviamente la laminetta. L’edi-zio princeps di questa sepoltura e della laminetta in G. FOTI-G. PUGLIESE CARRATELLI, Un sepolcrodi Hipponion e un nuovo testo orfico, Parola del Passato, 29, 1974, 91-126. Per una rilettura del
contesto di rinvenimento della tomba con la laminetta orfica con particolare riferimento al corre-
do ceramico, si veda il recente contributo di M.T. IANNELLI, La tomba 19 nel contesto della necro-poli occidentale di Hipponion, in S. SETTIS-M.C. PARRA (a cura di), Magna Graecia, Archeologiadi un sapere, Electa, Napoli 2005, pp. 144-145 e relative schede dei materiali compresa la lami-
netta orfica da 1.73 a 1.86. 39 Questo contenitore caratterizzato da una vasca bassa e larga e doppia ansa, nasce in Attica
verso la fine del V sec. a.C.; in Magna Grecia, i vasai hanno spesso adattato la forma ai gusti lo-
cali inserendo alcune varianti. Ad esempio a Vibo, nella necropoli sono documentati esemplari
Rubbettin
o
218
di bolsal con il piede con modanatura a doppio listello sottile. Cfr. C. SABBIONE, Ceramica a v.n.,
in AA.VV., Locri Epizefiri I, Sansoni, Firenze 1977, p. 105. 40 Il lydion, vaso per unguenti dalla forma globulare o piriforme, su alto piede, è originario dalla
Lidia regione dell’Asia minore posta ad occidente della Frigia.Questo tipo di contenitore costi-
tuisce uno dei numerosi esempi di ceramica di importazione presente sui mercati dell’Italia me-
ridionale, provenendo appunto da regioni orientali. È ipotizzabile un commercio di unguenti e
profumi che venivano commercializzati completi di relativo contenitore.Il gradimento di questo
piccolo vasetto per la sua forma e per il contenuto, fu tale da dare il vita, in vari siti della Magna
Grecia, a riproduzioni nei luoghi della distribuzione. Dalla necropoli occidentale provengono al-
cuni esemplari che sono stati attribuiti con sicurezza ad una produzione locale forse addirittura
ipponiate; cfr a questo proposito M. D’ANDREA, “Necropoli occidentale di Hipponion”, in «ASNP»,
serie III, vol. XIX, Pisa 1989, p. 785, Tavv. CVIII e CX. 41 La prima è infatti una lekythos attica a f.n anch’essa ben documentata sia in area di necropoli
che in area sacra. Presenta il piede a spesso disco, corpo tubolare, spalla distinta, collo cilindri-
co, ansa a nastro che dal collo si applica sulla spalla. Decorazione: terzo inferiore del corpo, fac-
cia superiore del piede ed ansa a v.n. sulla spalla boccioli di loto molto stilizzati, ed alla base del
collo tratti disposti a raggiera. Sul corpo tre serie di palmette divise tra loro da motivo affusolato.
Dettagli incisi. Vicino al Beldam-Group dataz. 480-470 a.C.; Il secondo esemplare, più piccolo
nelle dimensioni, presenta un altro tipo di decorazione; si tratta sempre di una lekythos attica a
v.n. spesso piede a disco, corpo tubolare ricoperto da v.n., spalla distinta decorata da boccioli di
loto stilizzati. Per questo oggetto è proponibile una datazione al V sec. a.C.42 Per la terminologia attualmente in uso si veda il lavoro di M. BARRA BAGNASCO, Protomi in ter-racotta da Locri Epizefiri. Contributo allo studio della scultura in Magna Grecia, Il Quadrante,
Torino 1986, pp. 16-17, nota 13, con bibliografia. In sintesi la studiosa, si trova d’accordo anche
con lo Zuntz e ritiene il termine protome più appropriato rispetto a quello di maschera. G. ZUNTS,
Persephone. Three Essays on religion and Thought in Magna Grecia, Oxford 1971, p. 142 43 Alcuni esemplari integri sono esposti in una vetrina del Museo “Capialbi” ed è interessante
notare che ve ne sono alcuni raffigurati al passo, altri nell’atteggiamento stante. 44 La ceramica miniaturizzata, all’interno delle aree sacre di epoca greca, costituisce una costan-
te assai tipica dei rituali connessi alle offerte. Infatti le forme decisamente ridotte degli oggetti
inducono ad escludere categoricamente un loro uso nella vita quotidiana per propendere verso
una produzione esclusivamente finalizzata ad un uso nel corso dei riti che venivano celebrati in
onore delle divinità. Le forme più comuni sono krateriskoi, hidriskai, phialai mesomphaliche koty-liskoi. Alcune di queste forme servivano a contenere cibi solidi, altri quelli liquidi e comunque
tutti da lasciare come offerta al dio per il quale era avvenuto il rito celebrativo. Per una disamina
sulla produzione di kotylai a scopo rituale si veda H. PAYNE, Necrocorinthia, Oxford 1931, p. 334,
mentre per considerazioni sulla ceramica miniaturistica da contesto sacro ipponiate, cfr. M.G.
FORTINO, Ceramica miniaturistica, in E. LATTANZI (a cura di), Santuari della Magna Grecia inCalabria Electa, Napoli 1996, pp. 149-150.45 Nel corso degli anni, presso le aree di necropoli indagate, sono state documentate numerose
incinerazioni; queste in massima parte rientrano in una classificazione definita di tipo seconda-
rio e prevedevano la deposizione del corredo insieme al defunto al quale veniva appiccato il fuo-
co dopo averlo deposto su di una pira o letto di legno. Per i diversi tipi di incinerazione nella ne-
cropoli nord occidentale della città, cfr. M. D’ANDREA, Recenti campagne di scavo alla necropolioccidentale di Hipponion, cit., pp. 765-786. per i rituali praticati nella necropoli cfr. M. D’AN-
DREA, Hipponion città greca d’occidente, Storia, archeologia, Miti, Apoikia, Vibo Valentia 2002,
pp. 120-136.46 Questa piccola collezione è stata messa insieme dal dott. Francesco David nel corso di molti
anni. Parallelamente ai materiali ceramici aveva raccolto numerose monete: di queste sono stati
schedati circa un centinaio di esemplari. Il dott. David ha accettato con entusiasmo la decisione
della Soprintendenza archeologica della Calabria di schedare la sua piccola raccolta, parteci-
pando attivamente alle fasi di analisi dei reperti, in particolare delle monete, di cui era partico-
larmente orgoglioso. Un doveroso ringraziamento ai familiari che dopo la sua scomparsa mi han-
no permesso di visionare ancora una volta i materiali in funzione di questo lavoro. 47 È questo un tipo di oggetto molto documentato in area di necropoli. Ve ne sono alcune di otti-
ma fattura che presenta una v.n. di ottima qualità fino ad alcuni tipi di lavorazione scadente e se-
riale. Cronologicamente vanno dal V al III sec. a.C.48 Per il piccolo reperto plastico della collezione David sono valide le osservazioni espresse per
quello custodito nella raccolta Cannella.49 La tecnica di lavorazione è quella della matrice bivalve che consisteva in un doppio “stam-
po”. Una volta ottenuti i due pezzi al positivo, questi venivano successivamente uniti con l’aiuto
Rubbettin
o
219
di argilla semiliquida che serviva a saldare il pezzo; i particolari venivano rifiniti a stecca, com-
pletando così l’oggetto.50 Cfr. supra nota 44 per un commento sull’uso e la finalità della ceramica miniaturizzata all’in-
terno delle aree sacre.51 L’idea di presentare nella vetrina del Museo archeologico di Vibo la ceramica miniaturizzata
disposta “a cumulo”, è stata ispirata dalla necessità di evidenziare e quindi spiegare dal punto
di vista quantitativo l’abbondanza dei materiali ed il loro massiccio impiego. 52 La necropoli detta di Piercastello costituisce un esempio assai significativo di area sepolcrale
di tipo ellenistico. Le indagini di scavo furono avviate a metà degli anni ottanta, quando, in oc-
casione degli sterri per la costruzione di civili abitazioni vennero alla luce alcune sepolture che
cronologicamente si disponevano in un periodo più recente rispetto alle aree indagate in prece-
denza. Anche durante i lavori di preparazione per l’apertura della strada Lacquari numerose tom-
be furono segnalate nel corso degli sbancamenti e documentate dal personale della Soprinten-
denza archeologica della Calabria. In questo settore che si presenta molto ampio ed indagato par-
zialmente, fu rinvenuta la famosa tomba pertinente ad un personaggio di spicco della società
Brettia. La sepoltura monumentale, costruita con blocchi di arenaria tagliati in diverse misure, si
è conservata per un’altezza di circa 90 cm. Qui gli archeologi hanno recuperato quanto rimaneva
del corredo posto ad accompagnamento del defunto che non sarà stato completo anche per via
del riutilizzo avvenuto successivamente. Degni di attenzione sono senza dubbio le statuette fittili
maschili che rappresentano due guerrieri che molto probabilmente costituivano delle applicazio-
ni poste sulla cassa lignea che conteneva i resti del nobile defunto. L’elmo indossato pare fosse
in dotazione sia all’esercito romano che a quello italico anche se si propende per un’attribuzione
ad un guerriero brettio. Chi ha portato alla luce la sepoltura, ha proposto un confronto con una
analoga da Roccagloriosa (SA) e pertinente all’elemento lucano. Cfr. L. CRIMACO-L.M. PROIETTI,
“Vibo Valentia necropoli in località Piercastello”, in «ASNP», n.s., II, XIX, 2, 1989, pp. 787-
810, tavv. CXII-CXIX.53 Questa località si trova quasi a ridosso delle mura di cinta di epoca greca di Trappeto Vecchio;
Paolo Orsi, nel corso delle sue indagini di scavo sulle mura, aveva notato la presenza di questa
necropoli che a suo avviso doveva essere un sepolcreto frequentato in epoca romana. Lo stesso
Capialbi aveva dato notizia del ritrovamento di sepolture in questa zona anche se dalla descrizio-
ne del materiale di corredo sembrerebbe trattarsi di tombe greche. Scavi sistematici non ne sono
stati mai condotti, se si esclude un breve intervento con personale della Soprintendenza archeo-
logica della Calabria che alla fine degli anni settanta aveva recuperato e cercato di documentare
quanto rimaneva sul terreno in seguito ad uno scasso effettuato da privati per la realizzazione di
un grosso parcheggio di TIR. La necropoli, conosciuta come De Caria dal nome del proprietario,
sulla base dei materiali rinvenuti si data al II sec. d.C. Le sepolture indagate ammontano ad un
centinaio, erano costituite da muretti e spesso erano stati riutilizzati blocchi di arenaria trafugati
dalle vicine mura di epoca greca. Oltre all’inumazione veniva praticato anche il rito dell’incine-
razione: in un caso è stata rinvenuta un’olla da cucina reimpiegata per l’occasione. Molto inte-
ressante la scoperta di quattro epigrafi riciclate che erano state usate per rivestire la tomba di un
bambino; per notizie più dettagliate inerenti lo scavo cfr. C. SABBIONE, Ricerche archeologiche aLocri e nelle sue subcolonie, in ACT, 1978, Taranto 1979, pp. 396-397; le epigrafi sono state in-
vece pubblicate da M. BUONOCORE, “Note di epigrafia latina vibonese”, in «Klearchos» XXVI,
1984, pp. 53-71, anche se l’autore le considera provenienti genericamente dalla città di Vibo e
non ne fornisce l’indicazione topografica precisa.54 Un excursus a grandi linee sulla storia della ricerca in Calabria, in R. SPADEA, Archeologia epercezione dell’antico, in Storia d’Italia, Le regioni dall’unità a oggi, La Calabria, a cura di P.
BEVILACQUA-A. PLACANICA, G. Einaudi, Torino, pp. 657-690.55 Colgo l’occasione per ringraziare l’amico dott. M. Panarello per la fattiva collaborazione nel
reperimento di parte del materiale qui proposto. Sono riconoscente alla dott.ssa Mariapina Di Si-
mone dell’Archivio Centrale di Stato di Roma per avermi fornito utili informazioni e competente
consulenza su alcuni di questi documenti conservati appunto presso il Fondo Ministero Pubblica
istruzione direzione generale Antichità e Belle Arti Divisione I, 1908-24, Busta 43F. 930. Qual-
cuno è redatto con la macchina per scrivere, altri compilati a mano: di questi si fornisce, oltre al-
l’originale, anche la trascrizione.56 Direttore generale alle Antichità e Belle Arti. 57 Sulla figura e l’opera di Paolo Orsi, Soprintendente a Reggio Calabria dal 1907 al 1925, esiste
una cospicua letteratura tenuto conto dell’ingente lavoro di scavo e studio svolto dall’archeologo
in Italia Meridionale e dei rapporti che aveva intrattenuto con studiosi, politici e amministratori
locali. La vasta produzione bibliografia è sistematizzata in A.M. MARCHESE-G. MARCHESE (a cura
di), Bibliografia degli scritti di Paolo Orsi, Pisa 2000. Sull’impegno profuso dall’archeologo tren-
Rubbettin
o
220
tino nei siti archeologici della Calabria si rimanda ai saggi contenuti nel recentissimo volume
complementare alla mostra del Complesso Monumentale di S. Giovanni di Catanzaro, MagnaGraecia archeologia di un sapere, cit, in particolare al saggio di M. PAOLETTI, alle pp. 192-198,
con una interessantissima nota bibliografia posta alla fine del lavoro.58 Archeologo in servizio presso il Museo di Napoli.59 Vittorio Spinazzola nativo di Matera ma di origini abruzzesi, era il Direttore del Museo archeo-
logico di Napoli. Aveva già avuto a che fare con la Calabria in quanto si era occupato del riordi-
no delle collezioni del Civico di Reggio Calabria E. LATTANZI, Storia della ricerca archeologica,
in F. MAZZA (a cura di), Reggio Calabria, Storia cultura economia, Rubbettino, Soveria Mannelli
1993, p. 74.60 Ettore Gabrici si era recato a Vibo Valentia, allora Monteleone, nel luglio del 1900; qui si era
fermato 11 giorni al fine di effettuare una ricognizione finalizzata alla stesura di una breve rela-
zione sulla raccolta. Di questa missione oltre al resoconto rimane traccia negli atti burocratici
espletati per l’incarico cfr. documento n. 16. 61 Il museo Civico di Reggio Calabria venne fondato nel 1882. Al 1907 risale invece l’istituzione
della Soprintendenza archeologica della Calabria. Per una ricostruzione delle vicende relative
alla istituzione del Museo civico reggino si veda E. LATTANZI, Storia della ricerca archeologica,cit., pp. 71-74; IDEM, Il Museo Nazionale di Reggio Calabria, Gangemi, Roma/Reggio Calabria
1987, pp. 9-11.62 Vergata di suo pugno, l’Orsi nella parte alta della lettera scrive: Con viva preghiera al Sig. Di-rettore Generale di esaudire la mia preghiera, f.mato P. Orsi.63 Agli inizi del XX secolo furono varate importanti leggi sui temi della tutela del patrimonio sto-
rico-archeologico. Infatti è del 12 giugno 1902 l’approvazione della legge n. 185 sulla conserva-
zione dei Monumenti e degli Oggetti di Antichità e d’Arte, prima legge organica del settore. Al 27
giugno 1907 risale la legge n. 386 concernente il Consiglio Superiore, gli Uffici ed il Personale
delle Antichità e Belle Arti e, soprattutto, il 20 giugno 1909, dopo complesso e travagliato iter,fu approvata la legge n. 364, con cui si tutelavano «le cose immobili e mobili di interesse stori-
co, archeologico, paletnologico o artistico» e che regolava la materia delle Antichità in rapporto
alla proprietà privata.64 Questa relazione sarà poi oggetto della richiesta di Orsi 11 anni dopo.65 M. PAOLETTI (a cura di), Vito Capialbi. Scritti, cit.
Rubbettin
o
227Fig. 7 - Vibo Valentia Collezione Can-nella: testina fittile maschile
Fig.8 - Vibo Valentia Collezione Can-nella: figura fittile di toro
Fig.9 - Vibo Valentia Collezione Can-nella: ceramica votiva miniaturisticaacroma
Rubbettin
o
228 Fig. 10 - Vibo Valentia CollezioneCannella: patere acrome
Fig. 11 - Vibo Valentia CollezioneCannella: applique in bronzo
Fig. 12 - Vibo Valentia CollezioneCannella: applique in bronzo
Rubbettin
o
229Fig. 13 - Vibo Valentia Collezione Da-vid: monete in bronzo
Fig. 14 - Vibo Valentia Collezione Da-vid: frammenti di statuette fittili rap-presentanti Demetra con il porcellino
Rubbettin
o
230
Fig. 16 - Vibo Valentia Collezione Da-vid: testina fittile maschile
Fig. 15 - Vibo Valentia Collezione Da-vid: testa fittile femminile di produ-zione medmea
Fig. 17 - Vibo Valentia Collezione Da-vid: figurina di torello
Rubbettin
o
231Fig. 18 - Vibo Valentia Collezione Da-vid: unguentari fittili
Fig. 19 - Vibo Valentia Collezione Da-vid: lucerne medievali
Rubbettin
o


















































































![Strumenti musicali nelle collezioni siciliane [Musical instrumentas in Sicilian collections], in Strumenti musicali in Sicilia, ed. by G. P. Di Stefano, S. G. Giuliano, S. Proto, Palermo,](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63377df2d102fae1b607646b/strumenti-musicali-nelle-collezioni-siciliane-musical-instrumentas-in-sicilian.jpg)