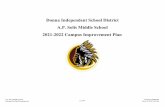La donna, il chiostro, l'eredità. Da Julia M. H. Smith alla Vita Hildegardis
Transcript of La donna, il chiostro, l'eredità. Da Julia M. H. Smith alla Vita Hildegardis
Storia Medievale LM – 2013-2014
Professor Giuseppe Albertoni
La donna, il chiostro e l’eredità
Da Julia M. H. Smith alla Vita Hildegardis
« Doveva uscire dalla sua cella, governare la sua parte di abbazia come un feudo, la quale cosa competeva trattative con l’abate,
ricevere ospiti, sollecitare prebende, ispezionare i magazzini, sorvegliare la disciplina e reprimere quelle sorelle che non
parevano naturaliter cristiane». Lucia Tancredi, Ildegarda. La potenza e la grazia, Roma: Città Nuova, 2009, p. 61.
Nicolò Rubbi
Filosofia e linguaggi della modernità – II anno
Indice
La donna, il chiostro e l’eredità.
Da Julia M. H. Smith alla Vita Hildegardis.
1. Julia M. H. Smith e la nuova storia culturale dell’Europa
2. Le donne nell’alto Medioevo. Uno sguardo generale
3. Le donne e la vita religiosa
3.1 Il chiostro e le unioni
3.2 Il chiostro e l’eredità. Ildegarda di Bingen
4. Conclusioni
Bibliografia
1. Opere
2. Manuali
1. Julia M. H. Smith e la nuova storia culturale dell'Europa Le introduzioni autentiche, quelle che riassumono il percorso d'analisi di un testo e al contempo
rivelano l'intenzione più profonda dell'autore ad esso sottesa, sono dei veri compendi di ragguagli
storiografici. E' così per il testo di Gasparri e La Rocca, nonché per quello di Smith; tra i due vi sono
numerosi punti di contatto circa le problematiche cronologiche e la necessità di adozione di tecniche di
indagine avanguardistiche per un nuovo dialogo con le fonti di sempre. Procediamo con ordine.
Lontana dal voler presentare un modello strutturalista – a là March Bloch, dove l'individuo si
perde nelle geometrie delle grandi strutture sociali enucleate, la studiosa si pone da una diversa
prospettiva per la valutazione di una storia dove gli individui, con le loro passioni e le loro paure, sono
attori e non pedine. La proposta di una «nuova storia culturale»1 dell'Europa poggia la sua portata
nientemeno che sulla convinzione che solamente la cultura di un popolo possa «smascherare le realtà
del potere e […] rivelare le strategie di dominio per quello che sono»2. Re ed imperatori, pertanto, non
potranno che essere figure su cui riflettere alla fine di ogni disamina; mai potranno imporsi come punti
di partenza.
La difficoltà a sposare le pretese definitorie di categorie nette quali 'antichità' e 'medioevo',
sovraccaricate di fardelli qualitativi antitetici già dall'epoca rinascimentale3, si trova in Smith congiunta
ad un ulteriore disincanto storiografico, ossia un fondato scetticismo nei confronti delle grandi
narrazioni4. Adottando un atteggiamento essenzialmente postomodernista, che le permette di
allontanare ogni facile concordismo con le sopradette, e ben più che consolidate, concezioni
dicotomiche di matrice postillumista, viene respinto persino ogni teleologismo5. Sono i fatti che devono
parlare, e lo storico deve far si che ciò avvenga come se non fosse a conoscenza dei successivi sviluppi
di una storia già avvenuta. Un simile terreno non permette nemmeno l'impiego dell'aggettivo 'feudale';
l'analisi della società, a partire dal concetto di feudalesimo, non è giudicata rilevante. Smith affronta
l'epoca altomedievale senza chiamare in causa il termine centrale dei lavori dello storico francese e dello
storico belga, che senz'altro conosce perfettamente6.
Il tentativo di capire dove sia effettivamente avvenuto il passaggio dall'antichità all'alto
Medioevo richiede accorgimenti nella scelta delle date in cui sviluppare l'indagine. Smith, sposando a
prima vista la concezione mutazionista, prende in analisi un blocco cronologico con estremi
convenzionali, approssimativi. E' convinta che la fase di passaggio, che prese il suo avvio nel V secolo,
non abbia prodotto divergenze nette prima del X-XI secolo7. Le preme, inoltre, ribadire che nel corso
1 J. M. H. SMITH, L'Europa dopo Roma. Una nuova storia culturale 500-1000 (2005), Bologna: Il Mulino, 2008, p.16. 2 Ivi, p.18. 3 Cfr. Ivi, 11. 4 Cfr. Ivi, p. 18. 5 Ricordiamo esser stata l'accusa mossa a Ganshof. Si pensava avesse letto le fonti a partire dal risultato che mirava ad
ottenere. 6 Nel capitolo sulle amicizie e la parentela, Smith si riferisce esplicitamente al capitolo Gli amici 'carnali' de La società feudale. 7 S. Gasparri e C. La Rocca adottano un approccio intermedio, individuando il punto di frattura nell'epoca carolingia. A ciò
di tale arco di tempo il cambiamento ebbe ritmi non uniformi8. Da qui la predilezione per la microstoria,
la cui lente, fissata sulle caratteristiche regionali e locali, possa testimoniare fedelmente ciò che va
inevitabilmente perduto all'ombra delle grandi strutture.
L'area geografica di riferimento è accostabile a quella di una mappa d'Europa odierna,
aggiornata ai nuovi ingressi del 1° maggio 2004. Affinché il peso delle moderne strutture politiche non
schiacci gli assetti del periodo storico scelto, Smith appone due doverosi distinguo: uno riguardante
l'esclusione dalla mappa della Grecia odierna in quanto espressione, al tempo, di un mondo bizantino
contrapposto alla cristianità latina; un altro a fare da memento circa la difficile, se non impossibile,
reperibilità di fonti per la ricostruzione sociale di alcuni territori9.
Tre approcci revisionistici rendono conto dei movimenti interni all'indagine, che caratterizzano
il testo dall'inizio alla fine. Alla tendenza di centralizzare l'attenzione al cuore dei territori europei viene
contrapposto un allargamento degli orizzonti che spazia dalla Scandinavia alla Spagna, si muove sui
territori ungheresi ed approda alle coste d'Irlanda, area prediletta dall'autrice10. Il secondo, invero già
implicitamente espresso sopra, è un tentativo di «prescindere dall'assillo storiografico per le entità
nazionali» passando ripetutamente da uno stato all'altro e «ignorando i confini politici moderni»11.
L'ultimo è il rifiuto di un intendimento dell'Europa altomedievale come «plaga culturalmente
omogenea»12.
In apertura di testo facevamo riferimento a punti di contatto nelle premesse introduttive di
L'Europa dopo Roma e Tempi barbarici. Laddove l'autrice britannica mostra di voler sostituire il
determinismo teleologico con un'etnografia comparata13, ci sembra di poter ravvisare un atteggiamento
simile a quello dei due storici italiani, a proposito dell'apertura ai contributi dell'antropologia14. Scambio
competitivo, economia del dono e ritualità innervano l'intero dettato smithiano. La sensibilità per il
linguaggio da parte della nuova storia culturale europea, vertente sull'indagine circa le discrasie fra i testi
e le realtà storiche realmente avvenute15, trova piena corrispondenza nella sezione del manuale dedicata
al linguistic turn. Lo stesso si dica per gli apporti della crescente archeologia di scavo16.
Il modello di Smith, infine, altro non è che un grande tentativo di mettere in evidenza le
particolarità altomedievali, in virtù del loro dinamismo costante, e soprattutto senza dimenticare
facevamo riferimento, quantomeno circa l'aspetto cronologico, in apertura. Rimandiamo pertanto a S. GASPARRI, C. LA
ROCCA, Tempi barbarici. L'Europa occidentale tra antichità e medioevo (300-900), Roma: Carocci, 2013, pp. 24 e seguenti. 8 Cfr. Ivi, p. 12. 9 Cfr. Ivi, p. 13. 10 Cfr. Ivi, p. 14. Ci permettiamo di esprimere questo giudizio sulla base di quanto si evince dal testo. Specialmente per
quanto concerne le tradizioni e i sistemi giuridici, l'Irlanda, assieme al lascito imperiale e alle usanze germaniche, costituisce uno dei punti con cui l'autrice costantemente si confronta. Non a caso, il capitolo sulla scrittura, ad esempio, chiama subito a testimonianza proprio questi territori.
11 Ibid. 12 Cfr. Ibid. 13 Cfr. Ibid. 14 Cfr. S. GASPARRI-C.LA ROCCA, op. cit., p. 23. 15 Cfr. J. M. H. SMITH, op. cit., p.17. 16 Riguardo il linguistic turn, cfr. S. GASPARRI-C. LA ROCCA, op. cit., p.21. Per l'archeologia, cfr. ivi, p. 20.
l'apporto effettivo ed imprescindibile dell'eredità romana17. Del resto, ciò che viene comunemente detto
alto Medioevo può essere inteso come un periodo senz'altro post-imperiale, ma nient'affatto post-
romano18: le strutture amministrativo-governative, così come gli influssi giuridici, permasero –
disomogeneamente – per quasi cinquecento anni su vaste aree territoriali.
Il tentativo di integrazione degli aspetti ideologici con quelli materiali si snoda in quattro sezioni,
ognuna composta da due capitoli. I primi due costituiscono 'le regole fondamentali' dei successivi: chi
sapeva o poteva scrivere, le lingue utilizzate nella sporadica documentazione e nel parlato, il fenomeno
dell'alfabetismo locale e del latino come strumento di potere; ma anche le relazioni con l'ambiente,
rilievi demografici, adattabilità al cambiamento climatico-meteorologico, rapporto con la morte e con la
vita, e ritualità cristiana in risposta agli imprevedibili fenomeni atmosferici. Il terzo e il quarto, invece, si
concentrano sulla trama di relazioni interpersonali, per mostrare come legami di parentela e amicizia, da
un lato, e differenze di genere, dall'altro, potessero organizzare la vita sociale e riflettersi – nonché
influenzare – nelle forme di potere e di governo19.
Ciò che ora ci preme è compiere una ricognizione lungo l'opera di Smith, fornendo una visione
generalissima della condizione femminile nell'alto Medioevo, così come da lei rilevata. Tenteremo alcuni
innesti con il testo di Tiziana Lazzari. Ci soffermeremo poi sul caso di donne votate alla vita monastica,
indagandone prima – checché se ne possa pensare – il curioso rapporto con le unioni matrimoniali; poi
toccheremo la delicata questione dell'eredità e delle donazioni alle abbazie. Quest'ultimo punto
proveremo ad argomentarlo rifacendoci alla vita di Ildegarda di Bingen. Sottesa a ciò, naturalmente, è la
volontà di capire cosa spingesse una donna a scegliere il chiostro o, ancor meglio, una famiglia a
destinarvela.
2. Le donne nell'alto Medioevo. Uno sguardo generale.
Essere donna tra V e XI secolo voleva dire essere succube di un regime di ristrettezze e limitazioni
giuridiche20, nonostante la situazione si facesse più sfumata col progredire dei secoli, a seconda della
zona. A volte capitava persino che, in luoghi di confine, la maggiore autonomia rilasciata alle donne
della popolazione vicina da una giurisprudenza con radici in tradizioni differenti, potesse arrivare
lentamente a modificare le più severe disposizioni in materia delle aree limitrofe. Non solo. Essere
donna significava rimanere coinvolta in un ciclo vitale che, contrariamente a quello maschile, si
configurava come maggiormente standardizzato e sicuramente meno variegato. La fissazione della
17 Cfr. J. M. H. SMITH, op. cit., p. 18. 18 Ivi, p. 12. 19 Ivi, p.15. 20 Ci riferiamo implicitamente a un testo su tutti: l'Editto di Rotari, riportato anche da Tiziana Lazzari come esempio
emblematico di politica di limitazione ai danni delle donne. Tra i punti trattati nel documento, ricordiamo l'impossibilità di una disposizione autonoma del proprio mundio (selpmundia), il dovere di chiedere il consenso del mundualdo per questioni concernenti la cessione o donazione di terreni, ma anche la piena potestà di poter scegliere nel mundio di chi entrare. Se la donna non aveva parenti maschi, entrava nel mundio del re. Rotari utilizza questa breccia giuridica come pretesto per l'ingresso del sovrano nella disposizione del patrimonio delle vedove. Cfr. T. LAZZARI, Le donne nell'alto Medioevo, Milano: Bruno Mondadori, p. 92.
maggiore età sulla soglia del dodicesimo anno, almeno nelle disposizioni longobarde, sanciva il
passaggio dall'infanzia alla potenziale vita matrimoniale. Per le fortunate cui il cielo concedesse una vita
lunga, poteva persino darsi il lusso di un ulteriore passaggio, quello dalla maternità alla vecchiaia21.
L'aumento demografico, non registrabile prima del X secolo, diveniva possibile soltanto quando
il tasso di natalità superava, per un certo periodo, quello della mortalità. Quest'ultimo restava
invariabilmente elevatissimo. Le scarse condizioni igieniche dei luoghi di parto e i metodi precari
d'assistenza medica alle partorienti innalzavano vertiginosamente il numero delle morti bianche, nonché
il numero delle donne che con esse trovavano la loro. Lo studio dei cimiteri dell'Inghilterra sudorientale
tra V e VIII secolo, in particolare quello di Buckland, stimano che il numero dei decessi femminili in età
fertile superasse quello degli uomini in un rapporto 3:222. L'archeologia delle sepolture può dire molto
sullo status sociale dei soggetti tumulati: l'abbigliamento veicolava «messaggi importanti riguardo al
rango, alla ricchezza, all'età e al genere», poiché «il codice maschile e femminile in materia […] rimasero
universali»23. Se la disposizione degli oggetti di sepoltura era una risposta proporzionale alla gravità della
perdita di un membro del clan famigliare, i dati ottenuti rivelano che «donne in età da marito o fertili e i
guerrieri a capo di gruppi parentali fossero più preziosi per le loro famiglie»24.
L'apporto femminile era così indispensabile per la trasmissione della stirpe e del suo buon
nome, che una cattiva condotta sessuale – di cui spesso la donna veniva tacciata per via della sua
mollezza etimologico-fisica e, quindi, morale25 - poteva gettare in discredito l'intera parentela. Per via di
questa inscindibile unione tra pratiche sessuali e onore, quanto prescritto dai codici sembra riguardare
molto più le donne che gli uomini. Per converso, una giusta disposizione del proprio corpo poteva
contribuire in maniera positiva alla perpetuazione di una reputazione onorevole26.
Le variazioni delle consuetudini onomastiche dicono qualcosa attorno al rango sociale della
donna. L'usanza romana nell'assegnazione dei nomi seguiva una linea unicamente patrilineare. Il IV
secolo fu scenario di usi più fluidi, come nel caso di Gregorio di Tours, il cui nome – il terzo nella
dicitura completa – rimandava al nonno paterno, vescovo e santo. Le influenze germaniche del V,
invece, diedero luogo alla pratica di fusione dei nomi: il primo figlio di Etelstan e Wulfgifu prese il
nome di Wulfstan, crasi di quelli paterni27. I VI secolo e la necessità di legittimazione mediante il ricorso
ai grandi nomi della stirpe condusse all'identificazione mononominale del soggetto.
Nonostante ciò, permanevano disparità di genere marcate e, per la mentalità del tempo,
ineliminabili. La capacità giuridica delle donne restava limitata e l'Editto di Rotari ne è un esempio
significativo. Il fenomeno dell'alfabetismo partecipativo – che, mediante la presenza di un funzionario,
21 Cfr. J. M. H. SMITH, op. cit., p. 159. 22 Cfr. Ivi, p. 93. 23 Ivi, p. 160. 24 Ivi, p. 161. 25 Nelle Etimologye, Isidoro fa derivare vir da vis e mulier da mollier. Cfr. ivi, p. 164. 26 Ivi, p. 140. 27 Cfr. Ivi, p. 124.
consentiva ad illetterati e analfabeti di prender parte al vasto mondo delle testimonianze giuridiche –
permette di allargare la visuale. Il caso del Placito di Trento mostra come tale cultura considerasse «sia
la testimonianza verbale di testimoni oculari di sesso maschile sia le registrazioni documentali adeguati
mezzi di prova del diritto proprietario o di risoluzione di una controversia»28. Tuttavia, casi come quello
del documento sottoscritto da Roiantken, moglie di Deurhoiarn, testimonia che, «nella misura in cui le
donne sposate disponevano di terre proprie o erano determinanti nel quadro di una più ampia strategia
famigliare riguardante la gestione immobiliare, esse erano in grado di sottoscrivere e convalidare gli atti
in congiunzione con un marito o con un figlio»29. Non dobbiamo, tuttavia, pensare che esse potessero
disporre dei propri possedimenti in totale libertà. Basti pensare ai limiti imposti dall'ineludibile
istituzione del mundio, o alle restrizioni alla possibilità di partecipare alle assemblee giuridiche.
Esse, infine, lavoravano. Ripartivano il proprio tempo e le proprie energie in occupazioni di cura
e supporto alle attività di mariti, padri e figli, ma anche in impieghi liberamente scelti, che
assecondassero le proprie inclinazioni30. Il lavoro rurale si articolava in specifiche mansioni per lo più
domestiche. Filavano, tessevano, lavoravano d'ago. L'educazione, quando non si trattava di figlie di
ricchi possidenti, era dominio esclusivo delle candidate alla vita monastica. Su di esse desideriamo ora
concentrarci; sul loro rapporto o non-rapporto con gli uomini, e su quello con i beni terreni, all'interno
di strategie di potere.
3. Le donne e la vita religiosa
3.1 Il chiostro e le unioni
La scelta di soffermarci sulla vita religiosa potrebbe farci ritenere dispensati da una digressione sul sacro
vincolo del matrimonio o, per utilizzare un'espressione del diritto romano, sul connubio31. Le fonti
narrative, più che i documenti formali, ci mettono in allerta da ogni liquidazione sbrigativa. Intendere
l'ingresso in monastero come il frutto di una libera scelta, o, ancor di più, come il frutto di una scelta
unicamente religiosa, sarebbe a dir poco sbagliato. Al di là dei casi fortunati o eccezionali, come poteva
essere quello di Ildegarda di Bingen, diversi e disparati fattori concorrevano a forgiare una decisione
simile. Un intreccio di politica, disposizioni ereditarie e tentativi di fuga da obblighi della consuetudine
o dal fisco regio, inficiavano l'autenticità della consacrazione a Dio. Il criterio con cui un donna
contemporanea può decidere di compiere questo passo in libertà non è metro di valutazione valido per
l'altomedioevo.
Abbiamo già incontrato, relativamente ai cicli vitali dei soggetti femminili, il giogo opprimente
28 Ivi, p. 101. Smith non cita espressamente il Placito trentino. Il corsivo è nostro. 29 Ivi, p. 63. 30 Cfr. T. LAZZARI, op. cit, p. 105. 31 L'espressione 'sacro vincolo del matrimonio', accanto ad un richiamo al diritto romano, può sembrare del tutto
improprio. Il connubio di cui parla Isidoro (cfr. Ivi, p.32), dalle radici pienamente piantate nel diritto imperiale, subirà successive e graduali modificazioni. La politica ecclesiastica circa il vincolo matrimoniale unico ed eterno esercitò la sua influenza ben più tardi. Si pensi al condizionamento che determinò nelle scelte matrimoniali della stirpe carolingia, dopo aver ripetutamente condannato le pratiche sessuali merovingiche.
di una tradizione radicata: sposarsi e fare figli era la prassi. Qualcuno, tuttavia, poteva ribellarsi e cercare
una scappatoia per non sottostare al dominio del consueto; in tale eventualità, la scelta monastica
poteva definire i suoi contorni in qualità di giustapposizione al vincolo matrimoniale, o come tentativo
di contrasto con esso. Il tema dell'aperto rifiuto dello sposalizio è rintracciabile nei drammi di Rosvita,
canonichessa del cenobio sassone di Gandersheim. L'«unica via lecita per sottrarsi alla propria
situazione di soggezione» era quella che «si legittimava attraverso la scelta della castità»32. Ed è proprio
questa che porta Rosvita a mettere in bocca alla vergine e martire Irene, in risposta alle minacce di
Sisinnio, parole irriducibili:
Meglio un corpo contaminato da non importa quali oltraggi, che un'anima corrotta dagli idoli
pagani33.
Qui l'avversione al paganesimo è l'avversione al potere coercitivo mascolino. La sintonia con il pensiero
cristiano è simbolo di una decisione autonoma di rifiuto, l'emblema di una ribellione che non conosce
freno. Due aspetti abbiamo lasciato in sospeso; tentiamo di riprenderli e svilupparli.
Rosvita di Gandersheim era una canonichessa. Le sectimoniales, questo il termine latino, erano
membri di comunità femminili che non seguivano la regola monacale. Indossavano abiti laici, avevano
servitù al seguito e godevano sia di ampia libertà di movimento sia di un cospicuo patrimonio
personale34. Ciò ci permette di rilevare un secondo movente di scelta ecclesiastica: la vedovanza. Le
donne che perdevano il marito, se in età avanzata, optavano per la vita claustrale. Qui, invero, c'è molto
di più. Alcuni snodi delle Leggi di Liutprando ci fanno dedurre che fosse pratica ricorrente quella
dell'ingresso in monastero senza pronunciamento di voti perpetui. Le motivazioni che potevano indurre
a ciò sono arginabili a un tentativo di non contrarre nuove nozze o a quello di disporre in autonomia
del proprio mundio, dunque del proprio patrimonio35. Ciò spiega l'urgenza delle disposizioni del re
longobardo, atte a tutelare il patrimonio dei figli e ad impedire il caso di selpmundio, già espressamente
vietato dall'Editto di Rotari, suo predecessore: «[...] se ha figli, sotto il cui mundio ella si trova, o delle
figlie, entri in monastero con metà dei suoi beni»36.
Non solo. Liutprando pretendeva che non si utilizzasse l'espediente monastico come sorta di limbo per
poi tornare alla vita sociale: «In merito a quelle donne che prendono il velo della santa religione [...]o
scelgono autonomamente di indossare l'abito religioso o la veste monastica, [...]non osino poi in alcun
modo far ritorno alla vita o all'abito secolare»37.
32 Ivi, p. 64. 33 Ivi, p. 72. Per una questione di trasparenza bibliografica, avendo consultato le fonti unicamente attraverso il testo di
Tiziana Lazzari, ogni riferimento che faremo rimanda al corpus da lei raccolto. 34 Cfr. Ivi, p.69. 35 Cfr. Ibid. 36 Leggi di Liutprando (728) in ivi, p. 83. 37 Leggi di Liutprando (723) in ivi, p. 79.
Se si accosta il connubio al concetto di soggezione, bisogna essere in grado di motivarlo in
modo più articolato di un semplice rimando ad una disparità di genere. La disposizione libera del corpo
di donne di basso rango, da parte dei nobili, era cosa ricorrente e non condannabile. Nonostante i casi
di unioni plurime, attestate persino nel diritto romano mediante la distinzione tra concubinato e
matrimonio, era sempre identificabile una prima moglie38. Prima non necessariamente in senso
cronologico; sicuramente in senso relativo al lignaggio. Persino in Irlanda è attestata la presenza di un
cétmuinter39. Per colei che figurava come tale, la vita non era più facile rispetto alle altre; tanto meno sotto
il profilo della disposizione dei beni. Le popolazioni di lingua germanica conoscevano l'espressione
'autorità coniugale': l'uomo la esercitava sulla donna in virtù del contratto matrimoniale, grazie al pieno
trasferimento del mundio paterno nella sua giurisdizione. Poteva darsi il caso che qualche vedova,
ancora in età da marito, volesse deliberatamente fuggire da seconde nozze. E' il caso di Gerberga;
l'aneddoto che la vede protagonista è riportato da Rosvita. Alle insistenti pressioni dello sposo
promesso, Gerberga, «che per sua volontà si era consacrata in segreto a Cristo»40, contrappose il suo
abbandono allo Sposo celeste. Ciò costituiva l'unico mezzo per la frantumazione dell'obbligo di
maritarsi, poiché «nessun superbo può nulla contro Dio»41. Tuttavia, sulle motivazioni profonde della
consacrazione al Cristo non possiamo permetterci di congetturare alcunché.
L'unione era presenza spettrale tra le mura dei monasteri. Per quanto visto, la stessa scelta
monastica può trovare piena spiegazione per lo più in risposta all'istituzione del matrimonio – oltre che
alla volontà di una libera disposizione dei propri beni42. L'icona della natività che si trova nel codice di
Hitda, databile tra il 1000 e il 1020, è un'opera della scuola di Colonia. In esso diversi stili vengono a
mescersi. Tra tutti, impossibile non notare il gusto bizantino nella costruzione della scena43. Una Maria
ricurva su se stessa, intristita dallo sforzo e dalla condizione della solitudine, sembra dare forma
pittorica a quella descrizione che Kierkegaard, circa otto secoli più tardi, darà della Vergine: ella non è
da intendersi come una donna aristocratica, un semidivinità dalle pallide mani, che si diverte a giocare
con il Figlio dell'Altissimo; bensì piuttosto come colei che seppe sopportare come donna il peso
sovrumano della Chiamata. Maria non è più il centro mistico dell'icona; è lo stigma della durezza della
vita materna e delle sue conseguenze. « Concepita in un ambiente tutto femminile formato da donne
che, in buona misura, quella esperienza potevano aver vissuta prima di aderire alla vita religiosa, poteva
servire da monito per le appartenenti alla comunità che, in età più giovane, ancora dovevano operare
38 Cfr. J. M. H. SMITH, op. cit., p. 167. 39 Cfr. Ivi, p. 171. 40 ROSVITA DI GANDERSHEIM, Le origini del monastero di Gandersheim (970), in T. LAZZARI, op. cit, p.73. 41 Ibid. 42 Il mundio è giuridicamente definibile come una giurisdizione protettiva da parte dell'uomo. Il mundio diviene così sinonimo
di libertà. Essere selpmundia vorrebbe dire poter godere dei propri patrimoni in autonomia, oltre che dei propri diritti; il godimento dei beni, dunque, combacia con la fruibilità della libertà. Pertanto, bisogna probabilmente avvedersi da ogni valutazione puramente utilitaristica nello studio sulla presa di possesso dell'eredità.
43 Cfr. Ivi, p. 67.
scelte importanti per la loro vita futura»44.
Ildegarda di Bingen entrò a Disibodenberg in tenera età. Assegnata alle cura di Jutta, che viveva
come eremita in una cella afferente al monastero, disse il suo più convinto 'sì' a ciò a cui,
probabilmente, la famiglia l'aveva destinata. La nobile origine e le occupazioni dei fratelli possono
aiutarci a capirne di più su tale ricorrenza, nonché su eventuali interessi patrimoniali ad essa associati.
3.2 Il chiostro e l'eredità. Ildegarda di Bingen
La questione dell'eredità permette l'affiancamento della vita monastica ad un'altra unione: quella dei
genitori. Le figlie, in qualità di potenziali eredi, traevano la legittimazione per l'eventuale godimento del
patrimonio familiare unicamente dalla validità del vincolo matrimoniale di cui erano frutto. Di certo
non possiamo permetterci qui una dettagliata digressione sulla giurisprudenza dei connubi; ciò che ci
importa rilevare è che soltanto il matrimonio ufficiale – e non il concubinato riconosciuto dal diritto
romano o le altre forme gregarie di unioni della tradizione germanica e irlandese – abilitava alla
trasmissione di beni45. Così per la dote della moglie, che entrava nelle casse del marito; e così per il
passaggio delle proprietà a quei figli che, mediante il riconoscimento dell'unione legittima dei genitori,
rientravano nel diritto privato.
Ildegarda di Bingen fu monaca benedettina presso il monastero di Disibodenberg e poi badessa
presso quello di Rupertsberg, di cui fu fondatrice. «Difficilmente» sarebbe arrivata a ricoprire tale ruolo,
« se non avesse portato un nome così altisonante»46. Il padre era amministratore dei beni della cattedrale
di Speyr. Membro della nobiltà, godeva di terre in piena proprietà. Con un linguaggio più conforme al
primo lavoro su feudo e beneficio, lo potremmo definire un allodiero. In virtù di una disposizione dei
terreni che non era quello dell'usufruttuario, non aveva alcun obbligo di chiamata militare47. Detto ciò, è
possibile comprendere il salvacondotto che il Barbarossa rilasciò al monastero di Rupertsberg, e la
possibilità concessa alla giovane consacrata di incontrarlo personalmente48.
Ildegarda era la decima figlia di Hildebertus e Matilde. Non disponiamo di informazioni adeguate
circa i destini di tutti i fratelli e le sorelle. Roricus fu sacerdote e canonico presso Tholey, nel Saar. Ugo
fu cantore del duomo dell'arcivescovo di Magonza. La sorella Clemenza la seguì, come consorella, negli
spostamenti da un monastero all'altro. Una tra Jutta, Odilia e Irmingarda, si sposò. Il fratello maggiore,
Drudwin, ereditò tutti i beni; alla sua morte, i fratelli, di comune accordo, li donarono a Rupertsberg49.
Quest'ultimo dato è oltremodo importante, poiché rivela una consuetudine o una strategia comune al
tempo. Per non frammentare il patrimonio, il possedimenti famigliari venivano trasferiti in toto al
primogenito maschio. Le famiglie miravano a «conservare il proprio status con il passare delle
44 Ibid. 45 Cfr.. J. M. H. SMITH, op. cit., pp. 124-125. 46 R. TERMOLEN, Ildegarda di Bingen. Biografia, Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2001, p. 59. 47 Cfr. Ivi, p.61. 48 Cfr. Ibid. 49 Cfr. Ivi, p.62.
generazioni, che era in gran parte in funzione della ricchezza disponibile»50. Sappiamo che le procedure
per l'eredità, diversificate per beni mobili e immobili, non escludevano di principio la possibilità di una
suddivisione della proprietà. Allo stesso tempo, sappiamo che il diritto femminile al patrimonio era
estremamente variabile a seconda della zona.
Si conobbe una seconda strategia per mantenere il patrimonio in orbita attorno al fulcro
famigliare, senza permettere alle vie collaterali di disperderlo. Termolen, studiosa di Ildegarda, ci dice
che, il più delle volte, « le decisioni paterne di avviare il figlio alla carriera ecclesiastica erano determinate
da motivi prettamente religiosi»51. Qualche battuta prima, però, si era affrettata ad apporre un
chiarimento doveroso: « Anche motivi economici e politici, tuttavia, potevano essere argomenti validi
per decisioni di questo genere», poiché «l'eredità […] non si poteva dividere a piacere»52. Era normale
che i genitori, assecondando le naturali inclinazioni dei figli, potessero destinarne alcuni alla vita
religiosa, sgravando il nucleo famigliare dal rischio di potenziali conflitti. In molti casi, probabilmente, si
trattò di qualcosa di più di un semplice 'assecondare'.
Il caso di Thietmar di Merseburg, nell'ultimo trentennio del X, e quello dei figli di Everardo,
marchese del Friuli, alla metà del IX, parlano chiaro. E' possibile leggerli, da un lato, come una sorta di
limitazione del numero degli eredi; dall'altro, come strategia per garantirsi – oltre la successione
dinastica, incarnata nei figli destinati alla vita matrimoniale – anche la soddisfazione dei bisogni spirituali
della famiglia53. La porzione di eredità ed essi destinata fluiva direttamente nella casse del monastero,
pagando di fatto il prezzo della commemorazione spirituale della famiglia nell'aldilà e non finendo
dispersa nel patrimonio di qualche genero. Interessante rilevare come questa consanguineità della
preghiera, già a partire dall'VIII, fosse l'unico momento in cui la cura dell'anima abbatteva ogni disparità
tra uomini e donne54.
Ildegarda fu eccezione, poiché probabilmente il buon cuore di suo padre non era ottenebrato
dalla ricchezza e da calcoli utilitaristici. Scelse il convento per garantire alla figlia una formazione ottima.
Se è vero che – in quanto decima e viste le difficoltà del parto – , si scelse di donarla come 'decima' a
Dio, su ciò non ci è concesso discorrere55. Ildegarda fu oltremodo fortunata, poiché poté dare l'assenso
del cuore a quanto destinata. Ella, con eco simile a quello di Liutprando, così ammoniva
amorevolmente le consorelle: « [Colei] che sceglie questo genere di vita, non vi entri in maniera
sconsiderata, nello stato di un uomo che si sia appena svegliato dal sonno, ma prima rientri in se stesso;
esamini e scruti nel profondo del suo animo se è in grado di perseverare nel suo proposito»56.
50 J. M. H. SMITH, op. cit., p. 189. 51 R. TERMOLEN, op. cit., p.71. 52 Ivi, p. 70. 53 Cfr. J.M. H. SMITH, op. cit., pp. 189-190. L'espressione 'limitare il numero di eredi è da Smith legata all'utilizzo di
contraccettivi. Non lo avremmo legato a Thietmar, se i paragrafi non fossero conseguenti. 54 Cfr. Ivi, p.126. 55 Cfr. R. TERMOLEN, op. cit., p.63. 56 Ivi, p. 71.
4. Conclusioni
Molteplici potevano essere le motivazioni della consacrazione alla vita ecclesiastica. Il più delle volte,
non erano nemmeno i singoli individui a scegliere la reclusione. La vita monacale poteva forse
configurarsi come isola felice per chi al matrimonio preferì lo studio e la contemplazione, ma non di
certo come zona affrancata dalle geometrie politiche e dagli interessi patrimoniali. Re Desiderio, quando
ormai il suo regno era braccato dalle schiere di Carlo Magno, affidò gran parte dei suoi beni alla figlia
Anselperga, badessa della comunità di San Salvatore a Brescia57. Esempi come questi hanno portato
Max Weber a definire la fondazione di monasteri – e, riteniamo noi, anche i meccanismi qui enucleati –
come immobilizzazioni artificiali del patrimonio58.
Bibliografia
1. Opere
LAZZARI T. , Le donne nell'alto Medioevo, Milano: Bruno Mondadori
SMITH J. M. H., L'Europa dopo Roma. Una nuova storia culturale 500-1000 (2005), Bologna: Il Mulino, 2008
TERMOLEN R., Ildegarda di Bingen. Biografia, Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2001
2. Manuali
GASPARRI S., LA ROCCA C., Tempi barbarici. L'Europa occidentale tra antichità e medioevo (300-900), Roma: Carocci,
2013
57 Cfr. T. LAZZARI, op. cit., p.69. 58 M. WEBER, Economia e società (1922), IV, Torino: Edizioni di Comunità, 1999, p. 202.