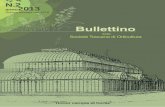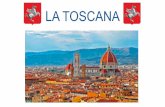L'eredità longobarda: aspetti dell'organizzazione ecclesiastica in Toscana
Transcript of L'eredità longobarda: aspetti dell'organizzazione ecclesiastica in Toscana
CENTRO ITALIANO DI STuDI DI STORIA E D’ARTEPISTOIA
STuDI STORICI PISTOIESI
v
L’eredità longobarda
Giornata di StudioPistoia, 28 settembre 2012
Sala vincenzo Nardi del Palazzo della Provincia di Pistoia
viella
Copyright © 2014 – Centro Italiano di Studi di Storia e d’Arte, PistoiaTutti i diritti riservati
ISBN 978-88-6728-318-7
viellalibreria editrice via delle Alpi, 32 I-00198 ROMAtel. 06 84 17 758fax 06 85 35 39 60 www.viella.it
Giovanni Cherubini, Premessa pag. vII
Stefano Gasparri, I nodi principali della storia longobarda » 1
Natale Rauty, L’eredità longobarda. Pistoia » 17
Mauro Ronzani, La Toscana: aspetti dell’organizzazione eccle-
siastica » 29
Maria Giovanna Arcamone, L’eredità longobarda nella odierna
toponomastica pistoiese » 39
Jean-Marie Martin, L’eredità longobarda: il Mezzogiorno » 63
INDICE
29
Mauro ronzani
La Toscana:aspeTTi deLL’organizzazione eccLesiasTica
devo confessare che ho accettato con molta titubanza l’invi-to — tanto lusinghiero quanto impegnativo — rivoltomi da giovanni cherubini, perché non posso certo definirmi uno «specialista» di storia longobarda e, in confronto ai colleghi che hanno preso o prenderanno la parola oggi, le mie competenze sono davvero assai limitate. cercherò allora di restare all’interno di tali ristretti ‘limi-ti’, concentrandomi sull’unico aspetto sul quale ho effettivamente lavorato un poco: quello dell’organizzazione ecclesiastica, intesa sia come sistema d’inquadramento pastorale della popolazione, sia come rete di edifici cultuali, ciascuno adibito a svolgere una partico-lare funzione.
a prima vista, questa scelta potrebbe sorprendere quanti imma-ginano ancora i Longobardi come «distruttori di chiese», o comunque spregiatori del clero cattolico-niceno, in nome di una fede «ariana» tenacemente proclamata e difesa. sta di fatto, però, che la storiogra-fia è sempre più incline a ‘ridimensionare’ la portata dell’arianesimo dei Longobardi
1; mentre la documentazione scritta giunta sino a noi (ossia, sostanzialmente, quella del secolo Viii) ‘pullula’ letteralmente di chiese, chierici ed edifici sacri, e trasmette l’immagine di una so-cietà saldamente inquadrata entro gli schemi religiosi e organizzativi del cristianesimo cattolico. al punto che, dopo il 774, il sistema d’in-quadramento pastorale vigente in tutto il Regnum Langobardorum, fondato sulle plebes battesimali, fu considerato da carlomagno e dai suoi successori uno strumento di grande utilità, la cui tutela fu l’og-
1 Mi limito a citare un lavoro di uno degli autorevoli relatori di questa giornata: s. gasparri, Culture barbariche, modelli ecclesiastici, tradizione romana nell’Italia longobarda e franca, «reti Medievali. rivista», Vi-2005/2 (luglio dicembre), leggibi-le in rete all’indirizzo < http://www.dssg.unifi.it/rM/rivista/saggi/gasparri.htm >.
30
Mauro ronzani
getto di molte norme inserite nei «capitolari italici»
2.in un certo senso, dunque, almeno per questo particolare aspet-
to i Longobardi ebbero il merito di ‘conservare’ e ‘trasmettere in eredità’ alle età successive la situazione che avevano trovato al loro arrivo in italia, la quale — a sua volta — si era delineata fra iV e V secolo, quando si era affermata la distinzione fra l’organizzazio-ne ecclesiastica urbana, guidata direttamente dal vescovo, e quella rurale, costituita da entità territoriali e umane definite parochiae, cia-scuna delle quali era imperniata su un edificio o un fonte battesimale (baptisterium)
3.ebbene, se all’inizio del secolo Viii il termine parochia sem-
bra caduto in disuso (almeno nel particolare significato suddetto), al suo posto ne troviamo un altro, anch’esso di matrice greca, come diocesis (che nell’uso corrente diventava spesso diocia), che indicava esattamente la stessa cosa; mentre l’edificio (o comunque il fon-te) battesimale continuava ad esser chiamato baptisterium, proprio come due o tre secoli avanti. e soprattutto, continuava ad essere ben chiaro che l’appartenenza delle «diocie» ad una determinata sede vescovile era comprovata da una serie di atti regolarmente ripetuti — l’«ordinazione» del prete da parte del vescovo, la consegna an-nuale del crisma, fatta dal secondo al primo, la visita periodica del presule nella «diocia» per impartire la cresima — dei quali era facile conservare o riattivare la memoria, così da costruire una tradizione che non correva il rischio di essere smentita.
È vero che, fra V e Vi secolo, le questioni concernenti l’appar-tenenza di una chiesa battesimale a questa o quella sede vescovile erano, almeno in italia, giudicate e risolte direttamente dal papa,
2 si vedano al riguardo gli studi ormai classici di a. castagnetti, L’organizzazione del territorio rurale nel Medioevo. Circoscrizioni ecclesiastiche e civi-li nella “Langobardia” e nella “Romania”, Torino 1979, pp. 26-30 e, più ampiamente, c. Violante, Le strutture organizzative della cura d’anime nelle campagne dell’Italia centrosettentrionale (secoli V-X), in Cristianizzazione ed organizzazione ecclesiastica delle campagne nell’alto medioevo: espansione e resistenze, spoleto 1982 (settimane di studio del centro italiano di studi sull’alto medioevo, XXViii), pp. 963-1158; ora anche in id., Ricerche sulle istituzioni ecclesiastiche dell’Italia centro-settentrionale nel Medioevo, palermo 1986, pp. 105-265: qui, alle pp. 183-204.
3 per quanto scritto in questo capoverso e nei due successivi, mi permetto di rinviare alle riflessioni da me presentate in M. ronzani, L’organizzazione spaziale della cura d’anime e la rete della chiese (secoli V-IX), in Chiese locali e chiese regio-nali nell’alto Medioevo, settimane di studio della fondazione cisaM, LXi, spoleto 2014, pp. 537-561.
31
La Toscana: aspetti dell’organizzazione ecclesiastica
mentre nel secolo Viii erano passate nella competenza del re, il qua-le — come nel caso della famosa disputa fra i vescovi di arezzo e siena — ne delegava la trattazione ad un proprio missus (di soli-to un notaio); di fatto, però, la decisione finale era nelle mani dei vescovi circonvicini, i quali ci appaiono estremamente attenti a sal-vaguardare il principio (di diretta derivazione tardoromana) che la situazione ereditata dal passato non poteva essere messa in discus-sione per motivi ‘estrinseci’, come ad esempio il modificarsi degli ambiti d’esercizio del potere ‘civile’ dei gastaldi, installati anch’es-si nella città.
così, se gli abitanti dell’ampia fascia territoriale che fu l’ogget-to della famosa controversia del 714-715
4 erano, dal punto di vista civile, «homines senenses», ossia obbedivano agli ordini del gastal-do regio insediato a siena, dal punto di vista ecclesiastico-pastorale essi erano invece «plebs sancti donati», ossia “popolo di fedeli” del-la sede vescovile aretina. certo, il potere politico non era del tutto alieno dall’intervenire nella sfera pastorale. Un paio dei testimo-ni ascoltati nel 715 affermarono chiaramente che il gastaldo senese Vuilerat non aveva esitato a sottrarre la popolazione di alcuni villag-gi della Valdorcia «de plebe clusina», imponendo a quelle persone di non recarsi più a far battezzare i bambini presso s. Felice (chiesa battesimale dipendente appunto dal vescovo di chiusi). essi, allora, cominciarono a servirsi dei «battisteri» aretini più facili da raggiun-gere: s. Vito, s. Quirico, s. Maria di cosona
5.Quest’ampia possibilità di scelta, rivendicata con un certo or-
goglio dai nostri testimoni, indica che in età longobarda l’assetto pastorale non era ancora così rigido e ‘bloccato’ come sarebbe di-ventato nei secoli successivi, certo in conseguenza dell’obbligatorietà del versamento delle «decime»
6. Ma soprattutto, suggerisce che, al-meno in quella zona, all’inizio del secolo Viii la rete delle chiese
4 Codice Diplomatico Longobardo [= CDL], i, ed. L. schiaparelli, roma 1929, nr. 17, pp. 48-51, 19-20, pp. 61-84. Ulteriori particolari e rimandi bibliogra-fici in M. ronzani, L’organizzazione ecclesiastica in età longobarda, in Arezzo nel Medioevo, a cura di g. cherubini - F. Franceschi - a. Barlucchi - g. Firpo, roma 2012, pp. 41-44.
5 CDL, i, nr. 19, pp. 70-71.6 si vedano al riguardo le osservazioni di g. andenna, Pievi e parrocchie in
Italia centro-settentrionale, in Pensiero e sperimentazioni istituzionali nella «societas christiana» (1046-1250), atti della XVi settimana internazionale di studi medioeva-li, a cura di id., Milano 2007, pp. 371-403: pp. 373-380.
32
Mauro ronzani
battesimali rurali era già piuttosto fitta. difficile dire da quanto tem-po lo fosse: i testimoni che proclamavano di appartenere alla «plebs sancti donati» avevano tutto l’interesse a far risalire tale assetto il più indietro possibile nel tempo. altrettanto difficile è pronunciarsi in merito alla ‘rappresentatività’ dell’area così eccezionalmente illu-minata dai documenti del 715. Ma se, come sembra di desumere da queste fonti, era ormai normale, a quell’epoca, che tutti o qua-si i bambini fossero battezzati (e magari fossero in seguito cresimati dal vescovo), non possiamo credere che per far ricevere loro que-sti sacramenti i famigliari dovessero affrontare viaggi eccessivamente lunghi o particolarmente disagevoli.
i testimoni del 715 affermarono peraltro che nuovi fonti batte-simali erano stati consacrati negli ultimi tempi dal vescovo di siena, come per imporre una sorta di ‘fatto compiuto’; ma tale comporta-mento fu condannato dai quattro vescovi riunitisi presso la chiesa di s. genesio (nel Valdarno, sotto l’attuale s. Miniato) il 5 luglio 715. essi negarono al ‘confratello’ senese adeodato la facoltà di «fontis adversus fontis faciendum, […] plebes subtrahendum, […] nec ul-lam ordinationem […] fatiendum» all’interno del territorio da lui reclamato, che era presidiato da ben 19 baptisteria sottoposti da tempo immemorabile alla sede vescovile aretina
7. come è noto, il presule adeodato, oltre che basarsi sull’effettiva dipendenza di quel territorio dal gastaldo di siena, ricondusse l’ingerenza dei vescovi di arezzo ad un lungo periodo di sedevacanza sofferto dal vescova-to senese; e il presule aretino Luperziano gli ribatté che «dall’epoca di rotari in poi la chiesa senese aveva sempre avuto un vescovo», ma quella di arezzo aveva continuato, fino al presente, a consacrare chiese e battisteri e «ordinare» gli officianti, come aveva fatto, del re-sto, «antea a tempore romanorum»
8.La storiografia ritiene, appunto, che con il re rotari (636-652)
fossero definitivamente superati i problemi causati all’organizzazio-ne ecclesiastica territoriale dall’arrivo e dall’affermazione in italia dei Longobardi; ma è sempre più prudente nel valutare le presunte al-terazioni dei confini diocesani che si sarebbero verificate fra Vi e Vii secolo. come è noto, a lungo si è trascinata una vera e propria ‘querelle’ erudita riguardo all’appartenenza ecclesiastica e civile del-la Valdinievole prima dell’occupazione longobarda; come se, cioè,
7 CDL, i, nr. 20, p. 83.8 Ivi, pp. 80-81.
33
La Toscana: aspetti dell’organizzazione ecclesiastica
la situazione descritta dai due documenti del 700 e del 716 (giuntici peraltro in copie tarde e lacunose)
9, che affermano chiaramente che la giurisdizione della chiesa vescovile lucchese arrivava allora fino al Montalbano (e forse valicava persino il passo di serravalle), potesse essere diversa da quella di un secolo e mezzo prima. È difficile pen-sare che la sede vescovile di pistoia fosse rimasta vacante anche dopo il regno di rotari, fino addirittura al passaggio fra Vii e Viii secolo. più semplice sembra ritenere che, in analogia con quanto sappiamo per siena, in certe zone l’influenza politica e civile di pistoia aves-se ‘debordato’ sulle frange occidentali del territorio diocesano di Lucca. Ma anche in questo caso, il collegio giudicante del febbraio 716, presieduto dal missus regio Urziano, si attenne strettamente al principio che le «diocie» appartenenti da tempo immemorabile ad una sede vescovile (nella fattispecie, quella di Lucca) non potevano essere staccate da questa; al punto che non ritennero di dare alcun particolare peso al fatto che da qualche tempo, per motivi ‘prati-ci’, «la chiesa di s. andrea, con il suo battistero, e la chiesa di s. gerusalemme», notoriamente sottoposte anch’esse alla sede vescovi-le lucchese, fossero officiate da preti inviativi dal vescovo di pistoia.
al di là di tutti i tentativi di identificare e localizzare le chiese menzionate nei documenti del 700 e 716 (e fatto salvo, ovviamen-te, il rispetto dovuto agli studiosi che se ne sono occupati)
10, ciò che sembra davvero degno di nota è la chiarezza con la quale questi do-cumenti affermano l’intangibilità dell’organizzazione ecclesiastica territoriale di matrice tardoantica. È quasi paradossale, allora, che la più vistosa alterazione degli assetti territoriali diocesani che sem-bra verosimile attribuire all’invasione longobarda, ossia l’estendersi dell’autorità della sede vescovile lucchese, a spese di quella pisana, a sud dell’arno e lungo le valli dei suoi affluenti di sinistra, dall’ego-la fino all’era e ai torrenti crespina e orcina, non abbia dato luogo a controversie in età longobarda, ma sia stata, per così dire, ‘tirata fuori’ dalla polvere dei cassetti (o meglio ancora dal buio della me-moria) solo in pieno secolo Xii, quando l’arcivescovo pisano Uberto accarezzò l’idea di lanciare un’offensiva giudiziaria, davanti alla sede
9 CDL, i, nr. 12, pp. 29-32 (700, maggio 21) e nr. 21, pp. 85-87 (716, febbraio).
10 L’intervento più recente ed equilibrato è quello di a. spicciani, Pieve a Nievole medioevale. Una chiesa battesimale lucchese nell’antico territorio di Montecatini Val di Nievole, pisa 2006 (con gli opportuni rimandi alla bibliografia precedente).
34
Mauro ronzani
apostolica, contro tutti i vescovati circostanti. a fondamento delle proprie rivendicazioni, Uberto non addusse però gli scombussola-menti dell’età longobarda, bensì gli effetti, più vicini nel tempo e soprattutto più ‘spendibili’ nel clima del secolo Xii, della sia pur breve occupazione subita da pisa intorno all’anno Mille ad opera dei saraceni, che avrebbe isolato per qualche tempo la città dal re-troterra, scatenando gli appetiti dei vescovi di Lucca, Luni, Volterra e Firenze
11.per tornare alla documentazione di età longobarda, c’è un altro
aspetto che, almeno ai miei occhi, merita di esser posto in evidenza; tanto più che si inserisce perfettamente nel tema di questa giornata di studi. come abbiamo visto, all’inizio del secolo Viii l’importan-za dei vescovi e delle sedi vescovili risulta chiaramente. nel caso di arezzo, una cosa colpisce a prima vista chiunque legga i docu-menti del 714-715: l’identificazione pressoché totale del vescovato aretino con san donato, il vescovo del secolo iV, presso la cui tom-ba, posta sull’altura di pionta a circa un km di distanza dalla civitas vera e propria, il presule in ufficio risiede e opera quotidianamente, sì che tutto il complesso episcopale è chiamato semplicemente «s. donato». come indicato dall’archeologia, questa situazione non era quella originaria del primo impianto della sede vescovile ad arezzo, ma risaliva, probabilmente, al tardo secolo Vi, quando san donato cominciò ad esser venerato come «martire»
12. in ogni caso, all’inizio del secolo Viii la chiesa vescovile aretina era senz’altro posta sot-to l’insegna di san donato, e il vescovo pro tempore officiava sia la chiesa sepolcrale vera e propria, sia un’altra chiesa contigua adibi-ta alla liturgia ordinaria, la cui intitolazione a s. Maria e s. stefano emerge però dalla documentazione solo nel secolo iX.
se volessimo interpretare questa situazione con le categorie
11 La «recordatio» di Uberto fu ‘riscoperta’ e valorizzata da W. Kurze, Un “falso documento” autentico del vescovo Uberto di Pisa. Contributo al problema dei falsi, «Bullettino dell’istituto storico italiano per il Medio evo», 98 (1992), pp. 1-76 (trad. dal tedesco di p. delogu). il saggio è stato ripubblicato in forma in-variata in id., Studi toscani: storia e archeologia, castelfiorentino, società storica della Valdelsa, 2002 (Biblioteca della «Miscellanea storica della Valdelsa», 17), pp. 159-228. Ulteriori considerazioni in M. ronzani, Ancora sulla “recordatio” dell’ar-civescovo pisano Uberto: memoria del passato e rivendicazioni territoriali verso la metà del secolo XII, «Bullettino dell’istituto storico italiano per il Medio evo», 112 (2010), pp. 239-271.
12 cfr. p. Licciardello, Le origini cristiane ad arretium, in Arezzo nell’Anti-chità, a cura di g. caMporeale - g. Firpo, roma 2010, pp. 237-246.
35
La Toscana: aspetti dell’organizzazione ecclesiastica
moderne cui siamo abituati, dovremmo dire che la «cattedrale» di arezzo era allora sul pionta, alquanto distante dalla civitas! Ma una siffatta nozione era estranea alla mentalità del tempo. ciò che im-portava davvero, era identificare la chiesa presso la quale il vescovo risiedeva e che officiava normalmente. Tale legame pressoché esclusi-vo fra persona e funzioni del presule, da una parte, e un determinato edificio cultuale (intitolato ad un determinato personaggio celeste), dall’altra, era naturalmente frutto di una scelta, che — almeno a mio parere — fu compiuta proprio in età longobarda, ed ebbe conse-guenze durevoli, ben evidenti ancora oggi.
nel caso di arezzo, è chiaro che la scelta fu motivata dalla pre-senza (potremmo dire: dalla ‘disponibilità’) dei resti mortali di san donato, la cui tomba diventò così il ‘nucleo’, il ‘cuore’ della sede vescovile aretina; tanto più che il presule pro tempore era, propria-mente, un «successore» del glorioso vescovo donato «martirizzato» da giuliano l’apostata. donde la decisione di stabilire la residen-za episcopale presso la tomba del santo. Una situazione simile non era, d’altronde, insolita nell’italia longobarda: ne resta traccia do-cumentaria per varie città della «Langobardia» vera e propria come novara, Vercelli, piacenza, Bergamo, padova, e altre. nella «Tuscia», essa è sicuramente attestata solo per arezzo (e forse ipotizzabile per chiusi, con riferimento alla chiesa che custodiva le spoglie mortali di santa Mustiola)
13.Ma bisogna aggiungere che il legame fra l’ufficio vescovile e un
edificio cultuale determinato, che nel secolo Vii, e sicuramente già prima, era sentito come qualcosa di normale, o meglio ancora di ne-cessario (vista la difficoltà di ‘maneggiare’ la nozione, di ascendenza romana, di «ecclesia» come persona giuridica), poté instaurarsi an-che a prescindere dalla presenza di un «corpo santo». Lo si vede molto bene a Lucca, dove, appunto all’inizio del secolo Viii, la «chie-sa del vescovo» è senz’altro quella di s. Martino, sì che ogni volta che in atti aventi rilievo giuridico c’è bisogno di riferirsi alla sede vescovi-le, si indica tale chiesa, precisando che lì vi è la «casa del vescovo» (o dei vescovi, considerati nella loro successione regolare e ininterrotta: «ubi est domus episcoporum»), dove, al presente, opera il vescovo X. nella particolare situazione lucchese, assai bene illuminata dalle
13 rimando a quanto osservato in M. ronzani, L’organizzazione territoriale delle chiese, in Città e campagna nei secoli altomedievali, settimane di studio della fondazione cisaM, LVi, spoleto 2009, pp. 191-217: pp. 201-202.
36
Mauro ronzani
fonti, si vede chiaramente che la preminenza di s. Martino non era dovuta a motivi strettamente ‘pastorali’ (giacché i riti battesimali era-no celebrati presso il fonte annesso all’altra chiesa di s. reparata), né era messa in discussione dal fatto che il più illustre e venerato «corpo santo» della città fosse quello del santo vescovo Frediano, custodito nell’omonima chiesa suburbana
14.perché, allora, i vescovi di Lucca scelsero di risiedere accanto a
s. Martino? ebbe forse un ruolo la dedicazione al grande e famoso vescovo di Tours, campione della lotta contro l’arianesimo nella se-conda metà del secolo iV? Questo tipo di considerazioni potrebbe offrirci una spiegazione anche per il caso di Firenze, dove pure esiste-va sin dall’età tardoantica una chiesa ‘pubblica’ dedicata alla martire siriaca reparata, ma, sicuramente già in età longobarda, la sede ve-scovile si identificava con la chiesa di s. giovanni Battista (che allora non era ancora il Battistero che ammiriamo oggi). e potrebbe vale-re anche per pistoia, in tanto in quanto darebbe un senso alla scelta di identificare la sede vescovile con una chiesa dedicata a san zeno, vescovo di Verona coevo di san Martino (e come lui campione della lotta contro l’arianesimo). per onestà, bisogna però aggiungere che la dedicazione a s. zeno della chiesa vescovile pistoiese non è atte-stata prima del secolo X, e fu, per qualche decennio, accompagnata da altri santi titolari
15.resta il fatto che, ancora oggi, le «cattedrali» di Lucca e di
pistoia sono intitolate, rispettivamente, a s. Martino e a s. zeno; e — cosa a mio parere ancor più importante — san donato è tut-tora il «patrono» principale di arezzo, come san giovanni Battista lo è di Firenze. in questi due ultimi casi, il percorso è stato del tutto lineare, sì che il santo titolare della sede vescovile è diventato ‘na-turalmente’ il santo patrono della civitas e del suo autogoverno di stampo comunale; mentre a Lucca e a pistoia la qualifica patronale è stata assegnata a entità celesti diverse — il «Volto santo» nel pri-mo caso, l’apostolo san giacomo il Maggiore nell’altro —, ma pur sempre ‘ospitate’ (per così dire) nel seno della rispettiva chiesa ve-scovile. dopo aver aggiunto, doverosamente, che in altre città come
14 La struttura della chiesa cittadina lucchese alla metà del secolo Viii è ‘fo-tografata’ dalla famosa «chartula iudicati» del vescovo Vualprando, del 2-3 luglio 754: CDL, i, nr. 114, pp. 334-336.
15 cfr. M. ronzani, Il volto cangiante della chiesa vescovile di Pistoia nel-l’età dei conti Cadolingi e Guidi (923-1124), in Culto dei santi e culto dei luoghi nel Medioevo pistoiese, a cura di a. Benvenuti - r. nelli, pistoia 2010, pp. 1-22.
37
La Toscana: aspetti dell’organizzazione ecclesiastica
pisa e siena la «chiesa del vescovo» era, allora come oggi, intitolata a s. Maria (e più precisamente a s. Maria assunta), potrei chiudere questa veloce rassegna con la constatazione che, per tacer d’altro, i Longobardi hanno lasciato in eredità ad alcune città toscane la figu-ra del santo patrono e la relativa festa
16!Ma nella documentazione scritta del secolo Viii c’è molto di più
di quanto sin qui accennato. Un aspetto ben noto è quello dei gran-di monasteri di fondazione regia o aristocratica, come s. salvatore al Monte amiata, s. salvatore di sesto, s. pietro di Monteverdi, e altri
17. Forse un po’ meno nota e soprattutto — fino a poco tem-po fa — studiata solo ‘a spicchi’ o per sondaggi monotematici, è la pratica assai diffusa di fondare e dotare chiese e luoghi di ricetto, documentata dalle carte lucchesi. Qualche anno fa, una tesi di lau-rea diretta da simone collavini e da me ne ha allestito un catalogo completo (purtroppo ancora inedito)
18, che consente di valutare il fenomeno nel suo insieme, e superare così i non pochi luoghi comuni creatisi intorno ad esso. a cominciare dall’illusione di poter selezio-nare il lessico usato nelle «chartae» di fondazione in base a criteri predeterminati: ad esempio, riconoscendo nel termine monasterium la spia di un’attività «missionaria» antiariana ad opera di religiosi fuggiti dal Mediterraneo orientale occupato dagli arabi. in realtà, os-serva elisabetta Mortolini, «non sembrano sussistere caratteristiche tali che, accomunando tutte le ecclesiae monasteria, le distinguano nettamente dalle altre semplici ecclesiae»
19. La precisione termino-logica sarebbe arrivata solo alla fine dell’Viii secolo. analogamente, «se dei 67 istituti privati fondati in Lucchesia tra Viii e iX secolo, solamente cinque sono esplicitamente definiti xenodochium (...) in realtà, le chiese private che attesero a compiti assistenziali furono molto più numerose e diffuse nel tempo e nello spazio»
20. così, nel 764, anspaldo del fu Teopaldo, fondatore di s. Maria in Via, stabilì che il rettore della chiesa provvedesse a sfamare dodici poveri «sicut
16 Ho ripreso qui osservazioni già fatte in La Chiesa e il clero secolare, in Storia della civiltà toscana. I: Comuni e Signorie, a cura di F. cardini, Firenze, cassa di risparmio di Firenze - Le Monnier, 2000, pp. 261-292.
17 d’obbligo rimandare ai lavori di W. Kurze, Scritti di storia toscana: as-setti territoriali, diocesi, monasteri dai Longobardi all’età comunale, a cura di M. Marrocchi, pistoia 2008.
18 e. Mortolini, Fondazioni ecclesiastiche private nel territorio di Lucca tra VIII e IX secolo, Università di pisa, a.a. 2005/2006.
19 Ivi, p. 106.20 Ibidem, p. 108.
38
Mauro ronzani
et in alia senodochia pauperes ad mensa pascere videtur»
21.interessanti anche le risultanze relative alla tipologia sociale dei
fondatori. nel 720, dopo aver compiuto un pellegrinaggio a roma, il «vir devotus» pertualdo fondò a Lucca una «ecclesia vel monaste-rio» di s. Michele, che nel 762 suo figlio peredeo, divenuto vescovo di Lucca, spostò in altro luogo, assegnandogli il compito di sfama-re ogni domenica dodici fra poveri e pellegrini
22. nel 730, invece, lo xenodochio dei ss. secondo, gaudenzio e colombano «in loco apulia» (probabilmente presso l’odierno Baluardo di s. colombano) fu fondato da sichimundo, «venerabilis arcipresbiter» di s. Martino e fratello del vescovo Talesperiano, insieme ai «viri magnifici gasindi regis» Teuperto, ratperto e godeperto
23.per vedere vescovi lucchesi impegnati in prima persona in una
siffatta attività che, prendendo a prestito un termine coniato per l’antichità, potremmo ben definire «evergetismo», dobbiamo però attendere la fine del secolo Viii e l’inizio del iX, con gli episcopati di giovanni (783-800) e di suo fratello iacopo (801-818). al primo di costoro, in particolare, si dovette la «traslazione» delle spoglie mortali di san regolo, dall’omonima chiesa posta in gualdo (presso populonia) alla «chiesa vescovile» lucchese di s. Martino, che otten-ne così il «corpo santo» che finora le mancava
24.La pratica delle «traslazioni» di reliquie e corpi santi, così come la
redazione dei relativi “racconti”, fu indubbiamente una caratteristica dell’età carolingia
25. Ma il longobardo giovanni sapeva sicuramente che, a suo tempo, il re Liutprando si era preoccupato di far traspor-tare le ossa di sant’agostino dalla sardegna, minacciata dagli arabi, a pavia — sede dei monarchi ormai ufficialmente e orgogliosamen-te «cristiani e cattolici» del Regnum Langobardorum — dove furono «riposte» nella chiesa di s. pietro in ciel d’oro
26.
21 CDL, ii, roma 1933, nr. 175.22 Mortolini, Fondazioni ecclesiastiche private, cit., pp. 25-26.23 Ivi, pp. 33-34.24 s.M. collavini, Da società rurale periferica a parte dello spazio politico luc-
chese: S. Regolo in Gualdo tra VIII e IX secolo, in Un filo rosso. Studi antichi e nuove ricerche sulle orme di Gabriella Rossetti, pisa 2007, pp. 231-245.
25 cfr. g. Vocino, Le traslazioni di reliquie in età carolingia (fine VIII-IX seco-lo): uno studio comparativo, «rivista di storia e Letteratura religiosa», XLiV (2008), pp. 207-255.
26 Pauli Historia Langobardorum, in Monumenta Germaniae Historica, Scriptores rerum langobardorum et italicarum, Hannover 1878, L. Vi, cap. 48 (p. 181).