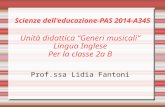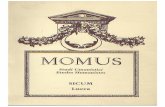Strumenti musicali nelle collezioni siciliane [Musical instrumentas in Sicilian collections], in...
-
Upload
rijksmuseum -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of Strumenti musicali nelle collezioni siciliane [Musical instrumentas in Sicilian collections], in...
cento e l’inizio del Novecento, dal cantante Evan Gorga che ha costituito il nucleo fondamentale del Museo Nazionale di Strumenti Musicali di Roma (CionCi 2004). A queste si aggiungono una note-vole quantità di importantissime raccolte storiche disseminate, da nord a sud, presso conservatori (in particolare quelli di Firenze, Milano, Napoli, Parma e Torino), accademie musicali (Accademie Filarmoniche di Bologna e di Verona e Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma), teatri (in pri-mo luogo il Teatro Alla Scala di Milano) e musei (per esempio le collezioni oggi esposte al Castello Sforzesco di Milano e al Museo Internazionale e Biblioteca della Musica di Bologna).2
Per quanto riguarda la Sicilia, si può ritenere che l’isola sia rimasta sostanzialmente estranea al fenomeno del collezionismo strumentale fino al No-vecento inoltrato. Se si eccettua infatti la collezione del Conservatorio di Palermo − di cui diremo a breve − e la raccolta di strumenti popolari siciliani messa insieme dal demologo Giuseppe Pitrè in occasione dell’Esposizione Nazionale di Palermo del 1891 (si veda al riguardo il contributo di Sergio Bonanzinga in questo stesso volume) tra la fine dell’Ottocento e per buona parte del Novecento, non sembra es-servi stata sostanzialmente traccia in Sicilia di vere e proprie collezioni di strumenti musicali.
Probabilmente per questa ragione, nel 1885 cadeva dunque nel vuoto la richiesta avanzata dal marchese inglese Hamilton all’allora sindaco di Palermo Salvatore Romano Lo Faso:
Mi pregio informarla che il comitato esecutivo per l’Esposizione Internazionale di Invenzioni e di mu-sica che avrà luogo a Londra dal maggio all’ottobre di quest’anno ha stabilito che nella sezione destinata esclusivamente per la musica, vi debba pur essere una collezione storica musicale formata col gentile e solo concorso degli amatori di musica o collettori che fos-sero fortunatamente possessori di istrumenti musicali antichi e moderni […]. Il sottoscritto a nome del co-mitato esecutivo ha l’onore di rivolgere preghiera a V. S. perché voglia colla sua influenza e col suo valido appoggio cooperare in modo che la mostra storica musicale tanto per gli oggetti preziosi ed interessanti che potessero appartenere a codesto Municipio o ad Istituzioni della città che dal Municipio dipendono, quanto per collezioni di privati che fossero a conoscenza della S.V., avesse a riuscire, come si hanno molte ragioni a sperare, interessante ed istruttiva […].3
1.CollezioniSull’onda del fenomeno del collezionismo di
stampo positivistico, tra la seconda metà dell’Otto-cento e l’inizio del Novecento nacquero in Europa e negli Stati Uniti d’America alcune delle più grandi raccolte di antichi strumenti musicali. Tra le più famose si annoverano quella appartenuta al celebre musicologo François-Joseph Fétis, acquistata nel 1872 dal governo belga come nucleo costitutivo della collezione del Conservatorio di Bruxelles (oggi Musée des instruments de musique); l’im-portante raccolta di Mary Elisabeth Crosby Brown, acquisita nel 1889 dal Metropolitan Museum of Art di New York; quella dell’olandese Paul de Wit che fu in parte venduta, tra il 1888 e il 1890, alla Berliner Musikhochschule (oggi esposta presso il Musikinstrumenten Museum); la collezione di Carl Claudius che nel 1897 costituì il primo nucleo del Musikhistorisk Museum di Copenhagen; la raccolta di Francis William Galpin confluita nel 1917 nelle collezioni del Museum of Fine Art di Boston.
In quegli stessi anni in Italia, paese che aveva van-tato fino al secondo Ottocento un ruolo di primaria importanza nel campo del collezionismo strumen-tale, si registrava sostanzialmente una tendenza di segno opposto. Con poche eccezioni, a cavallo tra Otto e Novecento si verificò infatti la dispersione, soprattutto a vantaggio del mercato antiquario inter-nazionale, di alcune delle più importanti collezioni private italiane.1 Caso emblematico è quello della preziosa collezione fiorentina del barone Alessandro Kraus la cui parte più preziosa, dopo essere stata sconsideratamente rifiutata dal Comune di Firen-ze, al quale era stata offerta, fu acquistata in buona parte nel 1908 dal collezionista tedesco Wilhelm Heyer di Colonia che nel 1926 la cedette a sua volta all’Università di Lipsia (Rossi Rognoni 2007).
Nonostante la disgregazione di tante antiche e importanti collezioni private, l’Italia − che ancora oggi continua a essere un bacino privilegiato per il mercato antiquario internazionale di strumenti musicali − ha mantenuto un posto di primo piano per qualità e quantità di raccolte strumentali, alcu-ne delle quali vantano appunto una storia più che secolare. Per limitarci alle collezioni pubbliche, possono essere ricordate la raccolta del musicografo modenese Luigi Francesco Valdrighi, esposta dal 1892 presso il Museo Civico di Modena (LuCChi 1982) e quella messa insieme, tra la fine dell’Otto-
Giovanni Paolo Di Stefano
Strumenti musicali nelle collezioni siciliane
18 Giovanni Paolo Di Stefano
Il modulo allegato alla lettera di Hamilton, con il quale il comitato britannico richiedeva di enu-merare gli strumenti musicali di interesse storico presenti in città, si conserva ancora intonso presso l’Archivio Comunale di Palermo e possiamo proba-bilmente immaginare che l’amministrazione mu-nicipale non ritenne dunque opportuno segnalare alcunché agli organizzatori della manifestazione britannica. D’altronde, di vere collezioni di antichi strumenti musicali, come dicevamo, non si ha so-stanzialmente notizia a quell’epoca né a Palermo né in altri centri dell’isola.4
In realtà, in occasione della mostra di «instrumenti antichi e rari» organizzata nell’ambito dell’Esposizio-ne Musicale di Milano del 1881, furono esposti due esemplari provenienti dalla Sicilia. Si trattava di «un Kinari Vina, con spiegazione del modo di usarlo e con una cassettina di corde acquistate in Calcutta» e di un violoncello di Antonio Stradivari del 1669 che erano stati rispettivamente dati in prestito da Giuseppe Giuliano, direttore del Real Circolo Bellini di Catania, e dall’editore palermitano Luigi Pedone Lauriel: ad ogni modo, i personaggi qui citati non possono essere considerati dei veri e propri colle-zionisti di strumenti musicali (EsposizionE 1881, pp. 41; 45).5 Ovviamente, antichi strumenti erano certamente presenti a quel tempo nell’isola ma non si trattava mai di vere raccolte quanto piuttosto di singoli esemplari, o tutt’al più di poche unità, preser-vati tra gli arredi di antiche dimore nobiliari, presso istituzioni musicali e istituti religiosi e − soprattutto nel caso degli strumenti ad arco − in possesso di musicisti che ne facevano uso a scopo professio-nale: nulla dunque di realmente paragonabile alle importanti raccolte dell’Italia centro-settentrionale o alle grandi collezioni internazionali.
Forse proprio all’assenza in Sicilia di collezionisti, fino ad anni abbastanza recenti, può essere dunque addebitata la dispersione, pressoché totale, del patrimonio strumentale anteriore al XIX secolo di cui rendono invece ampliamente conto le fonti archivistico-documentarie.6
Nelle pagine che seguono cercheremo di fornire una panoramica d’insieme delle raccolte siciliane, di contestualizzarne la storia e di descrivere le ti-pologie strumentali in esse custodite.
Antiche “collezioni didattiche”Come abbiamo accennato sopra, l’unica rac-
colta siciliana ottocentesca di antichi strumenti musicali di cui si abbia notizia, almeno per quanto ci è dato sapere, è quella del Conservatorio di Pa lermo (fig. 1). Come avvenuto in altri conserva-tori italiani, la collezione è il frutto di progressivi acquisti e di donazioni private.
Secondo Federico De Maria, che condusse ricerche presso l’archivio del Conservatorio in epoca precedente alla distruzione provocata da un bombardamento nel 1943, le prime informa-zioni relative all’acquisizione di strumenti mu-sicali risalgono ai primi decenni del Settecento quando:
si erano fatti acquisti di strumenti e di materiale musicale. Una nota di spese del 1721 ci dà notizia di un tale don Nicolò Petrini che fu incaricato dal Deputato priore di comprare a Napoli alcuni strumenti da fiato usati per l’ammontare di onze 9 e tarì 27 […], strumenti che furono messi a nuovo nell’officina dello stesso Conserva-torio. Più furono comprati un violino, corde di ricambio, carta da musica per onze 4 e tarì 4 […], «un cembalo con corde e sordine di rame, un violingello, una viola, altro cembalo con ottava stesa per il contrappunto» [DE MaRia 1941, p. 21].
Qualche altra informazione è fornita da Gaetano Daita in un opuscolo sulla storia del Conservatorio palermitano pubblicato nel 1875:
1. La collezione di antichi strumenti ad arco del Conservatorio di Palermo all’inizio del XX secolo (foto in DE MaRia 1941)
Strumenti musicali nelle collezioni siciliane 19
Un cenno apposito merita anche la collezione di stru-menti d’arco e da fiato che possiede il Collegio, nella maggior parte di costruzione pregevole. Ma fra tutti sono veramente preziosi: un Contrabbasso di Avena [sic] da Palermo ed un Violoncello antichissimo, d’ignoto au-tore, tutti e due donati all’Istituto dalla munificenza del principe di Butera, verso il 1815. Una Viola del rinomato Antonio Stradivario. Un Violino del tedesco Giacobbe Steiner ed altra Viola di Niccolò Amati. I nomi degli autori bastano solo per dimostrare il pregio speciale di siffatti strumenti [Daita 1875, pp. 9-10].7
Alcuni esemplari della collezione furono dunque donati da generosi benefattori. Tra questi, oltre al citato principe di Butera (probabilmente Pietro Lanza) va ricordato il messinese Guido Gaetano Anastasi, «cultore intelligentissimo di musica», che nel 1902, «per spontaneo impulso e sentimento d’arte», aveva regalato al Conservatorio tre antichi strumenti ad arco: un violino tedesco di scuola Steiner, un violino francese di Nicolas Augustin Chappuy del 1759 e una viola napoletana del 1792 realizzata da Giuseppe Gagliano.8
La raccolta, costituita principalmente da stru-menti ad arco, non era comunque stata formata con finalità museali o documentarie ma piuttosto per rispondere alle esigenze “pratiche” di maestri e al-lievi. L’uso che questi potevano fare degli strumenti era disciplinato da tre articoli del Regolamento che il Conservatorio aveva approvato nel 1866:
Art 19. Il Prefetto di musica ha la custodia e la manuten-zione degli strumenti di proprietà del Collegio. È quindi sua cura consegnare agli alunni pria di cominciare lo studio, gli strumenti di cui avrà bisogno […] e di ritirarli dai medesimi alla fine delle scuole.Art. 20. Ove occorrano delle riparazioni od acconciature agli strumenti, ne farà per mezzo del Direttore di musica richiesta al Presidente.Art. 21. Il Prefetto di musica terrà registro degli stru-menti del Collegio in due originali riconosciuti dal Presidente, uno dei quali rimarrà presso il Prefetto, e l’altro da lui firmato sarà conservato nell’archivio dell’Amministrazione. Alla fine di ciascun mese dovrà prender nota degli strumenti divenuti inservibili, e dei nuovi strumenti acquistati, e darne avviso all’Ufficio di amministrazione.9
È evidente che il Conservatorio, fino ad anni recenti, non maturò concretamente l’idea di costituire una collezione di strumenti storici per fini museali. Per questa ragione, con la parziale eccezione degli strumenti ad arco e di alcune arpe, praticamente nulla si è conservato del pa-trimonio strumentale in dotazione dell’Istituto tra Sette e Novecento: non appena ritenuti inser-vibili per l’attività musicale, gli strumenti erano
infatti destinati a essere alienati e sostituiti con modelli più moderni ed efficienti.10 Per esempio, nel 1868 il Conservatorio aveva venduto il suo antico organo a canne − ormai ritenuto inutiliz-zabile − alla parrocchia del paese di Cefalà Diana per rimpiazzarlo con un moderno armonium. Ne troviamo notizia in una lettera inviata dal presidente dell’Istituto all’ufficio del Ministro della Pubblica Istruzione:
Fra gli oggetti compresi nell’inventario trasmesso a codesto Ministero al N° 45 cat. Cappella, trovasi anno-tato un vecchio organo apprezzato per Lire 127.50. Or convenendo tanto negli interessi del Collegio quanto all’utilità dell’Istruzione degli Alunni acquistare invece un acconcio melodium [armonium], il sottoscritto prega il Ministero di voler permettere la vendita del vecchio organo, ed autorizzare che sul prezzo che se ne ritrarrà si faccia la compra del melodium.11
Meno di vent’anni dopo, nel 1885, lo stesso ar-monium, ormai inservibile «per vetustà», fu ba-rattato con uno nuovo.12 Stessa sorte ebbero, tre anni dopo, ventuno strumenti a fiato (tra i quali vi erano presumibilmente anche quelli cui faceva riferimento Daita nel 1875) che furono appunto dati in permuta al costruttore milanese Giuseppe Pellitti per l’acquisto di modelli aggiornati alle più moderne esigenze esecutive. Come infatti comu-nicava al Ministero Vincenzo Merlo, presidente dell’Istituto:
Essendosi resi inservibili i sotto descritti strumenti musicali non solo per vetustà ma ben’anco per la con-seguenza del nuovo corista normale già adottato, ho invitato diversi fabbricanti e negozianti di strumenti musicali di questa Città per tentarne la riduzione non che la riparazione. Essi però mi hanno dichiarato di non essere possibile che detti strumenti si mettessero in accordo col nuovo diapason. Rimanendo dunque inutili all’uso di questo R[eal] Istituto, ed offrendo il Signor Pellitti la somma di £ 105 che è stata la massima offerta del prezzo di detti strumenti, devo pregare la S.V. affinché voglia provocare la debita autorizzazione del Ministero perché si possano barattare pel detto prezzo il quale servirà ad attenuare la spesa di altri strumenti nuovi, già commissionati al detto Signor Pellitti dei quali questo Collegio sente bisogno di provvedersi. Gli strumenti inservibili sono i seguenti e portano il numero dello inventario come appresso: Flauti N° 40, 41, 378, 458; Clarini N° 45, 46, 47, 217, 238, 490, 717, 785; Oboè N° 50, 51, 164, 560; Ottavini N° 69, 371; Fagotti N° 43, 44, 86.13
Tali baratti, che determinarono la dispersione del patrimonio strumentale storico, erano anche dettati dalle perenni ristrettezze economiche in
20 Giovanni Paolo Di Stefano
strumenti a fiato citati nella relazione del D’Arcais non è comunque rimasta oggi traccia.16
Non più felice è stata d’altronde la sorte della collezione di antichi strumenti ad arco del Conser-vatorio − la più importante a sud di Napoli − che, pur essendo scampata al già citato bombardamento che nell’aprile del 1943 distrusse parte dell’Istituto, non è sopravvissuta all’incuria e alla dissennata gestione che, tra la fine degli anni novanta del Novecento e i primi anni del 2000, ha causato la dispersione di una parte consistente di questa pregevole raccolta, «caso limite − come osserva Renato Meucci − di come un patrimonio pubblico della nazione possa purtroppo trasformarsi in una specie di proprietà privata» (MEuCCi 2003, p. 141). Risale dunque all’ultimo ventennio la scomparsa di un numero cospicuo di strumenti ad arco della collezione tra cui una viola di Giuseppe Gagliano del 1792. Un recente progetto di musealizzazione del patrimonio strumentale superstite, attualmen-te in fase di elaborazione, dovrebbe finalmente − almeno così si spera − consentire la tutela e il recupero di quanto rimane di questa importante collezione storica.
Sempre alla seconda metà dell’Ottocento e all’ini-zio del Novecento risalgono le piccole raccolte di altre due istituzioni scolastiche palermitane: il Re-
cui versavano le casse dell’Istituto, come peral-tro testimoniano le estenuanti trattative che il Conservatorio palermitano fu spesso costretto a intrattenere con il Ministero per ottenere i fon-di necessari all’acquisto di strumenti. Ne rende conto la relazione redatta nel 1889 dal marchese Francesco D’Arcais, ispettore ministeriale presso l’Istituto palermitano:
Nessun riordinamento sarà efficace, e neanche possi-bile, se al R. Collegio di Palermo non verrà fatta una conveniente dotazione di strumenti musicali dei quali ora è sprovvisto. Il Consiglio, in seguito a domanda del Direttore tecnico, ha recentemente autorizzato l’acqui-sto di alcuni strumenti da fiato o a corda. Altri però ne occorrono. E innanzi tutto è urgente che si provveda il Collegio del necessario numero di pianoforti. Attual-mente il Collegio non possiede che quattro pianoforti, tre dei quali addirittura inservibili. Uno, il migliore, è un Pleyel non autentico ed ha bisogno di riparazioni, e non può servire neppure esso agli alunni che studiano per intraprendere la carriera del concertista o del pro-fessore di pianoforte. I convittori che attendono a questo studio, sono ora costretti a procurarsi a proprie spese, i pianoforti a nolo. Nelle scuole d’armonia manca pure il pianoforte e per conseguenza, è tolta la possibilità di qualunque esercizio pratico. Nel collegio di Palermo si studia l’armonia teoricamente, ma nessun allievo viene esercitato ad armonizzare un basso sul pianoforte o sull’harmonium, la qual cosa parrà incredibile a coloro che hanno qualche pratica delle musicali discipline. Quando, in forza del nuovo ordinamento, che si vien preparando, si dovrà aggiungere il Liceo al Convitto, e lo studio complementare del pianoforte diventerà obbligatorio per tutti indistintamente gli alunni, come già si fa negli altri Conservatori e Licei, non si avranno a Palermo gli strumenti, che val quanto dire i ferri del me-stiere, per effettuare questa salutare riforma. Il Direttore tecnico è di parere che occorrano almeno sette nuovi pianoforti, uno dei quali di gran formato, per concerti e gli altri di qualità inferiore. Ma a questa dotazione non arrivano le forze del bilancio dell’Istituto e converrà che il Ministero esamini il modo di provvedervi. La spesa per i nuovi strumenti dei quali l’Istituto ha bisogno (sette pianoforti, un harmonium, dieci violini, ecc.) ascenderebbe a circa diecimila lire, e sarebbe fatta per una volta tanto. È opinione del sottoscritto che, senza i necessari strumenti, la progettata riforma resterebbe, in molte parti, lettera morta.14
Quella messa in evidenza dal D’Arcais era una questione annosa dato che le lunghissime trattative per rinnovare lo strumentario, e in particolare per incrementare il numero di pianoforti dell’Istituto, erano state avviate almeno dal 1871.15 Anche di questi sospirati pianoforti − per esempio del citato Pleyel a coda moyen modèl acquistato a Parigi, dopo tante trattative, nella primavera del 1880 − e degli
2. Il teatro dell’Educandato Maria Adelaide in una foto dell’inizio del XX secolo. Sul palco il pianoforte a coda Steinweg, l’arpa Érard e un pianoforte verticale (Archivio dell’Educandato Statale Maria Adelaide, Palermo)
Strumenti musicali nelle collezioni siciliane 21
altre fonti documentarie, nel corso della sua vita aveva avuto occasione di suonarli. Si tratta di una piccola raccolta che tuttavia conta alcuni esem-plari di notevole interesse: uno dei più antichi pianoforti siciliani oggi noti (si veda la scheda 84 del catalogo); l’unico pianoforte verticale a forma d’armadio di costruzione inglese di cui si abbia notizia in Sicilia (scheda 86); un pianoforte a coda costruito a Monaco dalla fabbrica Seiler intorno al 1820 − appartenuto al compositore Mario Bellini, fratello minore di Vincenzo − che presenta una tastiera insolitamente estesa rispet-to ai pianoforti coevi (Fa0-Do7); un pianoforte a coda di fattura catanese dotato di una meccanica tipicamente siciliana (scheda 88); un pianoforte a tavolo viennese di Carl Fuchs che porta sul-la tavola armonica la firma dello stesso Bellini (scheda 90).17
Più o meno agli stessi anni del Museo Belliniano risale l’apertura del Museo d’Arte Teatrale inau-gurato il 1 maggio 1940, presso i locali del Teatro Massimo di Palermo, alla presenza del compositore Pietro Mascagni (ingRassia 1940a e 1940b).18
Il nuovo museo palermitano intendeva pro-babilmente emulare il riuscito esperimento del Teatro Alla Scala di Milano che, nel 1913, aveva appunto costituito il suo Museo Teatrale. Come il
gio Educatorio Maria Adelaide (oggi Educandato Statale) e l’Istituto Sant’Anna, ambedue originaria-mente destinati all’educazione femminile. Anche in questo caso, gli antichi strumenti che oggi si conservano presso i due Istituti − soprattutto pia-noforti e arpe di fattura otto-novecentesca − sono una testimonianza dell’attività didattico-musicale svolta in queste scuole (figg. 2-3).
MuseiRisale invece agli anni trenta del Novecento
l’inaugurazione dei primi due musei musicali sicilia-ni nel cui allestimento furono anche inclusi alcuni antichi strumenti musicali: il Museo Belliniano di Catania e il Museo d’Arte Teatrale di Palermo.
Il primo, tutt’oggi esistente, fu inaugurato il 5 maggio 1930 presso il Palazzo Gravina Cruyllas, casa natale di Vincenzo Bellini, in Piazza San Fran-cesco a Catania. L’allestimento, realizzato grazie al contributo di appassionati cittadini e persino di discendenti di Bellini, consentì la raccolta di auto-grafi musicali, dipinti, cimeli e strumenti musicali legati alla vita del compositore e dei suoi familiari.
Gli strumenti esposti, soprattutto pianoforti, sebbene non direttamente appartenuti a Belli-ni, erano stati in possesso di parenti e amici del compositore il quale, come attestano carteggi e
3. L’orchestrina dell’Istituto Sant’Anna, diretta dal compositore Guglielmo Zuelli, in una foto della fine del XIX secolo. Ben visibili le due arpe Érard ancora oggi in possesso dell’Istituto (Archivio dell’Istituto Sant’Anna, Palermo)
22 Giovanni Paolo Di Stefano
importanza storica (si pensi per esempio al prezioso violino di Girolamo Amati del 1683 conservato nei magazzini del Museo Civico Castello Ursino di Ca-tania, scheda 58) e, nella stragrande maggioranza dei casi, poco o per nulla valorizzato (gran parte degli strumenti versano infatti in cattivo stato di conservazione, molti di essi non sono fruibili al pubblico e giacciono in depositi, praticamente nessuno è stato finora catalogato dalle Sovrinten-denze di pertinenza).
Antiche dimore nobili e notabiliI palazzi dell’aristocrazia siciliana, scrigni di stra-
ordinari tesori artistici, non di rado custodiscono tra i loro arredi anche importanti testimonianze di artigianato musicale. Come è noto, la musica ha infatti svolto, almeno fino all’inizio del XX secolo, un ruolo significativo nell’educazione e nella vita sociale dell’aristocrazia e dell’alta borghesia e gli strumenti musicali − si pensi soprattutto al clavi-cembalo e, dalla seconda metà del XVIII secolo, al pianoforte − sono spesso stati degli immanca-bili quanto irrinunciabili complementi d’arredo e talvolta dei veri e propri status symbol nelle ca-se patrizie (Di stEfano 2011a, pp. 17-27). Basta dunque scorrere gli inventari dei beni mobili in possesso delle più importanti famiglie aristocrati-che dell’isola per rintracciare immancabilmente tra gli arredi anche pregevoli strumenti musicali. Particolarmente preziosi erano per esempio quelli presenti, nel 1629, presso la dimora della nobile Giovanna Branciforti principessa di Pietraperzia: «un cimbalo et una spinetta [...], un milacordio [clavicordo] picciolo, […] una chitarra di ebano, […] uno scrittorio di ebano et avolio istoriato con le sue porte et una spinetta, […] un scrittorio di Alemagna con un organo dentro con una investa [coperta] di velluto verde con due maniche di argento indorati» (Di stEfano 2007a, p. 44). Poco più tardi, nel 1665, il principe Giovanni Valdina custodiva nel suo palazzo di Palermo «un cimbalo plano foderato d’Alacchi [lacche] rossi con passa-mano d’argento, una chitarra di legno […], una chitarra di ebano, un cimbalo grande Romano comprato onze 40 foderato di coiro [cuoio] ros-so con fascetti adorati [dorati] dentro cassa, una spinetta Veneziana [...], un concerto di Viole tutti n. 6 [sei viole da gamba] con suoi archi» (ibidem).
Gli esempi tratti dalle carte d’archivio potrebbero essere numerosissimi, purtuttavia se ci limitiamo a una sommaria ricognizione del patrimonio stru-mentale tutt’oggi presente nei palazzi notabili sici-liani, almeno in quelli accessibili, risulta evidente che gli strumenti che si sono conservati − come abbiamo avuto già modo di sottolineare − sono
museo milanese, anche quello del teatro palermi-tano aveva infatti l’ambizione di illustrare la storia della musica e in particolare del melodramma attraverso l’esposizione di cimeli, di opere d’arte, di abiti di scena, di bozzetti teatrali, di partiture e autografi musicali, di documenti cartacei e di antichi strumenti musicali. Gli oggetti erano stati raccolti grazie al contributo di privati e rintracciati presso altri musei cittadini. Dalle collezioni del Museo Nazionale e della Società di Storia Patria erano per esempio rispettivamente giunti due degli strumenti di maggiore interesse della raccolta: il salterio settecentesco di Giovanni Battista Di Paola (scheda 80) e il pianoforte di Johann Jakesch che la tradizione voleva fosse appartenuto alla regina Maria Carolina (scheda 87).19
La storia del Museo d’Arte Teatrale durò pur-troppo meno di tre anni. Come annotava infatti, nel maggio del 1943, il direttore Giovanni Rutelli «la notte del 15 febbraio una barbara incursione nemica, gettando alcune bombe sulla piazza del Teatro Massimo, colpiva in più punti il colossale monumento del Basile e sconquassava il Museo d’arte teatrale».20 I cimeli − e dunque anche la piccola raccolta di strumenti musicali (per la cui descrizione rimandiamo al Censimento, curato da chi scrive, in coda a questo volume) − furono fortuna-tamente messi in salvo e successivamente trasferiti nei magazzini del Teatro dove sono sostanzialmente rimasti fino ai nostri giorni.
Ad anni più recenti risale l’apertura di altri due musei espressamente dedicati agli strumenti musicali, il Museo Musica e Cultura dei Pelorita-ni, inaugurato nel 1996 presso il Villaggio Gesso, nei pressi di Messina, e il Museo degli Strumenti Etnico-Musicali di Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa, che è stato aperto al pubblico nel 2000. Entrambi i musei − la cui sommaria descrizione è anche in questo caso fornita nel Censimento − sono dedicati agli strumenti etnico-folklorici (alla tradi-zione musicale messinese il primo e principalmente alle culture extra-europee il secondo).
Ancora più recente è il Museo delle Bande mu-sicali di Sicilia − istituito a Ramacca, in provincia di Catania, nel 2009 − che espone una raccolta di strumenti a fiato, principalmente ottoni della fine del XIX e dell’inizio del XX secolo.
A queste piccole realtà museali di taglio pret-tamente musicale si aggiungono una notevole quantità di musei d’arte, archeologici ed etno-an-tropologici che includono nelle proprie collezioni anche strumenti musicali (di questi diamo notizia ancora una volta nel succitato Censimento). Si tratta di un patrimonio disseminato sostanzialmente in tutte le province della regione, talvolta di notevole
Strumenti musicali nelle collezioni siciliane 23
extraeuropei di Fausto Cannone ad Alcamo, in provincia di Trapani).
Sempre ad anni relativamente recenti risale anche la costituzione della collezione di antichi strumenti musicali del flautista Dario Lo Cicero di Palermo. La raccolta comprende una pregevole selezione di strumenti a fiato dei secoli XVIII-XX, in particolare flauti traversi, tra cui spiccano pezzi di assoluto interesse quali, ad esempio, uno dei più antichi flauti in cristallo di Claude Laurent (scheda 40) e un raro flauto discendente al Sol di Stephan Koch (scheda 41). La collezione include anche alcuni antichi strumenti a tastiera, in parti-colare pianoforti di costruzione siciliana (si veda per esempio quello a tavolo descritto nella scheda 85) e strumenti sperimentali e singolari (tra cui un fantasioso salterio a tastiera proveniente dalla celebre collezione del citato barone Kraus di Fi-renze, scheda 83).
Quasi interamente dedicata agli strumenti a tastiera è poi la collezione del cembalaro Ugo Ca-siglia a Cinisi, in provincia di Palermo. La raccolta include pianoforti di costruzione straniera (tra cui una piccola selezione di strumenti a coda, verticali e a tavolo della fabbrica Pleyel di Parigi) e italiana (per esempio della manifattura De Meglio di Na-poli, scheda 89). La collezione comprende anche un raro organo a cilindro dell’inizio del XIX se-colo realizzato a Napoli dal viennese Anton Beyer (scheda 97) e un harmonino della fabbrica Debain di Parigi (scheda 94).
quasi sempre di costruzione successiva all’inizio del XIX secolo. Come abbiamo infatti già accennato, in modo pressoché analogo a quanto avviene oggi nel settore dell’elettronica e dell’informatica, gli strumenti musicali furono macchine sottoposte a continue innovazioni (oltre che ovviamente sog-gette all’inevitabile usura del tempo) e, come i computer dei nostri giorni, furono spesso destinati a essere messi da parte nel giro di pochi anni per essere sostituiti con modelli tecnologicamente più sofisticati, più efficienti in rapporto all’evoluzione dei repertori musicali e persino esteticamente più alla moda.
Generalmente, gli strumenti d’interesse storico che oggi ritroviamo negli antichi palazzi sono stati conservati per il loro fascino estetico e integrati tra gli antichi arredi delle dimore in quanto, oltre a essere degli “arnesi sonori”, ormai spesso non più efficienti, sono anche dei pregevoli mobili: rientrano in questa categoria in primo luogo gli strumenti a tastiera (soprattutto i pianoforti) ma anche le arpe e gli strumenti musicali meccanici di cui si conservano in Sicilia numerosi esemplari di fattura ottocentesca.
Sono per esempio riconducibili alle tipologie strumentali citate le piccole collezioni del museo di Palazzo Mirto a Palermo – che, oltre a pregevoli pianoforti del viennese Mathias Jakesch e della fabbrica parigina Pleyel, custodisce un raro organo a cilindro napoletano di Anton Beyer (Di stEfa-no 2011a) – quella del Castello di Donnafugata nelle vicinanze di Ragusa (dove si conservano pianoforti, tra cui forse il più antico strumento del viennese Conrad Graf, e alcuni pianoforti a cilindro) e ancora le piccole raccolte di strumen-ti antichi di Palazzo Nicolaci a Noto (fig. 4), di Villa Whitaker a Palermo, di Villa Piccolo a Capo d’Orlando ma la lista − che ancora è ben lontana dall’essere completa − potrebbe diventare assai più lunga. Se le dimore appena citate sono state infatti acquisite dalla pubblica amministrazione o sono passate sotto la gestione di fondazioni private che ne rendono fruibili le collezioni, gran parte di questo patrimonio è invece in possesso privato per cui un censimento completo, se non impossi-bile, risulta assai arduo da portare a compimento.
Collezioni privateAbbiamo già visto come la Sicilia sia sostanzial-
mente rimasta estranea al fenomeno del colle-zionismo strumentale fino ad anni assai recenti quando sono state costituite alcune collezioni di interesse etno-organologico (oltre alle raccolte di Gesso e di Chiaramonte Gulfi, di cui abbiamo già detto, va qui citata la collezione di strumenti
4. La sala della musica del Palazzo Nicolaci a Noto (Si-racusa)
24 Giovanni Paolo Di Stefano
e l’anno successivo stabilì con lo stesso una società per la costruzione di strumenti da vendere «tanto nella città di Palermo quanto nelle fiere di questo Regno di Sicilia».23 I tamburelli erano infatti spesso venduti in occasione delle fiere patronali cosicché − come ricordava ancora all’inizio del Novecento Gaetano La Corte Cailler − «qualche mese prima delle feste […] un fervente lavorio» di tamburinai provvedeva a rifornire «in abbondanza il popolo festante» (La CoRtE CaiLLER 1926, p. 117). A Paler-mo, tra Cinque e Seicento, la festa più solenne era quella in memoria della traslazione del corpo di Santa Cristina, almeno fino al 1625 quando Santa Rosalia fu eletta patrona della città. La fiera orga-nizzata in quella occasione, che si teneva nel mese di maggio per quindici giorni consecutivi, era la più ambita dagli artigiani della capitale che già molti mesi prima iniziavano a preparare le proprie mer-canzie che sarebbero poi state esposte in botteghe di legno costruite per l’occasione sul piano della cattedrale (gEnzaRDi 1891, p. 327). Fiere patronali erano comunque organizzate in tutti i principali centri dell’isola.
I tamburelli realizzati dagli artigiani palermitani erano generalmente costruiti in tre misure (grandi, mezzani e piccoli). Per gli strumenti grandi, nei documenti cinque-seicenteschi si incontra spesso il riferimento a tamburelli cosiddetti “di garbuli di larcara”, con diametro maggiore rispetto a quelli ordinari. Presumibilmente, si trattava di grandi tamburi a cornice − garbula è infatti il termine siciliano anticamente impiegato per indicare le cornici di setacci e tamburelli (MoRtiLLaRo 1862, p. 418) − caratteristici del paese messinese di Alcara li Fusi (fino al XVIII secolo detto appunto Larcara, L’Arcara o L’Alcara). All’origine non palermitana di questa tipologia di tamburi a cornice si dovrebbero anche riferire le espressioni «tamburelli magni ut dicitur fora di la porta» e «tamburelli di fora di lu posto», ossia tamburelli grandi provenienti da fuori città, che si incontrano in taluni documenti palermitani dell’epoca.24 Tali riferimenti archivi-stici sembrano essere le più antiche attestazioni su questa tipologia di tamburello di grande formato il cui uso è stato attestato ad Alcara li Fusi fino ad anni recenti.25
Tutti i tamburelli potevano essere dotati di piattini metallici (che negli strumenti più pre-giati avevano forma circolare) e molto spesso presentavano pelli decorate, generalmente con figure antropomorfe, realizzate da pittori che lavoravano al servizio dei tamburinai. Nel 1597 Laura e Mariano Zoida, madre e figlio, vendettero ad esempio a tale Matteo de Vincentio cinquecen-to tamburelli − tra grandi, medi e piccoli − con
Sempre in provincia di Palermo, questa volta a Gangi, si trova la collezione del saxofonista Luciano Inguaggiato che comprende circa sessanta saxofoni costruiti tra il 1866 e la seconda metà del XX secolo.
2.TipologiestrumentaliNelle prossime pagine forniremo un approfon-
dimento sulle principali tipologie di strumenti musicali, soprattutto di ambito culto, documen-tate in Sicilia tra il XVI e il XX secolo e in buona parte dei casi descritte nel presente catalogo (alle cui schede faremo dunque spesso riferimento nel corso della trattazione). Per comodità, l’or-ganizzazione dei sottoparagrafi segue all’incirca lo stesso criterio con cui sono state ordinate le sezioni del catalogo, basate − seppur non sempre rigorosamente − sul sistema di classificazione Hornbostel-Sachs.
Strumenti a percussione idiofoni e membranofoniLa produzione di percussioni in Sicilia fu so-
stanzialmente limitata agli strumenti di ambito popolare e semi-culto. Tamburi, tamburini − spesso impiegati assieme alle trombe per scandire il ritmo delle cerimonie ufficiali, di processioni e cortei − e tamburi monopelle a cornice (i tamburelli detti in siciliano tammurelli o tammureddi) furono ampliamente diffusi nell’isola nel Medioevo an-che se le prime testimonianze archivistiche sulla costruzione di questi strumenti risalgono soltanto al Cinquecento. È a partire da quel secolo che disponiamo infatti di un numero notevole di testi-monianze documentarie. Questi documenti – che pubblichiamo qui per la prima volta e sui quali desideriamo soffermarci – comprovano appunto la straordinaria produzione e diffusione in Sicilia di tamburelli, percussioni suonate in contesti di festa, per accompagnare momenti di danza e per sostenere ritmicamente il suono di altri strumenti.
Nel Rinascimento, la diffusione dei tamburi a cornice è documentata un po’ ovunque in Sicilia. Una delle testimonianze archivistiche più antiche risale al 1542 quando il prete alcamese Bernardo Gulino entrò in società con il pittore Filippo Giuf-fré per realizzare «tamburelli et tampanelli» le cui pelli dovevano essere decorate «cum immagine crucifixi et altri immagini» (CataLDo 1997, p. 63).
A Palermo, nella seconda metà del secolo, fu attiva la bottega del tamburinaio Giuliano Baruni che nel 1589 stabilì un accordo con il mastro Cesare Cascia per la costruzione delle cornici dei tambu-relli e per l’acquisto di pelli di agnello e di capretto utilizzate per la costruzione delle membrane.21 Nel 1596 Baruni incaricò il genero Bernardino Rizzo di «planare rotas viginti quatuor di tamburelli»22
Strumenti musicali nelle collezioni siciliane 25
Nel 1597 Aleonora Baruni vendette ai liutai palermitani Gaspare De Yraci e Pasquale Cangemi ben duecento tamburelli grandi e mille tamburelli più piccoli, alcuni dei quali presentavano pelli dipinte («coloritos») e piattini d’ottone («cim-bi octunj») montati nella cornice. La Baruni si obbligò a consegnare gli strumenti entro il mese di maggio, in vista della fiera di Santa Cristina, e si impegnò a «incimbare viginti tamburelolos magnos de cimbis tundis».30 L’anno successivo la tamburinaia vendette nuovamente al De Yraci circa ottocento tamburelli.31
Come era prassi comune a quel tempo, la Baruni stabilì spesso accordi per iscritto con figli e con-giunti così da regolamentare l’attività dell’azienda familiare. Nel 1599, per esempio, Aleonora insie-me alla figlia Agata, stipulò un atto notarile per mezzo del quale si impegnò a vendere al figlio Francesco e al genero Bernardino tamburelli al prezzo di 1 tarì e 6 grani per ogni singolo pezzo. L’atto stabilì inoltre che, per quall’anno, le due tamburinaie non avrebbero inviato i propri stru-menti alle fiere di Monreale e di Carini, eviden-temente per non guastare la piazza ai due soci.32 Nel 1601 Aleonora e Bernardino si impegnarono nuovamente con De Yraci per la costruzione di mille e quattrocento tamburelli che, secondo quanto precisato nel documento, dovevano essere suddivisi in «quattro cento tamburelli grandi et mizani» (centotrenta dei quali dotati di piattini tondi e in parte «di garbuli di larcara») e mille tamburelli piccoli tra i quali dovevano esservi an-che quattrocento tamburini (forse anche tamburi giocattolo).33 Pochi giorni dopo, i due tamburinai vendettero al già citato Matteo de Vincentio − parente del marito di Salvatora Baruni, figlia mi-nore di Aleonora − altri quattrocento «tamburelli grandi di garbuli di larcara» di cui duecento «cum li cimbi tundi», mille e cinquecento tamburelli piccoli e trecento «tamburini pinti».34 Gli stru-menti in questo caso furono decorati dal pittore Andrea Catalano che si era appunto impegnato con la Baruni «a dipingere tutta quella quantità di tamburelli» che avrebbe richiesto al prezzo di 26 tarì ogni cento «tamburellos magnos» e 13 tarì per ogni «singolo centenario» di tamburelli piccoli.35 L’anno successivo la Baruni vendette a De Vincentio mille tamburelli: duecento grandi «di garbuli di larcara», di cui cento con «cimbis tundis», settecento tamburelli piccoli e cento tamburini «pintj della pittura che ha solito fare et fa andrea pitturi della detta vendetrice».36 Due mesi dopo, De Vincentio ordinava altri cento tamburelli piccoli e venticinque grandi forniti di piattini e con pelli dipinte.37
piattini d’ottone e decorazioni sulle membrane («depictos cum eorum cimbis octunij»). L’accor-do precisava che «venticinque de li più grandi habiano di esseri pinti con quattro figuri seu pupi et li soi cimbi tundi conformi che fa gaspano [Ga-spare] seu tagliati per qualsivoglia tamburello li altri settanta cinque habiano esseri pinti cum tri figuri et li quattro cento picchiolanj habiano di essiri cum tri figuri per ognuno». Come si è visto, i piattini dovevano dunque essere quelli di un tale Gaspare (forse De Yraci) mentre le decorazioni, a quattro o tre figure, sarebbero state realizzate dal pittore Pietro Zoida, rispettivamente figlio e fratello dei contraenti, o in alternativa da un tale Vincenzo Messana.26
Zoida fu un decoratore di tamburelli molto atti-vo in quegli anni a Palermo. Nel 1596 si impegnò con il tamburinaio Bernardino Rizzo a dipingere novecento tamburelli, settecento piccoli e duecento grandi, che questi aveva venduto a tale Mariano Fa-chidihomo.27 Inoltre, dal 1597, con l’aiuto della mo-glie Pietrutia Ingales, Zoida lavorò frequentemente al servizio della tamburinaia Aleonora Marraffa, vedova del già citato costruttore Giuliano Baruni, che operava a Palermo nella zona del Ponticello dove la presenza di costruttori di tamburelli e di setacci è documentata fino alla seconda metà del XX secolo.28 A tal riguardo è opportuno precisare che, in tutta la Sicilia, i tamburinai furono appunto soliti costruire anche setacci (in siciliano crivu) costituiti da una cornice di legno analoga a quella dei tamburelli su cui, al posto della membrana di pelle, era montata una retina.
Tra Cinque e Seicento, la bottega diretta da Aleonora Baruni − che lavorò soprattutto con i figli Francesco, Agata e Sigismonda e con il marito di quest’ultima, il già citato Bernardino Rizzo − fu presumibilmente una delle più fiorenti a Palermo. Lo dimostrano gli inediti documenti d’archivio da noi rintracciati che, tra il 1597 e il 1611, registrano una produzione di strumenti davvero sorpren-dente (oltre dodici mila quelli di cui si dà notizia qui ma ovviamente questo numero non può che essere parziale). Tali fonti rivelano peraltro il di-retto coinvolgimento delle succitate donne nella costruzione dei tamburelli, fenomeno che potreb-be essere messo in relazione con la destinazione femminile di questi strumenti: dai tempi della Magna Grecia e fino al Novecento inoltrato, in Sicilia la pratica musicale del tamburello fu infatti tradizionalmente affidata alle donne. I documenti qui citati sembrerebbero dunque evidenziare un singolare caso di artigianato strumentale praticato da donne e destinato a un pubblico di esecutori in larga misura femminile.29
26 Giovanni Paolo Di Stefano
tamburelli piccoli «bonos coloritos cum eorum cimbij» − furono prodotti dalla Baruni nel 1608 (e nuovamente inviati nelle medesime quantità alle fiere di Trapani, Termini e Alcamo). Il prezzo concordato fu di 4 onze e 10 tarì ogni cento tam-burelli grandi e di 2 onze e 5 tarì per ogni «singulo centenario» di quelli piccoli.46 Nel 1611 la Barone vendette duecento tamburelli grandi e settecento tamburini anche al nipote Vincenzo Marraffa, figlio del citato Nicola.47
La bottega dei Baruni non era l’unica nella zona del Ponticello. Nel 1599, per esempio, due tamburi-nai di nome Francesco e Angelo de Grimaldo, padre e figlio, si impegnarono con il già citato Matteo De Vincentio per la costruzione di quattrocento tamburelli grandi «ut dicitur di quattro aposta e anco quello di fori non sia manco di diamitro di palmj dieci simplici et che a vinti dui di detti tamburelli ci habbino di essere li cimbi tundi» e duecento tamburelli «ut dicitur di minuzanj et anche lo più piccolo non sia manco di uno palmo simplici di diamitro» tutti dipinti «manu petri zoida vel vincentij de messana».48 Negli stessi anni furono attivi al Ponticello anche i tamburinai Antonino e Francesco Lavocato che, nel 1604, vendettero al violaro De Yraci «tamburellos mille bonos depin-tos» di cui duecento grandi e i restanti ottocento «pichiulini».49
A questa mole straordinaria di documenti d’ar-chivio − che consente dunque di intuire quanto ampia dovesse essere nei secoli passati la diffusione in Sicilia di tamburi a cornice − non corrispon-de un altrettanto ricco patrimonio di strumenti superstiti. Delle decine di migliaia di strumenti che furono infatti prodotti in Sicilia tra Cinque e Seicento, nemmeno un tamburello di quell’epo-ca si conserva infatti nelle collezioni siciliane. L’unica, seppur parziale, testimonianza di questa tradizione artigianale è un’inedita membrana sei-centesca decorata che, dopo essere stata rimossa dalla cornice lignea, all’inizio del Settecento fu utilizzata per la legatura in pelle di un volume no-tarile oggi conservato presso l’Archivio di Stato di Sciacca (fig. 5).50 La decorazione, purtroppo assai danneggiata, raffigura − come osserva Rachele Fichera − «due dame che danzano una giga, con un cavaliere tra loro, davanti a una tenda decorata a grandi fiori che segue il tondo e lascia intravedere un giardino. Le ampie gonne blu sono decorate a volute, tocchi in arancio e lumeggiature in biacca, come nei ricami a motivi naturalistici stilizzati e multicolori tipici del Seicento siciliano. Il cavaliere, piccolo come un ragazzo o forse un personaggio di rango inferiore, porta il pantalone al ginocchio e il giustacuore attillato con una bottoniera fitta,
I rapporti commerciali con De Vincentio pro-seguirono anche l’anno successivo visto che, nel 1603, questi risulta avere commissionato alla Baru-ni altri quattrocento tamburelli: cento grandi, di cui cinquanta con piattini tondi e cinquanta con piattini tondi singoli («cum una cimba tunda»), e trecento tamburelli piccoli «di midi palmi et di midi digiti» tutti «bene dipictos».38 Nel 1604 la Baruni stabilì una società per la costruzione di tamburelli e setacci con le figlie Agata e Sigismonda, quest’ultima ormai vedova di Bernardino e sposata in seconde nozze con un tale Cucinella.39 Le tre donne, in società con il pittore Catalano, ricevettero una nuova grossa commessa dal violaro De Yraci che ordinò ben duemila e seicento strumenti: tre-cento tamburelli tra grandi e medi, quattrocento tamburini «in li quali ci aviano di essiri tamborini cento di garbuli di larcara» e altri mille e seicento tamburelli piccoli. De Yraci precisava che i tam-burelli dovessero essere «di larghezza di la misura che tienino li detti contraenti scripta di mia mano et li tamburelli grandi ci haviano di essiri cento et dieci tamburelli di garbuli di larcara cum li cimbi tundi».40 Successivamente, il De Yrachi stabilì una società con tale Aglante Rocchetta per la vendita dei tamburi acquistati.41
Possiamo immaginare che, per la costruzione del-le cornici di legno dei tamburi, le donne dovessero avvalersi del lavoro di collaboratori. Già nel 1598 la Baruni aveva incaricato il genero Bernardino di «planare totam illam quantitatem garbularum» necessaria nel corso dell’anno.42 Morto Bernardino, nel 1604 la tamburinaia stabilì una società con il nipote Pietro Mazzotta, fabbricante di setacci (cri-barius), che fu forse ingaggiato proprio con questa mansione.43 Pietro e un altro congiunto di nome Demetrio Mazzotta furono anche i fornitori delle pelli d’agnello usate dai Baruni che dunque per la costruzione degli strumenti si avvalsero di un vero e proprio indotto familiare.44
Negli anni successivi gli affari della tamburinaia non sembrano avere subito battute d’arresto. Nel 1607 la Baruni si impegnò a costruire altri duemila strumenti, questa volta su richiesta del fratello Nico-la Marraffa che già, almeno dagli anni ottanta del Cinquecento, era stato in affari con il suo defunto marito Giuliano. Gli strumenti commissionati in questa occasione furono centocinquanta tamburini, duecento tamburelli grandi e millecentocinquanta tamburelli medi destinati alle fiere di altre città siciliane. Mille tamburelli furono dunque inviati a Trapani, cinquecento a Termini e altrettanti ad Alcamo.45 Altri duemila strumenti destinati alle stesse città − cioè cento tamburini, centocinquan-ta tamburelli grandi e millesettecentocinquanta
Strumenti musicali nelle collezioni siciliane 27
marchese Francesco Maria Emanuele Gaetani di Villabianca. Il nobile palermitano, nei suoi Diari, attribuisce infatti al reggimento svizzero − giunto a Palermo intorno al 1734 sotto il regno di Carlo III di Borbone − l’introduzione in Sicilia, intorno agli anni sessanta del secolo, di «tre strumenti novelli di tamburo e piattini di metallo» che furono utilizzati per la “musica turca” tanto di moda soprattutto in ambito operistico tra la metà del Settecento e l’inizio dell’Ottocento. «Questi strumenti ed altri chiamati triangolo, timpani ecc., che hanno portato li Svizzeri» furono ascoltati a Palermo per la prima volta in occasione di un concerto che la banda del reggimento, diretta dal maresciallo Claudio Flori-mondo de Jauk, tenne nel 1768 presso il palazzo dei principi di Resuttano (Di stEfano 2008b, p. 417).
Anche nel corso del secolo successivo, gli spora-dici riferimenti alle percussioni usate in contesti musicali di ambito culto confermano l’introduzio-ne in Sicilia di strumenti dall’Italia continentale e dall’estero.
Nella seconda metà del secolo a Palermo la più assortita raccolta di percussioni orchestrali fu quella in dotazione della Banda Municipale (su cui tor-neremo nel prossimo paragrafo) tanto che, fino all’inizio del Novecento, alcuni di questi strumenti furono sovente chiesti in prestito dal Conservatorio e dai teatri cittadini. L’inventario degli strumenti del Corpo di Musica Municipale, redatto nel 1885, comprendeva: una catuba di rame a cilindro, una catuba di legno a corda, cinque mazze per tamburo, sei tamburelli, un sistro con diciannove lastrine di ferro, otto paia di castagnette, un paio di piatti, sessantasette sognagli attaccati a cuoio, una frusta di legno a due battenti, una macchina per imitare la pioggia o il moto della locomotiva, cinque lastroni di ferro per l’imitazione del tuono, quattro cam-pane di diverse dimensioni, due tamburi di rame a cilindro, un triangolo. A questi strumenti negli anni successivi se ne aggiunsero di nuovi tra cui, nel 1893, un tam-tam che fu l’unico in città a quel tem-po disponibile e che fu anche utilizzato dal Teatro Massimo in occasione dell’esecuzione di opere di Giacomo Puccini.52 Ma ovviamente anche di questi strumenti ottocenteschi non è rimasta traccia.
Aerofoni: legni e ottoniA differenza di quanto avvenne nel settore orga-
nario, cembalario e liutario − di cui parleremo nei prossimi paragrafi − e se si esclude la pur importante produzione di strumenti documentata in ambito archeologico e popolare (argomenti trattati da An-gela Bellia e da Sergio Bonanzinga in questo stesso volume), l’attività dei costruttori siciliani di legni e ottoni non fu neanche lontanamente paragonabile
tipicamente seicenteschi. I visi, le mani e i piedi a tratti di pennello e i pochi colori, vicini agli originali per la permanenza al riparo dalla luce, indicano una fattura già seriale ma ricca di dettagli».51 I sog-getti femminili raffigurati, seppur qui più raffinati, ricordano le figure di donne stilizzate presenti su due tamburelli ottocenteschi custoditi presso il Museo Etnografico Siciliano “Giuseppe Pitrè” di Palermo (schede 21-22). Le decorazioni popolari con soggetti di donna − che ribadiscono peraltro la destinazione femminile di questi strumenti − fu-rono tanto diffuse sulle membrane dei tamburelli siciliani da avere ispirato l’espressione dialettale pupa di tammureddu (letteralmente “bambola di tamburello”) che i dizionari ottocenteschi rivelano appunto essere stata comunemente utilizzata per indicare una «figura a donna imbellettata o a dipin-tura malamente fatta» (MoRtiLLaRo 1844, p. 160).
Per quanto riguarda la costruzione in Sicilia di idiofoni di tradizione popolare e semi-culta − triangoli, sonagli, castagnette, campane (per i quali rimandiamo alle schede 1-16) − se si eccettua la produzione campanaria destinata alle chiese, le fonti archivistiche non sembrano fornire infor-mazioni neanche lontanamente paragonabili a quelle citate nelle pagine precedenti a proposito dei tamburinai.
Sulla diffusione nell’isola di idiofoni e mem-branofoni in ambito culto, un dato interessan-te è invece fornito alla fine del XVIII secolo dal
5. Frammento di membrana di tamburello, Sicilia XVII secolo (Ar-chivio di Stato di Agrigento - sezione di Sciacca: spezzone n. 111)
28 Giovanni Paolo Di Stefano
il «concerto dei pifari» − costituito appunto da due suonatori di piffero, un cornettista e un trombo-nista − che fu istituito nel 1628 a Caltagirone, in provincia di Catania, per accompagnare il Senato cittadino nei cortei processionali, in occasione delle cerimonie pubbliche e per effettuare esecuzioni musicali per le strade e nella piazza principale del paese durante le festività (Buono cds).
Larghissima parte degli strumenti a fiato in uso in Sicilia, eccetto quelli di tradizione prettamen-te popolare, furono generalmente importati dal “continente”: forse dalla Germania, da Venezia e soprattutto − come abbiamo visto nel caso dei piffari di Trapani − da Napoli. Ovviamente non possiamo escludere che vi siano stati anche in Sicilia costruttori e riparatori di strumenti a fiato ma, fino ai primi decenni dell’Ottocento, non disponiamo di informazioni documentarie al riguardo.
Il primo dato disponibile risale soltanto al 1833 quando un anonimo annotatore riferì di aver vi-sto a Ragusa «due trombe di canna fatte da un Sac[erdote] Eccellente nelle arti meccaniche chia-mato D[on] Antonino Ventura, le quali sonavano nelle orchestre con più melodia di quelle di bronzo ed ammirate furono acquistate da un signore della capitale».55 Quella del Ventura sembra comunque essere stata più la sperimentazione di un religioso appassionato di “arti meccaniche” che il prodotto di un costruttore professionista.
Botteghe effettivamente specializzate nella costru-zione e riparazione di strumenti a fiato furono invece presenti in quegli stessi anni a Messina dove Antonio e Natale Falconieri e Natale Bonaviri si dedicarono a questo settore dell’artigianato strumentale prestan-do la propria opera anche al di là dello stretto, per esempio presso la Scuola di Musica dell’Orfanotrofio di Reggio Calabria (pitaRREsi 1988, pp. 93-94; MEuCCi 1998a, p. 119 e ChiRiCo 2006, pp. 52-53).
Sempre negli anni trenta a Cefalù, poco lontano da Palermo, un tale Stefano Guercio apportò delle migliorie alla costruzione del clarinetto. L’inven-zione è comunicata in un articolo del 1837 apparso sul periodico «Effemeridi scientifiche e letterarie per la Sicilia»:
In Cefalù Stefano Guercio, inteso a riconoscere colle spinte del suo ingegno le imperfezioni del Clarino, seppe costruirne uno con aggiunte e miglioramenti degni di grandissima lode. Onde venuto in Palermo fu il suo strumento esaminato dai signori Domenico Ballo professore di clarino, e Giuseppe Lumia Maestro di Cappella, i quali conosciuta l’estenzione [sic] de’ suoni, che per quello si ottengono, e l’intonazione di ognuno, giudicarono che il Clarino del Guercio sorpassa quello ordinario in estenzione per una ottava e due tuoni, cioè da sì basso a sì acuto, cosicché riesce con tali aggiunte più
a quella degli artigiani attivi in altre aree della pe-nisola (per esempio a Napoli, Milano, Venezia e in molte altre città dell’Italia settentrionale).53
Ovviamente, la diffusione di strumenti a fiato è ampliamente attestata nell’isola sin da epoche remote (si vedano per esempio gli auloi alle schede 24 e 25 e il flauto globulare alla scheda 26, prove-nienti da scavi archeologici siciliani). Abbondanti sono anche le raffigurazioni d’età medievale − che rappresentano soprattutto trombe dritte, flauti, doppi flauti e zampogne − e d’epoca rinascimen-tale quando, come nel resto della penisola, fu assai diffuso il piffero. Questo aerofono ad ancia doppia dalla forma allungata terminante con un padiglio-ne svasato − che in Italia fu successivamente anche chiamato bombarda − in Sicilia era comunemente detto pìffara, bbìfara o bbìfira (nella provincia di Messina tale strumento fu impiegato in ambito popolare fino alla metà del XX secolo, si veda lo strumento alla scheda 50).
Troviamo testimonianza sull’uso dei pifferi in un atto notarile del 1558 che sanciva l’accordo professionale tra i suonatori ambulanti palermi-tani Vincenzo e Giuseppe Gallo, Cesare Deamico e Giuseppe D’arpino. I quattro musicisti, secondo quanto stabilito dinnanzi al notaio, costituivano una società per far «conserto di sono et andar ad sonari ad nozi et insignari ad ballari i di loro arti in casa de qual si voglia persona […] in questa città como fora» e si impegnavano a spartire equamente i proventi di tale attività anche nel caso in cui il sudetto Vincenzo Gallo avesse suonato per conto proprio «li pifari» o gli altri compagni avessero prestato autonomamente la loro opera.54
Occorre precisare che in tutta la penisola, tra Cinque e Seicento, con il sostantivo plurale piffari si indicarono gruppi strumentali costituiti, non solo da suonatori di pifferi propriamente detti ma anche di tromboneedi cornetto. Quest’ultimo, fino alla seconda metà del Seicento, fu assai diffuso nei due modelli “curvo” e “diritto” e, come il piffero, fu costruito in diverse taglie (la più grave, detta serpentone o “serpone”, era spesso utilizzata negli organici strumentali in alternativa al trombone: si veda l’esemplare tardo-settecentesco alla scheda 57).
Dal Cinquecento, gran parte delle città italiane ebbero al proprio servizio gruppi municipali di pif-fari. L’universitas di Trapani, nel 1587, acquistò per esempio a Napoli, al prezzo di 18 scudi, «sei pifari» concordando con i suonatori che, qualora tali stru-menti non fossero arrivati in città per tempo, quelli avrebbero usato i «trumbuni et cornetti» già in loro possesso (navaRRa 1986, p. 67). Tra le numerose testimonianze cinque-seicentesche, inerenti questo tipo di gruppi strumentali, possiamo anche citare
Strumenti musicali nelle collezioni siciliane 29
in ebano a tredici chiavi e due anelli di packfong della ditta Buffet-Crampon, un clarone in Si bemolle di packfong della ditta Buffet-Crampon, tre corni d’armonia in Si bemolle di packfong con sette ritor-ti, tre genis in Mi bemolle, tre trombe basse in Mi bemolle con ritorti, un piston in Mi bemolle, due flicorni in Si bemolle sistema Roth, una cornetta in Si bemolle dritta, una cornetta in Si bemolle sistema Müller, due flicorni bassi in Si bemolle, un bombar-dino dritto in Si bemolle, un eufonio dritto in Si bemolle, tre tromboni in Si bemolle, un trombone in Si bemolle di forma corta, due bombardoni (ossia oficleide) in Fa, due bombardoni in Mi bemolle, un elicon in Si bemolle e poi un gruppo di percussioni (un sistro a due piramidi, una coppia di piatti, un tamburo, un rullante e una grancassa).59
Come si evince dagli elenchi, gli strumenti forniti in dotazione ai quarantadue bandisti del Corpo di Musica di Palermo erano principalmente di costru-zione straniera (diversi provenivano dalle famose fabbriche parigine Buffet-Crampon e Thibouville, e da quella viennese di Ziegler). Altri strumenti erano stati acquistati presso manifatture dell’Italia settentrionale (tra cui soprattutto lo stabilimento milanese di Ferdinando Roth).
Le fonti documentarie sembrerebbero attestare una certa ritrosia degli strumentisti a fiato siciliani per i modelli dotati di meccaniche aggiornate alle tecnolo-gie più moderne. Giusto per fare un esempio, il cele-bre oboista palermitano Antonino Pasculli, direttore del Corpo di Musica cittadino, nel 1855 acquistò un oboe della fabbrica parigina Triébert et Compagnie modello Systéme 2 a undici chiavi, ormai abbastanza desueto per l’epoca (lo strumento di Pasculli si trova oggi nella collezione di Omar Zoboli a Ginevra, cfr. RossEtt 1987 e Di vita 2012, pp. 87-93). Inoltre, il sistema Böhm nel flauto traverso − che altrove era in uso da decenni − in Sicilia (come in molte aree italiane) fino ai primi decenni del Novecento non sembra avere avuto diffusione tra i flautisti che con-tinuarono a preferire modelli basati sul tradizionale sistema Ziegler (R. poRto 1903, p. 141).60
L’attività del Corpo di Musica palermitano e di molte altre bande dell’isola, spinse alcuni costrut-tori di strumenti a fiato a trasferirsi in Sicilia dove − come abbiamo già accennato − il settore della costruzione di legni e ottoni era poco sviluppato. Negli anni sessanta si stabilì ad esempio, da Ales-sandria a Palermo, il costruttore di strumenti a fiato in ottone Antonio Sacchi (fig. 6) che, nell’aprile del 1866, vendette appunto al Municipio degli strumenti e ne prese in permuta alcuni ormai in disuso.61 Sul finire del secolo giunse a Palermo un altro costruttore originario dell’Italia settentrionale, il milanese Carlo Gandiani. Il catalogo commerciale
armoniosa e perfetta l’esecuzione dei pezzi di musica. Quindi il Clarino sì fattamente migliorato dal siciliano artefice, per la forza del suo solo ingegno, sarà senza fallo ricercato dalle Accademie e dai Conservatori, ed egli ne avrà meritato guiderdone [EffEMERiDi 1837, p. 56].
Non sembra in realtà che il “clarinetto migliora-to” di Guercio abbia avuto il successo auspicato ma in ogni caso, quattro mesi dopo la pubblicazione di questo articolo, il costruttore ottenne dal Governo una privativa di cinque anni per la fabbricazione del suo strumento.56
Qualche anno più tardi, il costruttore palermi-tano Luigi Corvaja presentò un «flauto d’ebano nero montato in argento con numero dieci chiavi» in occasione dell’esposizione organizzata a Paler-mo il 30 Maggio 1840 dal Real Istituto d’Incorag-giamento d’Agricoltura Arti e Manifatture per la Sicilia, istituzione creata dal governo borbonico per promuovere le attività manifatturiere sicule (istituto D’inCoRaggiaMEnto 1840).
Una spinta notevole alla pratica degli strumenti a fiato, soprattutto degli ottoni, si ebbe nella seconda metà del secolo grazie alla straordinaria diffusione in tutti i principali centri siciliani, come d’altronde era avvenuto nel resto della penisola, delle bande musicali.57 A Palermo, a seguito del decreto regio del 2 luglio 1861, fu «data facoltà a ciascuna Legione [della Guardia Nazionale] di aversi un corpo di mu-sica, oltre il personale delle trombe e dei tamburi» (atti DEL govERno 1862, p. 233). Nel 1863 per le quattro Legioni palermitane della Guardia Nazio-nale fu costituita un’unica banda che, a seguito del suo scioglimento nel 1866, fu convertita in Corpo di Musica Municipale (tiBy 1957b, p. 339).
Un inventario del 1874 ci fornisce informazioni sull’organico di questa banda e sugli strumenti che essa aveva avuto in dotazione tra il 1863 e il 1873. La lista includeva un ottavino, due quartini (ossia flauti una quarta sopra quelli ordinari), quattro clarinetti, due piston, due biucoli (strumenti simili al flicorno soprano), una cornetta, quattro trombe in Mi bemolle, una tromba bassa, tre genis (flicorni contralti), due bombardini (flicorni baritoni), due flicorni bassi, tre tromboni, un elicon (basso di for-ma circolare) in Fa, tre elicon in Mi bemolle, due elicon in Si bemolle, un elicon in Do.58 Nel 1877, a seguito dell’insediamento del celebre oboista paler-mitano Antonino Pasculli come direttore del Corpo di Musica, il Municipio ordinò altri quarantasei nuovi strumenti presso il negozio del commerciante palermitano Giuseppe Benenati: un ottavino in Re bemolle di packfong, due quartini in Mi bemolle di packfong della ditta Buffet-Crampon, un flauto in ebano a dieci chiavi, nove clarinetti in Si bemolle
30 Giovanni Paolo Di Stefano
Pubblica Istruzione, con decreto regio n. 50955 del 30 ottobre 1887, stabilì infatti per tutto il paese l’adozione del corista di 870 vibrazioni semplici noto come corista internazionale o “tono normale”. A tale scopo, il Governo istituì l’Ufficio centrale del corista internazionale presso l’Istituto Fisico della Regia Università di Roma «coll’incarico di conservare il corista normale, di verificare con esso i coristi […], di correggerli eventualmente, e di certificarne l’esattezza con un marchio speciale».64 Nel 1888, l’Ufficio inviò al sindaco di Palermo copia del Regio Decreto e del Regolamento per l’adozione del diapason internazionale assieme a un corista bollato dall’Ufficio che fu così consegnato alla Delegazione della Musica Municipale che a quel tempo aveva comunque già adottato il nuovo diapason.65 Con disposizione della giunta comunale del 5 marzo 1887, il Corpo di Musica era stato infatti dotato di quarantadue strumenti «di nuovo corista» acquistati per 6870 lire presso il negozio del palermitano Ro-sario Maugeri il quale aveva preso in permuta «per proprio conto gli strumenti sinora usati dal Corpo medesimo […] per il prezzo complessivo di lire 1500».66 Gli strumenti erano stati ordinati ancora una volta presso la manifattura Buffet-Crampon di Parigi e presso la fabbrica Wenzel Stowasser’s
da questi pubblicato nel 1894 (fig. 7) fornisce delle informazioni sulla sua attività:
dopo d’aver dimorato parecchi anni nelle provincie meri-dionali, si stabilì a Catanzaro con fabbrica e rappresentanza d’Istrumenti Musicali. […] Durante il suo soggiorno a Bari, venne chiamato a Cosenza, onde procedere alla completa riparazione degl’istrumenti di quelle Bande Musicali; così pure degli egregi Capi Musica dei Reggimenti Fanteria 13°-14°-22°-30°-33°-53° nonché dai signori Maestri delle provincie di Reggio e Cosenza. […] Avendo ora scelto per ultima sua dimora Palermo, ha aperto il suo opificio in piazza Sant’Oliva, dentro l’Ospizio di Beneficenza, ove è stato ammesso nella qualità di Capo Officina […].62
Gandiani − che operò appunto presso il Real Ospizio di Beneficenza dove era peraltro attiva anche una scuola di musica e una fanfara giovani-le − nello stesso fascicoletto precisava di essere in grado di «ridurre a nuovo i più disordinati istru-menti [operazione che implicava l’eliminazione delle ammaccature e la pulitura interna ed esterna degli strumenti], di ridurli a qualsiasi tono e, per le Bande Musicali, al nuovo diapason adottato dalle bande Militari del R. Esercito Italiano».63
A seguito della conferenza internazionale che ebbe luogo a Vienna nel 1885, il Ministero della
6. Ricevuta in carta intestata consegnata nel 1866 al Corpo di Musica di Palermo dal costruttore di strumenti a fiato in ottone Antonio Sacchi (Archivio Comunale di Palermo, Corpo di Musica, Serie XI-1, c. 425)
7. Catalogo commerciale del 1894 della fabbrica palermitana di strumenti a fiato di Carlo Gandiani (Archivio Comunale di Palermo, Corpo di Musica, Serie XI, fasc. 3: 1867-1903, c. 214)
Strumenti musicali nelle collezioni siciliane 31
Nelle botteghe di questi artigiani (i cui nomi sareb-be inutile cercare nei repertori di liuteria poiché oggi del tutto sconosciuti) erano prodotti violini, viole da gamba e soprattutto liuti e chitarre, come testimonia per esempio l’inedito inventario redatto, nel 1619, alla morte del succitato liutaio Paolo Cul-laro nella cui bottega si trovavano appunto: «cordi di violi di barsalona [Barcellona], […] 46 chitarri spiduti [ultimate] a septi cordi senza cordi, altri 26 chitarri di la stessa forma senza spiduti [non ultimate], 7 chitarri a 9 cordi grandi, 4 chitarri abuscati rutti, 4 ligutazzi vechi, un bordoletto senza cordi, 2 chitarrazzi vechi» oltre a centinaia di tavole armoniche, casse e altre parti già lavorate e pronte per essere montate (Di stEfano, cds1). È opportuno constatare che, tra gli strumenti presenti presso la bottega del Cullaro, vi fossero ben ottantuno chi-tarre (di varia foggia e misura) a fronte di appena «4 ligutazzi vechi». Nei primi decenni del Seicento anche a Palermo, come in altre parti della penisola, il liuto, strumento principe del Rinascimento, era stato infatti progressivamente rimpiazzato dalla chitarra “alla spagnola” a cinque cori che in breve era diventato uno degli strumenti più popolari del Barocco italiano. Questo passaggio dal liuto alla chitarra è documentato anche dalla terminologia utilizzata per definire i costruttori di cordofoni a manico: dopo il 1630, a Palermo i termini liutaro e violaro furono infatti quasi del tutto sostituiti da citarraro.
La chitarra “alla spagnola” rimase in voga fino alla seconda metà del Settecento quando cominciò a essere sostituita dalla cosiddetta chitarra “alla francese”, la moderna chitarra a sei corde singole, che ebbe a quel tempo largo successo presso l’ari-stocrazia − come testimoniava il viaggiatore Joseph Hager nel 1799 − soprattutto per l’accompagna-mento di «brevi canzoncine popolari siciliane di carattere amoroso e birichino» (hagER 1799, p. 48). Ne troviamo testimonianza presso la biblioteca del Conservatorio di Palermo dove si conserva appunto una raccolta di composizioni e di canzoncine sicilia-ne manoscritte con accompagnamento di chitarra alla francese, alcune delle quali dedicate a esponenti dell’aristocrazia cittadina e tutte databili alla fine del Settecento o all’inizio del secolo successivo.68
I primi cordofoni a manico di produzione paler-mitana che sono giunti fino ai nostri giorni risal-gono al XVIII secolo quando erano attivi in città i liutai Bonanno (Angelo e Salvatore), Casiglia (Francesco e Giovanni), De Grandis (Ignazio e Matteo), Trusiano (Gaspare e Vincenzo). A questi ultimi, e in particolare a Vincenzo Trusiano detto Panormo, spetta un posto d’onore per il ruolo che ebbero nella storia della liuteria italiana ed europea.
Söhne di Graslitz che, sul finire del secolo, aveva impiantato anche una filiale a Verona.
Come avvenne al Conservatorio di Palermo, che nel 1888 aveva dato in permuta al costruttore mila-nese Pellitti tutti gli strumenti a fiato con vecchio corista, anche il Corpo di Musica nel 1887 alienò dunque lo strumentario acquisito precedentemente al 1885. L’inventario degli strumenti in possesso del Municipio, redatto nell’anno 1900, dimostra infatti che a quell’epoca la banda non possedeva più alcun esemplare acquistato appunto prima del 1885.67
L’alienazione dei fiati con il vecchio diapason, alla fine del XIX secolo, ha comportato dunque la pressoché completa dispersione del patrimonio strumentale più antico in possesso delle istituzioni musicali siciliane: gli strumenti a fiato che ritro-viamo oggi nelle collezioni dell’isola, con poche eccezioni (in buona parte peraltro addebitabili ad acquisizioni di epoca recente), anche in que-sto caso risalgono infatti soltanto agli ultimi anni dell’Ottocento o all’inizio del secolo successivo.
Cordofoni a manicoPoco diversa dalla situazione finora esposta è
quella relativa ai cordofoni a manico. Nonostante la ricca mole di informazioni, provenienti da fonti archivistiche e iconografiche, sulla costruzione e sulla diffusione in Sicilia di cordofoni a manico in età medievale, rinascimentale e barocca, anche in questo caso nemmeno un esemplare riconducibile a quelle epoche sembra essere sopravvissuto fino ai nostri giorni. Praticamente nessuno strumento di liuteria precedente al XVIII secolo − se si eccettuano il violino del cremonese Girolamo Amati (scheda 58), che porta la data 1683, e quello del bresciano Giovan-ni Battista Rogeri, databile intorno al 1680 (scheda 59) − si conserva infatti presso collezioni siciliane.
Questo dato, come dicevamo, ancora una volta stride con quanto testimoniato dalle fonti archivi-stiche che comprovano, soprattutto dalla seconda metà del Cinquecento, una consistente produzione e circolazione in Sicilia di strumenti di liuteria, tanto a pizzico quanto ad arco.
Centro nevralgico della produzione liutaria si-ciliana fu in quei secoli Palermo dove, presso il quartiere dell’Albergheria, nella cosiddetta zona del Ponticello − ossia in quell’area compresa tra la chiesa di San Giuseppe dei Teatini e il monastero dei gesuiti a Casa Professa, già citata a proposito dei tamburinai − era attiva una folta comunità di liutai. Tra quelli che operarono tra Cinque e Sei-cento, si possono ricordare i Sansotta (Pietro e Giulio) i Cullaro (Pietro, Antonio e Paolo), gli Yndusa (Antonino e Corrado), i De Yraci (Gaspare e Vincenzo), i Boccaccio (Costantino e Antonino).
32 Giovanni Paolo Di Stefano
destinati a maestri e allievi (si veda per esempio la pregevole viola d’amore alla scheda 63).
In stretti rapporti con Sgarbi furono i liutai pa-lermitani Camillo e Domenico Di Leo ed Enrico e Alfonso Averna (quest’ultimo gli subentrò peraltro come liutaio del Conservatorio). I fratelli Averna erano nipoti del noto liutaio nisseno Gesualdo, assai apprezzato per i suoi strumenti ad arco e inventore del manviolino, di cui si conserva un esemplare pres-so il Museo degli strumenti di Chiaramonte Gulfi (scheda 70). Il “manviolino ossia mandolino a guisa di violino”, dunque un ibrido dei due strumenti, fu brevettato da Gesualdo Averna nel 1910 (fig. 8) come apprendiamo da questo inedito documento:
L’inventore ha cercato di creare uno strumento che non avesse le difficoltà tecniche del violino e, nello stes-so tempo, per l’uso di un archetto (G) ammorbidisse un poco quell’argentina asprezza che è specifica del mandolino, per l’attrito della penna di tartaruga con le
Nato nel 1734, presumibilmente a Monreale, Vincenzo Trusiano fu attivo in Sicilia fino agli an-ni cinquanta del secolo come testimonia il con-trabbasso del 1752, sua prima opera nota, che si conserva presso la collezione del Conservatorio di Palermo (scheda 66). Successivamente, Vincenzo e Gaspare Trusiano (forse suo padre) abbandona-rono la Sicilia alla volta di Napoli dove adottarono l’appellativo Panormo in riferimento alla città di origine. Se Gaspare rimase definitivamente nella capitale partenopea, città in cui fu principalmente attivo come costruttore di strumenti a fiato, dopo il 1767 Vincenzo si trasferì invece a Parigi dove lavorò presso botteghe di altri liutai. Lo scoppio della Rivoluzione lo indusse ad abbandonare la Francia e a trasferirsi a Dublino. Pochi anni più tardi, nel 1791, Vincenzo − con i figli Joseph, Ge-orge e Louis − lasciò tuttavia l’Irlanda per Londra dove fu attivo fino alla morte, sopraggiunta nel 1813. L’arrivo di questo liutaio a Londra aprì la strada a un periodo particolarmente florido per la storia della liuteria inglese di cui Vincenzo e i suoi discendenti divennero tra i principali protagonisti (Di stEfano 2008a e Di stEfano cds2).
I rapporti tra Napoli e la Sicilia, regni vicini per ragioni politiche e culturali, furono assai intensi anche nel campo della liuteria: gli strumenti di scuola napoletana trovarono infatti consistente diffusione nell’isola e influenzarono i liutai locali. Alla tradizione liutaria napoletana appartengono per esempio molti strumenti della collezione del Conservatorio di Palermo tra i quali spiccano un violoncello di Carlo d’Avenia del 1716 (scheda 64) e un violino datato 1781 realizzato nella fa-mosa bottega dei Gagliano (scheda 60). Le scelte costruttive dei liutai napoletani, come dicevamo, influenzarono certamente la scuola liutaria sici-liana. Questo apparentamento con la tradizione napoletana è per esempio evidente nella viola di Casimiro Casiglia (scheda 62) e nel violoncello di Ernesto Lorini (scheda 65), entrambi strumenti di costruzione palermitana appartenenti alla collezio-ne del Conservatorio di Palermo, che dimostrano analogie con strumenti di scuola partenopea nel disegno della cassa, nella disposizione verticale delle effe e nella fattura dei filetti.69
Personaggio insigne nell’ambito della storia della liuteria palermitana di fine Ottocento fu Antonio Sgarbi. Emiliano d’origine, ma attivo sul finire del secolo anche a Roma, Sgarbi fu richiamato a Paler-mo dal Conservatorio cittadino intorno al 1896 per ricoprire l’incarico di liutaio dell’Istituto. Nel corso del suo mandato, Sgarbi curò il restauro di larga parte degli antichi strumenti del Conservatorio e portò a termine la costruzione di nuovi esemplari
8. Tavola illustrata allegata al testo del brevetto del 1910 del manviolino ossia mandolino ad arco di Gesualdo Averna (Archivio Centrale dello Stato, Roma)
Strumenti musicali nelle collezioni siciliane 33
sotto la guida del virtuoso mandolinista Belisario Mattera − divenne infatti una delle mode musicali più in voga tra le signore della buona società italiana per le quali la regina rappresentava un modello da emulare.71 In un paese giovane quale era appunto l’Italia unita, la ricerca di modelli culturali condi-visi e unificanti era divenuta un’esigenza sempre più impellente e il fenomeno del mandolinismo, sotto l’egida della regina Margherita, fece breccia proprio in questo bisogno. Ben presto, il fenome-no coinvolse fasce sempre più eterogenee della popolazione tanto che, come osservava in quegli anni Samuel Adelstein, il mandolino intorno agli ultimi decenni dell’Ottocento era diventato:
uno strumento suonato da tutte le classi sociali, dallo scognizzo più povero alla persona più importante della nazione, la regina. Proprio grazie alla adozione di esso da parte della famiglia reale il mandolino è diventato anche lo strumento della nobiltà. In tutte le principali città ci sono circoli costituiti dai migliori musicisti, e ad intervalli fissi, i musicisti del nord, con i loro mandolini lombardi, quelli del centro del paese coi loro mandolini romani ed i mandolinisti del sud coi loro strumenti napoletani si ritrovano in amichevole rivalità a parteci-pare a concorsi o competizioni [aDELstEin 1905, p. 16].
Margherita di Savoia promosse in prima persona la diffusione nel paese di associazioni mandolini-stiche e divenne l’icona stessa del mandolinismo italiano, come comprovano le numerose intesta-zioni alla sua persona di tanti circoli mandolinistici coevi. Non a caso dunque, in occasione della visita di Umberto e Margherita di Savoia all’Esposizione Nazionale di Palermo del 1891-92, i reali furono accolti con un concerto di un’orchestra di mando-lini (accompagnati da arpe e chitarre) costituita da donne della buona società cittadina (fig. 9). Lo
corde di acciaio. Lo strumento conserva le quattro note fondamentali del mandolino e del violino (mi, la, re, sol) a una o a doppia corda. La testa dello strumento (a1-a2) ha la forma piatta del mandolino, se non che alla parte superiore descrive lateralmente il riccio o cartoccio che è caratteristico del violino. La tastiera (a2-a3) è uguale a quella del violino ma ha in rame i tasti come quelli del mandolino. La tastiera (a2-a3) però – è questa soprattutto l’innovazione − è stata costruita della lunghezza di mm 351. Questa lunghezza è in vero superiore a quella che normalmente suole darsi alle tastiere di mandolini. Lo scopo di questa modificazione è il seguente: che poten-dosi costruire anche strumenti a una corda per ogni nota delle quattro fondamentali − a differenza del mandolino che ne ha due − la maggiore lunghezza concorre a dare alla corda una vibrazione più larga e più sonora e alla nota, quindi, un effetto più morbido. La tavola armonica ha questo di specifico: che al buco di mezzo sono state sostituite, quasi come nel violino, due mezze lune (c5, c6) laterali o due f caratteristiche nel violino. Tra le due mezze lune è stato introdotto il cosiddetto ponticello del violino (I ed a4). Intorno alla cassa armonica come nel violino − corre un bordo (c4, c3). La cassa armonica (B1) non ha la forma di quella del mandolino: ma si avvicina un po’ a quella del violino, diciamo che si avvicina un po’ perché mentre la curva della tavola armonica del violino si parte da tutti i lati, quella del nostro strumento è una curva regolare che si marca da un fianco all’altro (b2-b3). La stessa differenza di struttura esiste tra il fondo del violino e quello del no-stro strumento, Le modificazioni introdotte nell’interno dello strumento sono le seguenti: vi sono state costruite tre catene: due (c1c2, c3c4) nella parte interna della tavola armonica e nello stesso senso delle corde, tra le commessure delle due mezze lune (c5, c6), una nella parte interna del fondo (d1, d2) in centro o nella direzione stessa delle altre due. L’anima (A), che è situata sotto il ponticello o quasi, allo scopo di diffondere o dilatare per tutto lo strumento le vibrazioni, unisce le tre catene.Le stesse innovazioni l’inventore intende applicare per la costruzione del quartetto a plettro, cioè mandolino piccolo, mandolino, mandola e mandolincello, come pure alla chitarra.70
Il manviolino brevettato da Averna era dunque una delle molteplici varianti di mandolino napoleta-no che furono ideate in Italia tra Otto e Novecento quando questo strumento − inventato appunto a Napoli intorno alla metà del XVIII secolo e diffu-sosi già a quel tempo anche in Sicilia (Di stEfano 2008b, pp. 414-415) − si era guadagnato un posto di assoluto rilievo nel nostro paese tanto da dive-nire, nel giro di qualche decennio, lo strumento musicale nazionale per eccellenza.
Nel secondo Ottocento, la pratica del mandolino − strumento suonato e amato da Margherita di Sa-voia che sul finire degli anni sessanta, durante il suo soggiorno a Napoli, ne aveva intrapreso lo studio
9. Concerto mandolinistico organizzato in occasione della visita di Umberto e Margherita di Savoia (part. della litografia pubblicata sul periodico «L’Esposizione Nazionale illustrata di Palermo 1891-92»)
34 Giovanni Paolo Di Stefano
sterzata alla crisi economica postunitaria impian-tando grandi manifatture e, in alcuni casi, vere e proprie industrie specializzate appunto in questo settore della produzione strumentale.
Se in Sicilia i mandolini furono prodotti un po’ ovunque (si veda per esempio l’esemplare messi-nese della ditta di Giovanni Campo, scheda 71) fu soprattutto Catania a distinguersi per i suoi man-dolinari tanto da affermarsi, tra la seconda metà del XIX secolo e l’inizio del XX secolo, come il più importante polo manifatturiero italiano per la costruzione di questi strumenti.
Dopo l’apertura del Canale di Suez, nel 1869, il porto di Catania era divenuto uno degli snodi commerciali più importanti del Mediterraneo e le manifatture etnee avevano a quel punto avuto più facile accesso a molte materie prime d’importazione (specialmente ai legni esotici impiegati per la co-struzione degli strumenti musicali a corde). Queste nuove condizioni commerciali − e parallelamente la formazione di manodopera specializzata anche gra-zie alla costituzione di una scuola di liuteria presso il Real Ospizio di Beneficienza di Catania − resero dunque favorevole l’apertura di grandi fabbriche di strumenti musicali a corde.72 Tra di esse spiccava
studio del mandolino era d’altronde a quel tempo coltivato presso le principali scuole femminili pa-lermitane, in primo luogo nel Regio Educatorio Maria Adelaide e all’Istituo Sant’Anna dove le stesse suore suonavano questo strumento (fig. 10). For-se non possiamo affermare che la diffusione del mandolino napoletano, sulla spinta della regina Margherita, possa in origine aver risposto a un programmato disegno politico-culturale ma non v’è dubbio che il fenomeno del mandolinismo si rivelò un movimento “unitario” che travolse da nord a sud tutto il paese: da Milano a Palermo, praticamente nessun territorio del nuovo Regno ne restò estraneo.
Il crescente numero di mandolinisti e la costi-tuzione di circoli e di orchestre a plettro − feno-meno che coinvolse dilettanti di ambo i sessi e di ogni età − determinarono un incredibile fermento anche nell’industria liutaria italiana che dovette sopperire alla richiesta sempre più consistente di strumenti. Si trattò di un fenomeno di una por-tata tale da rivoluzionare persino l’economia di alcune aree geografiche del paese dove, sull’onda dell’imperante moda mandolinistica, i costruttori di strumenti musicali furono capaci di dare una
10. Orchestrina di mandolini dell’Istituto Sant’Anna in una foto del 1900 ca. (Collezione Cristina Fatta del Bosco, Palermo)
Strumenti musicali nelle collezioni siciliane 35
1898, medaille d’or all’Esposizione Internazionale di Digione del 1898, grand prix all’Esposizione Inter-nazionale di Suez del 1898, grand prix al Concorso Universale di Gerusalemme del 1899, grand prix all’Esposizione Internazionale di Londra del 1902, grand prix all’Esposizione di Saint-Etienne del 1902, medaglia d’oro all’Esposizione Internazionale di Mila-no del 1906, medaglia d’oro all’Esposizione Agricola Siciliana del 1907 (R. poRto 1907).73
Se la fabbrica Porto (fig. 11), che produceva ogni sorta di strumento musicale a corda (si vedano per esempio il mandoloncello alla scheda 72 e la chitarra alla scheda 75) era la più grande e la più premiata a Catania, ve ne erano tante altre in città che vantavano un numero davvero ragguardevole di dipendenti e una produzione assai consistente. Tra queste è opportuno almeno ricordare la ma-nifattura di Salvatore Indelicato, che dava lavoro a ben duecentocinquanta operai, e ancora quelle dei fratelli Carrabba, di Giuseppe Puglisi, dei fra-telli Casella, di Ermelinda Silvestri, che occupava-no anch’esse centinaia di lavoranti. La lista delle manifatture potrebbe comunque essere molto più ampia visto che l’industria liutaria catanese, tra Otto e Novecento, contava sul lavoro di circa
quella di Rosario Porto, attiva dagli anni sessanta dell’Ottocento, che all’inizio del secolo successivo giunse a impiegare oltre trecento lavoranti. Come riferiva una rivista del tempo:
La più grande ed importante fra le fabbriche catanesi di istrumenti musicali è quella della ditta Rosario Porto e Figli, che per il suo vasto impianto, la bontà universalmente riconosciuta della immensa varietà di strumenti che sorgono dalle sue officine, eccelle non solo sulle sue consorelle siciliane, ma eziandio su tutte le altre case consimili italiane. Fu fondata nel 1860, e quasi mezzo secolo di attività utilmente spesa ha pro-gressivamente allargato la cerchia dei suoi affari sì da permetterle di potere soddisfare qualunque richiesta le venga fatta tanto da dilettanti che da professori di musica. Il suo grande catalogo illustrato, che gratui-tamente viene spedito a chiunque ne faccia richiesta […] enumera tutte le specialità che essa fabbrica, e fra le principali di queste troviamo, oltre ad un grande assortimento di strumenti a corda, quali mandolini, chitarre, violini, viole, violoncelli, contrabbassi, di ogni qualità e prezzo, dal tipo più corrente da poco prezzo, a quello di lusso, fabbricato con eccezionale ricchezza, un lungo elenco di altri. […] Proprietario della Casa è attualmente il sig. cav. Giuseppe Porto [figlio di Rosario] alla cui intelligenza ed attività si deve se gli istrumenti musicali di questa fabbrica sono conosciuti adesso in tutto l’universo, facendosene una grande esportazione specialmente in fatto di mandolini e chitarre, e se in tutte le Esposizioni in cui concor-se le sono state assegnate primarie onorificenze (7 diplomi d’onore, 8 crocette al merito industriale, 18 medaglie d’oro, ed un’infinità di medaglie d’argento, di bronzo e menzioni onorevoli). Il Ministero di Agri-coltura, Industria e Commercio conferì a questa Casa la medaglia d’argento per la esportazione, e il titolo di Cavaliere della Corona d’Italia venne conferito al sig. Giuseppe Porto per avere elevato ad importante e primaria industria la fabbricazione degli istrumenti musicali [BontEMpELLi - tREvisani 1903, pp. 378-379].
Basta appunto dare uno sguardo ai riconosci-menti industriali assegnati alla fabbrica Porto tra il 1889 e il 1907 per comprendere l’importanza di questa manifattura: grand prix all’Esposizione Inter-nazionale di Lione del 1889, medaglia d’argento all’Esposizione Nazionale di Palermo del 1891, grand diplôme d’honneur, medaille d’or et croix insigne all’Esposizione Internazionale di Arcachon del 1897, grand diplôme d’honneur et medaille d’or all’Espo-sizione Internazionale di Bordeaux del 1897, grand prix d’honneur all’Esposizione Internazionale del Cairo del 1897, medaglia d’oro all’Esposizione Cam-pionaria di Roma del 1898, medaille d’or all’Esposi-zione Internazionale di Praga del 1898, medaglia d’oro all’Esposizione di Torino del 1898, grand prix all’Esposizione Internazionale di Perpignan del
11. Catalogo illustrato del 1903 della fabbrica Rosario Porto e Figli di Catania (Collezione Giovanni Paolo Di Stefano, Palermo)
36 Giovanni Paolo Di Stefano
una gita, o scopo di un geniale ritrovo di parenti e di amici. Il primo, il mandolino, è divenuto (o lo è sempre stato?) il compagno indivisibile dell’operaio che lo cerca per annasparlo con le sue dita incallite e bisunte, nei momenti più belli e talvolta in quelli più brutti, della sua faticosa giornata. Non è quello del signore, già s’intende! Niente avorio e madreperla, niente oro, niente argento: è di legno bianco, giallo, a strisce, ha la forma talvolta, anzi per lo più, di una cassetta col fondo piatto, dalle corde stridule, dalle chiavette sdrucite e cedevoli, dalla tastiera disuguale, dal suono fesso e poco gradevole.Oggi c’è più mandolini nelle case che… tavoli da pranzo (forse perché il mandolino riesce a scacciare presso certa povera gente la tentazione potentissima della fame…!). [gEntiLE 1906, pp. 1-2].
La fiorente industria catanese cominciò a entrare in crisi negli anni della Prima Guerra Mondiale. Come osservava un responsabile della locale Ca-mera di Commercio nel 1916, sebbene l’industria liutaria catanese «con pochi mezzi […] era assurta negli ultimi anni ad una opulenza invidiabile, e Catania era riuscita ad affermarsi fra tutte le altre piazze di produzione del mondo, come la più nota e la più importante» (CaMERa Di CoMMERCio 1916, p. 67), la Grande Guerra aveva arrecato un colpo durissimo a questo settore:
Una delle industrie più fiorenti di Catania è stata quella degli strumenti musicali a corda, sorta una ventina di anni fa e assurta ad importanza veramente degna di ri-lievo. Di strumenti musicali a corda ne furono esportati nell’anno 1912 per la sola via mare in numero di 45889 per L. 1.144.225. Nel 1913 si era saliti a 51701 strumenti per un valore di L. 1.297.525. Nel I° semestre 1914 si era saliti da 23358 a 33701 strumenti, e cioè da L. 583.950 a L. 841.225. Però la guerra uccise provvisoriamente l’industria che nel secondo semestre 1914 esportò solo 13764 pezzi per L. 206.460. Naturalmente anche nel 1915 le esportazioni diminuirono sino a spedirsi sol-tanto 1816 strumenti! I nostri industriali hanno però tentato esperire nuove vie e ottennero a suo tempo dal governo l’inoltro per pacchi postali per tutti i paesi e specie per la Russia, grande centro di consumo. Negli ultimi tempi avendo però la Svezia − per cui il transito si esportava − rifiutato il passaggio, i nostri industriali dovettero cessare dall’inviare i loro prodotti [CaMioLo vasta 1916, p. 9].
Negli anni del primo conflitto bellico «alcuni industriali tentarono ancora di inoltrare i loro pro-dotti non solo nei paesi neutri ma anche in quelli belligeranti ma, le sempre crescenti difficoltà nei trasporti ed i gravi rischi marittimi, li persuasero dopo lunghi e tenaci tentativi a rinunziare» (CaME-Ra Di CoMMERCio 1916, p. 67). Peraltro, larghissima parte della forza lavoro impiegata nelle fabbriche era stata richiamata alle armi e le manifatture per
duecento ditte. Molte di esse pubblicavano catalo-ghi illustrati plurilingue (solitamente in italiano, francese, inglese e tedesco) che consentivano la diffusione dei propri prodotti sia all’interno del territorio nazionale sia all’estero.
La produzione di queste grandi fabbriche era generalmente basata sulla costruzione di tipo semi-industriale con operai specializzati nella realizza-zione di singole parti. Le manifatture più grandi si avvalevano inoltre della collaborazione di un vero indotto costituito da tante piccole botteghe che producevano singole parti (casse armoniche, tastiere, decori in madreperla, ecc.) che poi veni-vano assemblate presso la “fabbrica madre”. Se, in linea generale, la qualità degli strumenti musicali non sempre uguagliava quella delle più rinomate botteghe napoletane, la produzione di queste ma-nifatture si rivelò assai concorrenziale e adatta a soddisfare il palato e le tasche del grande pubblico internazionale visto che, anche a causa del fenome-no dell’emigrazione di massa, tra Otto e Novecento la moda mandolinistica italiana si diffuse un po’ ovunque nel mondo.
Sul piano costruttivo, i mandolini di produzio-ne catanese presentano alcune peculiarità che consentono di distinguerli da quelli realizzati a Napoli: 1) hanno quasi sempre una particolare giuntura “a collare” tra il manico e il guscio; 2) spesso hanno manici rastremati e non tondeg-gianti come i napoletani; 3) sono frequentemente sovrabbondanti, almeno i modelli più costosi, di decorazioni in madreperla sulla tavola e sul manico. Una variante siciliana del mandolino napoletano prevedeva l’incordatura a dieci corde, ossia tripla per i due cori più acuti (La3 e Mi4), o a dodici corde. Tale tipologia ebbe tuttavia minore circolazione rispetto al tradizionale modello con quattro cori. All’inizio del Novecento fu anche diffusa una tipo-logia di mandolino napoletano con cassa a fondo piatto (al posto del tradizionale guscio a doghe) più semplice da costruire, più economico e fonda-mentalmente destinato al pubblico dei dilettanti. Proprio a questo modello faceva riferimento nel 1906 il musicista palermitano Stefano Gentile per evidenziare, con toni snobistici, la diffusione tra i ceti popolari del mandolino che «dalle soglie del trono» era sceso «sulle trine profumate, sulle chio-me bionde o corvine, […]» delle donne dell’alta società per divenire infine lo strumento prediletto del «popolino» che aveva «profanato» l’originaria destinazione «galante» dello strumento:
Oggi noi si parla di mandolino e chitarra, (incluso il popolino), come degli strumenti più e meglio adatti a completare una festicciuola di famiglia, un anniversario,
Strumenti musicali nelle collezioni siciliane 37
giore Francesco fino allo scoppio della Seconda Guerra. Anche durante il conflitto bellico, Car-melo continuò a costruire strumenti che vendette persino ai soldati americani sbarcati in Sicilia nel 1943. Dopo la guerra, la ditta di Carmelo Catania riprese a espandere i propri commerci tanto che, alla fine degli anni cinquanta, il liutaio acquistò un grande stabilimento a Mascalucia dove trasferì definitivamente la propria attività nel 1958 (fig. 12). Intorno al 1965, la fabbrica raggiunse il pe-riodo di massimo sviluppo con oltre cinquanta operai e una produzione annuale di circa 12.000 strumenti. I processi di lavorazione, sebbene ri-gorosamente manuali, erano di tipo seriale. Il ciclo di costruzione era infatti suddiviso in cinque macro-fasi alle quali corrispondevano altrettante squadre di operai specializzati che provvedevano rispettivamente ai seguenti compiti: costruzione della cassa; realizzazione di decori, filetti e tastiere; verniciatura; lucidatura; montaggio e collaudo.
Gli strumenti della fabbrica Catania erano so-prattutto destinati all’esportazione verso l’Europa continentale, l’America settentrionale e meridio-nale e l’Estremo Oriente. Se la produzione, nei primi decenni d’attività, aveva riguardato soprat-tutto i mandolini, tra il 1960 e il 1965 la commer-cializzazione di questi strumenti entrò in crisi (ben duemila e cinquecento esemplari rimasero infatti invenduti in deposito) e la produzione
non interrompere la produzione avevano dovuto impiegare operaie e bambini. Allo stesso tempo, le materie prime, per esempio i metalli utilizzati per le meccaniche, avevano cominciato a scarseggiare tanto che i costruttori per un certo periodo si erano trovati a dover addirittura spedire gli strumenti incompleti di meccaniche (CaMERa Di CoMMERCio 1918, p. 63). Un momentaneo recupero per questo settore si ebbe tra le due Guerre anche se, di fatto, l’industria liutaria catanese fu destinata a una crisi graduale che, poco alla volta, causò la chiusura di tutte le principali fabbriche.
Tra gli anni successivi alla Prima Guerra e quelli del boom economico che seguì la Seconda Guerra, il mercato liutario catanese trovò tra i suoi principali protagonisti il liutaio Carmelo Catania.
Nato nel 1908, Catania aveva iniziato a lavo-rare ancora bambino presso il liutaio catanese Carmelo Finocchiaro che, all’inizio del secolo, costruiva le casse per la rinomata fabbrica napo-letana di Raffaele Calace. Dopo aver egli stesso lavorato a Napoli presso Calace, Catania ritornò nel capoluogo etneo dove, sul finire degli anni venti, collaborò con i liutai Luciano ed Emilio Grimaldi e dove aprì la sua prima bottega in via Santa Caterina, a pochi passi dalla piazza Carlo Alberto. Iscrittosi alla Camera di Commercio di Catania nel 1936, il liutaio trasferì la bottega in via Grotte Bianche dove lavorò con il fratello mag-
12.La fabbrica di strumenti a corde di Carmelo Catania a Mascalucia in una foto del 1960 ca. (Archivio Giovanni Catania, Trecastagni - Catania)
38 Giovanni Paolo Di Stefano
cosiddetti arponi spesso citati in fonti archivistiche siciliane e napoletane seicentesche (Di stEfano 2007a, pp. 47-48).
Al di là dei riferimenti documentari, anche nel caso dell’arpa, nelle collezioni siciliane non sono apparentemente documentati esemplari precedenti al XIX secolo. Peraltro, nulla è noto sulla diffusione di questo strumento in Sicilia nel corso del XVIII secolo quando, soprattutto sulla spinta di costrut-tori francesi, l’arpa fu dotata di nuovi meccanismi azionati per mezzo di una pedaliera.
Per quanto riguarda l’arpa a pedali, nella prima metà del XIX secolo gli esecutori in Sicilia furono in numero assai esiguo e quasi sempre “forestieri”. L’unico di cui si abbia apparentemente notizia a Palermo a metà Ottocento è Luigi Kintherland, arpista presso il Teatro Carolino e socio onorario dell’Accademia di Santa Cecilia in Roma, il cui nome figura regolarmente nei libretti delle opere messe in scena negli anni quaranta e cinquanta del secolo e nelle statistiche dei professori di musica della città (annuaRio 1854, p. 537).
A quel tempo lo studio dell’arpa non era ancora previsto presso il Conservatorio di Palermo dove la prima cattedra fu istituita nel 1887 e affidata all’arpista Giuseppe Vitrano.75 Quest’ultimo, unico docente d’arpa allora presente in città, era stato allievo dello zio Francesco Bellotta, noto arpista palermitano che si era formato a Napoli alla scuola di Filippo e Alfonso Scotti (Ruta 1908a; pRofEta 1942, p. 436).
Risale dunque proprio agli anni 1887 e 1888 la trattativa tra il Conservatorio palermitano e il Ministero dell’Istruzione per l’acquisto della prima arpa. Lo strumento, a 43 corde in stile greco della ditta Érard di Parigi, fu reperito a Napoli presso il negozio di Michele Celentano, fabbricante di pianoforti, di armonium e riparatore di arpe, spe-cialità che aveva acquisito proprio presso la famosa fabbrica francese.76 Circa due anni dopo, questo strumento non fu tuttavia più sufficiente alle esi-genze dell’Istituto tanto che, a partire dal mese di ottobre del 1890, venne avviata una seconda e lunga trattativa per l’acquisto di una nuova arpa. Nella vicenda fu anche coinvolto il compositore Filippo Marchetti, direttore del Liceo Musicale di Santa Cecilia in Roma, al quale fu chiesto di recarsi presso il rivenditore romano Ceccherini per visio-nare un’arpa modello gotico della fabbrica Érard che tuttavia, al momento della visita, era ormai stata venduta. Lo stesso Marchetti, presa nota dei prezzi proposti dalla ditta Ceccherini, consigliò di rivolgersi direttamente alla fabbrica Érard presso cui lo strumento fu effettivamente acquistato nel giugno del 1892 al prezzo di 2400 lire.
della fabbrica Catania si spostò allora interamente sulle chitarre che, sull’onda del fenomeno della canzone d’autore, avevano invece cominciato a essere sempre più richieste (chitarre di Carmelo Catania furono acquistate in quegl’anni anche dai celebri cantautori Domenico Modugno e Claudio Baglioni).
In quello stesso periodo, Catania progettò un singolare modello di contrabbasso da band, a forma di chitarra (fig. 13), di cui si conserva un esem-plare presso la collezione del Conservatorio di Palermo (scheda 67). Si trattò però di una delle ultime invenzioni del liutaio catanese: la sua pre-matura scomparsa, nel 1970, segnò la chiusura di questa grande fabbrica e sostanzialmente il tra-monto dell’era delle grandi manifatture catanesi di strumenti a corda.74
Cordofoni senza manico: arpe e salteriNonostante la presenza degli spagnoli tra Quat-
tro e Settecento, diversamente da quanto avvenne nella penisola iberica, in Sicilia l’arpanon fu mai lo strumento prediletto per l’esecuzione del basso continuo (più comunemente eseguito all’organo o al clavicembalo). Dalle fonti documentarie ap-prendiamo comunque che le arpe ebbero senz’al-tro larga diffusione in Sicilia in epoca medievale, rinascimentale e barocca.
Le arpe raffigurate nei dipinti siciliani medievali e rinascimentali sono generalmente strumenti di piccolo formato con una sola fila di corde e spesso con colonne e modiglioni scolpiti o sormontati da elaborate sculture lignee. Ben poco è invece noto sull’impiego in Sicilia dell’arpa barocca a due o tre ordini di corde sebbene a questa tipo-logia potrebbero probabilmente corrispondere i
13. Contrabbassi nel catalogo illustrato del 1962 della fabbrica di Carmelo Catania (Archivio Giovanni Catania, Trecastagni - Catania)
Strumenti musicali nelle collezioni siciliane 39
dell’isola, soprattutto in ambito aristocratico e conventuale (Di stEfano 2008b, pp. 415-416). Il già citato marchese di Villabianca, per esempio, alla fine del Settecento riferiva di una suora chiamata Maria Carità, presso il monastero palermitano di Santa Maria delle Vergini, «dilettante di canto, cembalo e salterio» che, come tante altre religiose provenienti da famiglie aristocratiche, doveva es-sere stata educata alla pratica di questi strumenti (pitRè 1904, vol. II, pp. 183-184).81 Probabilmente il salterio fu anche spesso utilizzato per accom-pagnare il canto come raccontava per esempio, all’inizio dell’Ottocento, Francesco Cancellieri a proposito del pittore trapanese Giuseppe Erran-te. Giunto a Roma nel secondo Settecento per studiare pittura, Errante «formò una stretta lega con giovani Siciliani» e «siccome avea l’abilità di cantare con molta grazia le Canzonette della sua Nazione, ed anche accompagnarsele col Salterio, non essendo allora in uso la Chitarra Francese […] era spesse volte invitato da’ suoi concittadini, di andar seco loro la sera a cantare, ed a suonare» (CanCELLiERi, 1824, p. 8).
È verosimile che in Sicilia i salteri fossero costru-iti anche da artigiani locali, presumibilmente da costruttori di clavicembali. Questa supposizione sembrerebbe essere confermata almeno da uno strumento, l’unico oggi documentato in Sicilia, conservato presso la collezione del Teatro Massi-mo di Palermo che fu realizzato nel 1790 da un costruttore palermitano di strumenti a tastiera, Giovanni Battista Di Paola (scheda 80). Questo salterio manifesta analogie con strumenti di scuola napoletana e, come quelli, sembra avere risentito dell’influenza di modelli della tradizione francese e spagnola.
L’istituzione del Liceo femminile presso lo stesso Conservatorio e l’apertura di una seconda classe di arpa rese tuttavia necessario, nell’autunno dello stesso 1892, l’inoltro di una nuova richiesta al Ministero per l’acquisto di un altro strumento.77 L’apertura della nuova classe del Conservatorio e presso i due principali collegi femminili pa-lermitani − l’Educandato Maria Adelaide, dove la cattedra era stata affidata allo stesso Vitrano nel 1891, e l’Istituto Sant’Anna (fig. 14 e scheda 77) − incrementò il numero di arpiste e di arpe presenti in città. Tra i due secoli lo strumento di-venne dunque, assieme al pianoforte, quello più frequentemente presente nei salotti della buona società siciliana.
Morto Vitrano nel 1899 (Ruta 1908b), la cat-tedra del Conservatorio di Palermo passò fino al 1902 all’acclamata arpista fiorentina Rosalinda Sacconi e poi al napoletano Paolo Serrao che fu però assai contestato e sostituito nel 1905 dal suo concittadino Riccardo Ruta (Ruta 1911, p. 121). Proprio a Ruta, autore di due libricini sulla storia dello strumento (Ruta 1901 e Ruta 1911), si deve l’introduzione presso il Conservatorio palermitano dell’arpa cromatica brevettata nel 1894 da Gusta-ve Lyon, titolare della fabbrica Pleyel di Parigi. L’esemplare fatto acquistare da Ruta si conserva ancora presso l’istituto palermitano (scheda 78) che all’inizio del XX secolo, come molti altri con-servatori italiani, introdusse lo studio di questa nuova tipologia di arpa senza pedali e con due piani di corde incrociate.78
Se si eccettua lo strumento cromatico Pleyel del Conservatorio di Palermo, praticamente tutte le arpe presenti nelle collezioni siciliane sono strumenti a pedali, con meccanismo a doppio movimento, della casa Érard.79 Gli strumenti erano ritirati direttamente presso la fabbrica parigina o a Napoli dove era presente una più consolidata scuola arpistica e dove erano per questo attivi alcuni negozi specializzati nella vendita e nella riparazione di arpe. Tra di essi, oltre al negozio del già citato Celentano, va ricordata la ditta di Pasquale Curci che si era formato presso le fab-briche Érard e Morley di Londra e che nei propri cataloghi commerciali d’inizio Novecento preci-sava di essere fornitore dei Reali Conservatori ed Educandati di Napoli e di Palermo (CuRCi 1915 ca).80
Come per l’arpa, anche per il salterio le in-formazioni sono piuttosto esigue. Lo strumento dovette avere certamente diffusione durante il XVIII secolo quando il suo uso è occasionalmen-te registrato nelle fonti archivistiche, tanto nella Sicilia orientale quanto nella parte occidentale
14.Orchestrina di arpe e strumenti ad arco dell’Istituto Sant’Anna in una foto dell’inizio del XX secolo (Archivio dell’Istituto Sant’Anna, Palermo)
40 Giovanni Paolo Di Stefano
Proprio a Messina, città in cui fu attivo Grimaldi − secondo quanto indicato da Giovanni Battista Doni nelle sue Annotazioni sopra il compendio pubblicate a Roma nel 1640 − sembra che furono costruiti anche clavicembali enarmonici, dotati dunque di più di dodici tasti per ottava, che consentivano appunto l’esecuzione di suoni enarmonici (MEuCCi 1998b, pp. 248-249).
Tra gli altri cordofoni a tastiera che ebbero dif-fusione in Sicilia, almeno sin dall’inizio del Cin-quecento, vi fu poi la spinetta − nelle sue varianti con cassa poligonale, rettangolare e traversa − che ricorre con frequenza nelle fonti documentarie. Discreta diffusione sembra anche avere avuto in Sicilia la spinetta incordata in budello, detta tior-bino, che compare occasionalmente nelle fonti archivistiche sei-settecentesche (Di stEfano 2007a, p. 49).85 Un’altra variante, che sembra aver circolato anche in Sicilia, fu la spinetta doppia. Si trattava di uno strumento a pianta rettangolare nella cui cas-sa, accanto alla tastiera principale, era ricavato un vano che accoglieva una piccola spinetta all’ottava.Le due spinette, la principale e quella all’ottava, potevano essere dunque suonate contemporanea-mente da due diversi esecutori oppure, estraendo la spinettina e ponendola sopra quella grande, da un unico strumentista. «Due spinetti tutto d’un pezzo – ossia costituite da un’unica cassa – una grande nella quale n’entra l’altra picola con li tasti d’avolio […] rivestita di velluto verde chiaro assai bella» figurava nel 1646 nell’inventario di Ottavio Branciforti vescovo di Catania e costituisce uno dei più antichi riferimenti attestanti la presenza in Italia di questo genere di strumenti che furono tipici soprattutto della tradizione cembalaria fiam-minga (ibidem).86
Oltre a clavicembali e spinette, tra i cordofoni a tastiera più diffusi, dal Rinascimento almeno fino all’inizio del Settecento, vi fu il clavicordo che a quel tempo era più comunemente chiamato ma-nacordio o minacordio.
Clavicembali, spinette e clavicordi, nelle loro diverse varianti, costituivano − almeno in ambito domestico − anche una comoda e pratica alternativa all’organo per il cui funzionamento gli organisti erano obbligati ad avvalersi dell’aiuto di uno o più addetti al sollevamento dei mantici che portavano l’aria alle canne.
Gli strumenti a tastiera che abbiamo citato veni-vano spesso costruiti da artigiani locali che, in gran parte dei casi, erano al tempo stesso cembalari e organari. Talvolta clavicembali e spinette furono anche importati da altre zone d’Italia, per esempio da Napoli, da Roma e da Venezia. Spinette vene-ziane figuravano ad esempio nel 1618 nell’inven-
Secondo Valdrighi il salterio era ancora utiliz-zato in Sicilia nella seconda metà del XIX secolo (vaLDRighi 1884, p. 175). L’ipotesi sembrerebbe essere confermata dal catanese Lionardo Vigo che nel 1857 registrò appunto l’uso del salterio − di cui, raccontava, «odesi il tintinnio in qualche terra delle montagne» − in ambito popolare e in occasione di tenzoni poetiche che prevedevano anche l’uso di strumenti musicali (vigo 1857, p. 65). Allo stato attuale non sono comunque attestati strumenti risalenti a quell’epoca e riconducibili a questa tradizione.
Strumenti a tastieraNel campo della costruzione degli strumenti
musicali a tastiera, il primato in Sicilia spetta sicura-mente all’organo. L’intensa attività degli organari siciliani è infatti testimoniata da centinaia di stru-menti, i più antichi dei quali risalgono addirittura al XVI secolo, sparsi nelle chiese di tutta l’isola. Alla tradizione organaria siciliana, nel corso degli ultimi venticinque anni, sono stati dedicati un cospicuo numero di pubblicazioni sebbene sia ancora atteso uno studio che riconsideri in modo organico la storia di questa importante attività artigianale dal Medioevo all’età contemporanea.82
Almeno dall’inizio del Cinquecento − ma proba-bilmente si potrebbe andare ancora più indietro nel tempo − gli organari siciliani produssero anche cordofoni a tastiera, in primo luogo clavicembali.83 Come gli organi coevi, i clavicembali cinquecente-schi erano provvisti di una tastiera di quarantacin-que-cinquanta tasti. Occasionalmente sembra che in Sicilia, tra Cinque e Seicento, furono realizzati anche clavicembali a due tastiere: caratteristica abbastanza insolita nell’ambito della tradizione cembalaria italiana che privilegiava strumenti a un solo manuale. Un «cimbalum dublum» fu costruito già nel 1527 a Palermo dall’organaro Antonino Ortis per il nobile pisano Alessandro Rosolmini. Un altro «zimbalo dobulo» è poi menzionato nel 1607 nell’inventario del barone palermitano Luigi Scavuzzo e Russo di Cefalà mentre «un cembalo vecchio con due tastature» nel 1717 era citato tra i beni ereditari del celebre organaro e cembalaro messinese Carlo Grimaldi (Di stEfano 2007a, p. 48).84 Quest’ultimo, considerato tra i migliori co-struttori di clavicembali attivi in Italia tra il XVII e il XVIII secolo, è anche l’unico cembalaro siciliano di cui siano sopravvissuti con certezza strumenti fino ai nostri giorni. I tre preziosi clavicembali di Grimaldi oggi superstiti sono tuttavia conservati tutti fuori dalla Sicilia, rispettivamente presso i musei di strumenti musicali di Norimberga, di Parigi e di Roma (Di stEfano cds3 e CoRsi 1981).
Strumenti musicali nelle collezioni siciliane 41
portato in Sicilia soltanto alla fine del XIX secolo come pezzo d’antiquariato destinato ad arredare l’ottocentesca Villa Malfitano (scheda 82).
La dispersione di clavicembali, spinette e cla-vicordi, che abbondavano un tempo nei palazzi dell’aristocrazia siciliana, può essere addebitata alla straordinaria diffusione del pianoforte a partire dalla seconda metà del XVIII secolo. Il successo di questo strumento spodestò infatti, seppur gradual-mente, gli strumenti a tastiera più antichi di cui tra Otto e Novecento, anche a causa dell’assenza in Sicilia di collezionisti, si è persa praticamente ogni traccia. D’altronde, seppur in misura minore, sorte analoga hanno subito anche i pianoforti settecen-teschi e del primo Ottocento che, nella stragrande maggioranza dei casi, furono a loro volta sostituiti da modelli tecnologicamente più moderni.
I pianoforti settecenteschi, di cui qualche esem-plare sopravvive comunque in collezioni siciliane, fino alla fine del secolo furono soprattutto realizzati da cembalari locali.
Come avvenne in altre zone della penisola, dal punto di vista costruttivo i pianoforti siciliani settecenteschi presentano evidenti analogie con i clavicembali coevi. Il corpo dello strumento, ad esempio, è generalmente del tipo “con finta
tario dei beni appartenuti al messinese Giovanni Paolo de Ancona, nel 1630 tra gli strumenti di don Giovanni Maria Gisulfo di Agrigento e nel 1665 nell’inventario del principe palermitano Giovanni Valdina. Nel 1670 tre cembali, «uno romano grande et altri dui piccoli», erano inoltre citati, insieme a «un violino veneziano bello con sua fodera novo, [e] un violino grande novo», tra i beni dotali di tale Flavia Di Bartolomeo residente a Collesano, in provincia di Palermo.87 Un cembalo veneziano era inoltre presente nel 1734 presso il palazzo del principe palermitano Nicolò Placido Branciforti (Di stEfano 2007a, p. 49).
In realtà, di questo patrimonio su cui − come abbiamo dimostrato − non mancano numerose testimonianze documentarie quasi nulla si con-serva nelle collezioni dell’isola. Appena tre sono infatti gli strumenti della famiglia del clavicembalo fino a oggi documentati in collezioni siciliane: una spinetta traversa in possesso privato a Palermo, un clavicembalo italiano presso il Collegio Capizzi di Bronte (entrambi anonimi e ambedue peraltro trasformati in pianoforte nella seconda metà del XVIII secolo) e un clavicembalo francese di Ni-cholas Pigalle del 1737 (fig. 15), conservato presso la Fondazione Whitaker di Palermo, che però fu
15. Clavicembalo costruito a Digione nel 1737 da Nicholas Pigalle (Fondazione Whitaker - Villa Malfitano, Palermo)
42 Giovanni Paolo Di Stefano
al percussore consentendo così all’esecutore una maggiore gamma di sfumature dinamiche dal piano al forte. L’abbassamento del tasto, tramite la pressione del dito, spinge verso l’alto la leva intermedia che scaglia dunque il percussore ver-ticalmente contro la corda. A seguito dell’urto con la corda, il percussore a movimento verticale rimbalza e ricade per gravità come qualsiasi mar-telletto di pianoforte. L’estremità superiore di questi percussori di legno a movimento verticale, che percuotono la corda dal basso, ha solitamente forma arrotondata e può essere ricoperta di pelle oppure non avere alcun rivestimento.
Ricapitolando, gli elementi che contraddistin-guono gli strumenti siciliani dotati di questo tipo di meccanica sono i seguenti: 1) impiego di percussori non imperniati spinti contro le corde da leve in-termedie agganciate a un listello posto al di sopra della tastiera e orientate in direzione contraria all’esecutore; 2) presenza di percussori costituiti da una asticciola (che poggia sulla leva intermedia) sulla cui sommità è incollata una testa in legno che può essere nuda o rivestita di materiale morbido (pelle o feltro per gli strumenti ottocenteschi). Tali percussori pendono da una lista guida simile a quella dei salterelli del clavicembalo (ciò consente la rimozione della tastiera dal suo vano senza dovere estrarre i percussori, cosa generalmente impossibile negli strumenti dotati di questa meccanica che ap-partengono ad altre scuole costruttive); 3) assenza di apparato smorzatore, talvolta rimpiazzato da un dispositivo per l’imitazione dell’arpa − costituito da una sorta di spazzola che pressa le corde dell’alto smorzandone il suono − azionato per mezzo di una ginocchiera o di un pedale; 4) costruzione di tastiere con estensione ridotta rispetto ai pianoforti coevi e con telaio realizzato a “cassetto” come nei
cassa esterna”, solitamente privo di impiallaccia-ture e decorato secondo le modalità tipiche della cembalaria italiana settecentesca. Dal punto di vista tecnologico, i pianoforti siciliani del XVIII secolo (si veda per esempio quello del Museo Belliniano di Catania, scheda 84) presentano quasi sempre una meccanica piuttosto rudimen-tale del tipo con martelletti non imperniati (più comunemente nota come “meccanica a tangenti”) che ebbe diffusione nel Settecento anche in altre aree europee.88 Nel pianoforte con martelletti non imperniati le corde sono percosse da asticciole di legno (dei salterelli a percussione) che scorrono verticalmente dentro registri simili a quelli dei clavicembali e, come i comuni martelletti del pianoforte, percuotono le corde da sotto (fig. 16). Diversamente dai tradizionali martelletti – che so-no generalmente imperniati al telaio della tastiera o alle leve dei tasti e si muovono con movimen-to rotatorio, simile a quello di una catapulta – i percussori presenti in questi strumenti non sono incardinati ad alcun elemento della meccanica e si muovono perpendicolarmente alla corde. A differenza di altre meccaniche di pianofor-te (a partire da quella di Bartolomeo Cristofori che ne fu l’inventore intorno all’anno 1700) la meccanica con martelletti non imperniati non è inoltre dotata del meccanismo di scappamento, che ha la funzione di facilitare l’allontanamento del martelletto dalla corda dopo che questa è stata percossa. In genere, per esercitare sui percussori una spinta propulsiva più efficace – analogamente a quanto avviene nei pianoforti di derivazione cristoforiana – negli strumenti con martelletti non imperniati sono presenti leve intermedie. Queste sono sospese al di sopra del telaio della tastiera e amplificano l’energia cinetica trasmessa dal tasto
16. Meccanica con martelletti non imperniati: 1 leva del tasto, 2 punto di spinta, 3 leva intermedia, 4 martelletto non imper-niato a movimento verticale, 5 corda, 6 smorzatore unico (registro d’arpa). Disegno dell’autore
6
54
32
1
Strumenti musicali nelle collezioni siciliane 43
d’Austria − la quale aveva notevolmente favorito i rapporti culturali e politici tra la corte parte-nopea e quella di Vienna. Anche dopo la morte della regina, nel 1814, e a seguito del Congresso di Vienna le relazioni commerciali e culturali tra il Regno delle Due Sicilie e l’impero asburgico non furono sostanzialmente intaccate e ciò favorì l’afflusso a Napoli di molti costruttori viennesi (sELLER 2007).
Anche in Sicilia, almeno per i primi decenni dell’Ottocento, i pianoforti dei costruttori viennesi (per esempio di Joseph Böhm, Johann Fritz, Joseph Carl Fuchs, Conrad Graf, Johann Jakesch, Mathias Jakesch, Martin Müller giusto per citarne alcuni documentati in Sicilia) furono dunque assai dif-fusi (si vedano quelli alle schede 87, 90 e 91). Allo stesso tempo, a causa della politica protezionistica messa in atto dal governo borbonico dopo il 1824 per favorire le attività manifatturiere del Regno delle Due Sicilie e per ostacolare l’importazione di prodotti stranieri, tra gli anni venti e gli anni sessanta divenne sempre maggiore la presenza in Sicilia di pianoforti realizzati da artigiani locali e napoletani. L’aumento del dazio sull’importazione degli strumenti stranieri, sancito da un decreto regio del 12 settembre 1831, determinò infatti nell’isola un sostanziale distacco dalla produzio-ne di pianoforti importati dall’estero e il fiorire, soprattutto a Napoli e a Palermo, di numerose ma-nifatture in grado di soddisfare la richiesta locale.90 Peculiarità delle fabbriche napoletane e siciliane era quella di realizzare copie a basso prezzo di strumenti stranieri, soprattutto viennesi. Di fatto, per favorire i costruttori locali, il protezionismo borbonico rese dunque i pianoforti di produzione estera un vero e proprio lusso che soltanto le fa-miglie più abbienti potevano ostentare nei propri
cembali di scuola napoletana e siciliana del Sei-Settecento.
Pianoforti con queste caratteristiche, a coda e a tavolo, ebbero larga diffusione in Sicilia dalla seconda metà del XVIII secolo alla seconda metà del XIX secolo (si vedano ad esempio gli esemplari ottocenteschi alle schede 85 e 88).89
Sul finire del Settecento, l’importazione di pia-noforti stranieri, provenienti soprattutto dai paesi di lingua tedesca, determinò la diffusione in Sicilia anche della meccanica a contraccolpo con mecca-nismo di scappamento, la cosiddetta Prellmechanik. Questo meccanismo, originariamente ideato dal costruttore Johann Andreas Stein di Augusta e poi perfezionato sul finire del Settecento dai costruttori di Vienna, divenne la tipologia di meccanica più diffusa in Italia, e dunque anche in Sicilia, fino alla seconda metà del XIX secolo. Nella meccani-ca a contraccolpo di tipo viennese il martelletto è montato in una forcola infissa direttamente sulla leva del tasto (fig. 17). Si tratta di una meccanica leggera ma allo stesso tempo potente che consentiva agli strumentisti prontezza nell’esecuzione degli abbellimenti e delle note ribattute, potenza sonora e un’ottima cantabilità.
I pianoforti di Vienna − principale polo europeo per la produzione di questi strumenti tra Sette e Ottocento − ebbero larghissima diffusione in Italia anche e soprattutto a causa degli stretti rapporti dinastici, politici e commerciali che la casa im-periale asburgica instaurò con i regni dell’Italia pre-unitaria (Di stEfano 2008d). Non si dimenti-chi per esempio che, fino all’arrivo delle truppe napoleoniche, sul trono di Napoli e di Sicilia, al fianco di Ferdinando di Borbone, aveva seduto una regina austriaca − Maria Carolina d’Asburgo, tredicesima figlia dell’imperatrice Maria Teresa
17. Meccanica a contraccolpo di tipo viennese: 1 leva del tasto, 2 forcola, 3 martelletto, 4 meccanismo di scappamento, 5 corda, 6 smorzatore
6
5
43
21
44 Giovanni Paolo Di Stefano
Il modello di riferimento per i costruttori sicilia-ni, come abbiamo detto, fu soprattutto quello di Vienna anche se in alcune zone di provincia − so-prattutto nella Sicilia orientale, in particolare nel catanese e nel ragusano − si ebbe una propensione al mantenimento di tecniche costruttive ormai ca-dute in disuso altrove. Si tratta di un interessante caso di conservatorismo organologico forse dovuto alla condizione di perifericità geografica in cui si trovarono a operare questi costruttori di pianoforti che continuarono dunque a realizzare, fino a oltre la metà del secolo, strumenti con piccole tastiere di ambito settecentesco (spesso appena cinque ottave da Do1 a Do6), con “arcaiche” meccaniche dotate di martelletti non imperniati (del tipo che abbiamo descritto sopra) e privi di apparato smor-zatore. Caso emblematico, da questo punto di vista, è quello di un anonimo pianoforte catanese della collezione del Museo Belliniano − databile agli an-ni venti dell’Ottocento − appartenuto a Vincenzo Bellini, cugino omonimo del celebre compositore (scheda 88). Lo strumento si ispira chiaramente, sul piano estetico, allo stile dei coevi pianoforti con cassa a tripla curva e gambe a colonna realizzati a Vienna appunto negli anni venti del secolo. In questo caso la superficie esterna del mobile non è tuttavia impiallacciata − come era prassi a Vienna (e in tutta Europa) dalla seconda metà del XVIII secolo − ma, come negli strumenti italiani sette-
salotti (fig. 18). E nonostante i bei discorsi sulla bontà delle manifatture nazionali, formulati a quel tempo da economisti e da amministratori borbo-nici, forse anche un po’ a causa dell’esterofilia di cui la nobiltà siciliana aveva sempre sofferto, il ricorso a pianoforti di produzione locale costituì probabilmente più un ripiego dettato da esigenze economiche che una scelta voluta. Forse proprio per questa ragione, diversi pianoforti siciliani e napoletani ottocenteschi – spesso anche di buona fattura e quasi tutti realizzati a perfetta imitazione degli strumenti di Vienna – non furono firmati dai loro artefici così da lasciare ambiguamente il dubbio sulla loro provenienza. Non mancarono tuttavia costruttori (a Napoli ve ne furono oltre centocinquanta e anche in Sicilia lavorarono deci-ne di artigiani) che si guadagnarono una discreta fama nel Regno. Tra questi è opportuno per esem-pio citare i napoletani Carlo De Meglio (si veda lo strumento alla scheda 89), Giacomo Ferdinando Sievers e, per la Sicilia, il palermitano Francesco Paolo Stancampiano (di cui si conservano pia-noforti nella Collezione Lo Cicero di Palermo e presso la Fondazione Piccolo di Capo d’Orlando, in provincia di Messina).
Se Palermo, come dicevamo, fu il principale polo per la produzione di pianoforti, in Sicilia nel corso della prima metà dell’Ottocento, la costruzione di questo strumento è documentata un po’ ovunque.
18. Pianoforte a coda costruito a Vienna intorno al 1828 da Mathias Jakesch (Museo Regionale di Palazzo Mirto, Palermo)
Strumenti musicali nelle collezioni siciliane 45
diffusione degli strumenti importati, danneggiò irrimediabilmente la produzione locale. D’altron-de, il carattere ancora artigianale delle manifatture dell’isola − che sconoscevano il sistema della fabbrica − non permetteva di far fronte alla forza produttiva delle grandi industrie estere. Quest’ultime, avvalen-dosi della produzione in serie, immettevano infatti sul mercato un numero considerevole di strumenti in tempi più brevi e a prezzi competitivi.
Dalla metà del secolo, e in misura sempre mag-giore dopo gli anni sessanta, ebbero una buona diffusione in Sicilia i pianoforti francesi. Fino ad allora la circolazione di questi strumenti in Italia, e in particolare nel Regno delle Due Sicilie, era stata limitatissima a causa del protezionismo e − come raccontava nel 1849 il celebre costruttore parigi-no Pierre Érard − per la spietata concorrenza dei fabbricanti viennesi (ÉRaRD 1849, p. 6).
Tra le case costruttrici francesi oltre a Érard (di cui si conservano ad esempio pianoforti a coda del secondo Ottocento presso i palazzi palermitani dei principi Tortorici di Raffadali, della famiglia Withaker e dei principi Nicolaci di Villadorata a Noto) − e più sporadicamente Boisselot et fils di Marsiglia − la fabbrica Pleyel di Parigi fu senza dubbio quella di maggiore successo in Sicilia.91 I pianoforti Pleyel, dalla metà agli ultimi decenni del secolo, furono presenti nei più importanti salotti dell’isola (fig. 19), presso le principali istituzioni
centeschi, è invece realizzata in abete dipinto (in questo caso a imitazione dell’impiallacciatura di mogano comunemente utilizzata dai viennesi). Anche l’ambito della tastiera non corrisponde a quella dei pianoforti di Vienna: lo strumento ca-tanese ha estensione Sol0-Do6 (appena sessantasei tasti) laddove i pianoforti viennesi contemporanei avevano comunemente raggiunto l’ambito Do0-Fa6. La meccanica di questo pianoforte siciliano non è inoltre quella a contraccolpo con meccanismo di scappamento, tipica dei pianoforti viennesi, ma la già descritta meccanica con martelletti non imper-niati che nel resto d’Europa non si costruiva più da decenni e che in Sicilia fu invece realizzata ancora fino alla seconda metà dell’Ottocento. Questo sin-golare pianoforte siciliano, per concludere, coniuga dunque elementi estetici alla moda di derivazione chiaramente viennese con soluzioni tecnologiche decisamente retrive ancora legate alla tradizione costruttiva siciliana tardo settecentesca.
L’annessione della Sicilia al Regno d’Italia pose fine ai benefici di cui i costruttori locali avevano goduto in epoca borbonica. La crisi ebbe inizio con l’estensione all’intero territorio italiano della tariffa doganale sarda che ridusse i dazi d’importazione e abolì dunque il regime protezionistico di cui le industrie del Regno delle Due Sicilie avevano fino a quel momento approfittato (BaRBiERi 1994, p. 178). L’instaurazione del libero scambio, facilitando la
19. Pianoforte a coda costruito a Parigi nel 1858 dalla fabbrica Pleyel Wolff et Compagnie (Museo Regionale di Palazzo Mirto, Palermo)
46 Giovanni Paolo Di Stefano
Nella seconda metà del XIX secolo ebbero inol-tre larga diffusione, anche in Sicilia, gli armonium frequentemente impiegati in ambito domestico e liturgico come alternativa più economica all’organo a canne. Questi strumenti a tastiera ad ancia libera, nelle loro diverse varianti, furono principalmente importati dalla Germania e dalla Francia (si veda per esempio l’harmonino del parigino Alexandre-François Debain, inventore dell’armonium, alla scheda 94). Costruttori di armonium non manca-rono anche a Palermo, a Catania e in molti altri centri dell’isola dove questi strumenti furono anche realizzati da diversi organari.
Il medesimo sistema di produzione del suono impiegato nell’armonium fu adottato nel secondo Ottocento per la costruzione di altri strumenti ad ancia libera. Tra questi, anche in Sicilia, trovarono notevole favore l’organetto e la fisarmonica.
Particolarmente attive nella costruzione degli organetti a mantice furono alcune ditte della Sicilia orientale tra cui spiccano soprattutto le fabbriche di Giuseppe Porto (fig. 20) e del fratello Salvatore, figli del già citato Rosario Porto titolare dell’imponente manifattura catanese specializzata nella costruzio-
musicali e furono imitati da costruttori locali (per esempio Salvatore Bruilotta di cui si conserva uno strumento presso Palazzo Asmundo a Palermo) che ne riprodussero l’estetica pur continuando a dotare i loro strumenti della tradizionale meccanica viennese piuttosto che di quella francese.
Pianoforti Pleyel sono ancora oggi conservati nei palazzi palermitani dei principi di Mirto, dei principi di Gangi (il cui strumento fu suonato da Giacchino Rossini, che tracciò sulla tavola armonica la propria firma, e da Richard Wagner), dei conti Federico, dei principi Alliata di Pietratagliata, del barone Enrico Pirajno di Mandralisca a Cefalù. Pianoforti Pleyel furono anche in uso presso il Real Educandato Maria Adelaide, presso l’Istituto Sant’Anna e al Conservatorio di Palermo (quest’ul-timo strumento, che portava il numero di serie 70655, è tuttavia andato disperso). Una raccolta di quattro pianoforti Pleyel, di cui uno a coda del 1866 appartenuto al pianista e compositore fran-cese Eugène Ketterer, è anche presente presso la Collezione Casiglia di Cinisi ma questi strumenti sono comunque stati reperiti soltanto in epoca recente sul mercato antiquario italiano.
Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecen-to, il mercato siciliano del pianoforte − soprattutto degli strumenti verticali da studio − fu dominato dalle case costruttrici tedesche tra cui spiccano, tra gli altri, i nomi delle fabbriche Rönisch di Dresda, Schiedmayer di Stoccarda e Bechstein di Berlino. Piuttosto rara fu invece la presenza, fino all’inizio del XX secolo, dei pianoforti americani e in par-ticolare di quelli della celebre fabbrica Steinway and sons di New York di cui uno strumento (pro-babilmente il primo giunto a Palermo) fu proposto in vendita nel 1889 al Conservatorio cittadino dal commerciante Luigi Milazzo.92
Sempre a fabbricanti di pianoforti è presumi-bilmente addebitabile la costruzione di idiofoni a tastiera. Tra questi vi furono i cosiddetti “pia-noforti a cristalli” o “armoniche a tastiera”, una sorta di Glockenspiel in cui martelletti di pianoforte colpiscono piastrine di vetro, che furono utilizzati in ambito orchestrale (BERLioz 1844, p. 274) ma probabilmente anche come preziosi strumenti giocattolo. Pianoforti a cristalli furono realizzati, nel corso del XIX secolo, a Napoli da Raffaele e Giuseppe Bisogno (si veda, per maggiori dettagli, la scheda 92) e − almeno secondo quanto traman-dato oralmente − anche in Sicilia, in particolare a Ragusa, dai fratelli Bornò che furono soliti chia-marli “strumenti angelici” (di costruzione siciliana potrebbe essere, per esempio, un pianoforte a cristalli conservato presso la Collezione Lo Cicero di Palermo).
20. Pubblicità degli organetti a mantice nel catalogo illustrato del 1903 della fabbrica Rosario Porto e Figli di Catania (Col-lezione Giovanni Paolo Di Stefano, Palermo)
Strumenti musicali nelle collezioni siciliane 47
Qualche anno dopo aver brevettato le succitate invenzioni, Mazziniani dedicò alla fisarmonica altre due innovazioni. La prima, brevettata nel 1951, ri-guardava un «apparecchio deviatore della colonna d’aria atto ad ottenere i trasporti da una tonalità musicale ad un’altra negli strumenti a tastiera ad aria, caratterizzato dal fatto che raggiunge tale scopo mediante l’introduzione dell’aria nello stesso alveolo che contiene le ance da due fori diversi i quali vengono opportunamente chiusi o aperti da una lamina forata che si sposta orizzontalmen-te».94 Quattro anni più tardi, nel 1955, Mazziniani brevettò un «manale indicatore scorrevole alla fisarmonica con indicatore a scatto atto ad otte-nere una maggiore libertà di manovra della mano nel toccare i tasti in qualsiasi punto della tastiera (bottoniera) ed inoltre ad indicare la posizione di alcuni tasti per mezzo dello scatto di una molla».95 Tutte le invenzioni di Mazziniani non sembrano tuttavia avere trovato diffusione e rimasero poco più che esperimenti.
Strumenti meccanici Tra gli strumenti meccanici, gli orologi musicali
furono probabilmente quelli che si diffusero per primi in Sicilia. In questi dispositivi i meccanismi a orologeria mettevano generalmente in funzione piccoli organi a cilindro che riproducevano automa-ticamente brevi melodie appositamente arrangiate dai costruttori per quegli strumenti. La parte fonica dell’organo – solitamente costituita da un unico registro di canne metalliche – era celata dentro la cassa dell’orologio in modo che, allo scoccare dell’ora, la musica fuoriuscisse inaspettatamente da essa generando l’ammirato stupore degli astanti.
Nel corso del XVIII secolo, troviamo testimo-nianza di questi strumenti tra gli arredi delle più prestigiose dimore aristocratiche dell’isola. Due sontuosi orologi musicali settecenteschi, realizzati dalle famose manifatture parigine Meuron et Com-pagnie e Ferdinand Berthoud, sono per esempio presenti nei saloni del principesco Palazzo Mirto a Palermo (Di stEfano 2011, pp. 19-21).
Sempre nel Settecento, seppur sporadicamente e in via sperimentale, strumenti meccanici furono costruiti anche in Sicilia. A Catania, l’organaro e cembalaro Donato Del Piano, ad esempio, nel 1785 realizzò un organetto a cilindro a manovella che imitava il canto degli uccelli come accessorio per l’organo monumentale della chiesa benedettina di San Nicolò l’Arena (Buono - Di stEfano 2012).
Grandi e preziosi organi a cilindro con mecca-nismo a orologeria − del tipo definito dai tedeschi Flötenuhr o Spieluhr − azionanti automaticamente per mezzo di un peso-motore, giunsero nell’isola
ne di mandolini e chitarre. Salvatore Porto, oltre a essere un costruttore di organetti fu egli stesso organettista «insuperabile conosciuto in tutta Italia e all’estero» (BontEMpELLi-tREvisani 1903, p. 390). Una minuziosa descrizione dei numerosi modelli di organetto prodotti dalla fabbrica di questo co-struttore è fornita nel catalogo commerciale che Porto pubblicò nel 1902. Come si evince da questo opuscolo, e dalle parole dello stesso costruttore, la produzione era basata sul sistema di fabbrica e si avvaleva dunque della manodopera di operai specializzati:
La robustezza di voce, la precisione del lavoro e la lun-ga durata delle linguette è ormai notissima alla mia numerosa clientela, ed è perciò che ottenni il primato su tutte le altre fabbriche.Fabbrico con macchine speciali tutti gli accessori degli organetti e ogni operaio è tenuto a fare sempre un la-voro, per la qual cosa ho ottenuto la grande precisione dei lavori, l’eleganza e la mitezza dei prezzi. Tutte le altre fabbriche, per dare tono alle linguette le limano a mano. Nella mia vengono limate con macchine apposite, ottendendone voce più sonora e maggiore durata.I miei organetti a una fila di tasti, hanno il 1° tasto accordato bemolle del 5°, sicché la scala si rende più completa. Essi sono costruiti con piastrelle di zingo [sic] separate, e con camere delle linguette di eccezionali dimensioni, il che non si pratica da nessuna fabbrica [s. poRto 1902, p. 7].93
Sempre a Catania e nel vicino paese di Giarre furono inoltre attive le fabbriche di organetti della famiglia La Rosa di cui un esemplare si conserva presso il Museo Musica e Cultura dei Peloritani a Gesso (scheda 95). Organetti furono prodotti anche a Ragusa da Michelangelo Barone, premiato con menzione onorevole in occasione dell’Esposizione di Siracusa del 1871 (poRCaRi 1871), e a Palermo da Pietro Bisagna che aveva la sua bottega in vicolo Mango ai Maccheroni (siCiLia CattoLiCa 1880).
Sperimentazioni riguardanti la costruzione della fisarmonica furono invece condotte a Messina, intorno agli anni quaranta del Novecento, dal mu-sicista Leonardo Mazziniani di cui, anche in questo caso, si conserva un singolare strumento presso il Museo di Gesso (scheda 96). Questa particolare fisarmonica, realizzata su progetto di Mazziniani dalla fabbrica Idealfisa di Castelfidardo, è dotata di un’insolita tastiera i cui i tasti non seguono la disposizione canonica ma sono organizzati in mo-do da consentire l’esecuzione di scale differenti mantenendo la medesima diteggiatura. Il sistema, definito dall’inventore “Traspositono II”, seguiva una precedente invenzione detta “Trasposicromo”.
48 Giovanni Paolo Di Stefano
Anche in Sicilia – forse su indiretta influenza di Beyer – furono costruiti strumenti di questo tipo dal liutaio palermitano Luigi Perollo che, negli anni quaranta dell’Ottocento, fu premiato con meda-glia d’oro dal Real Istituto d’Incoraggiamento per la costruzione di uno strumento a cilindro detto panarmonico che fu giudicato un «lavoro eccellente e dal pubblico e dalle persone intelligenti, che ne fecero minuto e scrupoloso esame; paragonati agli stranieri fu trovato sostenere la concorrenza, anzi nel panarmonico, vi furono notate utili innovazio-ni» (istituto D’inCoRaggiaMEnto 1847).
Organi a cilindro «di smisurata grandezza, con meglio di duecento canne di piombo, altre di le-gno, un rango di zampogne imitanti un’orchestra eseguendo mirabilmente i più be’ pezzi di Rossini e Bellini» furono inoltre realizzati più o meno negli stessi anni ad Agrigento da Raffaello Politi (navaRRo 1836, p. 257).
Nella seconda metà del secolo la fabbrica di Rosario Porto, già citato nelle pagine precedenti, si distinse per la costruzione di organi a cilindro di svariate tipologie e misure. Questi strumenti, messi in funzione mediante una manovella (detta
per la prima volta intorno agli anni venti del XIX secolo. Due strumenti realizzati tra il 1825 e il 1840 dal viennese Anton Beyer, meccanico alla corte del re di Napoli, furono per esempio rispettivamente acquistati dai principi di Butera (strumento oggi nella Collezione Casiglia di Cinisi, scheda 97) e dai principi di Mirto (fig. 21). Giunto a Napoli nel 1823 su esplicito invito delle “Reali Maestà”, Beyer fu probabilmente il primo a costruire nelle Due Sicilie queste particolari “macchine armoniche”.96 In qualità di “meccanico della corte”, Beyer fu incaricato di provvedere alla manutenzione degli orologi delle residenze reali e di costruire organi a cilindro per il diletto del sovrano e della sua cerchia. A pochi mesi dall’arrivo in Italia risale dunque il primo strumento napoletano di Beyer che ancora oggi si conserva presso la Reggia di Caserta e che reca, su uno dei mantici e su un ingranaggio, la data 1823. Questo come gli altri strumenti a cilindro di Beyer, inclusi i due conservati in Sicilia, sono dei raffinati secrétaire di foggia tipicamente viennese contenenti organi con canne di legno. I cilindri intercambiabili degli strumenti contengono principalmente trascrizioni di brani operistici coevi (Di stEfano 2011a, pp. 44-47).
21. Organo a cilindro costruito a Napoli, intorno al 1840, da Anton Beyer (Museo Regionale di Palazzo Mirto, Palermo)
Strumenti musicali nelle collezioni siciliane 49
pertorio musicale dei pianini include canzonette e ballabili, presenti in tutti i comuni piani a cilindro, ma anche musiche appositamente concepite per questo spettacolo: la battaglia, la marcia, il galoppo e il lamento. Per tali brani i pupari dovevano fare specifica domanda ai costruttori degli strumenti affinché realizzassero cilindri appositamente de-stinati a questo spettacolo.98
A Palermo, uno dei primi costruttori di piani a cilindro sembra esser stato, a metà Ottocento, Liberto Canino. Attivo nel quartiere dell’Alber-gheria, Canino fu anche il capostipite di una nota dinastia di pupari. A questo costruttore sembra si rivolse il puparo Gaetano Greco che, giunto a Palermo da Napoli, nel 1826 inaugurò il primo teatro di marionette del capoluogo siciliano (Ca-taLDo 1997, p. 65).
Tra gli anni venti e cinquanta del Novecento, i teatri dell’Opera dei Pupi di Palermo poterono fare affidamento su un rinomato costruttore di piani a cilindro, il napoletano Vittorio Fassone. Di quest’ultimo si conserva, presso il Museo Interna-zionale delle Marionette di Palermo, un piccolo strumento la cui cassa fu decorata dal puparo Ga-spare Canino (scheda 98). Nato a Napoli nel 1872 da Costanzo Fassone, titolare di una fabbrica di pianini, Vittorio affiancò l’attività di costruttore a quella di musicista e compositore di canzoni. Nel 1922 sposò una palermitana e si trasferì nel capoluogo siciliano dove stabilì una piccola filiale della manifattura napoletana. Negli anni venti, la fabbrica Fassone era ubicata nei pressi del porto di Palermo, in via Molo 114. Successivamente, il costruttore napoletano trasferì il proprio labora-torio nel quartiere Magione dove lavorò fino alla morte, sopraggiunta nel 1953. Fassone fu uno degli ultimi costruttori e riparatori di piani a cilindro attivi nell’isola.
Una versione più elaborata di piano a cilindro era chiamata “piano orchestra” o “orchestrion” che, oltre alle corde del pianoforte, azionava meccanica-mente varie percussioni (campanelli metallici, piat-ti, triangolo, tamburi). Questi strumenti, utilizzati normalmente per l’intrattenimento musicale nei locali pubblici, potevano avere la forma di grande piano a cilindro (si veda per esempio lo strumento della ditta Ottina e Pellandi di Novara alla scheda 99) oppure in altri casi si presentavano come dei grandi armadi. Se inizialmente i piani orchestra erano azionati a manovella, ai primi del Novecento, questi strumenti (come d’altronde anche i piani a cilindro) furono spesso elettrificati e dotati di dispositivi che ne consentivano l’attivazione me-diante l’inserimento di una monetina (come nei jukebox di epoca successiva).
anche manubrio), erano venduti come «specialità per ballare» e utilizzati per l’intrattenimento dome-stico, nei locali pubblici e da musicisti ambulanti (R. poRto 1903, p. 195). Intorno al 1910, gli organi più grandi prodotti da questa fabbrica potevano essere dotati anche di motore «con movimento a vapore od elettricità, e con musica a cilindro o a cartoni, con ricco strumentale, prospetti artisti-ci, colonne giranti e figure movibili» (R. poRto 1910c., p. 97).97
Tra la seconda metà dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento, larghissima diffusione ebbero in Sicilia anche i piani a cilindro, pianoforti verticali la cui meccanica era appunto azionata da un cilindro chiodato messo in rotazione per mezzo di una manovella. Questi strumenti furono inizial-mente importati in Sicilia dall’Italia settentrionale, dove erano attive un gran numero di fabbriche, e da Napoli. Hanno per esempio questa provenienza i due piani a cilindro conservati presso il Castello di Donnafugata, vicino Ragusa, rispettivamente realizzati dalla fabbrica torinese di Giuseppe Mola e dal napoletano Giuseppe Giuliano, entrambi rinomati costruttori di fine Ottocento.
Molte furono anche le fabbriche di piani a cilin-dro attive in Sicilia. Specializzate nella costruzione di questi strumenti «di grande effetto per feste da ballo in famiglia, per grandi sale da ballo pubbliche e per suonatori ambulanti» furono ancora una volta le citate manifatture catanesi di Rosario, Giuseppe e Salvatore Porto (Di stEfano 2004).
Costruttori di piani a cilindro furono presenti anche a Caltanissetta dove, nei primi decenni del XX secolo, fu attiva la ditta di Damiano Polizzi e a Ragusa Inferiore dove operarono le ditte di Ema-nuele Battaglia e dei fratelli Bornò.
A Palermo la storia del piano a cilindro fu in particolare legata alle vicende del teatro popo-lare delle marionette, l’Opera dei Pupi, che – a partire dagli anni ottanta dell’Ottocento – affidò a questo strumento l’accompagnamento musicale dell’azione scenica. Fino a quell’epoca, le musiche di scena dell’Opera dei Pupi furono tradizional-mente eseguite da una orchestrina di strumenti a corda (che generalmente prevedeva l’intervento di violino, chitarra e mandolino). L’apporto della musica durante lo spettacolo era essenziale poiché, oltre ad accompagnare lo svolgimento dell’azione teatrale, consentiva di colmare il vuoto sonoro durante i cambi di scena. Sul finire del secolo, ra-gioni di carattere economico resero assai oneroso l’impiego di musicisti in carne e ossa che furono dunque rimpiazzati proprio dal piano a cilindro che da quel momento fu spesso identificato a Pa-lermo come “pianino dell’Opera dei Pupi”. Il re-
50 Giovanni Paolo Di Stefano
esemplare della ditta ditta Becker Brothers di New York si conserva, ad esempio, presso l’Università di Palermo) mentre non è attestata una produzione locale di questi strumenti.
La diffusione degli strumenti musicali meccanici entrò in crisi intorno agli anni venti del secolo a seguito della diffusione degli apparecchi per la riproduzione del suono, in prima istanza del grammofono e successivamente della radio, che portarono inesorabilmente all’estinzione di questo settore dell’industria strumentale.
NOTE1 Per un quadro d’insieme sul fenomeno del collezionismo di strumenti musicali nell’Italia del XIX secolo cfr. MEuCCi 2000.2 La più recente, anche se ormai non del tutto aggiornata, ricognizione sulle collezioni italiane di strumenti musicali è stata pubblicata da pERRonE 2001 (riedito con aggiornamenti nel 2005). Sulle collezioni italiane si veda inoltre MEuCCi 2003.3 Archivio Comunale di Palermo (da adesso ACPa), Corpo di Musica Municipale, Serie XXIV, 12 marzo 1885, s.c.4 Nessun collezionista è ad esempio citato nella ricognizione effettuata da Luigi Francesco Valdrighi tra il 1884 e il 1894. Cfr. vaLDRighi 1884.
Intorno alla fine dell’Ottocento furono introdotti in Sicilia anche altri strumenti musicali meccanici. Tra quelli che ebbero maggiore successo vi fu il piano melodico brevettato nel 1886 dal bolognese Giovanni Racca.99 Il piano melodico è un piccolo pianoforte automatico i cui martelletti sono azio-nati da cartoni perforati messi in movimento per mezzo della rotazione di una manovella. Una leva, posta a lato della manovella, avvicina o allontana la martelliera dalle corde consentendo dunque di variare l’intensità del suono. Caratteristica dei piani melodici è anche l’esecuzione del ribattuto in corrispondenza delle note lunghe che è appunto una delle peculiarità di questi strumenti.
Con queste parole la ditta Racca definiva i suoi piani melodici nel catalogo commerciale del 1908:
tali strumenti non hanno nulla di comune con altri conge-neri, dai quali differiscono tanto per la loro elegante forma come per la finezza dell’armonia. Chiunque ignaro di musica può gustare qualsiasi lavoro musicale, come Opere, Balli, Canzoni ecc. ottenendone perfettissima l’esecuzione, giacchè mediante una piccola leva si posssono ottenere le più lievi smorzature di suono, pianissimi, fortissimi e qualsiasi altro colorito. Tali istrumenti hanno le corde metalliche come i pianoforti, ed il pregio di avere la nota prolungata come gli Harmoniums. Per la loro perfezione hanno acquistato tale rinomanza da essere apprezzatissimi sia in Italia che all’estero [RaCCa 1908, p. 5].100
Gli strumenti di Racca furono prodotti in diverse varianti sebbene i due modelli più comuni avevano forma di piccolo pianoforte a coda e di tavolino (si veda per esempio il piano melodico alla scheda 100). Le estensioni erano principalmente due: a quattro ottave (48 note) e a sei ottave (73 note).
In Sicilia i piani melodici Racca furono cono-sciuti soprattutto dopo l’Esposizione Nazionale di Palermo del 1891-92 in occasione della quale il costruttore bolognese espose due strumenti (Espo-sizionE 1892, p. 516).
I piani melodici furono commercializzati in Sici-lia, tra gli altri, dal Premiato Stabilimento di Rosario Porto a Catania che ne pubblicizzò regolarmente le caratteristiche nei suoi cataloghi illustrati (fig. 22).
All’inizio del XX secolo entrarono nelle case siciliane anche altre tipologie di strumenti musicali meccanici. Il più diffuso – in Sicilia come altrove – fu probabilmente l’autopiano, un pianoforte verticale che poteva essere suonato in modo tradizionale op-pure essere azionato automaticamente mediante un meccanismo pneumatico che poneva in rotazione un rullo di carta perforata sul quale era “registrata” l’esecuzione che era così realizzata meccanicamente dallo strumento. Gli autopiani furono importati soprattutto dalla Germania e dagli Stati Uniti (un
22. Pubblicità del piano melodico di Giovanni Racca nel ca-talogo illustrato del 1903 della fabbrica Rosario Porto e Figli di Catania (Collezione Giovanni Paolo Di Stefano, Palermo).
Strumenti musicali nelle collezioni siciliane 51
19 Nella seconda metà del XIX secolo il pianoforte era originariamente esposto, insieme a un ritratto della regina Maria Carolina, presso il Museo Nazionale di Palermo (oggi Museo Regionale “Antonino Salinas”). Cfr. saLinas 1901, p. 93; e anche BattagLia 1908, p. 62. A seguito della tra-sformazione del Museo Nazionale in Museo Archeologico il pianoforte fu spostato presso la Società di Storia Patria che a sua volta lo concesse in comodato al Museo Teatrale. Il salterio non è invece citato nelle guide del del Museo Nazionale, dal quale proveniva, ma il suo trasferimento al Teatro Massimo è documentato da una autorizzazione ministeriale dell’11 giugno 1940 conservata presso l’ar-chivio teatrale.20 Archivio del Teatro Massimo, lettera manoscritta, Palermo, 15 maggio 1943. Il documento è conservato presso la biblio-teca del Teatro all’interno di un faldone (privo di numero d’inventario) contenente altre carte sciolte relative al Museo d’Arte Teatrale.21 Archivio di Stato di Palermo (da adesso ASPa), Fondo notai defunti, notaio Lorenzo Isgrò, vol. 8393, 16 settembre 1589, cc. 30v-31.22 Ivi, vol. 8396, 31 giugno 1596, c. 732.23 Ivi, 1 giugno 1597, cc. 770v-771v.24 ASPa, Fondo notai defunti, notaio Lorenzo Isgrò, vol. 8398, 31 luglio 1598, cc. 1085v-1087v; vol. 8398, 15 maggio 1599, c. 672; vol. 8399, 27 maggio 1600, cc. 962v-964.25 Sui tamburi di Alcara li Fusi cfr. saRiCa 1994, pp. 154-163.26 ASPa, Fondo notai defunti, notaio Lorenzo Isgrò, vol. 8396, 9 aprile 1597, cc. 598v-599v.27 Ivi, 13 aprile 1596, cc. 448v-450.28 Sui raporti tra la Baruni e Zoida cfr. ASPa, Fondo notai defunti, notaio Lorenzo Isgrò, vol. 8397, 25 settembre 1597, cc. 107-107v; vol. 8397, 31 luglio 1598, cc. 1085v-1087v; vol. 8398, 16 novembre 1598, c. 235; vol. 8398, 27 aprile 1599, cc. 623v-624; vol. 8398, 15 maggio 1599, cc. 671v-672v; e vol. 8399, 27 maggio 1600, cc. 962v-964.29 Sulla pratica femminile del tamburello cfr. guizzi - staiti 1989, pp. 15-16 e saRiCa 1994, pp. 149-165.30 ASPa, Fondo notai defunti, notaio Lorenzo Isgrò, vol. 8397, 26 marzo 1597, cc. 663v-664v.31 Ivi, 19 giugno 1598, cc. 982-983.32 Ivi, vol. 8398, 13 maggio 1599, cc. 674v-675.33 Ivi, vol. 8401, 6 ottobre 1601, cc. 150v-152v.34 Ivi, 18 ottobre 1601, cc. 187v-189v.35 Ivi, 6 maggio 1602, cc. 860v-861v.36 Ivi, 8 agosto 1602, cc. 1202v-1204v.37 Ivi, vol. 8402, 26 ottobre 1602, cc. 294-295.38 Ivi, vol. 8403, 15 ottobre 1603, cc. 194-194v.39 Ivi, 13 marzo 1604, cc. 736-737v. Accordo rinnovato con atto stipulato presso il medesimo notaio vol. 8409, 15 settembre 1610, c. 41.40 Ivi, 13 marzo 1604, cc. 736-738v.41 Ivi, 18 maggio 1604, cc. 738v-739v.42 Ivi, vol. 8397, 7 agosto 1598, s.c.43 Ivi, vol. 8403, 31 maggio 1604, cc. 1120-1120v.44 Ivi, vol. 8392, 27 settembre 1588, cc. 96v-97v.; vol. 8397, c. 549v.45 Ivi, vol. 8406, 17 maggio 1607, cc. 827-828.46 Ivi, vol. 8407, 19 maggio 1608, cc. 861v-862.47 Ivi, vol. 8409, marzo 1611, cc. 501-502v; il pagamento è registrato con atti del 4 maggio 1611, cc. 640v-641 e dell’8 agosto 1611, c. 930.48 Ivi, vol. 8398, 18 maggio 1599, cc. 694v-695.49 Ivi, vol. 8403, 13 marzo 1604, cc. 734v-735v.50 La pelle della membrana fu riutilizzata come copertina del bastardello n. 3465, relativo agli anni 1718-1721, del notaio Accursio Gagliano che rogò a Burgio e a Lucca Sicula dal 1693 al 1739.
5 Ringrazio Paola Carlomagno per avermi aiutato nel reperire questo testo. Su Giuseppe Giuliani cfr. aBBaDEssa 1998.6 Per un resoconto sugli strumenti musicali nelle fonti docu-mentarie dei secoli XVI, XVII e XVIII si veda Di stEfano 2007a.7 È possibile che Daita, il quale probabilmente si limitò a riportare informazioni ottenute per via indiretta, abbia fatto confusione nell’enumerazione degli strumenti. Non risulta infatti che l’Istituto abbia mai posseduto un contrabbasso del liutaio napoletano (e non palermitano) Carlo D’Avenia (Avena nel testo) di cui invece possiede un violoncello del 1716. Gli strumenti firmati Antonio Stradivari e Nicola Amati, oggi di-spersi e comunque falsi, erano invece violini (rispettivamente recanti i numeri d’inventario 64 e 66). 8 Archivio Centrale dello Stato (da adesso ACS), Ministero Pub-blica Istruzione - Antichità e Belle Arti - Divisione Arte Moderna, Arte drammatica e musicale (da adesso MPI - AA.BB.AA.), Dono al Conservatorio di due violini ed una viola, b. 80, 17 marzo 1902.9 ACS, MPI - AA.BB.AA., Real decreto che approva il Regolamento del R. Collegio di musica di Palermo, b. 74, 8 settembre 1866.10 Questa era una pratica comune presso tanti conservatori italiani. Caso analogo si registra presso il Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli la cui consistente collezione di an-tichi strumenti, la più importante dell’Italia meridionale, non è sostanzialmente derivata dall’antico patrimonio dell’Istituto ma è stata in gran parte acquisita, tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, grazie a lasciti privati finalizzati all’apertura del Museo storico-musicale. Cfr. sisto 2010, p. 189.11 ACS, MPI - AA.BB.AA., Vendita di un vecchio Organo ed acquisto di un Melodium, b. 75, 2 marzo 1868. L’antico organo fu ven-duto al prezzo di lire 318.75 al sacerdote Andrea Caruselli, parroco di Cefalà Diana. Il Conservatorio non ebbe più un organo fino all’inizio del XX secolo. Nel 1889 veniva infatti proposta la soppressione della cattedra d’organo ritenuta in quel momento «inutile perché mancano al momento i fondi per l’acquisto dello strumento»(ACS, MPI - AA.BB.AA., Nuovo Ruolo Organico. Proposte Personale Relativo, b. 80, 30 ottobre 1889). La cattedra fu tuttavia riaperta due anni più tardi, nel 1891, sebbene in questa prima fase, non disponendo l’Istituto dei fondi necessari all’acquisto di un organo, per l’insegnamento fu acquistato un nuovo armonium (ACS, MPI - AA.BB.AA., Per la scuola d’organo, b. 80, 26 settembre 1891). Nove anni più tardi il Conservatorio acquistò un organo, il cui costo di 10000 lire fu dilazionato fino al 1907, presso la fabbrica Inzoli Pacifico di Crema (ACS, MPI - AA.BB.AA., b. 80, 8 gennaio 1908).12 ACS, MPI - AA.BB.AA., Vendita di Harmonium, b. 80, set-tembre 1885.13 ACS, MPI - AA.BB.AA., Vendita a baratto di taluni strumenti musicali, b. 80, 9 aprile 1888. Pochi giorni più tardi il Ministero autorizzava la vendita a Pellitti, per 105 lire, dei 21 strumenti: ACS, MPI - AA.BB.AA., Vendita di strumenti musicali, b. 82 bis, 21 aprile 1888.14 ACS, MPI - AA.BB.AA., Ispezione del marchese Francesco D’Arcais al Cons di Palermo per il MPI, b. 80, 5 luglio 1889, ff. 5-6.15 Cfr. ACS, MPI - AA.BB.AA., Acquisto di un Pianoforte di Concerto, b. 77 bis, 28 ottobre 1871-30 aprile 1873. Nel 1873 l’Istituto finalmente ottenne l’acquisto, presso i negozianti palermitani D’Arone e Librino, di un pianoforte a coda della fabbrica Philippi Frères di Parigi: cfr. ACS, MPI - AA.BB.AA., Per lo acquisto di un pianoforte da concerto, b. 77 bis, 20 aprile 1873. 16 Cfr. ACS, MPI - AA.BB.AA., Per lo acquisto di un pianoforte, b. 77 bis, maggio 1880.17 Il primo catalogo del Museo Belliniano fu pubblicato in ConDoRELLi 1935. Una sommaria descrizione della collezio-ne di pianoforti, ricca però di errori e imprecisioni, è stata pubblicata in CoEn 2002.18 Mascagni era giunto a Palermo per le celebrazioni del cin-quantenario di Cavalleria Rusticana. L’opera era stata messa in scena in quei giorni presso il Teatro Massimo.
52 Giovanni Paolo Di Stefano
76 ACS, MPI - AA.BB.AA., Acquisto di un’Arpa pel Real Collegio di Musica di Palermo, 27 febbraio 1888, b. 81. Su Celentano cfr. Ruta 1911, p. 161.77 ACS, MPI - AA.BB.AA., bb. 79bis, 81.78 Sull’arpa cromatica cfr. pasEtti 2008, pp. 211-229.79 Sulla modalità di funzionamento del meccanismo a doppio movimento si veda la scheda 77.80 Copia di questo catalogo della ditta Curci, databile all’inizio del XX secolo, si conserva nella biblioteca di chi scrive.81 Sulla diffusione del salterio in ambito conventuale si veda ChiRiCo 2001.82 Lo studio più ampio, sebbene per certi aspetti an cora lacuno-so, è DispEnsa zaCCaRia 1988. A partire dai primi anni novanta del Novecento sono state portate avanti alcune campagne di catalogazione del patrimonio organario siciliano i cui risul-tati sono confluiti in pubblicazioni sugli antichi organi della città di Palermo (gaiEzza 1995) e delle diocesi di Monreale (vagLiCa 1991), Acireale (Cassata 1991), Piazza Armerina (Buono niCoLEtti LaRinà 1996), Noto (Buono 1998), Ragusa (appiano 1993) e Cefalù (CannizzaRo 2005a). Per un quadro complessivo sugli studi riguardanti l’organaria siciliana si veda anche Buono - Di stEfano 2012, pp. 9-10.83 Per una più ampia ricostruzione della storia della cembalaria siciliana cfr. Di stEfano 2009.84 Su Carlo Grimaldi si veda anche Buono 1994 e Costantini 1993.85 Sul tiorbino si veda anche noCERino 2000a.86 Sulla presenza di questi strumenti a Napoli cfr. noCERino 2000b.87 ASPa - sezione di Termini Imerese, Fondo notai defunti, notaio Antonino Cagimila, vol. 2466, 27 aprile 1670, c. 28. Ringrazio Luciano Buono e Rosario Termotto per avermi segnalato questo documento.88 Un’analisi di pianoforti siciliani settecenteschi di questo tipo è proposta in Di stEfano 2012a, pp. 71-80.89 Per una approfondita analisi di questa tipologia di piano-forti e della sua diffusione in Europa cfr. Di stEfano 2006 e Di stEfano 2008c.90 Per una più ampia analisi del fenomeno della costruzione del pianoforte in Sicilia cfr. Di stEfano 2003 e Di stEfano cds4. Sul pianoforte a Napoli nell’Ottocento si veda invece sELLER 2009.91 Sulle fabbriche Érard e Pleyel nella seconda metà del XIX secolo cfr. rispettivamente Di stEfano 2011b e Di stEfano 2012b. Per una dettagliata analisi delle meccaniche dei pianoforti Pleyel negli anni cinquanta e ottanta del XIX secolo cfr. ri-spettivamente Di stEfano 2011a, pp. 65-83 e Di stEfano 2010a.92 ACS, MPI - AA.BB.AA., Lettera del prof. Luigi Milazzo, s.d., b. 80. 93 Il catalogo illustrato della ditta Salvatore Porto da cui sono tratte queste informazioni si conserva presso la collezione di Fabio Tricomi a Bologna.94 ACS, Brevetti, Apparecchio deviatore della colonna d’aria allo scopo di ottenere il trasporto automatico della tonalità musicale negli strumenti musicali a tastiera ad aria, brevetto n. 472292, 1951.95 ACS, Brevetti, Manale indicatore scorrevole per fisarmonica atto ad ottenere una maggiore libertà di manovra nel suonare e per indicare l’ubicazione di alcuni tasti, brevetto n. 536221, 1955.96 Per maggiori informazioni sugli organi di Beyer cfr. Di stEfano 2011a, pp. 29-47.97 Copia di questo catalogo illustrato si conserva presso la collezione di Fabio Tricomi a Bologna.98 Sul piano a cilindro in Sicilia cfr. Di stEfano 2010b; e anche Bonanzinga 2007.99 ACS, Brevetti, Pianino meccanico, brevetto n. 1196, 9 settem-bre 1886.100 Copia di questo catalogo commerciale è conservata presso la biblioteca dell’Associazione Italiana per la Musica Mecca-nica a Cesena.101 Tali direttive sono state pubblicate in BaRCLay 1997.
51 Comunicazione dattiloscritta di Rachele Fichera che ringrazio per avermi segnalato questa antica membrana di tamburello.52 ACPa, Corpo di Musica, Serie XXIII, cc.23-23v; Serie XI-1 (1886-1908), c. 12v.53 Per un quadro d’insieme sulla produzione di strumenti a fiato in Italia nel corso del XIX secolo cfr. MEuCCi 1998a.54 ASPa, Fondo notai defunti, notaio Alfonso Cavarretta, vol. 1813, c. 761v, 28 agosto 1558.55 Archivio di Stato di Ragusa - sezione di Modica, Statistica, busta 48, fascicolo 1-4.56 ASPa, Ministero e R. Segreteria per gli Affari di Sicilia, Ripartimento interno, vol. 588, Real rescritto 24 aprile 1837.57 Per una ricognizione sulle bande attive in Sicilia all’inizio degli anni settanta del secolo si veda la statistica pubblicata in isti-tuti E soCiEtà MusiCaLi 1873. Un’ampia analisi sul fenomeno delle bande musicali in Italia nell’Ottocento è fornita in CaRLini 1995.58 ACPa, Corpo di Musica, Serie XI-1 (1866-1885), c. 209.59 ACPa, Corpo di Musica, Serie XI, fasc. 6 (1867-1903), cc. 116-120.60 Copia del catalogo del 1907 della fabbrica Rosario Porto e figli di Catania si conserva nell’archivio di chi scrive. Sulle resi-stenze dei flautisti al sistema Böhm si veda anche CiRiaCo 1920.61 ACPa, Corpo di Musica, Serie XI-1 (1866-1885), c. 425.62 ACPa, Corpo di Musica, Serie XI, fasc. 3 (1867-1903), c. 214.63 Ivi, c. 215.64 Copia del Regio decreto n. 50955, serie 3a, Monza, 30 ottobre 1887 si conserva in ACPa, Corpo di Musica, Serie XI, fasc. 3 (1867-1903), cc. 188-189.65 ACPa, Corpo di Musica, Serie XI, fasc. 4, 26 marzo 1888, cc. 186-187.66 ACPa, Corpo di Musica, Serie XI-1 (1886-1908), c. 373.67 Ivi, c. 123.68 La collezione include tre canzonette di autori ignoti: Canzo-netta con accompagnamento di arpone o chitarra [Su a lu munnu e un sacciu comu], coll. A 49; Canzonetta Siciliana con violino, chi-tarra e basso [Com’è possibili lassari a tia], senza coll.; Filli di mia, nun essiri tantu crudeli e ingrata. Canzonetta Siciliana con chitarra francese, senza coll.; tre barcarole del compositore Casiglia: Cca jttatu supra un sassu. Barcarola con chitarra francese a Basso, senza coll.; Ntra sti grutti unni natura. Barcarola con chitarra francese a Basso, senza coll.; Vola suspiru subito. Barcarola con chitarra francese a Basso, senza coll.; una canzoncina di Domenico Cimarosa: Canzoncina con chitarra francese [Già s’appressa o mio tesoro], senza coll.; e anche due duetti per chitarre alla francese di autori ignoti: Valz per due chitarre per uso di S. E. la Contessa di S. Marco, coll. A 43; Duettino per uso della Principessa di San Giuseppe, coll. A 62; e una Notturna e Cantata a due cori per voci e vari strumenti (tra cui due mandolini e due chitarre alla francese) composta da Francesco La Rosa nel 1793, senza coll.69 Per una descrizione delle caratteristiche della liuteria ad arco napoletana cfr. DE angELis 2009, pp. 14-21.70 ACS, Brevetti, Descrizione del Manviolino inventato dal Sig. Averna Gesualdo da Caltanissetta, brevetto n. 110388, 1910.71 Su Belisario Mattera − di cui presso la biblioteca del Con-servatorio Santa Cecilia di Roma si conserva il manoscritto autografo di un inedito Metodo per Mandolino [...] scritto ap-positamente per Sua Altezza Reale la Principessa di Piemonte, cioè Margherita di Savoia (coll. Governativo G.Mss.3340) − si veda anche MazzonE 1886. 72 Sull’Ospizio di Beneficenza di Catania cfr. sCiuto 1880.73 Il catalogo illustrato del 1907 della ditta Rosario Porto e figli, da cui sono tratte queste informazioni, si conserva presso la collezione di Fabio Tricomi a Bologna.74 Devo la conoscenza delle informazioni qui riportate alla te-stimonianza di Giovanni Catania, figlio di Carmelo, che lavorò presso la fabbrica paterna fino agli anni settanta del Novecento.75 ACS, MPI - AA.BB.AA., Nuovo ruolo proposte, 14 luglio 1887, b. 79.
![Page 1: Strumenti musicali nelle collezioni siciliane [Musical instrumentas in Sicilian collections], in Strumenti musicali in Sicilia, ed. by G. P. Di Stefano, S. G. Giuliano, S. Proto, Palermo,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050122/63377df2d102fae1b607646b/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: Strumenti musicali nelle collezioni siciliane [Musical instrumentas in Sicilian collections], in Strumenti musicali in Sicilia, ed. by G. P. Di Stefano, S. G. Giuliano, S. Proto, Palermo,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050122/63377df2d102fae1b607646b/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: Strumenti musicali nelle collezioni siciliane [Musical instrumentas in Sicilian collections], in Strumenti musicali in Sicilia, ed. by G. P. Di Stefano, S. G. Giuliano, S. Proto, Palermo,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050122/63377df2d102fae1b607646b/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: Strumenti musicali nelle collezioni siciliane [Musical instrumentas in Sicilian collections], in Strumenti musicali in Sicilia, ed. by G. P. Di Stefano, S. G. Giuliano, S. Proto, Palermo,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050122/63377df2d102fae1b607646b/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: Strumenti musicali nelle collezioni siciliane [Musical instrumentas in Sicilian collections], in Strumenti musicali in Sicilia, ed. by G. P. Di Stefano, S. G. Giuliano, S. Proto, Palermo,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050122/63377df2d102fae1b607646b/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: Strumenti musicali nelle collezioni siciliane [Musical instrumentas in Sicilian collections], in Strumenti musicali in Sicilia, ed. by G. P. Di Stefano, S. G. Giuliano, S. Proto, Palermo,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050122/63377df2d102fae1b607646b/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: Strumenti musicali nelle collezioni siciliane [Musical instrumentas in Sicilian collections], in Strumenti musicali in Sicilia, ed. by G. P. Di Stefano, S. G. Giuliano, S. Proto, Palermo,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050122/63377df2d102fae1b607646b/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: Strumenti musicali nelle collezioni siciliane [Musical instrumentas in Sicilian collections], in Strumenti musicali in Sicilia, ed. by G. P. Di Stefano, S. G. Giuliano, S. Proto, Palermo,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050122/63377df2d102fae1b607646b/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: Strumenti musicali nelle collezioni siciliane [Musical instrumentas in Sicilian collections], in Strumenti musicali in Sicilia, ed. by G. P. Di Stefano, S. G. Giuliano, S. Proto, Palermo,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050122/63377df2d102fae1b607646b/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: Strumenti musicali nelle collezioni siciliane [Musical instrumentas in Sicilian collections], in Strumenti musicali in Sicilia, ed. by G. P. Di Stefano, S. G. Giuliano, S. Proto, Palermo,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050122/63377df2d102fae1b607646b/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: Strumenti musicali nelle collezioni siciliane [Musical instrumentas in Sicilian collections], in Strumenti musicali in Sicilia, ed. by G. P. Di Stefano, S. G. Giuliano, S. Proto, Palermo,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050122/63377df2d102fae1b607646b/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: Strumenti musicali nelle collezioni siciliane [Musical instrumentas in Sicilian collections], in Strumenti musicali in Sicilia, ed. by G. P. Di Stefano, S. G. Giuliano, S. Proto, Palermo,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050122/63377df2d102fae1b607646b/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: Strumenti musicali nelle collezioni siciliane [Musical instrumentas in Sicilian collections], in Strumenti musicali in Sicilia, ed. by G. P. Di Stefano, S. G. Giuliano, S. Proto, Palermo,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050122/63377df2d102fae1b607646b/html5/thumbnails/13.jpg)
![Page 14: Strumenti musicali nelle collezioni siciliane [Musical instrumentas in Sicilian collections], in Strumenti musicali in Sicilia, ed. by G. P. Di Stefano, S. G. Giuliano, S. Proto, Palermo,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050122/63377df2d102fae1b607646b/html5/thumbnails/14.jpg)
![Page 15: Strumenti musicali nelle collezioni siciliane [Musical instrumentas in Sicilian collections], in Strumenti musicali in Sicilia, ed. by G. P. Di Stefano, S. G. Giuliano, S. Proto, Palermo,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050122/63377df2d102fae1b607646b/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: Strumenti musicali nelle collezioni siciliane [Musical instrumentas in Sicilian collections], in Strumenti musicali in Sicilia, ed. by G. P. Di Stefano, S. G. Giuliano, S. Proto, Palermo,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050122/63377df2d102fae1b607646b/html5/thumbnails/16.jpg)
![Page 17: Strumenti musicali nelle collezioni siciliane [Musical instrumentas in Sicilian collections], in Strumenti musicali in Sicilia, ed. by G. P. Di Stefano, S. G. Giuliano, S. Proto, Palermo,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050122/63377df2d102fae1b607646b/html5/thumbnails/17.jpg)
![Page 18: Strumenti musicali nelle collezioni siciliane [Musical instrumentas in Sicilian collections], in Strumenti musicali in Sicilia, ed. by G. P. Di Stefano, S. G. Giuliano, S. Proto, Palermo,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050122/63377df2d102fae1b607646b/html5/thumbnails/18.jpg)
![Page 19: Strumenti musicali nelle collezioni siciliane [Musical instrumentas in Sicilian collections], in Strumenti musicali in Sicilia, ed. by G. P. Di Stefano, S. G. Giuliano, S. Proto, Palermo,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050122/63377df2d102fae1b607646b/html5/thumbnails/19.jpg)
![Page 20: Strumenti musicali nelle collezioni siciliane [Musical instrumentas in Sicilian collections], in Strumenti musicali in Sicilia, ed. by G. P. Di Stefano, S. G. Giuliano, S. Proto, Palermo,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050122/63377df2d102fae1b607646b/html5/thumbnails/20.jpg)
![Page 21: Strumenti musicali nelle collezioni siciliane [Musical instrumentas in Sicilian collections], in Strumenti musicali in Sicilia, ed. by G. P. Di Stefano, S. G. Giuliano, S. Proto, Palermo,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050122/63377df2d102fae1b607646b/html5/thumbnails/21.jpg)
![Page 22: Strumenti musicali nelle collezioni siciliane [Musical instrumentas in Sicilian collections], in Strumenti musicali in Sicilia, ed. by G. P. Di Stefano, S. G. Giuliano, S. Proto, Palermo,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050122/63377df2d102fae1b607646b/html5/thumbnails/22.jpg)
![Page 23: Strumenti musicali nelle collezioni siciliane [Musical instrumentas in Sicilian collections], in Strumenti musicali in Sicilia, ed. by G. P. Di Stefano, S. G. Giuliano, S. Proto, Palermo,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050122/63377df2d102fae1b607646b/html5/thumbnails/23.jpg)
![Page 24: Strumenti musicali nelle collezioni siciliane [Musical instrumentas in Sicilian collections], in Strumenti musicali in Sicilia, ed. by G. P. Di Stefano, S. G. Giuliano, S. Proto, Palermo,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050122/63377df2d102fae1b607646b/html5/thumbnails/24.jpg)
![Page 25: Strumenti musicali nelle collezioni siciliane [Musical instrumentas in Sicilian collections], in Strumenti musicali in Sicilia, ed. by G. P. Di Stefano, S. G. Giuliano, S. Proto, Palermo,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050122/63377df2d102fae1b607646b/html5/thumbnails/25.jpg)
![Page 26: Strumenti musicali nelle collezioni siciliane [Musical instrumentas in Sicilian collections], in Strumenti musicali in Sicilia, ed. by G. P. Di Stefano, S. G. Giuliano, S. Proto, Palermo,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050122/63377df2d102fae1b607646b/html5/thumbnails/26.jpg)
![Page 27: Strumenti musicali nelle collezioni siciliane [Musical instrumentas in Sicilian collections], in Strumenti musicali in Sicilia, ed. by G. P. Di Stefano, S. G. Giuliano, S. Proto, Palermo,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050122/63377df2d102fae1b607646b/html5/thumbnails/27.jpg)
![Page 28: Strumenti musicali nelle collezioni siciliane [Musical instrumentas in Sicilian collections], in Strumenti musicali in Sicilia, ed. by G. P. Di Stefano, S. G. Giuliano, S. Proto, Palermo,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050122/63377df2d102fae1b607646b/html5/thumbnails/28.jpg)
![Page 29: Strumenti musicali nelle collezioni siciliane [Musical instrumentas in Sicilian collections], in Strumenti musicali in Sicilia, ed. by G. P. Di Stefano, S. G. Giuliano, S. Proto, Palermo,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050122/63377df2d102fae1b607646b/html5/thumbnails/29.jpg)
![Page 30: Strumenti musicali nelle collezioni siciliane [Musical instrumentas in Sicilian collections], in Strumenti musicali in Sicilia, ed. by G. P. Di Stefano, S. G. Giuliano, S. Proto, Palermo,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050122/63377df2d102fae1b607646b/html5/thumbnails/30.jpg)
![Page 31: Strumenti musicali nelle collezioni siciliane [Musical instrumentas in Sicilian collections], in Strumenti musicali in Sicilia, ed. by G. P. Di Stefano, S. G. Giuliano, S. Proto, Palermo,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050122/63377df2d102fae1b607646b/html5/thumbnails/31.jpg)
![Page 32: Strumenti musicali nelle collezioni siciliane [Musical instrumentas in Sicilian collections], in Strumenti musicali in Sicilia, ed. by G. P. Di Stefano, S. G. Giuliano, S. Proto, Palermo,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050122/63377df2d102fae1b607646b/html5/thumbnails/32.jpg)
![Page 33: Strumenti musicali nelle collezioni siciliane [Musical instrumentas in Sicilian collections], in Strumenti musicali in Sicilia, ed. by G. P. Di Stefano, S. G. Giuliano, S. Proto, Palermo,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050122/63377df2d102fae1b607646b/html5/thumbnails/33.jpg)
![Page 34: Strumenti musicali nelle collezioni siciliane [Musical instrumentas in Sicilian collections], in Strumenti musicali in Sicilia, ed. by G. P. Di Stefano, S. G. Giuliano, S. Proto, Palermo,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050122/63377df2d102fae1b607646b/html5/thumbnails/34.jpg)
![Page 35: Strumenti musicali nelle collezioni siciliane [Musical instrumentas in Sicilian collections], in Strumenti musicali in Sicilia, ed. by G. P. Di Stefano, S. G. Giuliano, S. Proto, Palermo,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050122/63377df2d102fae1b607646b/html5/thumbnails/35.jpg)
![Page 36: Strumenti musicali nelle collezioni siciliane [Musical instrumentas in Sicilian collections], in Strumenti musicali in Sicilia, ed. by G. P. Di Stefano, S. G. Giuliano, S. Proto, Palermo,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023050122/63377df2d102fae1b607646b/html5/thumbnails/36.jpg)