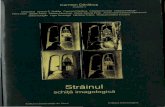I MORTI IN QUESTUA. FIGURE DELL'ALTERITÀ NEI RITI TRADIZIONALI DEL MERIDIONE D'ITALIA
Riti musicali popolari e devozioni "francescane" a Messina
Transcript of Riti musicali popolari e devozioni "francescane" a Messina
In copertina: Stampa raffigurante la chiesa di S. Francesco di E. Aldirani. 1841. Retrocopertina: Codice 544 della Biblioteca Antoniana di Padova. c. 208.
FRANCESCANESIMO E CULTURA NELLA PROVINCIA
DI MESSINA Atti del Convegno di studio
Messina 6-8 novembre 2008
a cura di Carolina Miceli e Agostina Passantino
BIBLIOTECA FRANCESCANA
OFFICINA DI STUDI MEDIEVALI PALERMO
2009
Francescanesimo e cultura nella Provincia di Messina : Atti del Convegno di studio : Messina / a cura di Carolina Miceli e Agostina Passantino. – Palermo : Biblioteca Francescana-Officina di Studi Medievali, 2009. (Franciscana ; 27) 1. Francescanesimo – Messina – Congressi – 2008 I. Miceli, Carolina II. Passantino, Agostina 271.3045811 CDD-21 ISBN 88-88615-91-1 CIP – Biblioteca Francescana di Palermo © Officina di Studi Medievali Via del Parlamento, 32 - 90133 Palermo e-mail: [email protected] www.officinastudimedievali.it – www.medioevo-shop.com Ogni diritto di copyright di questa edizione e di adattamento, totale o parziale, con qualsiasi mezzo è riservato per tutti i Paesi del mondo. È vietata la riproduzione, anche parziale, compresa la fotocopia, anche ad uso interno o didattico, non autorizzata dall’editore. ISBN 88-88615-91-1 Prima edizione italiana, Palermo, giugno 2009 Stampa: FOTOGRAF – Palermo Editing: Agostina Passantino Questo volume è pubblicato anche grazie ad un intervento finanziario dell’Università degli Studi di Palermo e del Dipartimento di Beni culturali storico-archeologici, socio-antropologici e geografici.
Riti musicali popolari e devozioni “francescane” a Messina Sergio Bonanzinga
In Sicilia, fino a un recente passato, le celebrazioni previste dal calendario li-turgico si solennizavano parallelamente presso le abitazioni dei fedeli. Gli offician-ti di questi riti domiciliari appartenevano a una specifica categoria di suonatori am-bulanti: gli “orbi” (obbi, uoibbi, orvi, ovvi, uorvi, uòrivi), così denominati poiché erano in prevalenza ciechi quanti intraprendevano questa professione. Di norma operavano in coppia – un suonatore di violino e uno di citarruni (bassetto a tre cor-de o violoncello adattato) o di chitarra – e sono stati particolarmente attivi nella dif-fusione di testi devozionali in siciliano, tanto che nella Palermo del Seicento la loro vicenda si è connessa all’istituzione di una confraternita posta sotto il protettorato dei Gesuiti. Se la trasmissione del repertorio sacro (orazioni e storie agiografiche, litanie, canzonette devote, ecc.) garantiva agli orbi un guadagno certo e continuati-vo, la Chiesa poteva nel contempo avvalersi del loro servizio per operare una forma di catechesi assai efficace, diffondendo in un linguaggio di immediata ricezione popolare temi e motivi religiosi plasmati secondo i canoni ufficiali.1
Nella città di Messina la storia degli orbi non si è intrecciata a quella di un Or-dine religioso, ma anche qui - come nel resto dell’Isola - la loro attività è stata pro-fondamente legata al mondo ecclesiastico. Nonostante la tradizione si sia interrotta negli anni Sessanta del Novecento, è stato possibile documentare buona parte del re-pertorio attraverso le esecuzioni di Felice Pagano, figlio di mastru Vitu u sunaturi, uno fra gli ultimi cantastorie ciechi messinesi. Da ragazzo Felice accompagnava il padre che si recava presso i parrucciani (clienti) per officiare le tradizionali “nove-ne” (nuveni). La centralità di questa pratica devozionale in ambito popolare è anche suggerita dall’appellativo nuviniddaru (novenatore) che si usava conferire al suona-tore-cantore, mentre i termini nuvinàriu e nuvena indicavano i lunghi componimenti da eseguire nei nove giorni precedenti alla festività da celebrare.
Un elenco delle novene che rientravano nel repertorio dei nuviniddara messi-nesi - a iniziare da quelle che si svolgevano nel mese di gennaio - è fornito da Nino La Camera (1961): santa Genuveffa, san Giulianu Vìscuvu, sant’Antòniu Abbati, san
1 Riguardo all’attività degli orbi si vedano in particolare: BUTTITTA 1960; GUGGINO 1980, 1981, 1988, 2004; BONANZINGA 2006. Documenti sonori sono contenuti in: GAROFALO-GUGGINO d.1987; Lo CASTRO-SARICA cd.1993 (brani 24-26); BONANZINGA cd.1995 (brani 45, 49); BONANZINGA cd.1996 (brani 1, 2, 7, 9).
14 Sergio Bonanzinga
Brasi (Biagio), Madonna di Lùddisi (Lourdes), san Giuseppi, Matri Addulurata, san Franciscu di Pàula, Maria santissima Annunziata, Matri i Pumpei, Spiritu Santu, Corpus Domini, Matri â Littra (Madonna della Lettera), sant’Antuninu, san Giuvanni Battista, Cori i Gesù, san Petru e Pàulu, santa Lisabetta, Matri ô Càrminu, Matri Assunta, san Gaitanu, Matri ô Rusàriu, Matri dâ Pruvidenza, Matri dî setti Duluri, san Micheli Arcànciulu, santa Bàrbira, san Nicola, Matri Mmaculata, santa Lucia, dû Bbamminu o di Natali, dî Tri Re o dî Re Magi. Vi erano poi la ddudicina dâ Matri i Muntàutu (“dodicina” della Madonna di Montalto) e una serie di novene «che ri-cordavano pubblici disastri, terremoti, temporali, guerre ed altre grandi calamità co-me carestie, pestilenze, siccità che nel passato avevano varie volte colpito la nostra città» (La Camera 1961: 8). In altre circostanze i suonatori erano chiamati a eseguire “orazioni” (raziuna) celebrative di un santo, della Vergine o del Cristo per una grazia richiesta o concessa, oppure altre orazioni destinate a commemorare i propri defunti. Queste le modalità con cui erano soliti operare i nuviniddara:
Tutti i santi giorni, col sole o con la pioggia, col freddo o col caldo, si
vedevano poveretti andare in giro, accompagnati dai soliti monelli, per cele-brare le loro novene. Sotto le cone [edicole votive] sbiadite dei Santi o dietro le porte dei devoti, essi cantavano con voce lamentosa e rauca le orazioni del Signore, della Madonna, dei Defunti e dei Santi. I versi che cantavano erano inafferrabili e la gente malignamente diceva che i novenatori più che cantare ruzzuliàvanu [ruzzolavano] o si manciàvunu [mangiavano] i loro versi. Ma questo ai devoti interessava fino a un certo punto, in quanto quello che pre-meva di più era che, con la celebrazione della santa novena e col cantare del-le orazioni, potessero ottenere dal Signore e dai Santi le grazie richieste. Qualche volta però si trovavano dei devoti oltremodo esigenti che pretende-vano che il povero suonatore [di violino o chitarra] cantando facesse chiara-mente sentire anche i versi senza sbagliare, ché se sbagliava era di cattivo augurio. [La Camera 1961: 5]
È ancora La Camera a fornire interessanti dettagli riguardo alla morfologia
dei componimenti tramandati dagli orbi messinesi, che egli ha potuto esaminare anche grazie alla consultazione di un “libro” manoscritto posseduto da Vito Pagano (successivamente andato perduto). Si distinguono tre tipi di novene in base alla forma metrica, che può essere a) in quartine di endecasillabi (metro epico), b) in sestine di ottonari (metro lirico) oppure c) nei due metri precedenti, alternati nel susseguirsi delle “giornate”. Queste ultime, dette nuveni ntruccati (novene trucca-te), sono quelle che più direttamente rinviano al “mestiere” del cantastorie. Lo sco-po della “truccatura” era anzitutto quello di variare il motivo musicale del canto, dato che a ogni metro poetico corrispondeva una diversa melodia, ma allo stesso tempo era una semplice strategia compositiva finalizzata ad approntare con rapidità
Riti musicali popolari e devozioni “francescane” … 15
una nuova novena per far fronte a eventuali richieste dei devoti: la ntruccatura in questo caso consisteva nella capacità di mischiare e adattare parti di testi già esi-stenti. Considerate invece sotto il profilo tematico, le novene presentano carattere a) storico-narrativo, b) storico-lirico-narrativo o esclusivamente c) lirico. Nel pri-mo caso il contenuto è costituito da una particolareggiata narrazione agiografica (dalla nascita alla morte del protagonista), mentre negli altri due tipi affiorano in modo via via più esteso elementi invocativi e laudativi.
Felice Pagano, pur non avendo mai esercitato dopo la morte del padre la pro-fessione di cantastorie, rammenta tuttora con precisione numerosi canti che esegue accompagnandosi al violino. Fra questi anche tre novene di spiccata ispirazione “francescana”, rispettivamente tributate all’Immacolata, alla Madonna di Pompei e a san Francesco di Paola. Sul piano metrico-tematico questi componimenti rispec-chiano – come si vedrà – le diverse tipologie ricorrenti nel repertorio dei nuvinid-dari messinesi. Le esecuzioni, rilevate nel dicembre 1991, vedono Pagano accom-pagnato alla chitarra da Domenico Santapaola e presentano un’articolazione co-stante: PRELUDIO / STROFA / INTERLUDIO / STROFA. Preludio e interludio sono costi-tuiti dalla medesima frase strumentale, mentre per il resto il violino si limita a rad-doppiare il canto. La chitarra alterna i bassi fondamentali agli accordi, strappati per intero quasi esclusivamente in coincidenza delle cadenze.
Il culto dell’Immacolata divenne popolare in Sicilia nei primi decenni del XV secolo, precedendo quindi l’ufficiale inserimento della festa nel calendario ro-mano (1476) e anticipando di parecchi secoli la proclamazione del relativo dogma da parte di Pio IX (1854). Un ruolo trainante nella promozione di questa devozione mariana svolsero, com’è noto, soprattutto in epoca post-tridentina, i predicatori ap-partenenti agli Ordini francescani, attivi a Messina già a partire dal 1212 (cfr. Cic-carelli - Valenza 2006 e Ciccarelli 2008).2
Le celebrazioni iniziano il 29 novembre con la novena. A Messina i nuvinid-dara eseguivano in questa circostanza un componimento costituito da trentasette sestine di ottonari (i primi quattro a rima alternata e gli ultimi due a rima baciata). Ogni “giornata” comprende quindi quattro strofe, a eccezione dell’ultima che ne prevede cinque. Il contenuto è di carattere lirico-narrativo: lodi alla Madonna (ver-gine, illibata, casta, pura, candida, perfetta, bella, intatta, felice, stella mattutina, rosa consacrata, ecc.), rievocazione dei momenti cruciali della vicenda mariana (nascita, annunciazione, natività del Cristo, ascensione), riferimenti al dogma dell’Immacolata Concezione e accorate implorazioni dei devoti.
2 Per un inquadramento in ottica antropologica del culto mariano, anche nella prospettiva di una continuità rispetto ai culti femminili precristiani dell’area mediterranea, si vedano tra gli altri: WARNER 1980; CATTABIANI 1988: passim; AA.VV. 1995; CARDINI 1995: 133-148; BUTTITTA 1996: 113-118.
16 Sergio Bonanzinga
La melodia comprende tre frasi, ulteriormente distinguibili in sei semifra-si corrispondenti agli ottonari del testo poetico. L’impianto tonale è in MI mag-giore, ma la seconda frase presenta una modulazione momentanea caratterizzata dal FA# minore in posizione cadenzale, raggiunto attraverso una “dominante minore” (DO#) nella prima semifrase e successivamente confermato dal passag-gio sul IV grado (SI minore) prima di cadenzare nuovamente sul FA#. La voce procede sillabicamente per gradi congiunti in ritmo tendente al 2/4. Il violino esegue una preludio strumentale in 6/8, ripreso tra le strofe con funzione di in-terludio. La trascrizione musicale (ES. MUS. 1) si riferisce alla parte iniziale del-la novena (preludio e prima strofa) ed è completa dell’accompagnamento che pone in evidenza lo stile chitarristico tipico del repertorio.
PRIMA GIORNATA
Lu gran Patri, Ddiu mmurtali, cuncipita, l’ammirau comu spècchiu ddivinali e dd’assai si nni priggiau. L’accittau pi ffìgghi’amata, Maria Cuncetta Immaculata.
Patri, Fìgghiu e Spiritu Santu, tutti tri si cuncittaru, pi cchiù glòria d’avantu, a sta vèggini mannaru. Senza macula criata, Maria Cuncetta Immaculata.
L’aduraru di lu cielu, prima già d’èssiri nata. Cun amuri e santu zelu fu da tutti vinirata. Senza macula criata, Maria Cuncetta Immaculata.
O Cuncetta Immaculata, cu ti fa la tua nuvena, sta ddivota a ttia ti chiama mâ scansati dd’ogni ppena. Gluriusa e risblennenti, ô to nomi trema l’infernu!
Il gran Padre, Dio immortale, avendola concepita, l’ammirò come specchio divino e molto si compiacque. L’accettò per figlia amata, Maria Concetta Immacolata.
Padre, Figlio e Spirito Santo, tutti e tre si accordarono per maggior gloria di vanto mandarono questa Vergine. Senza macchia creata, Maria Concetta Immacolata.
L’adorarono dal cielo, ancora prima di essere nata. Con amore e santo zelo fu da tutti venerata. Senza macchia creata, Maria Concetta Immacolata.
O Concetta Immacolata, chi fa la tua novena è una devota che ti invoca di scansarla da ogni pena. O gloriosa e risplendente, al tuo nome trema l’inferno!
SECONDA GIORNATA
L’infinita onniputenza pi llu munnu arricumpari, comu spècchiu dd’innucenza a Mmaria vosi criari. Senza màcula criata, Maria Cuncetta Immaculata.
L’onnipotenza infinita riappare nel mondo, come specchio d’innocenza ha voluto creare Maria. Senza macchia creata, Maria Concetta Immacolata.
Riti musicali popolari e devozioni “francescane” … 17
Quannu poi l’ebbi furmata, n-ventri d’Anna la mannau, tutta pura e ddilibata comu spècchiu l’adurnau. Supra a ttutti subblimata, Maria Cuncetta Immaculata.
L’altu Ddiu, bbuntà ddivina, chista vèggini ddiletta, comu stidda mattutina, pura, càndida e ppirfetta: vera rrosa cunsacrata, Maria Cuncetta Immaculata.
O Cuncetta Immaculata, tu l’infernu fa trimari, chi la Trinità ncriata tutt’a ttia vosi ndutari: cusì cantannu cu ddivuzioni la Mmaculata tua Cuncizioni.
Poi, quando le diede forma, la mandò nel ventre d’Anna, tutta pura e illibata l’ha adornata come specchio. Sopra tutti sublimata, Maria Concetta Immacolata.
L’alto Dio, bontà divina, questa vergine diletta, come stella mattutina, pura, candida e perfetta: vera rosa consacrata, Maria Concetta Immacolata.
O Concetta Immacolata, tu fai tremare l’inferno, che la stessa Trinità ti ha voluto dare tutto in dote: così cantando con devozione l’Immacolata tua Concezione.
TERZA GIORNATA
Già la corti ddivinali dill’impìriu cilesti a Mmaria vosi criari fra li spiriti cchiù onesti: casta, pura, ddilibata, Maria Cuncetta Immaculata.
Li virtù li iàggiu iu, privilegi e ggrazi immensi, chi non può stu sènsiu miu, spiagari sti scienzi. Senza màcula criata, Maria Cuncetta Immaculata
E ddill’ànciuli adurata, di l’arcànciuli e cchierubini, santi spiriti ddivini, patriarca e ssirafini: sutta a Ddiu e cchiù adurata, Maria Cuncetta Immaculata.
Miat’idda la pirsuna chi la servi ubbidienti a Mmaria pi sso furtuna! Pi cchiù glòria cuntenti, chista Vèggini climenti nni cunsola eternamenti.
Già la corte divina dell’empireo celeste ha voluto creare Maria fra gli spiriti più onesti: casta, pura, illibata, Maria Concetta Immacolata.
Le virtù le godo io, privilegi e grazie immense, che il mio intelletto non può spiegare queste scienze. Senza macchia creata, Maria Concetta Immacolata.
E dagli angeli adorata, dagli arcangeli e cherubini, santi spiriti divini, patriarchi e serafini: sotto di Dio è la più adorata, Maria Concetta Immacolata.
Beata quella persona che serve obbediente a Maria per sua fortuna! Contenta di ricevere più gloria, questa Vergine clemente ci consola eternamente.
18 Sergio Bonanzinga
QUARTA GIORNATA Sti gran meriti ddivini cantu a vvui bbedda signura. Stu gran Ddiu quann’ebbi fini la ndutau vèggini e ppura: senza màcula criata, Maria Cuncetta Immaculata.
Quannu Ddiu vosi criari suli, luna, stiddi e ccelu, aria, focu, terra e mmari cu l’arcànciulu Gabrieli, n-menti a vvui v’avìa criata, Maria Cuncetta Immaculata.
Poi lu tempu era vicinu, Ddiu n-terra avìa a ccalari, a ssant’Anna e a ssan Ghiachinu avìa sta pianta a girmugliari: cusì fu dditirminata, Maria Cuncetta Immaculata.
O Cuncetta Immaculata, cu a ttia ti loda e adura, tu si nostra gran vvucata, sacratissima signura, virginedda ddilibata, ddifinsura e avvucata.
Questi gran meriti divini canto a voi bella signora. Questo gran Dio quando completò l’opera la rese vergine e pura: senza macchia creata, Maria Concetta Immacolata.
Quando Dio ha voluto creare sole, luna, stelle e cielo, aria, fuoco, terra e mare con l’arcangelo Gabriele, nella sua mente vi aveva già creata, Maria Concetta Immacolata.
Poi il tempo era vicino, Dio doveva scendere sulla terra, a sant’Anna e a san Gioacchino doveva questa pianta germogliare: così fu determinata Maria Concetta Immacolata.
O Concetta Immacolata, chi ti loda e ti adora, tu sei nostra avvocata, sacratissima signora, verginella illibata, difensore e avvocata.
QUINTA GIORNATA
Ddiu ti sarvi gran Signura, matri a ccui di padri è fìgghiu, siti bbella, intatta e ppura, chi dill’ànciulu cunsìgghiu: vera rrosa cunsacrata, Maria Cuncetta Immaculata.
Quannu Ddiu s’avìa a ncarnari mannau l’ànciulu Gabrieli pi pputiri annunziari la rriggina di li celi: Ddiu nni manna sta mmasciata, Maria Cuncetta Immaculata.
Quannu l’àncilu scinni iusu riguardau lu bbellu visu, era un suli luminusu di Maria ngelicu visu: di Maria com’è ffurmata, Maria Cuncetta Immaculata.
Dio ti salvi gran signora, madre a colui che ti è figlio e padre, siete bella intatta e pura, che dell’angelo consiglio: vera rosa consacrata, Maria Concetta Immacolata.
Quando Dio doveva incarnarsi mandò l’angelo Gabriele per potere annunziare la regina dei cieli: Dio ci manda quest’annunzio, Maria Concetta Immacolata.
Quando l’angelo scese giù rimirò il bel viso, era un sole luminoso l’angelico viso di Maria: di Maria com’è plasmata, Maria Concetta Immacolata.
Riti musicali popolari e devozioni “francescane” … 19
O Cuncetta Immaculata, di la terra e ddi lu celu, tuni si nnostra avvucata, funti di ddivinu zelu: Mmaculata si n-eternu, ô to nomi trema l’infernu!
O Concetta Immacolata, della terra e del cielo, tu sei nostra avvocata, fonte di divino zelo: sei Immacolata in eterno al tuo nome trema l’inferno!
SESTA GIORNATA
Pi cchiù glòria d’avantu, cristianu stacci a ccura, si ncarnau lu Verbu santu nni st’amabili Signura. Fu nna donna furtunata, Maria Cuncetta Immaculata.
Ddivintau la quarta ddia, comu ntrìnsica e pparenti, chist’amàbili Maria n-senu avìa stu Ddiu putenti: sta gran vèggini sacrata, Maria Cuncetta Immaculata.
Di lu celu ogni mmumentu, ànciuli e arcànciuli calaru, cu ggran giùbilu cuntentu a llu Verbu salutaru: a Mmaria, matri sacrata, Maria Cuncetta Immaculata.
Doppu Ddiu ssennu ncarnatu ntra lu so corpùriu senu, nni Maria s’ebb’a nchianari la putenza di lu celu. Canta l’ànciulu e ddisponi viva la Mmaculata Cuncizioni!
Per maggior gloria di vanto, stai attento o cristiano, s’è incarnato il Verbo santo in quest’amabile Signora. Fu una donna fortunata, Maria Concetta Immacolata.
È divenuta la quarta divinità, in qualità d’intrinseca parente, quest’amabile Maria portava in seno questo Dio potente: questa gran vergine sacra, Maria Concetta Immacolata.
Dal cielo ogni momento discesero angeli e arcangeli, con gran giubilo e contentezza salutarono il Verbo: a Maria, madre sacra, Maria Concetta Immacolata.
Dopo che Dio si fu incarnato nel suo corporeo seno, verso Maria è dovuta ascendere la potenza del cielo. Canta l’angelo e dispone: viva l’Immacolata Concezione!
SETTIMA GIORNATA
L’altu Ddiu, bbuntà ddivina, chista vèggini ddiletta, ch’è nna stidda mattutina, pura, càndida e ppirfetta: nun fu mma’i culpa macchiata, Maria Cuncetta Immaculata.
E dill’ànciuli e lli troni di la summa mperatrici, santa vèggini n-unioni, la Scrittura parra e ddici: e ddi tutti è vinirata, Maria Cuncetta Immaculata.
L’alto Dio, bontà divina, questa vergine diletta, ch’è una stella mattutina, pura, candida e perfetta: non fu mai di colpa macchiata, Maria Concetta Immacolata. E degli angeli e i troni della somma imperatrice, in più santa vergine, la Scrittura parla e dice: è da tutti venerata, Maria Concetta Immacolata.
20 Sergio Bonanzinga
Comu spècchiu ddivinali di la Santa Trinitati, chi non c’è, parrannu, uguali, cristiani bbattizzati! Da lu Ddiu pridistinata, Maria Cuncetta Immaculata
O Cuncetta Immaculata, di lu celu mperatrici, tuni si nnostra avvucata, rosa candida e ffilici, gluriusa e risblennenti fa li ddivoti toi leti e ccuntenti!
Come specchio divino della santa Trinità, che non c’è, parlando, uguale, o cristiani battezzati! Da Dio predestinata, Maria Concetta Immacolata.
O Concetta Immacolata, imperatrice del cielo, tu sei la nostra avvocata, rosa candida e felice, gloriosa e risplendente rendi i tuoi devoti lieti e contenti!
OTTAVA GIORNATA
Mentri era ntra stu munnu, sta gran vèggini climenti, spiagarla mi cunfunnu, l’adurau ntra so menti, a sta vèggini sacrata, Maria Cuncetta Immaculata
Di lu suli, di la luna, ària, nùvuli e llu ventu, acqua, nivi e ogni cciuri cuncirtaru li strumenti cun’angelica armunìa dd’ogni pparti si sintìa.
E ll’aceddi dd’ogni ppatti, sta Maria unni passava, li chiamava a vvuci forti. E i cchiù ccosi l’adurnava sta gran vèggini sacrata, Maria Cuncetta Immaculata
Quannu poi fu idd’arrivata, – «Cristiani aviti ntisu?» – chista sacra Immaculata, cu lu so ngèlicu visu, dìcunu tutti cun vuci pirfetta: viva sta purissima Cuncetta!
Mentre era in questo mondo, questa gran vergine clemente, a spiegarlo mi confondo, l’adorò nella sua mente, a questa vergine sacra, Maria Concetta Immacolata.
Del sole, della luna, aria, nuvole e vento, acqua, neve e ogni fiore concertarono gli strumenti con angelica armonia che si sentiva da ogni parte.
E gli uccelli da ogni parte, dove questa Maria passava, li chiamava a gran voce. E di più cose [Dio] l’adornava questa gran vergine sacra, Maria Concetta Immacolata.
Quando poi fu arrivata, – «Cristiani avete inteso?» – questa sacra Immacolata, con il suo angelico viso, dicono tutti con voce perfetta: viva questa purissima Concetta!
NONA GIORNATA
Pi cchiù glòria d’avantu, quali su li tri pirsuni, Patri, Fìgghiu e Spiritu Santu ci ddunaru tri curuni: pi ncrunari a Matri amata, Maria Cuncetta Immaculata.
Per maggior gloria di vanto, quali son le tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo le donarono tre corone: per incoronare la Madre amata, Maria Concetta Immacolata.
Riti musicali popolari e devozioni “francescane” … 21
Prima fu lu Patri Eternu chi a Mmaria firmau curuni, a ddispettu dill’infernu, e ddi tuttu a fa patruna: ncurunau la fìgghia amata, Maria Cuncetta Immaculata.
E secunnu fu sso Fìgghiu, curuna famosissima, chi di grazi l’arricchìu a la matri so santissima, E sso Fìgghiu cci dicìa: «Quant’è bbedda a matri mia!»
Terzu fu u Spiritu Santu, na curuna luminusa, e ccu ll’ànciuli a llu cantu dannu lodi a lla so spusa. Ogni ànciulu dicìa: «Viva lu nomu di Maria!»
Matri ssennu ncurunata di la terra e ddi lu celu, siti vui Matri avvucata, funti di ddivinu zelu. Ed ogni ànciulu disponi: «Viva la Mmaculata Cuncizioni!»
Primo fu il Padre Eterno a firmare corona a Maria, a dispetto dell’inferno, e di tutto la rende padrona: incoronò la figlia amata, Maria Concetta Immacolata. E secondo fu suo Figlio, corona famosissima, che arricchì di ogni grazia la sua Madre santissima. E suo Figlio le diceva: «Quant’è bella la madre mia!» Terzo fu lo Spirito Santo, una corona luminosa, e con gli angeli accanto offrono lodi alla sua sposa. Ogni angelo diceva: «Viva il nome di Maria!»
Essendo stata incoronata Madre della terra e del cielo, siete voi Madre avvocata, fonte di divino zelo. E ogni angelo dispone: «Viva l’Immacolata Concezione!»
Diversamente dal culto dell’Immacolata, la devozione tributata alla Madon-
na di Pompei risale soltanto agli ultimi decenni dell’Ottocento. Questo è infatti uno dei titoli assunti dalla Madonna del Rosario in rapporto alla vicenda del beato Bar-tolo Longo, che diffuse nel Napoletano il culto di una miracolosa immagine della Vergine, poi custodita nel Santuario appositamente edificato a valle di Pompei nel 1880. Il culto si estese rapidamente a tutta l’Italia e nella città di Messina è stato introdotto dai Padri Cappuccini, ai quali si deve la costruzione dell’omonima chie-sa, benedetta l’8 maggio del 1888, con accanto il nuovo convento (la precedente struttura conventuale era divenuta carcere femminile dopo l’Unità d’Italia). L’edificio fu tuttavia sostituito nel 1906 con altra chiesa più grande per rispondere alla straordinaria devozione popolare verso questa Madonna. Travolto nel disastro-so terremoto del 1908, ricostruito e ancora distrutto dai bombardamenti del 1943, il sacro edificio è stato eretto nuovamente nello stesso luogo (sul colle “dell’Oliveto”), a testimoniare la tenacia dei Francescani e l’affezione dei Messine-si per la Madonna di Pompei, la cui chiesa fu fregiata del titolo di Santuario nel 1959 (cfr. Foti 1983: 341-344).
Dal 29 aprile al 7 maggio si svolge la novena della Madonna di li Pumpei. Anche questa era in passato officiata dai nuviniddara, che utilizzavano per
22 Sergio Bonanzinga
l’occasione un componimento particolare: in suo onore si eseguiva infatti una nu-vena ntruccata, realizzata impiegando strofe e formule stereotipe ricavate da nove-ne preesistenti. Le “giornate” dispari presentano contenuto esclusivamente lirico, con espressioni elogiative e implorative che riecheggiano quelle rilevate nella No-vena dell’Immacolata. Ogni giornata dispari è costituita da tre sestine di ottonari, con i primi quattro versi a rima alternata e il distico finale a rima baciata. Per le giornate pari il metro impiegato è invece la quartina di endecasillabi a rima alterna-ta – tre strofe a giornata eccettuata l’ottava che ne contiene quattro – e ogni gruppo di strofe narra un miracolo dispensato dalla Madonna di Pompei: II) salva un bam-bino caduto a mare mentre la madre lo conduce a far visita per Pasqua al padre car-cerato; IV) salva la vita a un ladro condannato a morte che però mostra fede nella sua sacra immagine; VI) resuscita il figlio di un devoto cavaliere tratto in inganno dal demonio; VIII) resuscita la famiglia di una devota, vittima della follia omicida del figlio maggiore e del marito.
La trascrizione musicale (ES. MUS. 2) si riferisce alla frase strumentale del vio-lino (in ritmo di 2/4, con tipico incipit sull’accordo di LAb magg.) e ai due moduli melodici rispettivamente impiegati per intonare le strofe in ottonari e quelle in ende-casillabi. La prima melodia comprende tre frasi, ulteriormente distinguibili in sei se-mifrasi corrispondenti agli ottonari del testo poetico. L’impianto tonale è in SOL mi-nore e presenta una struttura armonica ricorrente in questo repertorio: A (DO min / SOL min / FA magg. / SIb magg.) B (FA magg. / SIb magg.) C (SOL magg. / DO min / RE magg. / SOL min.). La voce procede sillabicamente per gradi congiunti in ritmo tendente al 2/4. La seconda melodia comprende quattro frasi corrispondenti alla quar-tina del testo poetico. Ritmo, armonia e andamento vocale riecheggiano il modulo melodico precedente, mentre invariata resta la frase strumentale del violino.
PRIMA GIORNATA
Sacratissima Signura, di Pumpei sacra Riggina, la to ngèlica figura, siti stella mattutina: sta ddevota chiam’a ttia di li Pumpei Matri Maria. E ognunu si facìa la so santa rreligioni i Pumpei Matri Maria cu ppirfetta ntinzioni, cu n-angelica armunìa di li Pumpei Matri Maria. O Maria di li Pumpei, cu ti fa la to nuvena, sta ddevota chiam’a ttia la scansati dd’ogni pena:
Sacratissima Signora, di Pompei sacra Regina, la tua angelica figura, siete stella mattutina: questa devota ti chiama, di Pompei Madre Maria. E ognuno osservava la sua santa religione di Pompei Madre Maria con perfetta intenzione, con angelica armonia di Pompei Madre Maria. O Maria di Pompei, chi ti fa la tua novena, questa devota ti chiama perché la liberi da ogni pena:
Riti musicali popolari e devozioni “francescane” … 23
comu summa mperatrici nni cunsola e bbenedici.
come somma imperatrice ci consola e benedice.
SECONDA GIORNATA
Nna donna avìa lu spusu cacciaratu, vinni la Pasca e annau a vvisitari, cu d’idda lu picciriddu sê pputtatu: ssennu pi strata cci cadìu a mmari. Nna chesa di Pumpei cci cumpari, ddà intra si mintìu a llacrimari, e llacrimannu cun affettu piu Maria di monachedda ci cumpariu.
«Vidi chi tti cunsola lu me fìgghiu Ddiu!» Li marinara si misiru a ppiscari: pigghiaru oû picciriddu nta la rriti. Li grazii di Maria sunnu nfiniti.
Una donna aveva lo sposo carcerato, venne la Pasqua e lo andò a visitare, ha portato con sé il bambino: mentre era per strada le cadde a mare.
Una chiesa di Pompei le apparve, là dentro si mise a lamentare, e lamentando con affetto pio le apparve Maria come monachella.
«Guarda che ti consola il mio figlio Dio!» I marinai si misero a pescare: presero un bambino nella rete. Le grazie di Maria sono infinite.
TERZA GIORNATA
O Riggina di lu celu, Matri a ccui reggi disponi, li to grazii arrivelu cu ppirfetta ntinzioni: la cchiù bbella e amata sei, o Maria di li Pumpei! L’Eternu Patri cci dicìa, nni la santa razioni, spiagava e ccusì dicìa, cu ppirfetta ntinzioni: cu n-angelica armunìa di li Pumpei matri Maria. O Maria di li Pumpei, tu l’infernu fai trimari! Sta ddivota chiam’a ttia, la to grazia tu cci’â ffari. Matri di Pumpei e mperatrici, nn’aiuta, nni cunsola e bbenedici.
O Regina del cielo, Madre che reggi e disponi, rivelo le tue grazie con perfetta intenzione: sei la più bella e amata, o Maria di Pompei! Il Padre Eterno le diceva, nella santa orazione, spiegava e così diceva, con perfetta intenzione: con angelica armonia di Pompei Madre Maria. O Maria di Pompei, tu l’inferno fai tremare! Questa devota ti chiama, la tua grazia le devi fare. Madre di Pompei e imperatrice, ci aiuta, consola e benedice.
QUARTA GIORNATA
C’era un ddivotu fidili di Maria, l’amici sû purtàrunu a rrubbari. Ogni vvota chi a Mmaria vidìa, la salutava cu nn’avimmaria. Un ghiornu, mentri rrobba a la campìa, fu pigghiatu e ccunnannatu a mmorti. E mmentri chi a la furca iddu ìa, vitti n’immagini pi sso bbona sorti.
C’era un devoto fedele di Maria, gli amici lo portarono a rubare. Ogni volta che vedeva Maria, la salutava con un avemaria. Un giorno, mentre rubava per la campagna, fu catturato e condannato a morte. E mentre andava alla forca, vide un’immagine per sua buona sorte.
24 Sergio Bonanzinga
Era i Pumpei la matri Maria, fidili cristiani stamu accorti! Era di marmu e li bbrazza llungau e ddi la morti rria lu libbirau.
Era la Madre Maria di Pompei, fedeli cristiani stiamo accorti! Era di marmo e le braccia ha proteso e dalla morte ria lo ha liberato.
QUINTA GIORNATA
O Maria quasi ddia, mperatrici di li celi, si non pò lu sènsiu miu, li to grazii m’arriveli, la cchiù bbella amata sei o Maria di li Pumpei. Patreternu llâ ccriatu prima assai dd’ogni alimentu, senza munnu, regnu bbiatu, senza nuddu firmamentu, la furmau nni li so ddei, o Maria di li Pumpei. Poi la terra cci’â ffurmatu, suli, luna ed alimenti, mari e cceli cci’â ndutatu a sta vèggini climenti, di Pumpei mperatrici nni cunsola e bbenedici.
O Maria quasi dea, imperatrice dei cieli, se non arriva il mio intelletto, le tue grazie mi riveli: la più bella e amata sei, o Maria di Pompei. Il Padreterno l’ha creata molto prima d’ogni alimento, senza il mondo, regno beato, senza alcun firmamento, la plasmò fra i suoi dei, o Maria di Pompei. Poi ha plasmato per lei la terra, sole, luna e alimenti, mari e cieli ha dato in dote a questa vergine clemente: di Pompei imperatrice, ci consola e benedice.
SESTA GIORNATA
All’ottu màggiu a la summa Riggina, un cavaleri un cunvitu cci facìa. Circava un cocu e nnu cìfuru cci spuntau e ccomu cocu cci s’apprisintau. Allura a lu palazzu lu mannau e llu pranzu a lli pòviri ci spartìu. All’ultimu lu cìfuru cci purtau a sso fìgghiu arrustutu e ssi nn’annau. Lu cavaleri nun si nn’addunau e secutau lu santu cunvitu, Maria di munachedda ddà cci annau e a lu so fìgghiu cci risuscitau.
L’otto di maggio alla somma Regina, un cavaliere offriva un convito. Cercava un cuoco e arrivò un diavolo che come cuoco si è presentato. Allora lo ha mandato al palazzo e divise il pranzo tra i poveri. Alla fine il diavolo gli ha portato suo figlio arrostito e se n’è andato. Il cavaliere non se ne accorse e proseguì il santo convito. Maria come monachella ci è andata e suo figlio ha resuscitato.
SETTIMA GIORNATA
Sacratissima Signura, di lu celu mperatrici, sta ddivota chiam’a ttia, rosa candida e ffilici, ssennu matri dû Missìa di li Pumpei Matri Maria.
Sacratissima Signora, imperatrice del cielo, questa devota ti chiama, rosa candida e felice, essendo madre del Messia, di Pompei Madre Maria.
Riti musicali popolari e devozioni “francescane” … 25
E dill’ànciuli e lli trona ed arcànciuli e cchirubini, santa e veggini n-unioni, rosa candida e ffilici, siti matri i lu Missìa di li Pumpei matri Maria.
Di li Pumpei si chiama, cu ti lauda e tti adura, sta ddivota chiam’a ttia, l’aiutati gran Signura: comu summa mperatrici nni cunsola e bbenedici.
E degli angeli e i troni e arcangeli e cherubini, in più santa e vergine, rosa candida e felice, siete madre del Messia, di Pompei Madre Maria.
Di Pompei si chiama chi ti loda e ti adora, questa devota ti chiama, aiutatela gran Signora: come somma imperatrice ci consola e benedice.
OTTAVA GIORNATA
Na donna mpastava lu pani, stamu attenti, matina i sabatu lassau un fanciullinu: si nn’avìa a nnèsciri e ntâ naca lu curcau e a lu frati cchiù ranni lu raccumannau. Allura a la missa si nn’annau, lu picciriddu ciancìa nta la naca, lu frati cchiù ranni lu scannau e ppi timuri ntô furnu s’ammucciau.
Vinni la madri e llu furnu appicciau, riminannu u niscìu com’un tizzuni. Rriva lu spusu e lla spusa ammazau e ttutti e ttri nta la càscia li furmau.
A la chesa di Pumpei li purtaru: Maria di Pumpei i risuscitau. Pi sti miràculi e ppurtenti chi facisti sta ddivota chiama e ttu l’assisti!
Una devota impastava il pane, stiamo attenti, alla mattina di sabato lasciò un fanciullino: doveva uscire e lo mise a dormire nella culla e lo raccomandò al fratello più grande. Allora se ne andò alla messa, il bambino piangeva nella culla, il fratello più grande lo ha scannato e per timore si nascose dentro al forno.
Venne la madre e accese il forno, ravvivando lo tirò fuori come un tizzone. Arriva lo sposo e ammazza la moglie e tutti e tre nella bara li compose.
Alla chiesa di Pompei li portarono: Maria di Pompei li resuscitò. Per questi miracoli potenti che hai fatto questa devota chiama e tu l’assisti!
NONA GIORNATA
Mperatrici di lu celu, o Maria celestaiali, la to grazia arrivelu chi a lu munnu nun c’è eguali: m-Paradisu amata sei o Maria di li Pumpei!
Quantu ànciuli stannu attornu, serafini ô to cumannu, chi fistèggiunu ogni gnornu la to gloria cantannu? Mmenzu all’ànciuli tu sei o Maria di li Pumpei! O facèmuci ddivoti di st’amabili Maria,
Imperatrice del cielo, o Maria celestiale, la tua grazia rivelo che al mondo non c’è uguale: in Paradiso se amata o Maria di Pompei!
Quanti angeli ti stanno intorno, serafini al tuo comando, che festeggiano ogni giorno la tua gloria cantando? Tu stai in mezzo agli angeli, o Maria di Pompei!
Facciamoci devoti di quest’amabile Maria,
26 Sergio Bonanzinga
m-Paradisu ddà si godi e cull’ànciuli in ncumpagnìa, cu Ggesù, Giuseppi e Mmaria, ànciuli e ssirafini in cumpagnìa.
in Paradiso si gode in compagnia degli angeli, con Gesù, Giuseppe e Maria, in compagnia di angeli e serafini.
La fervente devozione tributata dai Messinesi a san Francesco di Paola si deve alla localizzazione nel mare dello Stretto del suo più celebre miracolo: l’attraversamento a bordo del proprio mantello - con la compagnia di un altro frate - delle acque che separano la Sicilia dalla Calabria. Nel luogo dell’approdo, avvenuto secondo tradizione nel 1464, sorgeva fin dall’epoca normanna una piccola chiesa inti-tolata al Santo Sepolcro, «che apparteneva ai Benedettini di Monreale, i quali se ne servivano come punto di appoggio nei loro pellegrinaggi verso la Terra Santa» (Foti 1983: 236). L’edificio era situato poco a settentrione delle mura cittadine e si narra che il Santo avesse predetto che proprio lì sarebbe sorto un convento dell’Ordine dei Mi-nimi da lui fondato. Cosa che puntualmente avvenne nel 1503 a opera di fra Pietro da Messina, inviato dal Santo che si trovava a quel tempo presso la corte di Francia. L’elegante chiesa a tre navate, con annesso fabbricato conventuale (dopo l’Unità d’Italia trasformato in caserma dei carabinieri), subì gravissimi danni nel terremoto del 1908. La chiesa venne però ricostruita, sempre nello stesso punto dell’attuale viale del-la Libertà (all’incrocio con via Istria), assumendo il titolo parrocchiale di Santa Maria dell’Arco in San Francesco di Paola (cfr. Foti 1983: passim).
La Nuvena i san Franciscu i Pàula, detta anche dû santu Patri (del santo Pa-dre, secondo l’appellativo ricorrente in ambito popolare), si svolge dal 24 marzo all’1 aprile. Il lungo componimento appartenente al repertorio degli orbi messinesi è costituito da cinquantaquattro quartine di endecasillabi a rima alternata, in cui si narra la vicenda del Santo dalla nascita alla morte (rientra quindi nel genere delle storie). Le strofe sono distribuite in numero irregolare fra le giornate (cinque per I, VI e VIII, sei per III, VII e IX, sette per II e V), senza che venga tuttavia pregiudi-cata la coerenza della narrazione: I) Francesco è votato dai genitori a san Francesco d’Assisi e manifesta precocissima inclinazione verso la penitenza (al venerdì si ri-fiuta di allattare); II) il piccolo Francesco opera prodigi durante la permanenza nel convento francescano di San Marco Argentano (Cosenza), dove è incaricato di svolgere in cucina le mansioni più umili; III) tornato a Paola resiste alle tentazioni del demonio e osserva con costanza digiuni e astinenze; IV) eremita “nel deserto”, opera svariati prodigi e poi edifica miracolosamente una chiesa; V) richiede al Papa e ottiene il riconoscimento dell’Ordine monastico da lui fondato (Congregazione eremitica paolana di San Francesco d’Assisi che poi assumerà la denominazione attuale di Ordine dei Minimi); VI) effettua il prodigioso attraversamento dello Stretto di Messina e resuscita un impiccato appena giunto sulla costa siciliana; VII) senz’alcun aiuto trasporta una grande campana e la sistema nel campanile di un convento a Milazzo; VIII) si trasferisce alla corte di Francia, dove guarisce il re in-
Riti musicali popolari e devozioni “francescane” … 27
fermo e si mostra capace di predire il futuro; IX) muore gloriosamente, rendendo vano il tentativo degli “eretici” di bruciare il suo corpo che resiste alle fiamme.
La trascrizione musicale (ES. MUS. 3) si riferisce alla prima strofa della no-vena. La melodia è costituita da quattro frasi corrispondenti agli endecasillabi delle quartine in cui si articola il testo poetico. Si tratta del medesimo modulo ricorrente, con lievi adattamenti, nella seconda giornata della Novena della Madonna di Pom-pei (cfr. supra).
PRIMA GIORNATA A ttia ricurru, Cristu rredenturi, ddùnimi grazia e spieghimi la menti: cantu di san Franciscu di Paula lu to stupuri, stu gran servu di Cristu onniputenti.
Essennu ranni li so ggenituri, ddisiddiraru a nu fìgghiu sulamenti. A ssan Franciscu d’Assisi ànnu prigatu: faccennu prighieri, Ddiu cci l’à ccurdatu.
Ddi ddu mumentu chi ffu gginiratu supra a so casa nu sblinduri apparìu: lu focu celesti à ddimustratu ch’era nnu santu, cristianu miu! Per èssiri nnu santu gloriusu e rraru, lu venneddì u bbamminu no allattava: stu gran servu di Ddiu ddivinucatu, nnê fasci a soi vita mottificava.
Ddi celu bbeni chi l’à manifistatu, chi dduvìa suddisfari lu so votu, e ccomu patri e mmatri prumittìu: allura rreligiosu si vistìu.
Ricorro a te, Cristo redentore, fammi grazia e illumina la mia mente: canto di san Francesco di Paola il tuo stupore, questo gran servo di Cristo onnipotente. I suoi genitori, essendo anziani, desideravano soltanto avere un figlio. Hanno pregato san Francesco d’Assisi: facendo preghiere, Dio gliel’ha accordato. Dal momento in cui fu generato, sopra la sua casa apparì una luce splendente: il fuoco celeste ha dimostrato che era nato un santo, o mio cristiano! Dato che era un santo glorioso e raro, di venerdì il bambino non allattava: questo gran servo da Dio divinizzato, ancora in fasce mortificava la sua vita. Avendo il cielo manifestato chiaramente che doveva adempiere al suo voto, come il padre e la madre fece promessa: allora si vestì da religioso.
SECONDA GIORNATA
Tu chi gguverni li cilesti squatri, ddunami grazi, Ddiu, bbuntà nfinita: ch’iu lodu e ccantu di stu santu Patri, in chistu munnu la so santa vita.
Comu si trova scrittu in tanti quatri, la so gran santitati fu squisita: n-Calabria, n-Ssan Marcu, sent’a mmia, stu santu Patri chi vita facìa.
Nta la cucina stu santu assistìa: in èstisi spissu si nn’annava, in èstisi n-ogni pparti si vidìa, chi ddognidunu si maravigghiava.
Tu che governi le squadre celesti, donami grazia, Dio, bontà infinita: che io lodo e canto di questo santo Padre, la sua santa vita in questo mondo.
Come si trova scritto in tanti luoghi, la sua santità fu squisita: in Calabria, in San Marco, ascolta me, che vita faceva questo santo Padre.
In cucina lavorava questo santo: in estasi spesso se ne andava, in estasi si vedeva da ogni parte, che ognuno provava meraviglia.
28 Sergio Bonanzinga
Lu focu cu lli mani lu pigghiava e llu focu a lu santu nnô bbruciava, chi ssennu n-èstisi, aviti a ppinsari, chi si scurdava di fari u manciari. Ma tanti voti, prima di cinari, nta la cucina stu santu si nni stava: cu ll’aiutu di Ddiu, ddivoti cari, sùbitu tutti cosi apparicchiava. Facìa li supiriuri stupafiri, chi ssenza focu tuttu annordinava: però rristaru qua li so purtenti e ccertu chi stupisci chi li senti. San Franciscu di Pàula ccillenti, bbiatu cu ti chiama pri cchiù vvantu. Cu la nuvena cci fa cu ffidi ardenti, lu fa di li so grazii cuntenti.
Prendeva il fuoco con le mani e il fuoco al santo non lo bruciava, che dato che era in estasi, dovete pensare, che si scordava di fare da mangiare. Ma tante volte prima di cenare, questo santo se ne stava in cucina: con l’aiuto di Dio, devoti cari, subito tutto quanto apparecchiava. Faceva stupire i superiori, che senza fuoco tutto approntava: però restarono qua i suoi portenti e certo che si stupisce chi li sente. San Francesco di Paolo eccellente, beato chi ti chiama per più onore. Chi fa la novena con fede ardente, lo rende lieto delle sue grazie.
TERZA GIORNATA
Stu santu Patri, c’amurusu affettu, riturnau nta Pàula – mi senti? – cu vvera fidi e ccu ppinseri erettu, stu gran servu di Ddiu onniputenti. Sùbitu si nn’annau nta lu ddisettu pi cchiù ffari la vita pinitenti: e nnotti e gghiornu si disciplinava, così la vita soi muttificava. Lu ddimòniu a cchistu lu tintava: stu santu Patri, gluriusu e ppiu, nta l’acqua ggilata si ittava pi ddiscacciari lu sirpenti riu. E strittamenti a l’altu Ddiu prigava cu ggran fivvuri, cristianu miu. E ccusì tutti li casi à ssupiratu, san Franciscu di Pàula bbiatu.
Quannu l’eternu Ddiu l’ebbi pruvatu ch’era custanti a lli tintazioni, nn’ànciulu dû celu cciâ mmannatu, ddànnuci aiutu e ccunsulazioni. Na culonna ddi focu cciâ ffurmatu su la rutta di Ddiu di passioni, significannu ch’era fermu e fforti pi llibirarsi di l’eterna morti.
Questo santo Padre, con affetto amorevole, ritornò a Paola – mi ascolti? – con vera fede e con alto pensiero, questo gran servo di Dio onnipotente.
Subito se n’è andato nel deserto per fare una vita da penitente: e notte e giorno si fustigava, così la sua vita mortificava. Il demonio lo tentava: questo santo Padre, glorioso e pio, nell’acqua gelata si gettava per scacciare il serpente rio.
E intensamente pregava Dio con gran fervore, o cristiano mio. E così tutte le prove ha superato, san Francesco di Paola beato. Quando l’eterno Dio ebbe la prova che resisteva alle tentazioni, un angelo dal cielo gli ha mandato, dandogli aiuto e consolazione. Una colonna di fuoco ha plasmato sull’immagine della passione di Dio, a significare ch’era fermo e forte per liberarsi dell’eterna morte.
Riti musicali popolari e devozioni “francescane” … 29
QUARTA GIORNATA Carissimi ddivoti, stamu attenti: san Franciscu di Pàula opirau nta lu ddisettu tant’i ddi puttenti chi pi ttuttu lu munnu risunau. Ricugghìu ntô disettu tanta ggenti e mmolti rimitori furmau, cu mmònici a la so ddirizioni, cu ppinitenza e ccu ddivuzioni. Dopu di fari nna chesa disponi: ddà vicinu cc’era na muntagna. Stu gran servu di Ddiu di passioni la fa rrasari ch’è na cosa magna. Autri puttenti si nni senti e storii. Spissu si vidìa ntâ campagna: petri i milli cantara cumannava e ccu nna sula manu li purtava. Comi viti a ppezza a ppezza li spizzava, cusì chesa e ccunventu fabbricava. Pi ssanta carità tutti prigava, senza dinaru tuttu accumudava. Li maistri cu lli pòpuli stunava vidennu sti miraculi e pputtenti. San Franciscu dû celu cciâ ccalatu, cusì la chesa cci fici allungari. Li mura allura fìciru arrasari, li travi e àutri ligna s’allungaru. Pi ttutti i to miraculi e pputtenti fa li ddivoti toi leti e ccuntenti.
Carissimi devoti, stiamo attenti: san Francesco di Paola ha operato nel deserto tanti di quei portenti che per tutto il mondo è riecheggiato. Ha raccolto nel deserto tanta gente e ha fondato molti romitori con monaci alle sue dipendenze, con penitenza e devozione. Dopo decide di fare una chiesa: là vicino c’era una montagna. Questo gran servo di Dio appassionato la fa allontanare che è cosa grandiosa. Altri portenti e storie si raccontano. Spesso lo si vedeva nella campagna: pietre enormi comandava e con una sola mano le trasportava. Come viti le faceva a pezzi, così fabbricava la chiesa e il convento. Tutti pregava per santa carità, tutto risolveva senza bisogno di denaro. Sbigottiva dotti e popolani con questi miracoli e portenti. San Francesco dal cielo è disceso, così la chiesa ha fatto allungare. Le mura allora si sono allontanate, le travi e gli altri legni si sono allungati. Per tutti i tuoi miracoli e portenti rendi i devoti tuoi lieti e contenti.
QUINTA GIORNATA
Quann’à risoltu, st’ordini à furmatu: lu cappùcciu dû celu cciâ ccalatu, cu ll’aiutu di Ddiu, ddivoti cari, l’arcànciulu Gabrieli llâ pputtatu. Lu Papa a cchistu non vulìa accurdari quantu lu santu Patri cciâ ccircatu: ch’avìa a ffurmari sta rriligioni e ccusì stritta e ccu ddivuzioni. Senza manciari carni, si supponi, i nudda sorta e mmancu latticini, pisci e tunnina in tanta affrizioni, sempri frutti di mari di quintinu.
Quando ha finito, quest’ordine ha fondato: il cappuccio dal cielo è disceso, con l’aiuto di Dio, cari devoti, l’arcangelo Gabriele l’ha portato. Il Papa non voleva accordare quanto il santo Padre aveva richiesto: di costituire quest’ordine religioso con tanta intensità e devozione. Senza mangiare carne, si suppone, di nessun genere e neppure latticini, pesci e tonno in tanta afflizione, sempre e soltanto frutti di mare.
30 Sergio Bonanzinga
Dissi lu Papa nta st’occasioni: «Comu susteni lu corpu, mischinu, senza manciari carni?» Carissimi ddivoti, stamu attenti, chi lu Papa di chistu nun cunsenti. Rispusi u santu Patri a lu mumentu: «Comu pìgghiu lu focu cu lli mani, cusì sistimai lu me cunventu, in gloria di li grazi suprani. E si nun mànciu carni è un gran puttentu, ma li me frati sunnu sempri sani.» Ed autri puttenti à opiratu e l’òddini lu Papa cciâ ccurdatu.
Poi tanti cunventi à ffabbricatu senza dinari, a fforza i caritati. E ccu lu chiama cu ffidi pussenti, nni fa di li so grazii cuntenti.
Disse il Papa in quest’occasione: «Come sostiene il corpo, poveretto, senza mangiare carne?» Carissimi devoti, stiamo attenti, che il Papa questo non lo consente. Rispose allora il santo padre: «Come prendo il fuoco con le mani, così ho edificato il mio convento, nella gloria delle grazie più alte.
E se non mangio carne è un gran portento, ma i miei frati sono sempre sani.» E altri portenti ha operato e il Papa gli ha permesso [di costituire] l’ordine. Poi ha fabbricato tanti conventi senza denaro, con offerte caritatevoli. E quanti lo chiamano con fede possente, li ripaga con le sue grazie.
SESTA GIORNATA
Doppu chi firriò città e ppaisi, di Pàula a Catuna si ni vinni: San Franciscu di Pàula prumisi nnu purtentu mû ddivotu si nn’adduna. Supra lu mari lu mantellu stisi, chi mbarcari nô vvulìa nudda pirsuna: assemi a llu fratellu s’imbarcau e ssùbitu n-Sicilia arrivau. Ognidunu i stu puttentu fu supprisu, pirchì stu santu lu mari calmau. Chi li pisci fannu festa – aviti ntisu? – e llu mantu matraperla ddivintau.
Allura chi n-Sicilia sbarcaru, truvaru un omu, mischinu, mpinnutu già di tri ghiorna: lu risuscitau! Chi bbella sorti st’omu chi àv’avutu!
Ed assemi cu d’iddu sû purtau ed ognunu i stu puttentu sâ stuputu. Campau comu un santu st’omu mpisu, ora godi cu d’iddu n-paradisu!
Dopo che viaggio tra città e paesi, da Paola si spostò a Catona: san Francesco di Paola ha promesso un portento perché il devoto se ne accorga. Stese il mantello sopra il mare, perché nessuno lo voleva imbarcare: s’imbarcò insieme al fratello e subito arrivò in Sicilia. Ognuno fu sorpreso da questo portento, perché questo santo calmò il mare. Che i pesci fanno festa – avete inteso? – e il manto è diventato madreperla.
Al momento che sbarcarono in Sicilia, trovarono un uomo, poveretto, impiccato già da tre giorni: lo resuscitò! Che bella sorte ha avuto quest’uomo!
E lo portò con sé e tutti si stupirono di questo portento. Visse da santo quest’uomo impiccato, ora gode con lui in paradiso!
SETTIMA GIORNATA
Li miraculi chi ffici nta Milazzu, ora v’arraccuntu, cristiani:
I miracoli che ha fatto a Milazzo, ora vi racconto, o cristiani:
Riti musicali popolari e devozioni “francescane” … 31
chi cc’era un capitanu – povirazzu! – câ bbordu tinìa certi campani. Li so puttenti d’accapiri vi fazzu: in prisenza di tanti paisani, lu santu na campana cciâ ccircatu ed iddu la cchiù ranni cci ppruntatu.
Cridennu di bburlarlu, sâ ngannatu: lu santu la campana si pigghiau, ntra la mànica bbeni situata, sùbitu a llu cunventu lâ ppurtata. Nnu grossu travu curtu sistimau e ccu li mani sò l’ebb’a llungari: e lla campana nta lu campanaru e llu travu ô so postu si truvaru. Li mastri cu lli populi stunaru vidennu sti miraculi e puttenti: nta Milazzu pi ssantu l’acclamaru e a Nnapuli si nn’annò subitamenti. U rre di Napuli sû tinìa caru vidennu li miraculi e pputtenti: vinsi n-tanti battagli, si supponi, li nnimici cu lla so ddivuzioni.
c’era un capitano – poveraccio! – che teneva a bordo certe campane. I suoi portenti vi faccio capire: in presenza di tanti paesani, il santo una campana gli ha richiesto e quello la più grande gli ha portato.
Credeva di burlarlo ma si è ingannato: il santo si è preso la campana, nella manica ben sistemata, subito al convento l’ha trasportata. Una grossa trave corta ha piazzato e con le sue mani l’ha allungata: e la campana nel campanile e la trave al suo posto si trovarono. I dotti e i popolani si meravigliarono vedendo questi miracoli e portenti: a Milazzo lo acclamarono come santo e subito se ne partì verso Napoli. Il re di Napoli se lo teneva caro vedendone i miracoli e portenti: vinse in tante battaglie, si suppone, i nemici con la sua devozione.
OTTAVA GIORNATA
Sintennu u rre di Francia stu gran santu, subitamenti lu manna a cchiamari, ma san Franciscu di Pàula frattantu n-Francia, ddivoti, nun vulìa annari. Lu Papa e llu re, comu iò sentu, ô gran santu si misiru a pprigari, cu vveru amuri, svisciratu e ppiu, cusì stu santu Patri si partìu. Pi vvia a ttanti cunvirtìu, eretici, nfidili e ccristiani, n-Francia nni lu rre s’è prisintatu e ddi Francia lu rre era malatu. Tutti li nfermità cci lâ ssanatu, cci dissi chi ddu anni avìa à ccampari. A nna nobili dama cciâ nsittatu gravida chi mmàsculu avìa à ffari.
Chi tutti cosi cci avìa nsittatu, san Franciscu di Pàula bbiatu:
Il re di Francia sentendo di questo gran santo, prestamente lo manda a chiamare, ma frattanto san Francesco di Paola in Francia, o devoti, non voleva andare. Il Papa e il re, per quanto sento, al gran santo si misero a pregare, con vero amore, sviscerato e pio, così questo santo Padre se ne partì. Per via ne ha convertiti tanti, eretici, infedeli e cristiani, in Francia si è presentato dal re e il re di Francia era malato. Tutte le infermità gli ha sanato, gli disse che doveva vivere due anni. A una nobile dama gravida ha predetto che avrebbe partorito un maschio. Che tutto quanto aveva predetto, san Francesco di Paola beato:
32 Sergio Bonanzinga
ddopu ddu anni lu rre trapassau, lu santu Patri a lu fìgghiu ncurunau.
dopo due anni il re è trapassato, il santo Padre al figlio ha incoronato.
NONA GIORNATA
Ascutati, fidili bbattizzati, s’era stu santu gluriusu e ppiu: di san Franciscu di Pàula nnutati quanti grazii stu munnu arricivìu. Ci parrava a lu spissu, sappiati, cu lla matri santissima di Ddiu. Si mmi scutati cu ggran fidi forti, ora vi cuntu la so santa morti. Fu a lu ddui d’aprili, stamu accorti, ntô Venneddì Santu, cuntiplamu, a vintin’ura appuntu – oh bbella sorti! – san Franciscu di Pàula spirau. Un ggiòvini cci aprìu li santi porti: nna quantitati d’ànciuli mannau, tanti lodi sublimi cci cantaru e ll’anima a llu celu si purtaru. L’eretici nta Francia riturnaru e u so corpu vulìvunu bbruciari e li bbanchi dâ chesa vi sfasciaru, ma li ligna nun vvòsunu ddumari. E n-menzu di sti ligna chi puttàvunu cc’era na cruci, mei ddivoti cari: mortu s’abbraccia la cruci filici, s’ardìu la cruci e llu focu si sfici.
Ascoltate, fedeli battezzati, se questo santo era glorioso e pio: prendete nota di san Francesco di Paola quante grazie ha ricevuto il mondo. Sappiate che parlava spesso con la santissima madre di Dio. Se mi ascoltate con gran fede forte ora vi narro la sua santa morte. Fu il due di aprile, stiamo accorti, nel Venerdì Santo, contempliamo, proprio alla ventunesima ora – oh bella sorte! – san Francesco di Paola è spirato. Un giovane gli aprì le sante porte: una quantità di angeli ha mandato, tante lodi sublimi gli hanno cantato e l’anima in cielo hanno portato. Gli eretici sono ritornati in Francia e il suo corpo volevano bruciare e i banchi della chiesa hanno sfasciato, ma i legni non si vollero accendere. E tra quei legni che portavano c’era una croce, miei cari devoti, morto si abbraccia felice alla croce, ardette la croce e il fuoco si spense.
Se le esibizioni degli orbi cantastorie rinviano a una dimensione professiona-
le del fare musica (con preventiva regolazione del sistema prestazione-offerta), al-tre pratiche espressive, caratterizzate da un diverso grado di competenza esecutiva, venivano e vengono agite direttamente dai devoti. Si tratta di un vasto repertorio formato da rosari, litanie, orazioni e canzonette di argomento religioso, magari ori-ginariamente diffuse dagli stessi orbi, che entravano in circolazione dando vita a tradizioni autonome, attuate sia nei contesti domestici (ancora oggi gruppi di donne si riuniscono all’interno o all’esterno delle proprie abitazioni per ripetere i tradizio-nali rosari) sia nelle paraliturgie che si svolgono nelle chiese. Non di rado questi prodotti poetico-musicali, derivati da testi scritti e perlopiù eseguiti secondo melo-die di influenza chiesastica, si legano a specifiche tematiche locali: dalle leggende di fondazione dei culti (prodigiosi ritrovamenti di quadri, statue o reliquie) a mira-
Riti musicali popolari e devozioni “francescane” … 33
coli che potevano riguardare singoli individui (a esempio guarigioni) o intere col-lettività (liberazione da carestie, pestilenze, guerre, predazioni o calamità naturali).
Questa rassegna di riti musicali associati a devozioni popolari di ispirazione francescana si può pertanto concludere con un canto in onore dell’Immacolata che con-tiene espliciti riferimenti alla “storia” messinese. Fino agli anni Sessanta del Novecento la Raziuni dâ Mmaculata (Orazione dell’Immacolata) veniva cantata durante la proces-sione dell’8 dicembre nel casale di Giampilieri (situato lungo una fiumara nel versante ionico dei Peloritani, distante pochi chilometri dal centro urbano). In seguito è stata ri-presa solo per particolari occasioni celebrative, sempre a Giampilieri presso la chiesa di San Nicola di Bari. Il testo è costituito da cinque ottave di endecasillabi a rima alternata (il metro della cosiddetta canzuna siciliana). La prima strofa del canto fa riferimento a una vicenda risalente – secondo la tradizione – all’epoca dei Vespri:
Messina ha seguito l’iniziativa dell’Isola, ha cacciato i francesi,
s’è chiusa nelle sue mura turrite, e siccome dalla sua resistenza dipen-dono i destini della Sicilia tutta, compie atti di valore inauditi. […] Il duca Roberto D’Angiò è alle porte: ha devastato tutti i poderi, già ben poco coltivati per l’incrudelire della guerra, egli assedia e travaglia la città per terra e per mare, le impedisce qualsiasi rifornimento di vetto-vaglie, l’affama.
Messina è agli estremi: la mancanza di nutrimento indebolisce i corpi, ed allora re Federico […] si rivolge a frate Alberto, monaco di santa vita nel convento del Carmine, perché implorasse l’aiuto divino in tanta deficienza e in tanto pericolo.
E qui la leggenda ci narra che, appena frate Alberto finiva di ce-lebrare la messa, sbarcarono dal Faro tre navi cariche di frumento, che a vele gonfie passando senza contrasto in mezzo alle navi nemiche, che tenevano assediato il porto, giunsero al lido, scaricarono il grano e, quel ch’è più, senza richiedere alcun pagamento, e senza che i mari-nai e padroni fossero d’alcuno conosciuti, né sapendosi da dove venis-sero, o chi il soccorso inviato avesse, di nuovo si partirono… Lo stu-pore sorprese l’animo non meno dei cittadini e del Re, ma pur anche degli stessi nemici, che tolsero l’assedio e si ritirarono a Catania. Ciò avvenne nell’anno 1302. [La Corte Cailler 1928]
La soluzione di carestie grazie all’arrivo di vascelli carichi di alimenti, co-
mune a numerose città marinare del Mediterraneo, viene dai Messinesi rievocata nella festa del Corpus Domini. In questa occasione si reca in processione a passo rapido un piccolo fercolo sormontato da una nave d’argento carica di spighe di grano: è il Vascidduzzu (lett. vascelletto), commissionato intorno al 1580 come prezioso ex-voto mariano dai confrati di “Santa Maria di Porto Salvo dei Marinai”
34 Sergio Bonanzinga
(cfr. D’Agostino 1985). La prima strofa della Raziuni di Giampilieri rappresenta quindi un diverso modo di celebrare il miracolo dell’abbondanza dispensato dalla Madonna. Il canto prosegue illustrando il primato della devozione mariana nei ca-sali dislocati lungo la fiumara di Altolia-Giampilieri, con riferimenti alle chiese di Santa Maria delle Grazie (distante circa un chilomentro dal centro di Giampilieri), Santa Maria della Scala e Santa Maria di Portosalvo (più a monte, nei territori dei casali Molino e Altolia). Le due strofe conclusive ribadiscono la fede in Cristo e nella Madonna, esortando i fedeli a una assidua pratica religiosa.3
L’esecuzione responsoriale del canto presenta notevole originalità: mentre la parte narrativa è interamente svolta da una voce solista (maschile), l’intervento del coro (composto soprattutto da donne) si limita alla ripresa delle due sillabe conclu-sive della parola che chiude ogni verso (eccettuati il terzo e il settimo), formando una sorta di eco sulla rima. La melodia, in tonalità di SOL maggiore, copre una quartina del testo poetico. Il profilo melodico è discendente e il ritmo piuttosto li-bero. La voce procede in stile sillabico (a eccezione del melisma che si ripete nella cadenza della prima frase), muovendosi in prevalenza per gradi congiunti (con insi-stenza su tonica e sensibile che assumono quasi funzione di “corde di recita”). L’intervento del coro consiste esclusivamente nel ribattere il primo grado (nella co-stante figurazione semiminima-croma), rafforzando l’elementare struttura armonica del canto (tonica-dominante-tonica). Ogni strofa si conclude con il grido corale di acclamazione a Maria (cfr. ES. MUS. 4).
(i) Ch’è bbella Maria nta lu so mantu / …antu ie carricata d’oru ie dd’aggentu / …entu. Tuttu Missina iera misa a cchiantu, non c’era non ffarina e non fummentu / …entu. Sona la llòria di lu Sàbbutu Santu / antu, puttaru tri ggaleri (e) di fummentu / …entu. Quant’u parrinu isa lu càlici santu, ladatu sempri sia lu Sacramentu!/Viva Maria! (i) Ch’è bbella la ciumara di Giampilieri/…eri ie nnudda chiesa ccia stat’a lu pari / …ari.
Quant’è bella Maria con il suo manto e coperta d’oro e d’argento. Tutta Messina era in pianto, non c’era né farina né frumento. Suona il gloria del Sabato Santo, hanno portato tre galee di frumento. Appena il prete innalza il calice santo, lodato sempre sia il Sacramento!
Quant’è bella la fiumara di Giampilieri tanto che nessuna chiesa può starle alla pari.
3 Il rilevamento è stato effettuato il 29 novembre 1974 da Salvatore Bottari – appassionato cultore di storia patria messinese che ringraziamo per avere reso disponibile la registrazione – in oc-casione del terzo centenario del miracolo relativo al quadro della “Madonna della Pietà” custodito nella chiesa di San Nicola: «La più importante opera d’arte che arricchisce la chiesa, per la reputazio-ne del suo autore e per la tradizione a cui è legata, è una tela raffigurante la Deposizione dalla Croce di Antonio Alberti Barbalonga (1601-1649). […] La tradizione vuole che, nel 1674, durante il sacco del casale, un soldato spagnuolo vibrò sulla tela un colpo di alabarda e subito ne uscì un rivolo di san-gue, che il soldato, spaventato, cercò istintivamente di bloccare con un pugno di calce sulla ferita. L’episodio, narrato anche dal Gallo, è ancora ricordato ogni anno con una celebrazione liturgica il 29 novembre» (Foti 1992: 53).
Riti musicali popolari e devozioni “francescane” … 35
E no Missina e nuddu munasteri Maria di la Ràzia si chiama / …ama. (i) A lo Mulinu la sacrata scala / …ala chi nchiana e scinni la Matri ddivina / …ina. (i) A Pottu Sabbu lu me cori abbrama, unni rripusirà d’amma mischina! / Viva Maria!
Cchianamu di sta bbiniditta strada / …ada, nnamu unni la Veggini Maria / …ia. Maria nta lo so casa ritirata, cu so spusu Giuseppi n-cumpagnìa / …ia. Maria nte ruvetti fu llasciata / …ata, lu principi a Scaletta la vulìa / …ia. Maria chi ddi lu celu fu ccalata Risposta desi a tutti quantu sia! / Viva Maria! Si vvoi sapiri quantu Cristu t’ama / …ama, dî celu scinni n-terra ogni mmatina / …ina. Poi si menti nta na pìccula rrama mmi mmustra la so putènzia ddivina / …ina. Amara cu di Cristu s’alluntana / …ana, chi ffa nna vita pòvira e mmischina / …ina Si vvoi fari la liggi cristiana tâ ssèntiri la missa ogni mmatina!/Viva Maria!
Fici l’atennu Ddiu quantu vosi fari / …ari, si cchiù vulìa fari cchiù facìa / …ia. Fici lu celu, la terra ie lu mari, fici la sò ddivina prufizìa / …ia. Si ddonn’all’atra lu vurrìa fari / …ari, centu e mmilli voti e lu farrìa / …ia. Na sula cosa nun putissi fari, nn’autra Matri Vèggini Maria! /Viva Maria!
Né Messina né alcun monastero si chiama Maria della Grazia. A Molino c’è la scala consacrata, dove sale e scende la Madre divina. A Porto Salvo il mio cuore smania, dove riposerà quell’anima infelice!
Salendo per questa benedetta scala, andiamo dalla Vergine Maria. Maria ch’è nella sua casa ritirata, in compagnia del suo sposo Giuseppe. Maria fu lasciata tra gli sterpi, il principe di Scaletta la voleva. Maria che fu fatta discendere dal cielo diede a tutti risposta adeguata!
Se vuoi sapere quanto Cristo t’ama, dal cielo scende in terra ogni mattina. Poi si mette su un piccolo ramo per mostrare la sua potenza divina. Amara [sorte] per chi da Cristo si allontana, perché farà una vita povera e meschina. Se vuoi osservare la legge cristiana devi andare a messa ogni mattina!
L’eterno Dio fece quel che voleva fare, se più voleva fare più faceva. Fece il cielo, la terra e il mare, fece la sua divina profezia. Se un’altra volta lo volesse fare, cento e mille volte lo farebbe. Una sola cosa non potrebbe fare, un’altra Madre Vergine Maria!
36 Sergio Bonanzinga
Esempi musicali Le trascrizioni musicali – eseguite da Santina Tomasello (ess. 1, 4) e Ales-
sandro Giordano (ess. 2, 3) con la collaborazione di S. Bonanzinga – sono state ef-fettuate ricorrendo alle normali risorse del pentagramma, opportunamente integrate dalla indicazione cronometrica della durata di ogni frase e dai seguenti segni diacri-tici: ’ (presa di fiato); x (nota a intonazione non ben determinata). La disposizione grafica di ogni trascrizione segue la struttura fraseologica. Ogni frase melodica cor-risponde a un rigo di pentagramma, senza divisione in battute per rispecchiare il ritmo tendenzialmente libero del canto.
Riti musicali popolari e devozioni “francescane” … 37
1. Novena dell’Immacolata Esecuzione: Felice Pagano (voce e violino), Domenico Santapaola (chitarra). Rilevamento: Messina, 01/12/1991. Ricerca: S. Bonanzinga e G. Giacobello. Edizione: Bonanzinga cd.1996b (brano 2).
38 Sergio Bonanzinga
2. Novena della Madonna di Pompei Esecuzione: Felice Pagano (voce e violino), Domenico Santapaola (chitarra). Rilevamento: Messina, 01/12/1991. Ricerca: S. Bonanzinga e G. Giacobello.
Riti musicali popolari e devozioni “francescane” … 39
3. Novena di san Francesco di Paola Esecuzione: Felice Pagano (voce e violino), Domenico Santapaola (chitarra).
Rilevamento: Messina, 01/12/1991. Ricerca: S. Bonanzinga e G. Giacobello.
40 Sergio Bonanzinga
4. Orazione dell’Immacolata Esecuzione: voce maschile e coro dei fedeli in chiesa.
Rilevamento: Messina (Giampilieri Superiore), 29/11/1974. Ricerca: S. Bottari.
Riti musicali popolari e devozioni “francescane” … 41
Riferimenti
d. = edizione in disco 33/30
cd. = edizione in compact disc
AA.VV.
1995 Madonne e Sante di Sicilia, Istitituto di Storia antica, Università degli Studi di Palermo.
Bonanzinga, Sergio
cd.1995 (a cura di), Documenti sonori dell’Archivio Etnomusicale Siciliano. Il ciclo della vita, colla-
borazione di R. Perricone, con libretto allegato, Centro per le Iniziative Musicali in Sicilia, Palermo.
cd.1996 (a cura di), Documenti sonori dell’Archivio Etnomusicale Siciliano. Il ciclo dell’anno, col-
laborazione di R. Perricone, con libretto allegato, Centro per le Iniziative Musicali in Sicilia, Palermo.
2006 Tradizioni musicali per l’Immacolata in Sicilia, in Ciccarelli - Valenza 2006: 69-154.
Buttitta, Antonino
1960 Cantastorie in Sicilia. Premessa e testi, in “Annali del Museo Pitrè”, VIII-X (1957-59): 149-236.
1996 Dei segni e dei miti. Una introduzione alla antropologia simbolica, Sellerio, Palermo.
Cardini, Franco
1995 Il cerchio sacro dell’anno. Il libro delle Feste, Il Cerchio, Rimini.
Cattabiani, Alfredo
1988 Calendario. Le feste, i miti, le leggende e i riti dell’anno, Rusconi, Milano.
Ciccarelli, Diego
2008 San Francesco all’Immacolata di Messina, Biblioteca Francescana - Officina di Studi Medie-
vali, Palermo.
Ciccarelli, D. - Valenza, M. D.
2006 (a cura di), La Sicilia e l’Immacolata. Non solo 150 anni, Biblioteca Francescana - Officina di
Studi Medievali, Palermo.
Conti, G. - Corsi, G.
1980 Feste popolari religiose a Messina, nota introduttiva di L. M. Lombardi Satriani, Edizioni
G.B.M., Messina.
42 Sergio Bonanzinga
D’Agostino, Paolo
1985 Il Vascelluzzo di Messina tra storia, tradizioni e simboli, Tip. “La Celere”, Messina.
Foti, Giuseppe
1983 Storia, arte e tradizione nelle chiese di Messina, Grafo Editor, Messina.
1992 Storia, arte, tradizioni nelle chiese dei casali di Messina, Grafo Editor, Messina.
Garofalo, G. - Guggino, E.
d.1987 (a cura di), I cantastorie ciechi a Palermo, Albatros VPA 8491.
Guggino, Elsa
1980 I canti degli orbi. 1. I cantastorie ciechi a Palermo, Folkstudio, Palermo.
1981 I canti degli orbi. 2. I quaderni di Zu Rusulinu, Folkstudio, Palermo.
1988 I canti degli orbi. 3. I quaderni di Zu Rusulinu, Folkstudio, Palermo.
2004 I canti e la magia. Percorsi di ricerca, Sellerio, Palermo.
La Camera, Nino
1961 Novenistica popolare siciliana, Tip. S.T.E.M., Messina.
La Corte Cailler, Gaetano
1928 Antiche feste messinesi. Il “Vascelluzzo”, in “La Gazzetta” (Messina), II/135 (7 giu.): 3.
Lo Castro, N. - Sarica, M.
cd.1993 (a cura di), A cantata di li pasturi. Il Natale nella tradizione musicale della provincia di Mes-
sina (Sicilia), Taranta-SudNord-Arché TA08-SN0038.
Warner, Marina
1980 Sola fra le donne. Mito e culto di Maria Vergine [1976], con una Nota di F. Jesi, trad. it. Selle-
rio, Palermo.
Indice generale
I Premessa 1 Adriana Arena La chiesa e il convento di San Francesco a Patti 13 Sergio Bonanzinga Riti musicali popolari e devozioni “francescane” a Messina
43 Giampaolo Chillè Il patrimonio scultoreo di età moderna della chiesa di San Francesco
all’Immacolata di Messina 59 Diego Ciccarelli La visita del p. Antonio Fera vicario generale OFMConv. (1579-1580) 65 Francesco Costa Giovanni Reitano da Messina, oratore († 1693) 87 Ilenia Craparotta Un predicatore di Patti: Serafino Cavallari 91 Elvira d’Amico La Pala dell’Immacolata e santi nella chiesa di San Papino dei Padri
Riformati Francescani di Milazzo 95 Fernando Dominguez Reboiras Causa, finis et quies huius mundi: el discurso cristològico de Raimundo
Lulio en Messina 125 Antonella Doninelli Appunti per una storia delle presenze degli Spirituali a Messina 131 Nicoletta Grisanti Un trattato di medicina del protomedico Antonino Oliveri. Messina 1624
139 Stefania Lanuzza Il convento dei Cappuccini di Messina 153 Giuseppe Lipari Ad uso di… I libri di p. Antonino da San Marco 161 Salvatore Mangione San Fratello 163 Carolina Miceli Un amanuense messinese del Trecento 173 Alessandra Migliorato San Francesco stigmatizzato in due dipinti cinquecenteschi di nuova
attribuzione 181 Giovanni Molonia La Madonna degli Angeli di Antonello Gagini nella chiesa di San Francesco
d’Assisi di Messina 187 Rosario Moscheo Il commento al De Sphaera di p. Celestino de Oddis 207 Elvira Natoli Martino Montanini e la committenza francescana a Messina 213 Annunziata Maria Oteri La cultura neomedievalista a Messina nell’Ottocento e i restauri della chiesa
di S. Francesco d’Assisi
225 Giuseppe Pantano Fra Bartolomeo da Montalbano. Biografia del venerabile Bartolomeo
Buccheri, frate laico dei Minori Osservanti Riformati 249 Luca Parisoli L’attesa escatologica in Pietro di Giovanni Olivi 261 Agostina Passantino Salvato dal terremoto del 1908: un libro di “Bolle e Monacati”. Dal
Monastero di S. Barbara al Convento di S. Francesco di Messina
269 Teresa Pugliatti San Francesco Stigmatizzato di Filippo Paladini nel Museo Regionale di
Messina 273 Carmen Puglisi - Rosaria Stracuzzi I manoscritti della Biblioteca Provinciale dei Cappuccini di Messina 285 Ivana Risitano Il Viaggio del cielo di Serafino Caruso 299 Carmela M. Rugolo La fondazione del convento dei Cappuccini di Lipari 313 Daniela Santoro Intrecci di potere: aristocrazia messinese e Francescani tra XIV e XV secolo 321 Giacomo Scibona P. M. Vincenzo Federico Pogwisch, minore conventuale, archeologo 325 Elena Scrima La Biblioteca dei Cappuccini di Francavilla di Sicilia alla fine del XVI
secolo: libri e letture tra proibizioni e prescrizioni 361 Angelo Sindoni Francescanesimo, istruzione e cultura a Messina dopo la Soppressione degli
Ordini Religiosi (1866-1867) 369 Francesco Paolo Tocco Costanza di Svevia e il Francescanesimo femminile a Messina. Alle radici di
una mistificazione 383 Elisa Vermiglio La presenza francescana a Messina tra il XIV e XV secolo: lasciti, donazioni
e testamenti 401 Illustrazioni 473 Indice dei nomi e dei luoghi