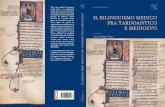Effects of habitat characteristics and sedimentation on performance of marine reserves in St. Lucia
La comunità giudaica di Santa Lucia (Messina)
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of La comunità giudaica di Santa Lucia (Messina)
3
SOMMARIO
5 La diaspora giudaica.
7 Gli Ebrei in Sicilia.
11 Gli Ebrei a Santa Lucia.
14 Motivi della presenza ebraica a Santa Lucia.
16 L’apporto della comunità giudaica luciese all’economia della Valle del Mela.
20 1492: abiurare o partire.
22 1511: abiurare o morire.
24 Sopravvivenze ebraiche a Santa Lucia del Mela.
26 Conclusioni.
28 Appendice I - Rassegna di documenti sulla presenza ebraica a Santa Lucia.
49 Appendice II - Nomi di ebrei luciesi ricavati dai documenti rintracciati.
50 Appendice III - Contrade luciesi in cui gli ebrei avevano proprietà.
51 Appendice IV - Prospetto dei notai luciesi i cui atti sono regestati nella “Giuliana Parisi”.
52 Appendice V - Santa Lucia, da casale a città. Breve excursus storico.
57 Bibliografia
4
ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI
ACP = Archivio Capitolare della Diocesi di Patti, detto “Arca Magna”
ACSL = Archivio Comunale di Santa Lucia del Mela
ASM = Archivio di Stato di Messina
ASP = Archivio di Stato di Palermo
CRS = Corporazioni Religiosi Soppresse
AMICO = V. AMICO, Notitia sexta Cappellaniae Majoris S. Luciae de Milatio, in R. PIRRI, Sicilia
sacra disquisitionibus et notitiis illustrata, Palermo 1733 (rist. Sala Bolognese 1987), pp. 1346-1352.
DI CHIARA = S. DI CHIARA, De Capella Regis Siciliae, Palermo 1815
DI GIOVANNI = G. DI GIOVANNI, L'ebraismo della Sicilia, Palermo 1748 (rist. Forni 1976).
GARUFI = C. A. GARUFI, Fatti e personaggi dell’Inquisizione in Sicilia, Palermo 1978.
Giuliana = G. PARISI, Mende in cronologia, 11 tomi manoscritti del sec. XVIII conservati nell’Archivio
Storico del Comune di Santa Lucia del Mela (La cifra romana indica il tomo, quella araba il numero che
contraddistingue il documento all’interno del singolo tomo). L’intera collezione è normalmente intesa
come “Giuliana Parisi”.
LAGUMINA = B. E G. LAGUMINA, Codice diplomatico dei giudei di Sicilia, 3 voll., Palermo 1884-
1895 (rist. 1990).
LA MANTIA = V. LA MANTIA, Origine e vicende dell’Inquisizione in Sicilia, Palermo 1977.
MILANO = A. MILANO, Storia degli ebrei in Italia, Torino 1992.
PARISI = G. PARISI, Alla ricerca di Diana Facellina. S. Lucia e il “Melan” nel mito e nella storia, S.
Lucia del Mela 1973.
RENDA = F. RENDA, Gli ebrei prima e dopo il 1492, in Italia Judaica-V. Gli ebrei in Sicilia sino
all’espulsione del 1492. Atti del V convegno internazionale, Palermo, 15-19 giugno 1992, Roma 1995,
pp. 31-54.
Ricevitoria = Tribunale del Santo Officio del Regno di Sicilia, Registri di Ricevitoria.
TRASSELLI = C. TRASSELLI, Siciliani fra Quattrocento e Cinquecento, Messina 1981.
5
LA DIASPORA GIUDAICA
1.1 - Chi sono gli Ebrei.
A sentire loro stessi, gli Ebrei sono l’unico popolo al quale Jahvè, il loro Dio, avrebbe rivolto
direttamente la Parola e con il quale avrebbe stretto un patto di Alleanza eterna. A sentire i loro
detrattori, si tratterebbe invece di un'accozzaglia di poveri pastori senza arte né parte.
Quello che è certo è che la loro presenza viene avvertita dovunque e da chiunque come qualcosa di
intrinsecamente “estraneo”, di abnorme, di incontrollabile.
Gli Ebrei compaiono nella Storia all’improvviso. Nessuno sa chi sono e da dove vengono. Li troviamo
nel XII secolo a.C. insediati in Palestina, come aggregazione di diverse tribù nomadi o seminomadi
dedite all’allevamento di greggi. Lì si creano un proprio spazio a scapito delle popolazioni già insediate.
Quel territorio lo ritengono ricevuto da Jahvè, lo chiamano “Terra Promessa” e decidono di non
staccarsene mai più.
1.2 - La diaspora giudaica.
Nel corso dei secoli, gli Ebrei hanno avuto col loro Dio un rapporto altalenante. A seconda della loro
maggiore o minore fedeltà al patto concluso da Jahvè con Abramo, il loro capostipite, essi vengono
innalzati al massimo della gloria o abbassati al massimo dell’ignominia. Per questo il popolo ebraico è
costretto, in diverse riprese, ad abbandonare la Palestina per “disperdersi” su tutta la superficie del
pianeta. È quello che si chiama la “diaspora”.
La prima deportazione documentata risale al 722-721 a.C. a seguito della conquista del Regno del Nord
da parte degli Assiri. Una seconda deportazione è legata alla distruzione di Gerusalemme nell’anno 587
a.C da parte dei Babilonesi. A cominciare dall’anno 135 d.C. la storia del popolo ebraico, rimasto senza
patria, coincide praticamente con la storia della diaspora.
1.3 – Come vivevano gli Ebrei della diaspora.
Costretti a vivere all’interno di società per loro estranee, gli Ebrei della diaspora sentono fortissimo il
vincolo di appartenenza alla propria cultura e alla fede dei padri. Essi hanno con i popoli ospitanti
rapporti di lavoro, di cultura e di commercio, ma non di culto e di matrimonio e nemmeno di mensa1. Si
aggrappano tenacemente alle proprie tradizioni religiose: riposo sacro nel giorno di sabato,
circoncisione, astinenza dalla carne di maiale, astinenza dal sangue.
Una caratteristica essenziale è quella di non mettere radici in nessun luogo. Dovunque si trovino, a
Babilonia, in Egitto, a Roma, in Spagna, gli Ebrei della diaspora hanno sempre il pensiero fisso a
Gerusalemme, la patria perduta dove sperano fermamente di tornare.
Per le popolazioni ospitanti, questi individui dai comportamenti strani ed estranei, in genere non creano
problemi. Sono bravi lavoratori agricoli, abili artigiani, avveduti mercanti, esperti nella medicina.
Rendono movimentato e attivo il mondo economico.
Così, fino al IV secolo d.C., gli Ebrei della diaspora non incontrano particolari problemi di convivenza
con le popolazioni ospitanti. La legislazione romana permette lo stanziarsi di nuclei ebraici produttivi
nelle province dell’Impero, garantendo agli israeliti la libertà di culto e il godimento dei diritti civili e
politici, con due sole limitazioni: non possono entrare nella milizia e, se hanno servi cristiani, non
possono imporre loro la conversione al giudaismo2.
1 È notorio, ad esempio, che gli Ebrei non bevono altro vino che quello prodotto da loro stessi.
2 Q. SENIGAGLIA, La condizione giuridica degli Ebrei in Sicilia, in «Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche», XLI (1906),
pp. 75-76.
6
I problemi cominciano con l’editto di Milano del 313, allorché la religione cristiana viene riconosciuta
come religione di Stato e nascono due tipici pregiudizi nei confronti del popolo ebraico: l’accusa di
deicidio e la convinzione che la dispersione nel mondo ne rappresenti il conseguente castigo3.
La situazione si aggrava a cominciare dall’XI secolo, perché da quel momento gli Ebrei vengono
considerati come un corpo estraneo nella società cristiana e vengono adottate nei loro confronti diverse
misure restrittive: obbligo di portare segni distintivi nell’abbigliamento, esclusione da determinate
attività economiche, divieto per i soggetti esercitanti la medicina di curare pazienti cristiani, ecc.. In vari
paesi gli Ebrei sono soggetti a restrizioni che li costringono praticamente a limitarsi al piccolo
artigianato e al prestito; essi sono costretti ad abitare in quartieri speciali, a pagare tributi altissimi.
Alla segregazione socio-religiosa si accompagna quella psicologica: gli Ebrei vengono fatti oggetto di
vendette popolari (spesso fomentate dai predicatori sacri), di accuse infamanti, di persecuzioni. Nei loro
confronti si levano accuse di delitti rituali, quando non vengono accusati di diffondere la peste. Il nome
stesso di “Giudeo” richiama immediatamente alla memoria la figura di Giuda, il traditore per
antonomasia, per cui viene spontaneo abbinare alla gente giudaica la qualifica di “perfida”.
Fino all’introduzione del “Novus Ordo Missae” (3 aprile 1969), la stessa Chiesa Cattolica faceva
recitare ai propri fedeli, la sera del Venerdì Santo, la seguente preghiera: Preghiamo anche per i perfidi
Giudei, affinché Dio, nostro Signore, tolga il velo dai loro cuori ed essi riconoscano Gesù Cristo nostro
Signore4.
1.4 – Un segno distintivo per riconoscere gli Ebrei.
Questi variegati rapporti di sofferta convivenza, che talvolta sfociavano in veri e propri atti di
intolleranza, rendevano necessario determinare a prima vista chi fosse giudeo e chi non lo fosse, allo
scopo di evitare il contatto e la frequentazione con persone ritenute pericolose per la salute spirituale e
talvolta anche corporale dei cristiani.
La pratica dell’endogamia consentiva, è vero, un primo immediato riconoscimento attraverso i caratteri
somatici tipicamente semitici: statura media, mani e piedi piccoli, viso smunto, naso grosso e carnoso, la
cui punta ricade sovente più in basso delle narici, mento sfuggente, pelle bianco-bruna, capelli ondulati
ricciuti e di colore variabile dal castano al nero. Ma era un criterio troppo empirico per non dar luogo ad
errori.
Altro importante segno di individuazione e di differenziazione erano le tradizioni e i riti religiosi, le cui
manifestazioni più peculiari erano, come già detto, la sospensione di ogni attività lavorativa nella
giornata del sabato, la pratica della circoncisione, l’astinenza dalla carne di maiale e l’astinenza dal
sangue. Ma si trattava in genere di pratiche che si svolgevano nell’intimità del focolare domestico e
quindi di scarsa visibilità.
Solo l’abbigliamento esterno poteva offrire un modo valido e immediato per riconoscere un ebreo. Fino
a quando i giudei portarono il taled non ci fu bisogno di segni distintivi particolari. Ma quando essi
cominciarono ad abbandonare il loro abbigliamento caratteristico, le autorità cristiane, a cominciare dal
IV Concilio Lateranense (1215), ritennero opportuno obbligarli a indossare abiti di foggia tale da essere
facilmente distinguibili dal resto della popolazione5.
3 Tale convinzione risulta contraria alla tradizione biblica, che ritiene la diaspora voluta da Jahvé per diffondere il
proprio culto presso gli altri popoli (“Egli vi ha disperso in mezzo alle genti per proclamare la sua grandezza”, Tobia
13, 3-4. Il libro di Tobia non è ritenuto canonico dai Giudei). 4 Testo latino: Oremus et pro perfidis Judaeis, ut Deus et Dominus noster auferat velamen de cordibus eorum, et ipsi
agnoscant Jesum Christum Dominum nostrum .
5 Cesare Colafemmina sostiene che lo scopo principale del provvedimento fu quello di evitare rapporti carnali fra giudei e
donne cristiane (C. COLAFEMMINA, Donne, ebrei e cristiani, in «Quaderni medievali», n. 8, dicembre 1979, pp. 118-119), ma
appare chiaro che la normativa aveva una portata di carattere più generale.
7
GLI EBREI IN SICILIA
2.1 – Gli Ebrei in Sicilia.
Quando gli ebrei abbiano messo piede in Sicilia per la prima volta non si sa6. Non è da escludere che la
prima immigrazione di gruppi più o meno considerevoli di Ebrei in Sicilia risalga agli anni della
distruzione del Tempio e degli inizi della diaspora7.
Della presenza di un nucleo di Ebrei a Siracusa si ha notizia attraverso il racconto, giudicato apocrifo
dalla maggior parte degli studiosi, della vita e del martirio di S. Marciano, vescovo di quella città nel I
secolo, ucciso, secondo la tradizione, per l’appunto dai Giudei8. Di Ebrei presenti nelle città di Messina,
Catania, Palermo e Agrigento nel VI secolo fa cenno S. Gregorio Magno nelle sue “Epistole”9.
Durante la dominazione araba, la situazione degli Ebrei siciliani migliorò. Essi si svilupparono a tal
punto che si diffusero anche nei villaggi e per conformarsi alle usanze dei dominatori arrivarono a
chiamare “moschee” o “meschite” le loro sinagoghe. La loro presenza è attestata altresì sotto i
Normanni, gli Svevi, gli Angioini e gli Aragonesi. Attilio Milano sostiene che “la Sicilia normanna era
divenuta la regione di tutta Italia di maggior concentramento degli Ebrei e forse era anche quella dove
questi Ebrei godevano delle migliori condizioni di vita”10.
2.2. – Condizioni giuridiche degli Ebrei in Sicilia.
La situazione giuridica degli Ebrei in Sicilia non fu sempre la stessa11. Al tempo di Gregorio Magno
sembra che i più fossero “coloni” e che pagassero un canone alla Chiesa. Sotto la dominazione saracena,
gli ebrei, al pari dei cristiani, erano soggetti al pagamento di un tributo particolare (la gesìa) in cambio
della libertà di culto. Questa speciale forma di tassazione li accompagnerà per tutto il periodo della loro
permanenza in terra siciliana. Sotto gli svevi e gli aragonesi li troviamo inquadrati nella condizione
giuridica di “servi della regia camera” o “della camera reginale”. Essi erano quindi “cosa” del re o della
regina. Come tali godevano della protezione del sovrano, ma dovevano al tempo stesso soddisfarne le
richieste, in primo luogo quelle di denaro12. In ogni tempo, comunque, gli ebrei godettero in Sicilia della
possibilità di professare la propria religione, di svolgere attività produttive e di avere possedimenti
stabili. Per questo la Sicilia fu per loro una terra privilegiata, vigendo in essa disposizioni meno rigorose
che altrove. Nell’ambito della vita amministrativa delle singole località siciliane, le comunità giudaiche
costituivano delle “università” a sé stanti, alla cui guida venivano posti dei rappresentanti liberamente
eletti, chiamati “Prothi”.
6 Sugli insediamenti ebraici in Sicilia in epoca classica, v. C. GEBBIA, Comunità ebraiche nella Sicilia imperiale e tardo
antica, in «Archivio storico per la Sicilia Orientale», LXXV (1979), pp. 241-275. 7 RENDA, p. 34.
8 DI GIOVANNI, pp. 6-7 e 277-278. Sull’autenticità del racconto agiografico, v. C. GEBBIA, op. cit., pp. 245-246.
9 DI GIOVANNI, pp. 8-16. Cfr. in particolare S. BOESCH GAJANO, Per una storia degli Ebrei in Occidente tra Antichità e
Medioevo. La testimonianza di Gregorio Magno, in «Quaderni Medievali», n. 8 (dicembre 1979), pp. 12-43. 10
MILANO, p. 94 11
Per uno sguardo d’insieme, v. Q. SENIGAGLIA, La condizione giuridica degli ebrei in Sicilia, in «Rivista Italiana per le
Scienze Giuridiche», XLI (1906), pp. 75-102 e, più recentemente, G. MODICA SCALA, Le comunità ebraiche nella contea di
Modica, Modica 1978, pp. 43-59. 12
Sulla portata di questa singolare condizione giuridica in Sicilia, si veda in particolare F. RENDA, La fine del giudaismo
siciliano, Palermo 1993, pp. 42-77.
8
2.3 – I quartieri ebraici: separazione e convivenza.
La differenza di cultura e di stile di vita rispetto alla società ospitante portava naturalmente gli Ebrei a
raggrupparsi tra di loro e ad isolarsi dal resto della popolazione. Si crearono così, in ogni località dove si
registravano presenze ebraiche, quartieri caratterizzati da una preponderante popolazione giudaica e
dalla presenza di particolari strutture quali la sinagoga (che fungeva anche da scuola), il macello
(distinto da quello cristiano) o il bagno delle donne. Proprio per questa sua caratterizzazione il quartiere
assumeva ovunque la denominazione di “giudaica” o “giudeca”13. Ma le “giudaiche” non erano ghetti.
Bisogna scacciare via dalla mente l’idea che fra la comunità cristiana e quella giudaica esistesse una
muraglia fisica. La barriera fra le due comunità era costituita unicamente da un diaframma rituale e
religioso. All’interno della quartiere giudaico non era infrequente trovare abitazioni, negozi e persino
luoghi di culto destinati ai cristiani14.
La comunità ebraica era, a tutti gli effetti, una città dentro la città, con propri “capitoli”, propri
“privilegi” e proprie magistrature.
2.4 - Rapporti tra Ebrei e Cristiani in Sicilia.
I rapporti tra Ebrei e Cristiani in Sicilia sono stati in genere improntati ad una reciproca diffidenza. Per
questo motivo era proibito ai giudei di testimoniare contro i cristiani, di giudicare i cristiani, di
esercitare la professione medica nei confronti dei cristiani (almeno fino al 1450), di tenere schiavi
cristiani.
Nella città di Marsala, per le feste di Natale e S. Stefano protomartire, gli Ebrei erano costretti ad andare
nella chiesa dei cristiani ad ascoltare la predica dell’oratore e all’uscita erano fatti bersaglio di pietre che
da ogni parte venivano lanciate contro di loro, allo scopo di controbilanciare quello che i loro ascendenti
avevano fatto a S. Stefano lapidandolo15. La consuetudine fu ufficialmente abrogata nel 1399 dal re
Martino I, ma il provvedimento dovette essere reiterato nel 1403 e nel 1405 a causa della radicata
ostilità antiebraica dei cristiani.
Episodi di forti frizioni si verificarono anche a Messina. Secondo una tradizione riportata dal Samperi16
e dal Gallo17, la sera del Venerdì Santo del 1347 un bambino cristiano venne catturato dagli Ebrei,
seviziato, crocifisso e gettato in un pozzo. Ma, prodigiosamente, il sangue del bambino traboccò dal
pozzo fino a scorrere per le vie. I responsabili del delitto vennero quindi uccisi a loro volta e le loro teste
furono esposte sul luogo del misfatto. Una lapide, tuttora murata sulla facciata del Duomo (anche se
ormai resa quasi illeggibile), ricorda il tragico avvenimento.
Ancora oggi la parola “ebreo” assume nella cultura siciliana una connotazione fortemente negativa e
viene pronunciata con un tono di disprezzo, caricandosi di significati aggiuntivi, come “strozzino”,
“nemico della religione” e simili18. Nelle sacre rappresentazioni della Settimana Santa, molto diffuse in
Sicilia, un ruolo importante lo svolgono i “giudei”, presentati come crudeli nemici di Cristo, degni del
più profondo disprezzo. Si aggiunga che nel dialetto siciliano, per dire “una persona” si dice “un
cristianu”, essendo fortemente radicata nell’inconscio collettivo la convinzione che gli appartenenti alle
altre religioni (giudei compresi) non meritino l’appellativo di persona.
Secondo l’insegnamento di S. Agostino, gli Ebrei dovevano essere considerati dai cristiani come i
testimoni della verità, una prova evidente che i testi biblici non sono stati alterati, ma al tempo stesso
erano meritevoli di punizione per essersi macchiati della colpa di deicidio19. Questa teoria, ripresa da
13
Il termine “Giudaica”, oltre ad indicare il quartiere abitato in prevalenza da ebrei, assumeva anche il significato di
“comunità ebraica di un determinato luogo” (in questo senso era sinonimo di “universitas judaeorum”). 14
Come scrive Titta Lo Jacono, “In Sicilia una vera e propria segregazione non fu mai imposta regolarmente tra ebrei e
cristiani” (T. LO JACONO, Le stanze di Isacco, Salemi 1992, p. 93). 15
F. LIONTI, Gli ebrei e la festa di S. Stefano Protomartire, in «Archivio Storico Siciliano», N.S., VIII (1883), pp. 463-482. 16
P. SAMPERI, Iconologia della gloriosa Vergine Madre di Dio Maria Protettrice di Messina, Messina 1644 (rist. anast.
Messina 1991), pp. 469-470. 17
C.D. GALLO-G. OLIVA, Gli annali della città di Messina, tomo II, Messina 1758 (rist. anast. Forni 1980), pp. 203-204. 18
Mi è stato segnalato che dalle parti di Caccamo il geco, animale aborrito, viene chiamato “iudìa” (giudeo). 19
RENDA, p. 41.
9
Pascal, è ancora oggi circolante. Recentemente è stata riproposta dallo scrittore Vittorio Messori20. Per i
cristiani, dunque, gli Ebrei hanno sempre costituito una sorta di male necessario, da aborrire per un
verso, da salvaguardare per l’altro.
Un aspetto che non è assolutamente da trascurare quando si esaminano i rapporti fra giudei e cristiani in
Sicilia, è la differenza di cultura fra le due comunità. Titta Lo Jacono ha recentemente sottolineato come
la dimestichezza con i libri sacri e lo studio assiduo della legge mosaica dessero agli Ebrei un bagaglio
culturale che non era possibile riscontrare nella popolazione cristiana21. Tra i cristiani, infatti,
l’alfabetizzazione raggiunge soltanto gli ecclesiastici e pochissimi altri privilegiati, mentre la gente
comune si guarda bene dal toccare i libri sacri, accontentandosi di ricevere i rudimenti della fede dalla
viva voce dei predicatori22.
Il basso livello culturale della componente cristiana del milazzese nel XV secolo è documentato da
alcune pergamene. Proprio a Santa Lucia, per fare un esempio, nel 1454, uno dei due giudici preposti ai
contratti, un certo Lanza Russu, non sapendo scrivere, appone la propria sottoscrizione per mano del
presbitero Giovanni Cancilleri23. Lo stesso accade nella vicina Milazzo, dove nel 1453, i due giudici
sono entrambi analfabeti24.
Il livello di istruzione più elevato consentiva, ovviamente, agli Ebrei anche una maggiore capacità e
destrezza in campo economico e una maggiore intraprendenza nel settore delle attività autonome.
2.5. – Un segno distintivo per riconoscere gli Ebrei siciliani.
Nel grande crogiuolo di razze che è stato in ogni tempo il territorio siciliano, diventava ancora più
difficile riconoscere le persone di etnia ebraica dagli altri abitanti dell’isola, senza adottare particolari
accorgimenti.
Disposizioni a questo riguardo vennero emanate, pertanto, da Federico di Svevia (1221), da Federico III
d’Aragona (1366), dal re Martino I (1395) e da altri sovrani siciliani.
Agli Ebrei venne imposto in un primo momento l’uso di un abito particolare e successivamente
l’esposizione sull’abito di un segno distintivo (la “rotella rossa”), in maniera che chiunque, incontrando
un ebreo, lo riconoscesse per tale a prima vista.
2.6. – L’espulsione degli Ebrei dalla Sicilia.
Nel 1412, in seguito al Concilio di Caspe, la Sicilia cessò di essere un regno autonomo e diventò una
dipendenza della Spagna. Da quel momento la storia siciliana cammina di pari passo con quella
spagnola. A reggere le sorti dell’isola sarà chiamato un vicerè, fedele esecutore degli ordini che vengono
dalla lontana penisola iberica. Questa situazione trascinò la Sicilia nei grandi conflitti europei e portò sul
nostro suolo provvedimenti che nulla avevano da spartire con gli interessi dei Siciliani.
Due di questi provvedimenti interessarono in particolare gli Ebrei residenti nell’isola: l’espulsione
generale dalla Spagna e dai territori ad essa soggetti e il Tribunale della Santa Inquisizione.
Il 31 marzo 1492, dietro suggerimento del proprio confessore, il crudelissimo ed onnipotente
Torquemada (o Torrecremata), Inquisitore Generale del Tribunale dell’Inquisizione, il re Ferdinando,
seguendo l’esempio di Luigi XI che nel 1481 aveva cacciato gli Ebrei dalla Provenza testè occupata,
20
V. MESSORI, Ipotesi su Gesù, Torino 1976, pp. 83 e 86. L’autore considera la presenza degli Ebrei, che nei secoli hanno
sempre conservato gelosamente l’integrità della loro Scrittura, una inoppugnabile garanzia che ci troviamo di fronte a testi
sicuramente non manipolati 21
T. LO JACONO, Judaica Salem, Palermo 1990, p. 40-41. 22
La pratica impossibilità di accedere alla lettura del Libri Sacri da parte dei fedeli fu una delle tante accuse mosse alla Chiesa
di Roma da Martino Lutero (1483-1546), che provvide personalmente a tradurre la Bibbia in lingua volgare per renderla
accessibile a tutti. 23
ASP, Tabulario del Monastero di S. Maria Maddalena in Valle Giosafat e di S. Placido Calonerò di Messina, perg. 1040, 10
luglio 1454: “+ Ego magister lanza russu Judex terre sancte lucie scribere nesciens manu presbiteri Johannis Cancilleri me
subscribi feci et testor”. 24
Ibidem, perg. 1034, 25 agosto 1453.
10
decretò l’espulsione degli Ebrei di qualunque rango e di qualunque età25 da tutti i suoi domini, Sicilia
compresa. Il Vicerè di Sicilia, Ferdinando de Acugna, il 28 maggio, per evitare massacri, pose gli Ebrei
sotto la protezione regia. Il bando di espulsione venne pubblicato nell’Isola il 18 giugno dello stesso
anno.
Molte voci si levarono contro il provvedimento. Una rappresentanza delle cariche più importanti scrisse
direttamente al re per esprimere il proprio dissenso26. Dopo diverse dilazioni, il termine ultimo per la
partenza degli Ebrei venne fissato al 12 gennaio 1493, ma già prima del 31 dicembre l’operazione era
stata condotta a termine.
Secondo qualche studioso, l’abbandono della Sicilia da parte degli Ebrei fu totale e definitivo, tanto che
nessun nucleo ebraico si sarebbe più insediato nell’isola27. In realtà sembra poco probabile che vi sia
stato un esodo totale, dato che sicuramente alcuni preferirono approfittare della possibilità di restare
inseriti nel contesto cittadino attraverso la conversione, vera o fittizia che fosse. Spuntano così i
cosiddetti “neòfiti”. Trasselli esprime l’impressione che “i poveri siano partiti ed i ricchi siano
rimasti”28. Anzi egli ritiene “possibile dimostrare che non solo molti Ebrei si erano convertiti per restare,
ma che molti di quelli che erano partiti in un primo momento, rientrarono come cristiani e cominciarono
a recuperare i vecchi crediti”29.
Possiamo anticipare che a Santa Lucia accadde di più. Vedremo, infatti, che qualcuno rientrò
conservando addirittura la qualifica di “giudeo” e poté riacquistare le proprietà che era stato costretto a
vendere al momento dell’espulsione.
2.7 - L’Inquisizione in Sicilia.
Forse non tutti sanno che la Storia registra due tipi di Inquisizione. Vi fu, infatti, una ordinaria
inquisizione sulle eresie, affidata ai vescovi delle singole diocesi. Questa fu la cosiddetta “Inquisizione
Romana”, voluta dal Concilio Lateranense IV (1215) e inserita nel piano della legislazione universale
della Chiesa. Il compito di istruire i processi per i giudizi di eresia venne affidato inizialmente (1235) ai
domenicani dell’Ordine dei Predicatori, particolarmente preparati in filosofia e teologia, e
successivamente (1246) anche ai Francescani dell'Ordine dei Frati Minori o Mendicanti. Questa fu
l’Inquisizione operante in Sicilia fino a tutto il XV secolo.
Altra cosa è la “Inquisizione Spagnola”, con tutto il suo poderoso apparato di tribunali, ufficiali e
delatori. Creata da Sisto IV nel 1480, su sollecitazione dei sovrani di Spagna Ferdinando il Cattolico e
Isabella di Castiglia, essa aveva lo scopo di combattere i “marrani” (ebrei spagnoli che fingevano di
convertirsi al cristianesimo) e i “moriscos” (musulmani convertiti, ma sospettati di insincerità). Questa
forma inquisitoria più drastica mette piede in Sicilia nell’anno 1500, ma fino al 1510 rimane
praticamente inattiva30. La reale attività processuale inizia nell’anno 1511. Il Tribunale del Santo Officio
di Sicilia si pone al di sopra di qualsiasi autorità isolana, sia essa civile o religiosa, e risponde
direttamente all’Inquisitore Generale, in prima istanza, e al Re, in seconda istanza. Esso toglie di fatto
ogni potere inquisitorio sugli eretici agli ordinari diocesani e si sostituisce ad essi.
I metodi inumani e la mania persecutoria messi in atto dal Santo Officio suscitano orrore ancora oggi, a
cinque secoli di distanza. Le condanne (in genere alla morte sul rogo) venivano pronunciate dal
Tribunale dell’Inquisizione, ma venivano eseguite dalla magistratura civile (il cosiddetto “braccio
secolare”), alla quale il condannato veniva consegnato o, come si diceva allora, “rilasciato” per
l’esecuzione della sentenza.
25
“judios y judias, grandes y pequenyos” recita il testo dell’editto reale (cfr. F. RENDA, La fine del giudaismo siciliano, cit., p.
174). 26
Il documento è pubblicato in I. LA LUMIA, Gli Ebrei siciliani, Palermo 1984, pp. 59-62. 27
MILANO, p. 221 28
TRASSELLI, p. 151. 29
Ibidem, p. 153. 30
Sulla distribuzione cronologica dell’attività dell’Inquisizione in Sicilia, v. in particolare F. RENDA, La fine del giudaismo
siciliano, cit., p. 151.
11
GLI EBREI A SANTA LUCIA
3.1. – La presenza ebraica a Santa Lucia.
Santa Lucia31 è uno dei 52 Comuni siciliani che hanno ospitato in passato comunità giudaiche. Lo
attestano in maniera incontrovertibile i documenti della Regia Cancelleria e del Protonotaro del Regno,
rintracciati dal canonico Giovanni Di Giovanni32 e pubblicati in parte dai fratelli Lagumina33.
L’antico territorio di Santa Lucia aveva una vastissima estensione che andava dal torrente Muto fino ai
confini di Pozzo di Gotto, al di là del fiume detto appunto di Santa Lucia (oggi Mela), e dalla costa
tirrenica allo spartiacque dei Peloritani, inglobando il territorio degli attuali Comuni di Pace del Mela
(autonomo dal 14.7.1926), S. Filippo del Mela (autonomo dall’1.1.1852), Merì (staccatosi agli inizi del
Seicento) e Santa Lucia del Mela.
Quando li incontriamo per la prima volta, nel 141534, gli Ebrei luciesi costituiscono già una comunità (o,
come si diceva allora, “università”) consistente ed attiva. In quell’anno, infatti, il Vicerè (che era
l’infante Giovanni, figlio di Ferdinando I) ordina agli Ebrei di Santa Lucia di prestare alla Regia Corte
la grossa somma di 15 onze d’oro35 (stesso importo al quale venne assoggettata la giudaica di
Castroreale).
Nel 1428, la comunità giudaica di Santa Lucia offre al nuovo sovrano, Alfonso il Magnanimo, due
donativi, ottenendo in cambio la conferma dei privilegi goduti nel passato36.
Quasi sessant’anni dopo, nel 1486, gli Ebrei di Santa Lucia inviano una petizione per potere ampliare la
loro sinagoga. Il permesso viene loro accordato il 22 febbraio dello stesso anno dal vicerè Gaspare de
Spes, a condizione che vengano rispettati i limiti fissati precedentemente da Alfonso il Magnanimo37.
Sull’epoca e sulle circostanze dell’arrivo degli Ebrei a Santa Lucia non possediamo assolutamente
alcuna notizia. Né esiste alcun appiglio per azzardare ipotesi.
Quanti erano gli Ebrei residenti a Santa Lucia? Anche questa è una notizia che ci sfugge. Vari studiosi si
sono sforzati di calcolare la popolazione delle singole giudaiche siciliane. Gli studi più accreditati sono
quelli di Carmelo Trasselli38 e G. Modica Scala39. Da ultimo vi si è dedicato, con nuove e convincenti
argomentazioni, Francesco Renda, il quale ha calcolato per Santa Lucia una presenza, nel 1492, di 51
nuclei familiari, con 287 membri40. In occasione del censimento più ravvicinato, quello del 1505,
31
La specificazione “del Mela” è stata aggiunta soltanto nel 1863 (R. D. 26.3.1863, n. 1218). Ritengo opportuno, quindi,
utilizzare la denominazione qual era al tempo della presenza ebraica (XIV-XVI sec.). 32
DI GIOVANNI, pp. 378-379. 33
LAGUMINA, Parte I, vol. I, pp. 327-328, n. CCLX; pp. 399-400, n. CCCXXVI; pp. 425-426, n. CCCXLIV; pp. 436-437,
n. CCCLI; Parte I, vol. II, pp. 383-384, n. DCCXIX. 34
Una labile traccia di una presenza giudaica nel territorio di Santa Lucia nel sec. XII è rappresentata dalla citazione, in un
privilegio dell’ottobre 1188, di un certo Maymone Lardo, che possedeva una vigna proprio lungo la linea di confine del casale (ACP, Fondazione, I, f. 208; ACSL, II D 5 (Primo volume della scrittura presentata dalli possessori di S. Filippo contro
l'Abbate Vaccarino per la vigesima), ff. 3-8; K. A. KEHR, Die Urkunden der normannisch-sicilischen Könige, Innsbruck
1902, pp. 456-457; M. SCHIAVO, Memorie per servire alla storia letteraria della Sicilia, vol. I, Palermo 1756, pp. 147 sgg. 35
V. Appendice I, doc. 1. Non è affatto sorprendente che la Corte facesse ricorso al prestito di denaro da parte di privati. È
notorio, infatti, che la corte aragonese era ridotta in povertà, tanto che nel 1479 mancava addirittura il denaro per provvedere
ai funerali del re Giovanni (G. E. DI BLASI, Storia cronologica de’ Vicerè, Luogotenenti e Presidenti del Regno di Sicilia, rist.
Palermo 1974-75, I, p. 276). E’ difficile fare un raffronto fra il valore monetario del 1415 e quello attuale. Francesco Renda
(La fine del giudaismo siciliano, cit, p. 160, nota 76) precisa che tra il 1450 e il 1512 un’onza corrispondeva al salario di 20
giornate di lavoro nei campi. Con le dovute cautele, giusto per dare un’idea approssimativa, possiamo calcolare che un’onza
del XV secolo corrispondesse all’incirca a mille euro attuali. 36
V. Appendice I, doc. 2. 37
V. Appendice I, doc. 10. 38
C. TRASSELLI, Sull'espulsione degli Ebrei dalla Sicilia, in «Università di Palermo. Annali della Facoltà di Economia e
Commercio», VIII (1954), p. 141. L’autore assegna a Santa Lucia una presenza di 30 famiglie (o “fuochi”) con un totale di
180 individui. 39
G. MODICA SCALA, Le comunità ebraiche nella contea di Modica, Modica 1978, pp. 402-411. Secondo i suoi calcoli a Santa
Lucia erano presenti 318 ebrei. 40
F. RENDA, La fine del giudaismo siciliano, cit., pp. 29-30.
12
l’intera popolazione luciese era composta da 564 nuclei familiari41. I nuclei ebraici rappresentavano
dunque a Santa Lucia il 9% della intera popolazione.
3.2 - La contrada “Giudaica”.
Come gli altri Comuni dell’isola con insediamenti ebraici, anche S. Lucia aveva il suo quartiere abitato
in prevalenza da elementi giudaici: la Giudaica, per l’appunto. Anche se la collettività attuale ne ha
perso totalmente la memoria, ci vengono in aiuto i regesti della “Giuliana Parisi”42, dove la menzione
della contrada Giudaica ( o Giudeca) di Santa Lucia compare ripetute volte43, in un arco di tempo che va
dal 1526 al 1621, all’interno di atti che riguardano la compravendita o la concessione enfiteutica di
fabbricati (case e magazzini).
L’esistenza di un quartiere destinato agli Ebrei potrebbe far pensare a una loro segregazione dagli altri
abitanti. La realtà fu ben diversa. La documentazione in nostro possesso ci consente di escludere con
certezza la ghettizzazione della popolazione giudaica. Anzi, il livello di convivenza consentiva la
contemporanea presenza nella stessa area di edifici ebraici e cristiani. E’ documentato, per esempio, che
nella contrada “Valli” coesistevano ed erano addirittura tra loro confinanti due botteghe dell’artigiano
ebreo Ferdinando Maijo e un ospizio del Monastero benedettino di S. Placido Calonerò di Messina44.
3.3 - La meschita.
La significativa consistenza della popolazione ebraica luciese comportava l’esigenza di soddisfare
diverse necessità, legate alla diversità di religione e di tradizioni. Occorreva in primo luogo una
sinagoga, l’edificio sacro destinato alle funzioni religiose e all’ascolto della “Torah”. Sin dal tempo
della dominazione araba, gli Ebrei siciliani avevano preso l’abitudine di chiamarla “meschita” ed è con
questo nome che troviamo indicata la sinagoga luciese nel 1486, allorché il vicerè Gaspare de Spes
concede ai proti e ai maggiorenti della Giudaica della terra di Santa Lucia la licenza di ampliare la
propria “mischita” utilizzando a tale scopo l’area di un adiacente magazzino45, analogamente a quanto
era stato concesso agli Ebrei di Marsala nel 137446. Viene comunque imposto di attenersi alle
dimensioni fissate a suo tempo da Alfonso il Magnanimo. La presenza di “maggiorenti”, oltre che di
“proti”, fra i rappresentanti della Giudaica è una ulteriore conferma che la comunità ebraica di Santa
Lucia era abbastanza numerosa e ben strutturata.
Dalla “Giuliana Parisi” apprendiamo dell’esistenza di una contrada, denominata “Moschita”, attraverso
la lettura di due atti rogati dal notaio Impò nel 152647. La citazione, nello stesso anno, di una contrada
“Moschita” e di una contrada “Giudaica” ci fa propendere per l’ipotesi che le due contrade non fossero
coincidenti e che quindi la sinagoga luciese sorgesse all’esterno del quartiere ebraico vero e proprio.
41
Ibidem, p. 40. 42
Si tratta di undici tomi manoscritti, intitolati Mende in Cronologia e conservati nell’Archivio Storico del Comune di Santa
Lucia del Mela. Essi furono compilati dal notaio Giuseppe Parisi dal 1753 al 1760 e contengono i regesti degli atti perpetui
rogati da 17 notai luciesi nel periodo 1477-1686, oltre a numerose notizie sulla storia locale. L’elenco dei notai è riportato
nell’appendice IV al presente lavoro. L’opera meriterebbe di essere pubblicata. 43
Per agevolare ulteriori ricerche, i regesti da me rintracciati sono pubblicati, in ordine cronologico, nell’appendice I al
presente lavoro. 44
Giuliana, VIII, 109. 45
ASP, Protonotaro del Regno, vol. 119 (1485-1486), f. 19; Conservatoria, vol. 70, f. 71; LAGUMINA, Parte I, vol. II, pp.
383-384, doc. DCCXIX. 46
V. il documento pubblicato in F. LIONTI, Sulla sinagoga di Marsala, in «Archivio Storico Siciliano», N.S., VIII (1883),
pp.152-155. 47
Giuliana, VIII, 1790 e 1795.
13
3.4 - Altri edifici pubblici ebraici (Il cimitero, il bagno delle donne, l’ospedale, il macello).
Secondo Attilio Milano, “quando si formava una nuova comunità, gli Ebrei chiedevano
preliminarmente due concessioni: il diritto di mantenere una casa di preghiera e un cimitero per i
morti”48. È probabile, quindi, che nel periodo della loro permanenza luciese, gli Ebrei abbiano avuto un
luogo separato, fuori le mura della città, per sotterrare i loro morti49. Così come è fortemente probabile
che esistesse un luogo destinato alla purificazione, per immersione, delle donne mestruate. Doveva
esserci parimenti un ospedale riservato alla comunità giudaica, analogamente a quanto accadeva nella
vicina Castroreale50. Infine, per potere procedere all’uccisione degli animali per sgozzamento, in
maniera da fare fluire completamente il sangue (che per gli Ebrei è tabù), s’imponeva l’esigenza di
disporre di un mattatoio apposito, che poteva essere anche all’aperto.
Di tutti di questi luoghi, tuttavia, non mi è stato possibile trovare alcuna traccia nella documentazione
reperita.
48
MILANO, p. 452. 49
Le comunità cristiane, invece, fino alla seconda metà del XIX secolo, provvedevano alla sepoltura dei loro defunti nelle
cripte ricavate sotto il pavimento delle chiese. La prolungata resistenza ad accettare i cimiteri in aperta campagna, introdotti
dalle note leggi napoleoniche, forse ha anche a che fare con una nascosta volontà di non adeguarsi ad una costumanza propria
della comunità giudaica. 50
Cfr. DI GIOVANNI, p. 374.
14
MOTIVI DELLA PRESENZA EBRAICA A SANTA LUCIA.
4.1 – Perché una comunità ebraica a Santa Lucia.
La distribuzione degli insediamenti ebraici nelle varie località della Sicilia risponde a precisi requisiti,
non sempre di facile individuazione. Secondo Attilio Milano “due sono le possibilità che l’ebreo ricerca
in ogni posto in cui intende soffermarsi: un luogo propizio dove poter seguire le proprie leggi religiose e
i propri riti, e una piazza dove poter esercitare il proprio talento commerciale”51.
Padre Giovanni Parisi52, seguito pedissequamente ed acriticamente da Renato Molinarolo53, attribuisce
la presenza giudaica a Santa Lucia al particolare stato di “Prelatura Nullius” di cui la cittadina avrebbe
goduto da tempo immemorabile. A questo proposito bisogna rilevare che l’istituzione della Prelatura di
Santa Lucia è un fatto di epoca relativamente recente, successiva alla scomparsa della comunità
ebraica54.
Ritengo, invece, che il motivo della preferenza per un sito come Santa Lucia possa essere ricercato in
due particolari circostanze: l’appartenenza di Santa Lucia al regio demanio e la sua ubicazione lungo
una grande arteria di comunicazione.
4.2 – Santa Lucia, città demaniale.
L’attuale insediamento urbano di Santa Lucia risale al 1322, anno in cui Federico II d’Aragona ordinò la
fondazione di una fortezza sul monte Maccarrone (o Mangarrone), nel quale potessero trasferirsi e
trovare all’occorrenza rifugio gli abitanti dei casali circonvicini, lontano dalle devastazioni e dalle razzie
provocate dalle soldatesche angioine e aragonesi55.
Il nuovo centro abitato nasce come “terra demaniale”, dipendente direttamente dalla Regia Corte, non
sottoposta all’autorità di alcun barone, ma dotata di un proprio autonomo ordinamento municipale56. La
nuova “Terra” viene retta, infatti, da un capitano di giustizia e da quattro giurati.
Era naturale e quasi scontato che gli Ebrei, considerati “servi della regia camera”, avessero una
particolare propensione ad insediarsi nei centri appartenenti al regio demanio57.
L’80% degli Ebrei risiedeva, infatti, nelle città regie demaniali58. D’altra parte la stessa corte viceregia
si dimostrava interessata a coltivare la presenza giudaica nei luoghi di regio demanio. Nel giugno 1426,
51
MILANO, p. 57 52
PARISI, p. 286. 53
R. MOLINAROLO, S. Lucia del Mela, in Architettura judaica in Italia. Ebraismo, sito, memoria dei luoghi, Palermo 1994, pp.
148-150. 54
Sulla Prelatura nullius di Santa Lucia del Mela v. Appendice V alla presente ricerca. 55
Uno stralcio del diploma di fondazione è stato pubblicato da padre Giovanni Parisi, che ha potuto leggerlo nel “Libro
Rosso” o “Libro del Sindaco” di Santa Lucia, oggi introvabile. Lo riporto per comodità degli studiosi: “Volentes saluti et
indemnitatibus eorum quorum et aliorum omnium nostrorum fidelium cura pervigili incessanter et indefesse sollicite
occurrere et salubriter providere quoddam Fortilitium pro conservatione earumdem rerum et facultatum, ac pro securiori
statu et habitatione nostrorum fidelium Casalis Sanctae Luciae positi in praedicto Plano Milatii et aliorum locorum et
Casalium eidem Fortilitio circumadiacentium, ac etiam vicinorum ad illud eorum transferre volentium incolatum, de novo in
quadam motta seu monte prope dictum Casale Sanctae Luciae, dicto de Maccarrone, construi nostra mandavit Serenitas et
fundari” (PARISI, p. 272, nota 8). 56
Sul particolare status delle città demaniali, cfr. F.RENDA, Introduzione a F.M. EMANUELE E GAETANI, Le città demaniali
della Sicilia, Palermo 1989, pp. 5-16. 57
La presenza di insediamenti ebraici nelle città demaniali è un fenomeno generalizzato. Delle 43 città demaniali, soltanto 10
non sono incluse dal Di Giovanni fra i centri che ospitarono comunità giudaiche, ma solo perché lo studioso taorminese non
trovò documenti che attestassero tale presenza. Rosalia La Franca (Caratteri insediativi e memoria dei luoghi ebraici di
Sicilia, in Italia Judaica V. Gli ebrei in Sicilia sino all’espulsione del 1492. Atti del V convegno internazionale, Palermo 15-
19 giugno1992, Roma 1995, p. 253) ha segnalato, infatti, tracce di insediamenti ebraici anche ad Acireale e Linguaglossa. 58
RENDA, p. 37. Le città demaniali erano in tutto 43. Eccone l’elenco secondo l’ordine del seggio occupato nel Parlamento:
1) Palermo, 2) Messina, 3) Catania, 4) Siracusa, 5) Girgenti, 6) Trapani, 7) Patti, 8) Cefalù, 9) Mazara, 10) Sciacca, 11) Noto,
15
per esempio, il viceré respinse alcune richieste dell’università cristiana di Girgenti contro gli Ebrei per
la preoccupazione che gli israeliti “abbandonerebbero le città e i luoghi di regio demanio e andrebbero
ad abitare in luoghi dei baroni” 59. E nel 1481 proprio gli Ebrei di Santa Lucia, nel chiedere il rispetto
del pagamento dei donativi nella tradizionale misura della trentesima parte di quanto dovuto dalla
“università” cristiana, facevano presente al viceré che, in caso contrario, si sarebbero visti costretti ad
abbandonare la terra demaniale dove abitavano e “cercari loro comeatu undi meglio potissiro et quisto
redunderia in danno et disconczo de quilla terra”60.
4.3 – Il sistema viario.
Non è semplice ricostruire il tracciato e le caratteristiche delle strade siciliane nei secoli XIV-XVI,
perché le notizie al riguardo sono scarse e frammentarie. Di un “dromo pubblico”, che attraversava il
territorio di Santa Lucia in contrada “Muscia”, abbiamo notizia attraverso un contratto rogato dal notaio
Domenico Impò nell’anno 152561. Da un altro atto coevo62 apprendiamo che la contrada “Muscia” si
trovava nel feudo di Paparcudi, per cui appare presumibile che il “dromo” passasse attraverso l’attuale
abitato di Soccorso (frazione di Gualtieri Sicaminò) e coincidesse, quindi, con la strada Santa Lucia-
Gualtieri, che in una relazione del 20.8.1869 viene definita “esistente da tempi immemorabili”63.
Tommaso Fazello, nelle sue De rebus siculis decades duae, pubblicate a Palermo nel 1558, nel
descrivere la regione di Val Demone e le sue città, fornisce la seguente successione, che fa pensare ad
un collegamento viario: Castroreale, Gala, Santa Lucia, Gualtari, Condro, S. Pietro di Monforte, Rocca,
Mauroianni, Venetico, Monforte, Rametta, Saponara64, S. Martino, Calvaruso, Babuso, S. Gregorio,
Gibiso, Salice, Capo Peloro65.
Nicolas de Fer, geografo del Delfino di Francia, nella sua carta intitolata “Isle et Royaume de Sicile”,
compilata nell’anno 1701, raffigura un itinerario che, partendo da Messina, segue il seguente tragitto:
Saponara, Morojanni (oggi Valdina), S. Pierre (oggi S. Pier Niceto), Santa Lucia, Furnari, Oliverio,
Tindari, Patti, ecc.66.
Il geografo Franz Johann Joseph von Reilly, nella sua “Die Sicilianische Landaschaft Val de Mone” del
1791, presenta un altro itinerario, leggermente diverso: Messina, Rometta, Santa Lucia, Milazzo, Pozzo
di Gotto, Oliverio, Patti, ecc.67.
Santa Lucia appare, quindi, sempre interessata da una via di comunicazione importantissima che collega
Messina con Palermo. Sicuramente lungo l’asse rappresentato da questa via principale si svolgevano i
movimenti legati ai traffici commerciali dell’epoca e ciò rappresenta una ulteriore ragione per spiegare
la presenza a Santa Lucia di una comunità ebraica, dedita ai traffici e allo scambio di merci di varia
natura.
12) Caltagirone, 13) Troina, 14) Termini, 15) Marsala, 16) Lentini, 17) Castrogiovanni, 18) Naro, 19) Licata, 20) Nicosia, 21)
Polizzi, 22) Taormina, 23) Piazza, 24) Calascibetta, 25) Randazzo, 26) Mineo, 27) S. Filippo d’Argirò, 28) Vizzini, 29) Monte
S. Giuliano, 30) Salemi, 31) Corleone, 32) Mistretta, 33) Augusta, 34) Aci, 35) Castronovo, 36) Sutera, 37) Castro Reale, 38)
Milazzo, 39) Santa Lucia, 40) Rometta, 41) Tortorici, 42) Linguaglossa, 43) Pozzo di Gotto. La presenza ebraica nelle città
demaniali più prossime a Santa Lucia, cioè Rometta e Milazzo, meriterebbe uno studio approfondito. Per quanto riguarda
Milazzo, mi limito a segnalare l’esistenza di una contrada “Giudeo” nel 1547 (Giuliana, VIII, 552 e 558) e di una contrada
“Lo Giudecco” nel 1561 (Giuliana, VIII, 1734). Lo studioso Piero Gazzara mi segnala una contrada “Giudecca” a Rometta,
dove sono tuttora molto diffusi cognomi come Isaia (o Saia) e Giordano. 59
I. PERI, Restaurazione e pacifico Stato in Sicilia (1377-1501), Bari 1988, p. 94; LAGUMINA, I, 388-90. 60
LAGUMINA, II, 302. v. Appendice I, doc. 7. 61
Così regestato dal notaio Giuseppe Parisi: “Domenico di Amico, del Casale di Galtieri, modo etc., in perpetuum vendette
all’onesto Presbitero Clemente Morina, presente, un pezzetto di terreno, in questo Territorio, contrada Muscia, confinante
col Dromo puplico ed eredi del quondam Lancellotto Morina; pel prezzo di tarì 15, che furono confessati di contanti; colla
difesa generale, come per atti sudetti sotto li 2 settembre XIV Indizione 1525 al foglio 20 di detto Registro Minuta 6”
(Giuliana, VIII,1760). 62
Giuliana, V, 36. 63
ACSL, Classificazione strade obbligatorie, 20.8.1869. 64
Dell’esistenza di un “dromo puplico” nel territorio della “terra” di Saponara abbiamo conferma attraverso un atto notarile
del 29.9.1583 (Giuliana, VII, 46). 65
T. FAZELLO, Storia di Sicilia, 2 voll., Palermo 1991,vol. I, p. 450. 66
E. IACHELLO (a cura di), L’isola a tre punte. La Sicilia dei cartografi dal XVI al XIX secolo, Catania 1999, p. 34, carta n. 32. 67
Ibidem, p. 49, carta n. 47.
16
L’APPORTO DELLA COMUNITA’ EBRAICA LUCIESE
ALL’ECONOMIA DELLA VALLE DEL MELA.
5.1 – Le attività degli Ebrei luciesi.
I pochi documenti reperiti non ci consentono di delineare un quadro completo delle attività svolte dai
componenti della comunità giudaica di Santa Lucia. La maggiore difficoltà è costituita dal fatto che
siamo in presenza di regesti e non degli atti originali completi, per cui ci sfuggono i dettagli di
disposizioni testamentarie, di donazioni, di compravendite e di permute che avrebbero potuto essere una
fonte preziosa di notizie ormai perdute per sempre.
Pur in presenza di una così scarna documentazione, riusciamo comunque a farci un’idea, anche se solo
approssimativa, dei lavori ai quali si dedicavano i figli di Abramo in terra luciese.
5.1.1. – La coltivazione della terra.
Era più che naturale che in un paese ad economia essenzialmente agricola, come Santa Lucia, buona
parte degli ebrei, al pari della popolazione cristiana, fosse occupata nell’agricoltura. D’altro canto, sin
dall’epoca imperiale, l’occupazione agricola era peculiare agli ebrei siciliani68.
Dalla documentazione rintracciata ho potuto rilevare che alcuni Ebrei, dichiarati tali dai documenti o
presunti tali in base al cognome, risultano proprietari di terreni nei feudi di S. Filippo e di Cagegi69. Fra i
beni stabili venduti dai giudei in occasione dell’espulsione generale del 1492 troviamo, infatti, alcuni
terreni “nel feudo e contrada S. Filippo”, soggetti all’obbligo della vigesima nei confronti dei
Basiliani70. Nella stessa contrada, ancora nel 1586, i coniugi Andrea e Diana Maggio (cognome
dichiaratamente ebreo) possiedono un vigneto che vendono al “maestro” Giulio Trifirò71. Ai Maggio
troviamo intestati ininterrottamente dal 1558 al 1594 alcuni terreni nelle contrade Porticelli e Pantana
all’interno del feudo di Campo, Cageggi e Paparcudi, appartenente ai Cistercensi del Monastero di S.
Maria di Roccamadore di Messina (Tremestieri). Gli atti riguardano Florio Maggio nel 1558, Clemente
e Domenico Maggio nel 1571, Giuseppe Maggio di Angelo nel 1588, 1591 e 1594, Giuseppe Maggio
fu Florio nel 159272. Sulle relative colture le fonti accennano soltanto a frumento, uliveto, gelseto ed
altri alberi. Non siamo in grado di precisare se i suddetti Maggio fossero solo proprietari (o, più
esattamente, enfiteuti) o se provvedessero direttamente anche alla coltivazione del proprio fondo.
5.1.2. – Il lavoro artigianale.
Negli atti notarili in nostro possesso, molti Ebrei insediati a Santa Lucia vengono qualificati come
“maestri”, titolo che veniva assegnato a coloro che svolgevano un’attività artigianale73. Il primo che
68
Cfr. C.GEBBIA, op. cit., p. 267. 69
Il termine “Chagegi” era presente come cognome fra gli ebrei di Trapani (cfr. C. TRASSELLI, Sull’espulsione degli ebrei
dalla Sicilia, cit., pp. 147-148). 70
Giuliana, VIII, 131. 71
Giuliana, VIII, 800. Diana Magio, sopravvissuta al marito, la incontriamo ancora nel 1605 come acquirente di mezza casa
(Giuliana, IX, 915) e nel 1638 come debitrice di un censo alla “Compagnia dei defunti” della Cattedrale (Giuliana, X, 304). 72
I regesti dei relativi documenti, tutti trascritti nell’appendice I al presente lavoro, sono nell’ordine: Giuliana, VII, nn.748,
750, 2073, 3604, 3608, 1495, 3929, 3831. 73
È fuorviante l’interpretazione di Franco Chillemi che, trattando degli ebrei di S. Marco, attribuisce al termine “maestro” il
significato odierno di insegnante e ne deduce un “buon livello intellettuale” della comunità (F. CHILLEMI, Le giudecche dei
17
incontriamo è il maestro Ferdinando Maijo, proprietario di due botteghe, vendute nel 1492 e poi
riacquistate. Su questo personaggio avremo modo di ritornare. Altri “maestri” sono Giovanni Rubini nel
1521, Florio Magio nel 1558, Pietruzzo Isaja nel 1560, Leonardo Magio nel 1606 e i figli Pasquale e
Francesco nel 1620. Per nessuno di loro, purtroppo, è possibile risalire al tipo di attività artigianale
esercitata.
5.1.3 – La bachicoltura e la produzione della seta.
Nei regesti di contratti nei quali intervengono ebrei luciesi troviamo spesso menzione di terreni coltivati
a gelseto. In alcuni casi, oggetto della compravendita sono addirittura le sole piante di gelso, estrapolate
dal terreno circostante. Acquirenti di alcune piante di gelso in contrada Casanuova sono, per esempio,
gli ebrei Salamone Capone e Bitino Maijo prima dell’espulsione74. Nel 1497 il Magnifico Giacomo
Staiti, neofita, acquista una singola pianta di gelso nella contrada Sotto Porta Valle per il prezzo di 18
tarì (qualcosa come 500 mila lire di oggi)75. Verso la fine del secolo XVI, quando di ebraico a Santa
Lucia rimane ormai soltanto qualche cognome, Croceano Isaja (cognome ebraico, nome cristiano)
compra un terreno coltivato a gelsi e canneto nella contrada Giribotta76 e un altro terreno coltivato a
gelsi e querce nel territorio di Milazzo77.
La diffusione della coltura del gelso a Santa Lucia è sicuramente da mettere in relazione con
l’allevamento del baco da seta (Bombyx mori), che si nutre esclusivamente delle foglie di quella pianta,
il cui acquisto lascia chiaramente intendere che gli acquirenti erano produttori di seta grezza. Lo stesso
Croceano, infatti, nello stesso periodo vende “tre luoghi di manganelli di seta” nella contrada
Canalicchio, con la relativa “gebbia” ed “acque pendenti”78. Il termine “manganello” non ha nulla a che
vedere con l’arma utilizzata oggi dalla polizia contro i manifestanti, ma indicava in passato uno
“strumento col quale si cava la seta da’ bozzoli”79 oppure “un attrezzo a forma di ruota attorno al quale
si avvolgeva il filato, in quantità variabile secondo la grossezza che si voleva ottenere”80. Il nostro
Croceano, dunque, lavorava la seta. Era, come si diceva allora, un “manganaro”. Della vasta produzione
di seta nel territorio di Santa Lucia troviamo testimonianza in Vito Amico, il quale afferma che nel
palazzo dell’Abate “per antica consuetudine conservansi le bilance e i pesi della seta, di cui si fa gran
traffico nella contrada”81.
5.1.4 – La concia delle pelli.
Nel 1527 un certo Giulio Pagano acquistò ad un’asta pubblica una “conzaria” (conceria) che era stata
confiscata dalla “Santissima Inquisizione” al neofita Stefano Elia82. Questo ebreo convertito esercitava
dunque il mestiere di conciatore83. Anzi, tutto ci autorizza a pensare che questa attività dovesse essere
Nebrodi tra assimilazione forzata ed espulsione, in S. BOTTARI, a cura di, Problemi e aspetti di storia dei Nebrodi, Marina di
Patti 1999, pp.65-66, nota 19). 74
Giuliana, VIII, 136. 75
Giuliana, VIII, 135. 76
Giuliana, VIII, 811. 77
Giuliana, VIII, 744. 78
Giuliana, VIII, 760. 79
A. TRAINA, Nuovo vocabolario siciliano-italiano, Palermo 1868 (rist. anast. Milano 1991, col titolo Vocabolario siciliano-
italiano), s.v. manganeddu. 80
La lavorazione della seta a Rometta, ricerca della Scuola Media “Giurba” di Rometta, in DISTRETTO SCOLASTICO 037
MILAZZO, I mestieri dell’artigianato e le botteghe dell’arte, Milazzo 1998, pp. 96-99. Analoga funzione viene attribuita al
manganello dal Pitrè (G. PITRÈ, Usi e costumi, credenze e pregiudizi del popolo siciliano, vol. III, Firenze 1944, p. 506). 81
V. AMICO, Dizionario topografico della Sicilia, tradotto dal latino e annotato da Gioacchino di Marzo, vol. I, Palermo 1855,
p. 626. 82
Giuliana, VIII, 1824. 83
Che questa attività fosse ampiamente praticata dagli Ebrei siciliani è comprovato dalla esportazione di cuoio verso l’Egitto
(TRASSELLI, p. 136).
18
molto sviluppata a Santa Lucia, visto che (come risulta dallo stesso atto e da documenti successivi)
un’intera contrada aveva preso il nome di “Conzarie”84.
La presenza di botteghe per la concia delle pelli comporta, ovviamente, una numerosa presenza di
animali adatti alla fornitura della materia prima (vitelli, capre, capretti, equini, ovini, ecc.) e, dato che
nel periodo che ci interessa si praticava solamente la concia al vegetale, anche la presenza di piante che
fornissero il tannino, ricavato all’epoca dalle foglie e dalla corteccia del mirto o mortella85.
Forse un’indagine approfondita potrebbe dirci se nei secoli XV e XVI il territorio luciese era interessato
da questo tipo di coltura. In proposito posso solo precisare che vaste estensioni di mortella erano
presenti nel XVI secolo nel feudo della Pace, allora appartenente a Santa Lucia86. Non è improbabile,
quindi, che coltivazioni similari esistessero nel restante territorio luciese.
5.1.5 - Il commercio in genere.
Gli Ebrei sono universalmente ritenuti un popolo eminentemente dedito al commercio. L’opinione era
così diffusa e generalizzata anche in passato che, allo scopo di rivitalizzare il morente commercio, il 9
ottobre 1728 venne emesso un bando per richiamare in Sicilia quegli Ebrei che volessero rientrarvi.
Viene naturale, quindi, pensare che anche a Santa Lucia buona parte degli scambi commerciali fosse in
mano agli Ebrei. La produzione della seta grezza e delle pelli conciate comportava sicuramente un
intenso traffico di contrattazioni e di scambi sia per l’interno della Sicilia che fuori dall’Isola87. Tuttavia,
nel corso delle presenti ricerche, non mi è capitato di rintracciare alcun documento attestante attività
commerciali. L’unico appiglio potrebbe essere costituito dalle due “botteghe” vendute e poi riacquistate
da Ferdinando Maijo, ma la qualifica di “maestro” che lo contraddistingue ci induce a ritenere che si
trattasse di botteghe artigiane.
5.1.6. - Il commercio di denaro.
Nel 1481 i responsabili della Giudaica di Santa Lucia dichiaravano che la maggior parte degli Ebrei
luciesi erano “poverissimi”88. Si tratta probabilmente della solita esagerazione di chi vuole sottrarsi ad
una odiosa imposizione fiscale, ma la realtà non doveva essere comunque molto diversa da quella
dichiarata, anche se sappiamo con certezza che all’interno della comunità ebraica c’erano alcuni
facoltosi. A costoro i giurati luciesi, nel 1490, avrebbero voluto fare anticipare la somma dovuta dalla
comunità cristiana, ma il viceré intervenne per impedire un tale sopruso89.
Si è sempre voluto affibbiare agli Ebrei la brutta nomea di usurai. Tuttavia, come precisa Attilio Milano,
“a metà del Duecento, Tommaso d’Aquino teneva a porre in evidenza che gli Ebrei italiani,
diversamente da quanto avveniva in altri paesi, traevano il loro sostentamento dal lavoro e non dal
prestito”90. CarmeloTrasselli ha trovato addirittura casi di Ebrei che erano debitori nei confronti di
cristiani91.
84
La contrada “Conzarie” o “Li Conzarj” viene citata ancora in un atto del 4.3.1629, nel quale è precisato che essa confina, tra
l’altro, con “fiume pubblico ed acquidotto del molino”, (Giuliana, V, 640, notaio Cirino). 85
Sull’uso della mortella nella conciatura, v. C. FILANGERI, Mirto, la storia, in COMUNE DI MIRTO, Mirto: il suo patrimonio
artistico e culturale, Mirto 1988, pp. 9-13. 86
La notizia è contenuta nel resoconto di una lite fra il Monastero di S. Placido Calonerò e l’Ospedale Grande di Messina
(ASM, CRS, vol. 119, f. 507-514, Factum pro Monasterio S. Placidi litis Feudi Trisini seu della Pace). 87
È documentata l’esistenza di scambi commerciali tra Santa Lucia e la Calabria nel XV secolo. Nel 1469, per esempio, un
certo Giovanni di Salvo, di Santa Lucia di Milazzo, riceveva dal clericus Pietro Papardo due onze per acquistare alla fiera
d’agosto di Reggio un certo quantitativo di lino da commerciare a Messina e nel suo territorio (ASM, notaio Matteo
Pagliarino, F.N. 6/1, c. 277; M.G. MILITI, Vicende mercantili di Calabria in alcuni registri notarili messinesi del
Quattrocento, in: Messina e la Calabria nelle rispettive fonti documentarie dal basso medioevo all’età contemporanea. Atti
del primo colloquio calabro siculo, Reggio Calabria-Messina, 21-23 novembre 1986, Messina 1988, p. 356). Se Giovanni di
Salvo fosse ebreo non siamo in grado di precisarlo, ma Francesco Renda indica come “neofito probabile” un Andrea Salvo di
Trapani (F. RENDA, La fine del giudaismo siciliano, cit., p. 271). 88
Protonotaro del Regno, vol. 100, f. 128v; LAGUMINA, II, pp. 301-303. 89
Protonotaro del Regno, vol. 133, f. 62v; LAGUMINA, II, p. 483, doc. DCCLXXXVI (solo regesto). 90
MILANO, p. 109-110. 91
TRASSELLI, p. 142.
19
In ogni caso, per quanto riguarda gli Ebrei luciesi, da nessun documento appare che essi abbiano
esercitato attività di prestito di denaro, anche se alcuni di essi vengono indicati col titolo di “Magnifico”,
che fa pensare a una condizione economica agiata. Tali sono, per esempio, Giacomo Staiti nel 149792,
Niccolò Isaja nel 153193, Rainerio Isaja e il figlio Francesco nel 156094 e nel 156695, e la sua vedova
Giovanna nel 157096. Non siamo in grado di precisare quale attività svolgessero esattamente queste
persone. È probabile che fossero medici97.
5.2 – I tributi pagati dagli Ebrei di Santa Lucia.
Oltre alla gisìa, tassa dovuta dagli Ebrei in cambio della libertà di professare la propria religione, la
comunità giudaica andava soggetta ai donativi e alle contribuzioni che con frequenza venivano
deliberati dal Parlamento o dal sovrano per sopperire a necessità varie.
A ciò si aggiungono i tributi che si pagavano in base alle esigenze e alle consuetudini locali. Nel 1481,
in una petizione indirizzata al viceré Gaspare de Spes, gli Ebrei luciesi fanno presente di essere soggetti
a diverse “angarie” e citano ad esempio:
1) la tassa di un’onza l’anno dovuta al regio mastro cappellano per il castello;
2) “presenti” (cioè regali), di cui non è specificata né l’entità né il destinatario.
Da un’attenta lettura del documento si evince che, in generale, le tassazioni venivano fatte in capo alla
Giudaica nel suo complesso, indipendentemente dal numero dei suoi componenti, ed erano ragguagliate
alla trentesima parte di quanto veniva imposto alla comunità cristiana. Gli istanti sostengono, infatti, che
l’eventuale abbandono della terra di Santa Lucia da parte degli Ebrei più poveri tornerebbe a danno dei
giudei facoltosi, perché tutto il peso fiscale graverebbe sulle loro spalle98.
92
Giuliana, VIII, 135. Il cognome “Staiti” o “Estayti” compare tra i neofiti di Messina e Palermo (cfr. F. RENDA, La fine del
giudaismo, cit., pp. 201-274). 93
Giuliana, VIII, 1868. 94
Giuliana, VIII, 1566. 95
Giuliana, XI, 1129. 96
Giuliana, XI, 1648. 97
Francesco Renda (La fine del giudaismo siciliano, cit, p. 160) segnala il caso di Ferrando di Aragona, medico, segnalato con
l’appellativo di “magnifico”. In proposito v. anche TRASSELLI, p. 141. 98
“quisto redunderia in danno et disconczo de quilla terra et anco di alcuni Iudei chi hanno alcuna substancia chi tutto lo
carrico restiria supra loro” (Protonotaro del Regno, vol. 100, f. 128v; Lagumina, II, pp. 301-303).
20
1492 - ABIURARE O PARTIRE
6.1 – Effetti del decreto di espulsione sugli ebrei luciesi.
Dopo il 1412, anche la “Terra” di Santa Lucia, come il resto della Sicilia, costituiva un’appendice della
Spagna. Basti dire che il castello era presidiato da una guarnigione di soldati spagnoli99. Anche a Santa
Lucia si risentirono quindi gli effetti del decreto di espulsione generale emanato da Ferdinando
d’Aragona.
L’analisi dei documenti in nostro possesso fa sorgere il dubbio che fino all’ultimo momento gli Ebrei
abbiamo sperato in una revoca del provvedimento sovrano, ritenuto assurdo e insensato. Lo deduciamo
dal fatto che Salamone Capone e Bitino Maijo, avendo acquistato delle piante di gelso, non provvidero a
rivenderle, ma ne lasciarono l’usufrutto al venditore, in attesa del loro rientro100.
È difficile, forse impossibile, quantificare quanti Ebrei siano partiti, abbandonando la terra che li aveva
visti nascere e crescere, e quanti si siano piegati alla soluzione dell’abiura per restare.
Fra gli Ebrei che lasciarono Santa Lucia nel 1492, rifiutando quindi l’accomodamento della
conversione, vi furono sicuramente i predetti Salamone Capone e Bitinio Maijo. Il Capone lo ritroviamo
nel 1496 come servo di Ferdinando Maijo che, a suo nome, risolve una questione pendente con un certo
Antonino Mendolia a proposito di alcune piante di gelso acquistate prima dell’espulsione101. Lo stesso
Ferdinando Maijo fu anch’egli nel gruppo dei partiti, dopo aver venduto le sue due botteghe artigiane102.
È probabile che a lasciare il territorio luciese siano stati in parecchi, visto che la Regia Curia avvertì la
necessità di affidare la gestione dei rapporti economici e la soluzione dei problemi insorgenti a un certo
Rugerotta Pandolfo, che in un atto del 30 maggio 1496 viene definito “Commissarius ad causas
Judaeorum in Terra Sanctae Luciae”103.
6.2 - Dove sono andati gli Ebrei espulsi da Santa Lucia?
Da Santa Lucia gli Ebrei si portarono a Messina, il luogo di raccolta prima della partenza finale.
Secondo la tesi più accreditata, gli Ebrei che lasciarono la Sicilia si diressero verso l’Africa
settentrionale, la Grecia, la Turchia o, più probabilmente, verso il Regno di Napoli, lo Stato della
Chiesa e la Toscana, in attesa di eventi migliori e nutrendo magari la speranza di un possibile ritorno104.
6.3 – I neofiti del 1400, convertiti per non partire.
Chi voleva evitare l’esilio doveva compiere una scelta a prima vista semplicissima: abbracciare la
religione cristiana. Quanto questa scelta fosse, in realtà, difficile e quali conseguenze comportasse a
livello personale e sociale, è stato messo in evidenza da diversi studiosi105. Chi alla fine decideva di
compiere il grande passo e accettava il battesimo, assumeva la qualifica di “neofita”.
Fra i neofiti troviamo, nel 1497, un certo Pietruzzo Patti106 e il Magnifico Giacomo Staiti107, cognomi
acquisiti, con ogni probabilità, al momento del battesimo108. In entrambi i casi si tratta di persone
99
Nell’anno 1576 diversi soldati spagnoli furono colpiti dalla peste che si diffuse a Santa Lucia (Giuliana, XI, 2301, 2317,
2325 ed altri). 100
Giuliana, VIII, 136. 101
Giuliana, VIII, 136. 102
Giuliana, VIII, 109. 103
Giuliana, VIII, 127. 104
MILANO, p. 216; F. RENDA, La fine del giudaismo siciliano, cit., p. 118. 105
Sulle variegate implicazioni, anche psicologiche, connesse con la conversione degli Ebrei al cristianesimo, v. in particolare
F. RENDA, La fine del giudaismo siciliano, cit., pp. 128-129. 106
Giuliana, VIII, 132. Il cognome “ de Patti” compare tra i neofiti di Siracusa, Sciacca e Palermo (cfr. F. RENDA, op. cit., pp.
201-274). 107
Giuliana, VIII, 135.
21
benestanti, per cui sembra confermata l’ipotesi, avanzata da Carmelo Trasselli, che chi aveva proprietà o
godeva di una posizione sociale più elevata, in genere preferì convertirsi e rimanere per non perdere
quello che aveva.
6.4 – I rientrati dopo la cacciata.
A Santa Lucia, così come abbiamo già visto per il resto della Sicilia, la ricerca e la condanna degli
eretici fino all’anno 1500 rientrava nella competenza dell’ordinario del luogo, cioè, nel nostro caso, del
Regio Cappellano Maggiore del Regno di Sicilia, che risiedeva a Palermo ed era rappresentato in loco
da un luogotenente109, la cui maggiore preoccupazione era probabilmente quella della riscossione delle
decime sui beni prodotti nel territorio luciese. Abbiamo già rilevato, inoltre, che dal 1500 al 1510 il
Tribunale dell’Inquisizione, pur essendo già insediato nell’isola, di fatto restò inoperante.
Queste due circostanze servono a spiegare come mai a Santa Lucia, nel 1496, a quattro anni
dall’espulsione, siano presenti ancora persone che vengono ufficialmente qualificate come “giudei”.
“Giudeo” viene definito, infatti, Isacco Mazzara nel 1496110; “giudei” sono i suoi figli, Girolamo e
Romana, nel 1497111; “giudeo” è il “maestro” Ferdinando Maijo nel 1496 e addirittura nel 1510.
La vicenda di quest’ultimo personaggio è veramente emblematica. Sappiamo della sua partenza
da Santa Lucia nel 1492, perché prima di partire vendette due botteghe da lui possedute nella contrada
Valli. Ma nel 1496 lo ritroviamo a Santa Lucia, intento a chiedere la restituzione di quattro anni di
usufrutto su alcune piante di gelso a suo tempo acquistate da un altro ebreo, Salamone Capone, che
frattanto è diventato suo servo. Lo incontriamo ancora nel 1510, allorché riacquista le due botteghe che
aveva vendute al momento dell’espulsione, sborsando esattamente la stessa cifra che aveva incassato 18
anni prima112. E tutto questo non di nascosto, ma alla luce del sole, con atto pubblico rogato da notaio.
Nel 1511, però, quando l’Inquisizione Spagnola si mette all’opera seriamente e i tempi per gli Ebrei si
fanno veramente tristi, maestro Ferdinando si arrende agli eventi e chiede quel battesimo al quale non
aveva voluto piegarsi nel 1492. L’anno seguente lo troviamo, infatti, con la qualifica di “neofita”,
mentre detta le sue disposizioni testamentarie113. Unica soddisfazione per questo ebreo pertinace, quella
di conservare il nome e il cognome originari.
Da questo momento non troveremo più “giudei” a Santa Lucia. Alcuni (pochissimi) finiranno da “eroi
della fede”, arsi vivi sulla Piazza Marina di Palermo. I più accetteranno la situazione e, obliando riti e
usanze dei padri, cessato anche l’uso del segno distintivo della “rotella rossa”, annienteranno se stessi
nel grande mare della società cristiana.
108
In un atto del 7 Febbraio 1496 (Giuliana, VIII, 143) compaiono il Magnifico Egidio Staiti e il padre Andrea, ma per
nessuno dei due viene utilizzato il predicato di “giudeo” o “neofita”. 109
All’epoca dell’espulsione generale degli Ebrei, il regio Maggior Cappellano era Dalmazio di Tolosa, rappresentato a Santa
Lucia, almeno fino al 1501, dal luogotenente presbitero Leonardo Aliberto (Giuliana, VIII, 648; l’atto di nomina del
luogotenente è riportato in DI CHIARA, Series Diplomatum, pp. 89-90). Va quindi corretta la cronotassi riportata da Vito
Amico (AMICO, p. 1348v) e da Salvatore Cambria (S. CAMBRIA, La Prelatura Nullius di S. Lucia del Mela, Palermo 1962, p.
13). Il primo Cappellano Maggiore che fissò la sua residenza a Santa Lucia fu mons. Rao-Grimaldi, eletto Prelato il 15 agosto
1602 (AMICO, p. 1349v; PARISI, p. 244). Sulla situazione della giurisdizione ecclesiastica a Santa Lucia nei secoli XV e
XVI, v. appendice V alla presente ricerca. 110
Giuliana, VIII, 127. 111
Ibidem. Il cognome “Mazara” è presente fra i neofiti di Trapani, Monte S. Giuliano (= Erice) e Licata. (cfr. F. RENDA, La
fine del giudaismo siciliano, cit., pp. 201-274). 112
Giuliana, VIII, 109. È da notare che l’acquirente delle due botteghe era il prete Leonardo Aliberto, che nel 1501 era
luogotenente del Regio Maggior Cappellano e forse è da identificare col “magnifico” Leonardo de Alberto che il 7 giugno
1526, assieme a Pietro de Amico, commissionò ad Antonello Gagini la statua della Madonna della Neve (v. G. DI MARZO, I
Gagini e la scultura in Sicilia nei secoli XV e XVI, memorie storiche e documenti, Palermo 1880, vol. II, pp. 136-137; S.
CUCINOTTA, La Madonna della Neve e le sue vicende. Documenti e notizie luciesi, Messina 1926, pp. 12-13) 113
Giuliana, VIII, 686.
22
1511 - ABIURARE O MORIRE.
7.1 – L’Inquisizione a Santa Lucia.
Per estirpare la “eretica pravità” del giudaismo dai domini spagnoli, quello dell’espulsione generale fu
soltanto il primo colpo. Un altro provvedimento, ancora più drastico, lo seguì: quello dello sterminio
fisico attraverso la condanna a morte sul rogo. Il braccio attuativo di tale disegno fu rappresentato dal
Tribunale della Santa Inquisizione.
Anche Santa Lucia ebbe il suo squadrone di ufficiali e “familiari”. Possediamo l’elenco, pubblicato da
Francesco Giunta, redatto da Juan Perez de Aguilar nel 1561. Lo staff luciese era così composto:
Giulio Pagano, luogotenente di capitano;
prete Francesco Triferio114, luogotenente di ricevitore;
Giovanni Antonio Castellano, luogotenente di maestro notaro;
Girolamo Patti, depositario115.
Per quanto riguarda l’operato dell’Inquisizione, sappiamo che il Tribunale procedette alla confisca dei
beni di alcuni neofiti e alla loro vendita all’asta pubblica. Nel 1527 un certo Girolamo Ingarcia ricopriva
la carica di “Percettore della Santissima Inquisizione” e aveva l’incombenza della gestione del pubblico
incanto col sistema detto “della candela vergine”116.
7.2 – I neofiti del 1500, convertiti per non morire.
Fu ben diversa la situazione di coloro che abbandonarono la fede mosaica e abbracciarono quella
cristiana nel 1492 per potere restare in Sicilia a difendere la propria posizione e i propri interessi da
quella di coloro che si convertirono dopo il 1511, intimiditi dalla potente macchina repressiva messa in
moto dall’Inquisizione Spagnola. I primi fecero una scelta di convenienza, i secondi dovettero fare una
scelta di vita o di morte. La vicenda di Fernando/Ferdinando/Ferrante Maijo, che abbiamo già visto, è
molto eloquente.
Del “maestro” Giovanni Rubini, che compare come “neofita” in un documento del 1521117, non
sappiamo assolutamente nulla. Così come nulla sappiamo di tutti i neofiti luciesi presenti nei registri
dell’Inquisizione. Il 6 maggio 1521 vennero incriminati dall’Inquisizione e “rilasciati in statua”118 tre
neofiti di Santa Lucia: Cola Maiolino119, Desiata Santa Lucia120 e Marquesia Stagno121. Altri due neofiti
subiranno la stessa sorte il 24 agosto 1527: Fiore Galefi122 e Vito Galisi123. Sorte migliore toccò alle
114
Forse da identificare col “presbitero Francesco Trifirò” che nel 1526 acquistò una casa nella contrada Moschita (Giuliana,
VIII, 1795) e che il 7 settembre 1551 prese possesso dell’ufficio di Luogotenente di Maggior Cappellano (Giuliana, VIII,
1589). Lo stesso, al momento della visita eseguita nel 1552 dal visitatore Giacomo Arnedo, era detentore della gabella di tutti
i redditi dovuti al Cappellano Maggiore del Regno, per il corrispettivo di 46 onze e 24 tarì l’anno (DI CHIARA, Series
Diplomatum, p. 107). 115
F. GIUNTA, Dossier Inquisizione in Sicilia, Palermo 1991, p. 57. 116
Giuliana, VIII, 1824. 117
Giuliana, VIII, 1754. 118
Questa formula indicava la condanna in contumacia dell’interessato, al posto del quale veniva arso un manichino. 119
LA MANTIA, p. 178, n. 117. 120
Ibidem, p. 179, n. 132. Il cognome “Santa Lucia” compare anche tra i neofiti di Mineo e Sciacca (cfr. F. RENDA, La fine del
giudaismo siciliano, cit., pp. 201-274). 121
Ibidem, p. 196, n. 349. 122
Ibidem, p. 182, n. 160. Probabilmente la corretta lettura del cognome è “Galesi”, perché sotto questa forma ne è attestata la
presenza a Santa Lucia nei secoli XVI e XVII attraverso la “Giuliana Parisi”. Il 30 settembre 1573, per esempio, venne
celebrato il matrimonio di Vincenzo Galesi con Florella Bonanno e, contemporaneamente, quello di Niccolò Bonanno con
Laurella Galesi (Giuliana, XI, 2004 e 2005). Ancora nel 1642, incontriamo un certo Damiano Galesi, debitore di un censo di
due tarì l’anno nei confronti della chiesa di S. Nicolò (Giuliana, X, f. 236). Un “Geronimo Galifi” figura nel 1532 tra i neofiti
di Messina (cfr. F. RENDA, La fine del giudaismo siciliano, cit., p. 235-236) 123
Ibidem, p. 204, n. 447. v. anche la nota precedente. Una “Agata Galisi” figura nel 1535 tra i neofiti di Lentini (cfr. F.
RENDA, op. cit., p. 226).
23
neofite Rosa de Neapoli e Antonella Maiolino, che nell’autodafé celebrato il 12 marzo 1540 vennero
condannate al carcere perpetuo e alla confisca dei beni124. Alla sola confisca dei beni, infine, andarono
soggetti Benedicto Muleto125, Flore, moglie di Jacobo Mustaza126, e il neofita Stefano Elia, che
possedeva una bottega e una piccola casa nella contrada Conzarie e del quale abbiamo notizia soltanto
attraverso la “Giuliana Parisi”127.
124
GARUFI, p. 14. 125
ASP, Ricevitoria, registri n. 20 e 21. 126
ASP, Ricevitoria, registro n. 20. 127
Giuliana, VIII, 1824.
24
SOPRAVVIVENZE EBRAICHE A SANTA LUCIA
8.1 - Che fine hanno fatto gli edifici della comunità giudaica luciese?
Quando ci si mette alla ricerca di qualcosa, bisogna innanzitutto conoscere bene l’oggetto della ricerca.
Per cercare la sinagoga (o meschita) di Santa Lucia, bisogna sapere che cosa era una sinagoga. Per
questo è importante sgombrare innanzitutto la nostra mente dall’idea che la sinagoga sia il
corrispondente ebraico di una chiesa cristiana. Rosalia La Franca ha evidenziato in maniera magistrale
la sostanziale differenza che passava (e passa) tra i due edifici. La sinagoga non è un luogo dove si
svolgono cerimonie rituali, non c’è un altare, né un sacerdote; non è un tempio. Il tempio per gli Ebrei è
uno solo, quello di Gerusalemme. Il termine greco συναγωγή significa “riunione” e questo era
sostanzialmente una sinagoga: un luogo dove la comunità si riuniva per leggere i testi sacri, per erudire i
bambini, per amministrare la legge sacra. La sinagoga poteva, quindi, essere benissimo una casa adattata
a luogo di riunione.
E’ evidente, quindi, che risulterebbe del tutto velleitario mettersi oggi alla ricerca di un tale edificio che,
una volta cessata la pratica pubblica dei riti ebraici, sarà stata adattata ad altro uso. Analoga fine avranno
fatto sicuramente gli altri edifici di uso pubblico, come l’ospedale, il bagno femminile, il macello.
8.2 – Sopravvivenze ebraiche nell’onomastica.
Nell’affermare che al momento dell’espulsione gli Ebrei ricchi rimasero, Trasselli sostiene che alcuni
conservarono il loro cognome originario, altri lo tradussero in siciliano: Levi diventò Lu Presti (il prete);
altri presero il cognome del padrino al momento del battesimo.
I volumi delle “Giuliane” del notaio Parisi ci consentono di individuare con certezza i cognomi di
alcune famiglie ebraiche residenti a Santa Lucia. Tra essi troviamo Capone, Isaia e Saya (con diverse
varianti), Maio o Magio (con le varianti Di Maio e Di Magio), Maiolino, Mamone, Mazzara, Patti,
Staiti. Tutti questi cognomi sono ancora oggi in mezzo a noi, ma il tempo e l’adattamento alla società
dominante hanno ormai fatto perdere alle famiglie che li portano ogni reminiscenza di appartenenza
all’etnia ebraica.
La ininterrotta presenza dei Maggio a Santa Lucia è ben documentata attraverso la “Giuliana” del notaio
Giuseppe Parisi. Il 10 gennaio 1620 il “maestro” Pasquale Magio, figlio del “maestro” Leonardo,
acquista un fondo nel territorio di Milazzo, contrada Sùvaro128. Il 28 febbraio dello stesso anno, egli
consegna al genero Marco Pandolfo, la dote dovuta per la figlia Antonina129. Il 17 settembre 1621
acquista “un luogo di manganello…in contrada Lo Canalicchio”130.
Anche la presenza dei Mamone o Maimuni è attestata con continuità: Domenico Mamone nel 1549131,
Giuseppe Mamone nel 1571132, Angiolo Mamone nel 1572133, Francesco Maimuni nel 1606134,
Antonino Mamone nel 1631135.
128
Giuliana, V, 56. Il cognome compare nella forma “Mayo” o “de Mayo” fra i neofiti di Messina e di Sciacca (cfr. F. RENDA,
La fine del giudaismo siciliano, cit., pp. 201-274). 129
Giuliana, V, 63. 130
Giuliana, V, 221. 131
Giuliana, VIII, 1566. 132
Giuliana, XI, 1723. 133
Giuliana, XI, 1917. 134
Giuliana, II, 4773 135
Giuliana, IX, 2009. Un “Vincenzo Maymuni” compare nel 1513 tra i neofiti di Sciacca (cfr. F. RENDA, op.cit., p. 262).
25
8.3- La toponomastica.
Per ritrovare la contrada “Giudaica”, di cui oggi non vi è più memoria, ci basterebbe sapere dov’era il
“Vallone di Mangarunà”. Un contratto del 31 dicembre 1586 ci fornisce, infatti, questi due toponimi
come varianti della denominazione della contrada136. Purtroppo anche il Mangarunà (o Mangarrone,
secondo una versione più italianizzata) è scomparso completamente dalla memoria collettiva. Lo si
trova citato ancora in atti del 20 aprile 1610137 e del 29 agosto 1625138, ma già nel 1623 compare sotto la
forma storpiata di “Maccarrunà”139che lascia trasparire uno scarso uso del termine e prelude al suo
definitivo abbandono. Un contratto del 1611 abbina il nome “Giudaica” al toponimo “Bisterna” che non
sembra avere avuto migliore fortuna ed oggi risulta anch’esso del tutto ignoto140.
Anche del toponimo “Moschita”, che abbiamo visto attestato da due contratti rogati nel 1526 dal notaio
Domenico Impò 141, non esiste oggi alcuna traccia.
Corre voce che la sinagoga o meschita, dopo la cacciata degli Ebrei dal regno di Sicilia, sia stata
distrutta e che sulla sua area sia sorta l’attuale chiesa di S. Nicola. Tale notizia potrebbe avere qualche
fondamento, se si considera che a Palermo sui resti della “meschita” ebraica sorse la chiesa di S. Nicolò
Tolentino142. La circostanza che già nel 1308 esisteva a Santa Lucia una chiesa di S. Nicola143 non ci
impedisce di accettare come credibile la suddetta tradizione orale, considerato che, come vedremo più
avanti144, l’attuale abitato di Santa Lucia rimonta al 1322 e quindi la presente chiesa di S. Nicola è stata
sicuramente costruita in epoca successiva.
Un altro labile legame con la presenza ebraica potrebbe essere intravisto nella denominazione della
contrada “Gesita”, al confine dei tre Comuni di Santa Lucia del Mela, S. Filippo del Mela e Pace del
Mela, probabile reminiscenza della “gesìa” pagata dagli Ebrei.
136
“Contrada Giudaica, seu Vallone di Mangarunà” (Giuliana, VIII, 802); 137
Giuliana, VI, 293. 138
Giuliana, V, 335. 139
Giuliana, V, 217. 140
“contrada della Giudaica, seu Bisterna” (Giuliana, II, 4824). 141
Giuliana, VIII, 1790 e 1795. 142
F. LIONTI, Documenti relativi agli Ebrei di Sicilia, in “Archivio Storico Siciliano”, N. S., VIII (1883), p. 152, n. 1. 143
P. SELLA (a cura di), Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV. Sicilia, Città del Vaticano 1944, p. 51, n. 483 e p.
66, n. 872. 144
v. Appendice V.
26
CONCLUSIONI
9.1. – Considerazioni finali.
Il quadro d’insieme che si può ricavare dall’esame dei documenti in nostro possesso per quanto riguarda
la presenza giudaica a Santa Lucia è che, malgrado la diversità di cultura e di pratiche religiose, in
questo nostro centro collinare cristiani e giudei siano vissuti in un’atmosfera di reciproca tolleranza,
godendo delle rispettive abilità e competenze. Non si registrano, infatti, a Santa Lucia gli episodi di
intolleranza verificatisi in altri luoghi dell’isola. Il provvedimento di tutela dei giudei luciesi in
occasione della settimana santa, emesso dal viceré il 17 marzo 1490 a richiesta del loro “ambasciatore”
Iosep Alpastani145, sembra piuttosto una misura precauzionale, che la conseguenza di specifici episodi di
intolleranza. Probabilmente i responsabili della Giudaica luciese temevano che i giurati o i predicatori
quaresimali potessero fomentare una reazione popolare alla disposizione emessa 13 giorni prima dallo
stesso viceré per evitare che gli Ebrei facoltosi anticipassero le somme dovute al fisco dalla comunità
cristiana146.
Gli unici contrasti di cui abbiamo notizia sono di natura fiscale e riguardano i rapporti della “Giudaica”
con i giurati, cioè con gli amministratori civici, che nel 1481 avrebbero voluto esigere dagli Ebrei una
contribuzione doppia rispetto al passato e per questo incarcerarono i proti della comunità giudaica, ma
furono costretti a liberarli in seguito all’intervento del Viceré.
La documentazione di cui disponiamo lascia quindi intuire che anche a Santa Lucia vigessero quelle
“condizioni di tollerante pace sociale” che Titta Lo Jacono ha ben messo in risalto per la comunità di
Salemi147. Questo clima di reciproca collaborazione fra le due comunità, quella cristiana e quella
ebraica, arrecava ovviamente notevoli benefici alla vita civile complessiva e consentiva il fiorire di
scambi commerciali e di attività economiche.
Il provvedimento di espulsione degli Ebrei non sembra aver arrecato all’economia luciese quel crollo di
cui tanto si parla a livello generale siciliano. Se molti furono, infatti, gli Ebrei che abbandonarono il
territorio luciese, non furono certamente pochi quelli che rimasero, scegliendo la strada del neofitismo, o
quelli che rientrarono, approfittando della iniziale tolleranza dell’Inquisizione. E se è vero che i rimasti
in loco si trasformarono da giudei in cristiani, è anche vero che essi continuarono ad esercitare il
lavoroche svolgevano in precedenza (agricoltore, artigiano, commerciante, medico, ecc.).
Probabilmente non è esistito un marranesimo luciese. Tutto lascia intendere, infatti, che i convertiti,
volenti o nolenti, si siano in genere adeguati al loro nuovo stato, abbandonando le usanze giudaiche e
conformandosi alle usanze cristiane.
Assistiamo quindi a una progressiva cristianizzazione degli Ebrei, inizialmente costretti a una
conversione di comodo e poi, lentamente ma progressivamente, inseriti e confusi nella comunità
cristiana. Nel 1615 incontriamo un Natale Magio che è addirittura procuratore della Chiesa di S.
Michele Arcangelo148 e già alla fine del XVI secolo non sono infrequenti i matrimoni misti. Il 5 ottobre
1580, per esempio, Bartolomeo Maggio contrasse matrimonio con Natalizia Cicirello, il cui cognome
non sembra essere di origine ebraica149, e nel 1582 la magnifica Giovanna Isaja andò sposa al magnifico
Giovanni Filippo Pagano150, non ebreo.
9.2. – Giudizio sui provvedimenti di Ferdinando il Cattolico.
Dare un giudizio spassionato sul provvedimento del re Ferdinando è certamente difficile. È opportuno
comunque evidenziare che, se veramente gli Ebrei si fossero macchiati delle delitti loro imputati
dall’editto reale, la giusta punizione, secondo le norme canoniche e civili allora vigenti, sarebbe stata la
145
Protonotaro del Regno, vol. 133, f. 99; LAGUMINA, II, 492, doc. DCCXCVII. 146
Protonotaro del Regno, vol. 133, f. 62v; LAGUMINA, II, p. 483, doc. DCCLXXXVI. 147
T.LO JACONO, Judaica Salem, cit., p.31. 148
Giuliana, III, 522 e 998. 149
Giuliana,VII, 340. 150
Giuliana, VII, 3107.
27
condanna al rogo. Lo dicono, in maniera chiara, i supremi magistrati siciliani nella loro perorazione :
“Si cognoscissimo li Judey di quistu regnu essiri causa nutriri heresia ne chi per loro conversacioni si
havissi causatu ne si causassi cosa alcuna di Infidilitati supplichiriamo vostra Regal Majestà non
sulamenti si expellissiro ymmo divirisi cremari”151. L’editto di Ferdinando fu dunque, se fatto in buona
fede, un gesto di clemenza nei confronti degli Ebrei, comminando loro la semplice espulsione in luogo
della distruzione fisica dei loro corpi, dei quali il sovrano poteva disporre a suo piacimento come di cosa
di sua proprietà152.
È legittimo, a mio parere, che uno Stato o un sovrano decidano di estromettere dai propri territori
persone esterne, ritenute ( a ragione o a torto) pericolose per il benessere e la sicurezza della nazione.
Quello che non è legittimo, è costringere un individuo con la violenza, morale o fisica, ad abbandonare
la fede e le tradizioni dei propri padri per abbracciare un credo e delle usanze aborrite fino al giorno
prima.
Ferdinando non è condannabile (esprimo ancora una mia opinione) per avere decretato l’espulsione
degli Ebrei da tutti i suoi domini. La sua grande colpa è piuttosto quella di avere avviato l’operazione
della conversione forzata degli Ebrei (procedura non ammessa sin dai tempi di Gregorio Magno) e di
avere armato a tal fine il braccio della Santa Inquisizione.
151
I. LA LUMIA, Gli Ebrei siciliani, Palermo 1984, p. 60. 152
“Tucti li corpi di li judei chi in nostri regni et dominactioni stannu su nostri di li quali putemu per nostra real potencia et
suprema potestati ordinationi disponiri a nostra voluntati” (cfr. F. RENDA, La fine del giudaismo siciliano, cit., p. 173).
28
APPENDICE I
RASSEGNA DI DOCUMENTI SULLA PRESENZA GIUDAICA A SANTA LUCIA
1. Catania, 1415, 2 dicembre
L’Infante Giovanni, viceré di Sicilia, impone alla giudaica di Santa Lucia di prestare alla Regia
Corte la somma di15 onze, che sarà restituita l’anno successivo.
Regia Cancelleria, vol. 51, f. 35v; Lagumina, I, 327, nota 1.
2. Palermo, 1428, ?????
Re Alfonso ottiene due donativi dagli Ebrei luciesi. In cambio conferma i privilegi concessi in
precedenza alla loro comunità (G. Di Giovanni, p. 378)
Regia Cancelleria, anno 1428, ff. 95-96.
3. Palermo, 1436
Il Regio Tesoriere rende conto delle somme ricevute dalle giudaiche del Regno per ragione di
collette.
La giudaica di Santa Lucia paga 5 onze, la metà di quanto pagato da Castroreale.
Computo del Tesoriero, anno 1435-36; Lagumina, I, 425-426, doc. CCCXLV.
4. Palermo, 1438, 15 febbraio.
Il viceré Ruggero de Paruta manda speciali commissari ad esigere il donativo offerto dalle città e
giudaiche siciliane per la conquista del regno di Napoli.
La giudaica di Santa Lucia paga 5 onze , un terzo del donativo pagato da Castroreale.
Regia Cancelleria, vol. 73, p. 192; Lagumina, I, 436-437, doc. CCCLI..
5. Palermo, 1477, 28 luglio
I viceré Guglielmo de Peralta e Guglielmo Puiades proibiscono che in occasione dei regi donativi la
giudaica di Santa Lucia paghi più della trentesima parte della somma per cui è tassata l’università
cristiana.
Protonotaro del Regno, vol 79, f. 158. LAGUMINA, II, 216-217, doc. DCVI.
Ioannes etc.
Vicereges etc. Capitaneo Iudicibus Iuratis et locumtenenti ac ceteris officialibus et taxatoribus
contingencie regij donativi terre sancte lucie ad quos seu ad quem spectet et presentes fuerint
presentate fidelibus regijs dilectis salutem. Cum gravi querela ni e stato noviter exposto per parti di
la Iudeca et particulari Iudei di quissa terra, chi cum zo sia ab antiquissimis temporibus citra sia
stato sempri costumato taxarisi et contribuiri quissa predicta Iudeca in li contingencii di la dicta
terra di li regii collecti et soluctioni ad tari uno per omni uncia chi paga la dicta universita
appartatamenti da cristiani et supra czo alias tanto da li magnifici mastri racionali di quisto regno
comu di lo quondam Spectabili misseri Iohanni di muncaya olim vicere eiusdem regni haviri
obtenuto provisioni non divissi essiri constricta la dicta iudeca ad pagari in li dicti soluctioni
altramenti chi era stato solito et costumato ne divissi essiri constricta ipsa Iudeca ne soi particulari
Iudei ultra dicta sua contingencia ad inprentari per la rata contingenti ala universitati di li cristiani
secundo che in quilli provisioni date messane VIII octubris VIIII Indicionis victimo contenirisi haviti
vui noviter temptato in contento di li dicti provisioni taxari la dicta Iudeca in la rata di lo novo regio
donativo in plui summa di quillo chi e stato solito ut supra eciam constringiti alcuni di quilli Iudei ad
bistrairi comu facultusi ultra la dicta summa per ipsi Iudei divuta a lo pagamento di li cristiani in
loro grandi lesioni et iactura. Et pertanto humiliter ni facto supplicari non volissimo permectiri
essiri li dicti Iudei ad premissa gravati. immo providiri farili observari li dicti provisioni. Qua
29
suplicacione admissa non intendendu nui ipsa Iudeca et soi particulari Iudei divirisi taxari ultra
quillo e stato solito ne altra summa bistrayri per li cristiani chi quilla ad loro contingi havimo
provisto et per la presenti vi dicimo et comandamo expresse ad penam regalium mille regio fisco
applicandam digiati observari a la dicta Iudeca et soi particolari Iudei li soi prehemencionati
provisioni iuxta la loro continencia et preter illarum formam in aliquo non li molestari, si desiderati
non incurriri in la pena predicta. Dat. in urbe felici panormi die XXVIII Iulij X Indicionis
MCCCCLXXVII. Guillem de peralta. Guillem puiades.
Domini Vicereges mandarunt
mihi Antonio Sollima locum-
tenenti et magistro notario
in officio prothonotarij
6. Messina, 1481, 1 giugno.
Il viceré Gaspare de Spes ordina l’esazione dell’ultimo donativo offerto dal parlamento al Re.
Ai giurati di Santa Lucia per onze 19 e tarì 25; alla sua Giudaica per tarì 10.
Protonotaro del Regno, vol. 97, f. 244; Lagumina, II, 298.
7. Messina, 1481, 14 agosto.
Il viceré Gaspare de Spes ordina che per il corrente donativo la giudaica di Santa Lucia non sia
obbligata a pagare più della trentesima parte (tarì uno per onza) della rata assegnata a quella terra.
Protonotaro del Regno, vol. 100, f. 128 v; Lagumina, II, pp. 301-303.
Ferdinandus etc.
Vicerex etc. Iuratis et ceteris omnibus et singulis officialibus terre sancte lucie quibus spectet et
presentes fuerint presentate tam presentibus quam futuris fidelibus regijs dilectis salutem. Noviter ni
fu presentata una supplicacioni di lo tenuri sequenti: Illustrissime et potens domine in regno sicilie
vicerex etc. Si exponi humilimenti a vostra Illustri Signoria per parti di la Iudeca et particulari
Iudei di la terra di sancta lucia chi essendo la dicta Iudeca a longo tempore citra continuatis
temporibus in cuius contrarium non est hominis memoria stata solita pagari tantum et contribuiri
in li rati tangenti a la universitati di la dicta terra di li regij colletti sive donativi ad raxuni di tarì
uno per uncza et cossi esseri stato alias provisto per diversi viceregij provisioni et di lo officio di li
mastri racionali per li quali provisioni etiam si providi et comanda chi non siano constricti ad
bistrahiri ultra la dicta loro contingencia cum li altri facultusi christiani ma solamenti di haviri
pagari lo dicto tari per uncza como per li dicti provisioni claramenti si demonstra. Noviter li iurati
et officiali di la dicta terra li fanno novitati et molestanuli et ia hanno fatto carcerari li prothi ad
diviri pagari ad tari duy per uncza in certa rata di donativo chi de presenti paga la dicta
universitati contra la forma di li dicti provisioni chi czo sarria altro chi farili dispopulari da quilla
terra per chi la più parti di li dicti Iudei su poverissimi et non solamenti contribuixino ad tali
pagamenti ma pagano diversi altri angarij comu su unza una lo anno per lo castello de quilla terra
a lo regio mastro cappellano et presenti chi su tenuti fari: per la quali cosa humiliter recurrino et
supplicano a vostra Illustri signoria se digni non voliri permectiri li sia facta tali et tanta novitati
ma vogla providiri et comandari chi ipsa Iudeca hagia di pagari et siali observato secundo la
forma di li dicti provisioni actalchi quilli Iudei videndo esseri ben tractati et non derogati ala solita
forma di lo passato hagiano causa di perseverari et habitari in la predicta terra: altramenti per
non potiri abastari et essiri ultra debitum vexati li sarria forczato cercari loro comeatu undi meglo
potissiro et quisto redunderia in danno et disconczo de quilla terra et anco di alcuni Iudei chi
hanno alcuna substancia chi tutto lo carrico restiria supra loro: ut dominus vos conservet per
tempora longiora etc. La quali supplicacioni per nui intellecta non volendo permectiri siano ipsa
Iudeca et Iudei chi su servi di la regia camera preter debitum ac solitum vexati attisi li dicti
provisioni quilli visti et recogniti per li magnifici mastri racionali havimo eorum deliberacione
provisto et per la presenti vi dichimo et comandamo expresse digiati a la prefata Iudeca et voi
particulari Iudei observari li provisioni predicti nullatenus contra la forma de quilli ne altramenti
30
chi e stato solito per lo passato taxarili in tali et simili pagamenti molestarili ad contribuiri et pagari
oy farili altra indebita novitati ma in continenti digiati excarcerari li dicti prothi: pagando pero la
summa chi li contingi a la raxuni et taxa e stato solito ut predicitur pro preterito pagari:
guardandovi farindi ne temptari modo aliquo lo contrario per quanto haviti cara la regia gracia et
in pena di unci cento da applicari a lo regio fisco ultra li altri peni contenti in li premencionati
licteri desiderati non incurriri. Et nihilominus si raxuni alcuna pretenditi in contrarium comparendo
legitime innanti nui vi sarra provisto de iusticia. Dat. in nobili civitate messane die XIIII mensis
augusti XIIII Indictionis MCCCCLXXXI. Gaspar de Spes.
Dominus vicerex mandavit
mihi Antonio Sollima locum
tenenti et magistro notario in
officio prothonotarij et vidit
eam Iacobus bonannus magi-
ster racionalis.
8. Castrogiovanni, 1484, 26 settembre.
Il Presidente del Regno Giovanni Valguarnera sospende l’elezione degli ufficiali delle giudaiche.
Protonotaro del Regno, vol. 108, f. 181; Lagumina, II, pp. 328-329, doc. DCLXXVI.
Rex etc.
Presidentes etc. Servi regie cammere. Comandamovi expresse chi a la nova creacione di li prothi
maiurenti et altri officiali di la Iudeca di quissa terra digiati pro servicio di la Sacra regia Maestati
et universali beneficio di quissa prefata Iudeca suprasediri infini ad altro nostro expresso
comandamento: guardandovi modo aliquo farindi lo contrario per quanto haviti cara la gracia di
ipsa Maesta et a la pena di unzi centu regio fisco applicandi desiderati non incurriri. Dat. Castro
Ioannis XXVI septembris III Indictionis. Ioannes de valguarnera.
Domini Presidentes mandarunt
mihi Antonio Sollima locum-
tenenti et magistro notario in
officio prothonotarij.
9. Santa Lucia, 1485, 2 giugno
Testamento, secondo l’usanza ebraica, di Tirona Maggio, moglie di Bitinio Maggio.
Regesto: Giuliana, VIII, 622.
Tirona di Magio, di Nazione della perfidia Ebrea, seu Giudea, moglie di Bitinio, inferma a letto, fa il
di lei nuncupativo testamento, a stile Ebreo, come per atti sudetti sotto li 2 giugno III Indizione 1485,
al foglio 8 di detta Minuta unica, qual sudetto testamento vedesi co’ soliti sugelli, e poscia aperto al
solito. (Notaio Antonino Cortina).
10. Palermo, 1486, 22 febbraio.
Il vicerè Gaspare de Spes concede ai giudei di Santa Lucia di ampliare la loro meschita, attenendosi
alle dimensioni precedentemente fissate dal re Alfonso.
Originale: perduto
Copia dell’originale: ASP, Protonotaro, vol. 119 (1485-1486), f. 19; Conservatoria, vol. 70, f. 71.
Pubblicazione: Lagumina, Parte I, vol. II, pp. 383-384, doc. DCCXIX.
Ferdinandus etc.
Vicerex etc. prothis et maiorentibus Iudayce terre sancte lucie presentibus et futuris servis regie
camere graciam regiam.
Per vostra parti simo stati informati chi contiguo a la mischita de quissa Iudeca e uno casalino de
ipsa Iudeca lo quali la Iudeca havia murato ad opu di conservarichi li cosi di ipsa mischita. et perchi
31
secundo la Iudeca la mischita e pichola et stricta vorrissivo di tali casalino acrixiri la dicta mischita
como per regio privilegio concesso a tucti li Iudechi de quisto regno vi e permisso ampliarila.
Supplicandoni perhumillime hi super hoc ad mayuri cautela et corroboracioni vi concedissimo
nostra licencia. Nui vero per comoditati et beneficio di ipsa Iudeca simo contenti et per la presenti vi
damo licencia et facultati chi libere et impune pozzati di lo dicto casalino piglari tanto terreno quillu
diruendo et de novo hedificando et incorporando cum la mischita predicta chi quilla pozzati
ampliari di tanti giunta di larghiza longhiza et altura per quanto vi e concesso per la forma di lo
privilegio di la immortali memoria di lo signuri re don Alfonso et non aliter nec alio modo.
procedendo pero cum deliberacioni di lo consiglio di quissa Iudeca seu di la mayuri parti de quilla.
comandando per hanc eamdem ad tucti et singuli officiali mayuri et minuri di lo dicto regno
presertim di quissa terra ad cui specta presenti et futuri vi digiano la presenti licencia et provisioni
teniri et observari iuxta la sua continencia et tenuri et non faczano lo contrario per quanto la regia
gracia hanno cara ac sub pena unciarum centum regio fisco applicandarum. Dat. in urbe felici
panhormi die XXII mensis februarij IIII Indictionis MCCCCLXXXVI. Gaspar de Spes.
Dominus Vicerex mandavit mihi Antonio
Sollima locumtenenti et magistro notario
in officio prothonotarij et vidit eam
nicolaus sabia fisci patronus.
11. Palermo, 1490, 4 gennaio.
Il viceré Fernando de Acugna ingiunge agli ufficiali delle giudaiche di Sicilia di raccogliere, entro il
termine di due mesi, i seimila fiorini offerti al Re.
Protonotaro del Regno, vol. 137, f. 94; Lagumina, II, pp. 466-468.
Rex etc..
Vicerex etc. Regie Camere servi. como ben sapiti si fici per li Iudechi di quisto regno obligacioni a la
regia Curti di pagari florini seymila infra termino di dui misi appresso fussiro acceptati et concessi
per la Sacra Regia Maesta la continencia et tenuri di li capituli per li Iudechi predicti innanti ad nui
presentati et inde tramisi a la prefata Sacra Maesta.
Et perochi noviter per sua altecza ni e stato tramiso lo privilegio havimo comandato spacharisi la
oportuna nostra executoria et cussi per darisi ordini effectivo a lo pagamento di li dicti florini
seymilia al tempo predicto. significandovi et dandovi noticia di quisto vi dicimo et comandamo
expresse chi cum tucta diligencia sollicitudini et cura digiati dari ordini celeri et effectivo exigiri la
integra rata ad quissa Iudeca contingenti di li dicti florini seymila per forma chi sencza altra
dilacioni al tempo stabilito di li dicti misi dui li quali dicurrino da hogi innanti tali denari siano
rescossi et tramisi in quista felici citati et depositati in banco al nomo di lo magnifico alferi di
leofanti regio thesaurario nomine regie curie. guardandovi in quisto comittiri negligencia oy
tarditati alcuna perchi tali casu ultra chi tali dinari si prindiriano elapso termino ad cambio ad
vostri spisi et interessi astricti eciam sarriamo destinari commissarij ad vostri spisi. nec minus vi
dicimo et comandamo chi al tempo mandireti dicti denari oy vero innanti secundo ad vui meglo
parra uno di vui prothi oy maiorenti si digia personalmenti conferiri ad nui cum lo debito et legali
quinterno et notamento di tucti li fochi su in la Iudeca di quissa terra. Et premissa exequiti cum
effectu guardandovi di lo contrario per quanto la gracia di la dicta Maesta haviti cara et in casu
contravencionis ad sua indignacioni et ira desiderati non incurriri. Dat. in urbe felici panhormi die
quarto mensis Ianuarij VIII Indictionis MCCCCLXXXVIIII. Post datam. vi comando chi tali denari
faczati exigiri secundo per vui et vostro solito consiglo sarra meglo accordato non facendo di tali
pagamento exempti persuna alcuna. Dat. ut supra. Fernando dacugna.
Dominus vicerex mandavit mihi
Antonio Sollima locumtenenti et
magistro notario in officio pro-
thonotarij visam per thesaurarium.
32
12. Palermo, 1490, 4 marzo.
Il viceré Fernando de Acugna, considerato che la giudaica di Santa Lucia e Piana di Milazzo paga un
tarì per ogni onza dovuta dall’università cristiana, proibisce che i giudei facoltosi di detta giudaica
siano obbligati ad anticipare tutto il danaro dovuto dalla università cristiana.
Protonotaro del Regno, vol. 133, f. 62v; Lagumina, II, p. 483, doc. DCCLXXXVI (solo regesto).
13. Palermo, 1490, 17 marzo.
Il viceré Fernando de Acugna, a richiesta di Iosep Alpastani, ambasciatore della giudaica di Santa
Lucia, provvede alla tutela di quei giudei specialmente nella settimana santa.
Protonotaro del Regno, vol. 133, f. 99; Lagumina, II, 492, doc. DCCXCVII (solo regesto).
14. Messina, 1492, 28 maggio.
Il viceré Fernando de Acugna mette sotto la salvaguardia regia le giudaiche e i giudei di Sicilia.
Regia Conservatoria di Registro, vol. 74, f. 9; Regio Patrimonio, vol. 177, f. 149; Lagumina, III, pp.
3-6, doc. DCCCLXXII.
15. Messina, 1492, 17 luglio.
Il viceré Fernando de Acugna assicura tutti i giudei di Sicilia che saranno ben trattati se si
convertiranno alla fede cattolica.
Protonotaro del Regno, vol. 146, ff. 176v-177v; Lagumina, III, 96-97, doc. DCCCCXXVII.
Servi regie Camere. simo informati alcuni Iudei di quistu regnu haviri delibiratu redducirisi a la
sancta fe cattolica et farisi cristiani et dubitanu farlo per lu vulgari dictu di alcuni persuni czoe
facendosi dicti Iudey christiani sarriano maltractati in persona et beni. et desiderando nui lu
augmentu di la dicta santa fe cattolica et saluti di li animi di tucti li Iudey declarandovi nostra
volutati vi dicimo declaramo et affirmamo chi tucti quilli Iudey li quali si vurrannu fari christiani
non li sarra inferta ne facta vexacioni alcuna. ymmo tucti sartiano ben tractati in omnibus et per
omnia comu si tractano li altri christiani. et per loro maiuri bon tractamento declaramo chi quilli
Iudey li quali si bacticziranno essendo poveri et non tenendo beni ancorchi siano obligati de persona
non sarriano constricti de persona. et cussi cum deliberacione del sacro regio consiglo havimo
graciose deliberato di quilla per la presenti nostra lictera. Dat. messane die XVII Julij X Ind. 1492.
Fernando dacuna.
Sollima locumtenens prothonotarij.
16. Messina, 1492, 29 agosto.
Il viceré Fernando de Acugna invia speciali commissari per indagare se i regi ufficiali abbiano
estorto donativi dai giudei e se si siano lasciati corrompere da loro.
Protonotaro del Regno, vol. 145, f. 149v; Lagumina, III, pp. 162-164, doc. DCCCCLXXI.
17. Messina, 1492, 31 ottobre.
Il viceré Fernando de Acugna fa emettere il bando che il re Ferdinando ha accordato ai giudei di
Sicilia di pagare i loro debiti alla Regia Curia mediante una composizione e che ha concesso la
proroga di quaranta giorni alla espulsione dei medesimi.
Protonotaro del Regno, vol. 153, f. 215; Lagumina, III, 217-219, doc. MIX.
18. Messina, 1492, 10 novembre.
Il viceré Fernando de Acugna ingiunge a tutti i secreti di Sicilia di riconsegnare alle giudaiche e ai
singoli giudei i loro beni che erano stati inventariati, quando hanno avuto piena sicurezza che
ciascuna giudaica e i singoli ebrei saranno in grado di pagare le rate loro spettanti della composizione
di centomila fiorini e del donativo di 5.000 fiorini.
Protonotaro del Regno, vol. 153, f. 250; Lagumina, III, pp. 236-241, doc. MXV.
33
19. Messina, 1492, 16 dicembre.
Il viceré Fernando de Acugna ingiunge ai secreti (fra cui, Giacomo Balsamo, secreto di Castroreale e
Santa Lucia) di eseguire le disposizioni del Tesoriere circa la commissione avuta per l’esazione delle
rate della composizione di centomila fiorini e del donativo di 5.000 fiorini.
Protonotaro del Regno, vol. 145, f. 256; Lagumina, III, pp. 269-271, doc. MXXXIX.
20. Santa Lucia, 1496, 21 novembre.
Compromesso in merito all’usufrutto di un gelseto acquistato dagli ebrei Salamone Capone e Bitino
Maijo e rimasto per quattro anni in potere del venditore Antonino Mendolia in seguito all’espulsione
generale dei giudei.
Regesto: Giuliana, VIII, 136.
Antonino Mendolia si divisa cum sit quod temporibus praeteritis Antoninus la Mendolia vendiderit
Salamoni Caponi et Bitino Maijo, Judaeis, certos sicomos, sive moros, quae sunt in ejus clausura in
contrata, quae dicitur di Casanova, pro pretio unciarum duarum, ita et prout jacet in contractu
prout contineri dixerunt in actis egregij Antonini de Cortina, qui Judaei emptores cum decessissent
a Regno Siciliae, pro generali expulsione Jaudaeorum ex Regia ordinatione et mandato, dicti sicomi
remanserunt in posse ipsius Antonini venditoris et consequtus fuit sive potitus usufructus ipsorum
pro annis quatuor, usque dictus Bitinus reverteretur in Regnum epistola nomine Magister
Ferdinandus de Maijo, qui pro dicta causa interpellabat dictum Antoninum et moverat sibi
questionem, tam de resumendis ipsis sicomis, quam de solvendo usufructus ipsorum pro dictis annis
quattor, qua mota questione, nonullae fuerunt inter ipsas partes expensae causatae, pro quibus
amicis comunibus intervenientibus devenerunt ad infrascriptam concordiam, et sic denuo inter eos
pepegerunt, quod dictus Magister Fernandus sponte promittens de rato pro dicto Salamone Caponi
Judaeo, nunc eius servo, restituit et remisit et vult ut remaneat dicto Antonino la Mendolia possessio
ipsorum sicomorum, et ipse Magister Ferdinandus sponte confessus fuit recepisse et habuisse untias
duas pro pretio, pro quibus emerat dictos sicomoros, quos ipse Antoninus sibi restituit, renunciando
et quia venditio ipsorum sicomorum erat cum carta gratiae, prout dixit ipse Antoninus, qui pro
usufructibus quibus potitus fuit sponte consentiens etiam solvere dicto Magistro Ferdinando etiam
uncias 2.12, pro quibus usufructibus erat condemnatus ad uncias 3.6 assentit ipse Magister
Ferdinandus, de quibus sibi relaxavit tarenos sex, XXIIII et fuerunt concordes pro dictis unciis 2.XII
quas consignare debet uncias I, tarenos VI in proximum mensem Julij primo venturo, aliam vero
unciam I, tarenos VI ad complementum illinc ad annum, pro quibus non evenerit cum exatione brevi
manufacienda in bonis et in persona, variando e con altre condizioni, come per atti sudetti sotto li
21 novembre III Indizione 1496, al foglio 75 di detto Quinternello II così è l’atto istesso. (Notaio
Giovanni Filippo Guidotti o Antonino Cortina)
21. Santa Lucia, 1497, 26 aprile.
Vendita di un appezzamento di terreno nel feudo di S. Filippo, facente parte dei beni stabili venduti
dai Giudei in occasione dell’espulsione generale.
Regesto: Giuliana, VIII, 131.
Giovanni Guglielmo Carrozza detto compradore dei beni stabili de’ Giudei, in virtù di provvista
data in Messina, sotto li 26 Aprile XI Indizione 1497, dicto nomine in perpetuum vendette ad
Antonio di Nucarra, presente, un luogo in questo Territorio, nel Feudo e contrada S. Filippo, lo
istesso che possedea Filippo Recupero, e quel medesimo ricevuto come da’ beni delli suddetti
Giudei, consistente in piante e terreno, confinante con detto compradore, eredi del quondam Salvo
Patti e vigna di Guglielmo Lipari, sogetto alla solita vigesima, pel prezzo di onze 3, in contante, fu
confessata onza 1di contanti, colla promessa della difesa, detto per atti sudetti sotto li 30 Giugno II
Indizione 1597, al foglio 13 di detto Quinternello II. (Notaio Giovanni Filippo Guidotti o Antonino
Cortina)
34
22. Santa Lucia, 1497, 30 giugno
Enfiteusi perpetua di un terreno nel Feudo di Pancaldo a favore del neofita giudeo Pietruzzo Patti.
Regesto: Giuliana, VIII, 132
Paolo Calori in perpetuum concedette ad emphiteusim a Pietruzzo Patti, Neofita Giudeo, presente,
un luogo, in questo Territorio, nel Feudo e contrada Pancaldo, consistente in terreno e diversi
alberi, confinante con Fiderico di Vita, eredi del quondam Antonio di Natali, Zuberto di Alì e stretto
puplico alla ragione di tarì 4 l’anno di cenzo utile perpetuo didotto il cenzo perpetuo dovuto al
Magnifico Barone di detto Feudo di mondello uno di formento e mezzo mondello di orzo l’anno,
come per atti sudetti sotto li 30 Giugno II Indizione 1597da leggere 1497, al foglio 14 retro di
detto Quinternello VI. Ed allo incontro, per atti sudetti sotto li 28 dicembre XIII Indizione 1509,
detto di Calori confessò da esso di Patti, presente, il capitale del cenzo, ordinans etc. irritari et
vacavit et penitus vacat etc.
23. Santa Lucia, 1497, 7 agosto.
Acquisto di un albero di gelso da parte del Magnifico Giacomo Staiti, neofita.
Regesto: Giuliana, VIII, 135.
Domenico ed Agata Caldarone, marito e moglie, abitadori in questa, in perpetuum vendettero al
Magnifico Giacomo Staiti, neofita, presente, un piedi di celso col suo terreno, in questo Territorio,
contrada Sotto porta Valle, confinante ed in mezzo del luogo di detti venditori, pel prezzo di tarì 18,
che furono confessati di contanti; colla promessa della difesa, come per atti sudetti sotto li 7 Agosto
II Indizione 1497 al foglio 120 retro di detto Quinternello II. (Notaio Guidotti o Cortina).
24. Santa Lucia, 1497, 7 aprile.
I fratelli ebrei Girolamo e Romana Mazzara pagano al Commissario per le cause dei giudei della
Terra di Santa Lucia un debito contratto l’anno precedente dal padre Isacco.
Regesto: Giuliana, VIII, 127.
Rugerotta Pandolfo, Commissarius ad causas Judaeorum in Terra Sanctae Luciae, ad istanza di
Filippo Furnari, presente, confessò dicto nomine da Girolamo e Romana Mazzara, figli d’Isacco,
Giudei, onze 10 di contanti, furono per quelle istesse per sudetto Isacco dovuteli, in virtù d’atto per
atti di Notar Piero Paolo di Amico, sotto li 30 Magio XIV Indizione 1496, come per atti del sudetto
Notar Guidotti o Cortina, sotto li 7 Aprile II Indizione 1597 sic, ma da leggere “1497”, al foglio 5
di detto Quinternello II.
25. Santa Lucia, 1510, 5 giugno.
Ferdinando Maijo, giudeo, ricompra allo stesso prezzo di vendita due botteghe contigue, nella
contrada della Valle, che aveva vendute al prete Leonardo Aliberto in occasione dell’espulsione
generale.
Regesto: Giuliana, VIII, 109.
Il Venerabile Presbitero Leonardo Aliberto [si divisa come segue] : Ex quo, in recessu Judaeorum
Venerabilis Praesbyter Leonardus de Aliberto, habitator Terrae Sanctae Luciae, emisset a Magistro
Ferdinando Maiju Judaeo duas collaterles sic, per “collaterales” apotecas sitas et positas in dicta
Terra Sanctae Luciae, in contrata Vallis, cum dilatione redimendi, ideo non vi sed sponte gratiose
etc. in perpetuum retrovendette a detto Maestro Ferdinando, presente, dette due botteghe,
confinanti colla bottega di Maestro Clemente Guido e bottega, seu Ospizio di S. Placido Calonerò
35
di Messina e via puplica, pello istesso prezzo di onze 15 che furono confessate di contanti, colla
promessa della difesa, come per atti sudetti sotto li 5 Giugno XIII Indizione 1510, al foglio 72 di
detto Quinternello 8, ed al foglio 73 siguente vedesi l’atto di posesso di dette due bottege [sic!]
prese da esso Notar Guidotti, seu meglio notar Antonino Cortina, a nome di detto Maestro
Ferdinando.
26. Santa Lucia, 1512, 16 aprile.
Testamento del neofita Ferrante Maggio.
Regesto: Giuliana, VIII, 686.
Maestro Ferrante di Magio, Neofita, abitadore in questa, infermo a letto, fè il di lui sollenne, o
chiuso testamento, come per atti sudetti sotto li 16 Aprile XV Indizione 1512, al foglio 166 di detta
Minuta unica è detto di Magio di nazione Ebrea. (Notaio Antonino Cortina)
27.Palermo, 1520, 11 novembre.
La Santa Inquisizione sequestra i beni di Paolo Staiti e della moglie, neofiti. Il Viceré ordina che i
creditori non li molestino.
Ramo Protonotaro, vol. 19, 11.11.1520. C.TRASSELLI, Sugli Ebrei in Sicilia, p. 51.
28. Santa Lucia, 1521, 8 marzo.
Vendita di una casa nella contrada Bernardimura, confinante con Maestro Giovanni Rubini,
neofita.
Regesto: Giuliana, VIII, 1754.
Matteo e Rosella di Amico, marito e moglie, in perpetuum vendettero a Maestro Francesco ed
Antonella Lombardo, marito e moglie, di loro nipoti, presenti, una casa terrana, in questa, nella
contrada Bernardimura, confinante con Maestro Giovanni Rubini, neofita, Florella Ficarra e via
puplica pel prezzo di onze 6 ex accordio, che furono allo incontro confessate di contanti; allo
incontro, vedesi la rattifica di Antonio di Amico, figlio di detti venditori; colla promessa generale
della difesa , come per atti sudetti sotto li 8 Marzo X Indizione 1521, al foglio 11 retro di detto
Registro Minuta 6. (Notaio Domenico Impò).
29. Santa Lucia, 1526, 23 febbraio.
Compravendita di una casa nella contrada Moschita.
Regesto: Giuliana, VIII, 1795.
Bernardo e Francesca Licandro, marito e moglie, in perpetuum vendettero al Presbitero Francesco
Trifirò, presente, una casa terrana, in questa, nella contrada Moschita, confinante col Maestro
Leonardo di Meo e Mariano Stuppia, pel prezzo di oncia 1 netto, che fu dilazionata, colla promessa
generale della difesa, come per atti sudetti sotto li 23 Febbraro XV Indizione 1526, al foglio 59
retro di detto Registro Minuta 6. (Notaio Domenico Impò)
30. Santa Lucia, 1526, 10 ottobre.
Compravendita di una casa solarata con cucina sita nella contrada “Giudaica”.
Regesto: Giuliana, VIII, 1292.
Il Magnifico Giovan Andrea Patti, del quondam Francesco, in perpetuum vendette ad Andrea
Valenti, presente, una casa solarata con sua cocina, in questa Terra, nella contrada Giudaica,
confinante Reale Russo, vedova del quondam Domenicuccio ed eredi del quondam Domenico di
Paola e Paolo Ferrario; pel prezzo di onze 10.10 netto, come fu stimata, che furono confessati di
contanti; colla promessa generale della difesa e notifiche fatte de jure prothomiseos vicinitatis,
36
all’uso di compilarsi le sollenni vendizioni¸ come per atti sudetti sotto li 10 ottobre XV Indizione
1526 al foglio 1 di detta Minuta II che si è di Sollenni, dall’anno 1527 sino all’anno 1549.
31. Santa Lucia, 1526, 26 ottobre.
Compravendita di una casa nella contrada “Giudaica”.
Regesto: Giuliana, VIII, 154.
Giacomo Sisilli vendette in perpetuum a Niccolò Trovato, presente, una casa terrana, in questa,
nella contrada Giudaica; confinante con detto compradore ed eredi del quondam Francesco
Picciolo; pel prezzo di onze 3, che furono poste in dilazioni; colla promessa della difesa, come per
atti sudetti sotto li 26 ottobre 1526 al foglio 3 retro di detto Bastardello III (Notaio Guidotti).
32. Santa Lucia, 1526, 24 dicembre.
Compravendita di una casa nella contrada Moschita.
Regesto: Giuliana, VIII, 1790.
Niccolò Foti vendette in perpetuum a Salvo Milazzo, presente, una casa solarata in questa, nella
contrata Moschita, confinante con detto Salvo e Maestro Antonello Stuppia non divisa prezzo; colla promessa generale della difesa, come per atti sudetti sotto li 24 dicembre XV Indizione 1526,
al foglio 55 retro di detto Registro Minuta 6. (Notaio Domenico Impò)
33. Santa Lucia, 1527, 1 maggio
Vendita all’asta pubblica di alcuni immobili confiscati dall’Inquisizione al neofita Stefano Elia.
Regesto: Giuliana, VIII, 1824.
Il Magnifico Domenico Ingarcia, Percettore della SS.ma Inquisizione, per incantum candelae
extinctae, vendette a Giulio Pagano, plus offerenti, presente, una bottega, seu conzaria, in questo
Territorio, contrada Conzarie, che si era confiscata da potere di Stefano Elia, neofita, confinante
con Giovanni li Conchi, come pure altra casa picula in detta contrada e dello istesso, che furono
confiscate per detta SS.ma Inquisizione, die etc. pel prezzo di onze 4 che furon poste in due iguali
paghe; come per atti sudetti sotto il primo Magio I Indizione 1527, al foglio 97 di detto Registro
Minuta 6. (Notaio Domenico Impò).
34. Santa Lucia, 1534, 11 luglio.
Compravendita di una casa solarata con annessa cucina, sita nella contrada “Giudaica”.
Regesto: Giuliana, VIII, 231.
Giulio Valenti vendette in perpetuum jure sanguinis al Maestro Girolamo Trifirò, presente, una
casa solarata con sua cocina, in questa, nella contrada Giudaica; confinante con Giacomo Giunta
ed Andrea è rosicchiato il cognome; pel prezzo di onze 13 ex accordio, che furono accollate; colla
promessa della difesa; come per atti sudetti sotto li 11 Luglio VII Indizione 1534 al foglio 17 retro
di detto Bastardello XIII. (Notaio Guidotti)
35. Santa Lucia, 1534, 16 settembre.
Quietanza del corrispettivo di una casa sita nella contrada “Giudaica”.
Regesto: Giuliana, VIII, 188.
Francesco Sardo, come marito di Amata di Paola, dicto nomine confesso da Francesco di Paola, di
lui cognato, presente, onze 3 di contanti; furono pella casa, pel sudetto di Paola promessagli per
37
dote, come per madrimonio, die etc. posta in questa Terra, contrada Giudaica, juxta suos fines; per
aversi la medesima rinvenita ippotecata ad un cenzo bollale di onze 1 l’anno; quietantes ad invicem
etc.; con altre condizioni, come per atti sudetti sotto li 16 settembre VIII Indizione 1534 al foglio 19
di detto Bastardello VII. (Notaio Guidotti).
36. Santa Lucia, 1543, ? agosto.
Permuta di una casa sita nella contrada Giudaica con altra casa in contrada Fondaconuovo.
Regesto: Giuliana, VIII, 496.
Maestro Angelo Murello, d’una parte, e Giacomo di Paola, dall’altra, fecero in perpetuum atto di
permuta tra tutte e due le aprti, cioè detto Giacomo, titulo permutationis, li assegnò una casa, in
questa Terra, nella contrada Giudaica; confinante con Andrea valveri e via puplica, e detto Angelo
li assegnò altra casa terrana, in questa, nella contrada Fondaco nuovo; confinante con Francesco
Cuminali; e detto Giacomo confessò il sovrappiù di casa; colla riciproca promessa della difesa,
come per atti sudetti sotto li è rosicchiato il dì Agosto III Indizione 1543 al foglio 3 retro di detto
Quinternello, ovvero Bastardello XXII.
37. Santa Lucia, 1549, 22 gennaio.
Concessione ad enfiteusi perpetua di una parte di casaleno nella contrada “Giudaica”.
Regesto: Giuliana, VIII, 142.
Maestro Luciano di Amico ad emphiteusim in perpetuum concedette a Giovanni Messina, presente,
una parte di casaleno, spettanteli, in questa Terra, contrada Giudaica, confinante colle parti di
Domenico di Amico e strada puplica, alla ragione di cenzo perpetuo di tarì 5 l’anno, co’ patti soliti,
come per atti sudetti sotto li 22 Gennajo VIII Indizione 1549 al foglio 417 di detta Minuta IV.
38. Santa Lucia, 1549, 28 luglio.
Vendita di un terreno da parte di Domenico Mamone e della moglie Agrippina.
Regesto: Giuliana, VIII, 1566.
Domenico ed Agrippina Mamone, marito e moglie, del luogo di Mandanici, abitadori in questa, in
perpetuo vendettero a Paolo Allegruzzo o Allerruzo, di detto luogo, seu di Pagliara, presente, un
pezzo di terreno scapolo nel Feudo nomato lo Sciglio non divisa meglio, confinante con Antonino
Sansoni e Feudo di Arcontasi; lo istesso luogo, dotatogli da Caterina Bruschetta, di loro suocera e
madre rispettivamente die etc. pel prezzo di onze 3.6, che furono confessati di contanti, colla
promessa generale della difesa, come per atti sudetti sotto li 28 Luglio VIII Indizione 1549, al foglio
590 di detta Minuta IV. (Notaio Domenico Impò).
39. Santa Lucia, 1558, 21 gennaio.
Il “maestro” Florio Magio vende un terreno in territorio di Milazzo, contrada Suvaro.
Regesto: Giuliana, VII, 1528.
Maestro Florio di Magio, in perpetuum vendette a Bernardo Mazzagatti, presente, un luogo, nel
Territorio di Melazzo, contrada lo Suvaro, consistente in celsi, terreno ed altri alberi, confinante
con Antonino Trifirò, Antonino Intilleti ed altri confini; colla promessa generale della difesa come
per atti sudetti sotto li 21 gennaio I Indizione 1558 al foglio 23 di detta Minuta VI di sollenni.
40. Santa Lucia, 1558, 16 novembre.
Il “maestro” Florio Magio ed altri fanno denuncia di un censo dovuto al reverendo Matteo Papardo
sopra una loro proprietà nel feudo di Cageggi, contrada Porticelli.
Regesto: Giuliana, VII, 748.
38
Maestro Florio di Magio, Andrea Impalà, Angelo di Magio e Domenico Impalà fecero atto di
riquisizione a favore del Reverendo Signor Matteo Papardo, come sovra e pagarli un cenzo
perpetuo di salma una e tumoli quattordeci di formento l’anno; dovuto cioè tumola dieci pel sudetto
Maestro Florio, tumola dieci pel sudetto Andrea, tumola dieci pel sudetto Angelo ed il resto pel
sudetto Domenico, colle condizioni come per atti sudetti sotto li 16 novembre II Indizione 1558, al
foglio 251 di detta Minuta I; sovra un luogo, come sovra, nella contrada Porticelli, confinante con
Marino Fruscella.
41. Santa Lucia, 1558, 16 novembre.
Il “maestro” Florio Magio e Tommaso Amico fanno denuncia di un censo dovuto al reverendo
Matteo Papardo sopra due loro proprietà nel feudo di Cageggi, contrada Pantana.
Regesto: Giuliana, VII, 750.
Tommaso di Amico e Florio di Magio, insolitum, come compradori di due luoghi rispettivamente
vendutoli dal quondam Antonello di Bartolo e Domenico Garaldo, diebus etc. , fecero riquisizione
a favore del reverendo Signor Matteo Papardo, come sovra, e pagarli un cenzo perpetuo di tarì 9
l’anno, cioè: di tarì 2.5 pel sudetto Florio; e di tarì 6.15 pel sudetto Tommaso; colle condizioni,
come per atti suddetti, sovra un loro luogo in due corpi in questo Territorio, nel feudo di Cageggi,
contrada Pantana, confinante con Bartolomeo Isbono, come per atti sudetti sotto li 16 novembre II
Indizione 1558, al foglio 252 di detta Minuta I.
42. Santa Lucia, 1560, 9 settembre.
Rainerio e Francesco Isaja promettono i dovuti beni dotali al rispettivo genero e cognato
Dettagiuto Impò.
Regesto: Giuliana, VIII, 1566.
Dettiagiuto Impò, maritali nomine, confessò dalli magnifici Rainerio e Francesco Isaja, padre e
figlio, di lui suocero e cognato, presenti, tutte le doti promesseli in virtù di madrimonio die etc.,
come per atti sudetti, sotto li 9 settembre IV Indizione 1560, al foglio 644 di detta Minuta V. (Notaio
Domenico Impò)
43. Santa Lucia, 1560, 5 ottobre.
Il “maestro” Pietruzzo Isaia e la moglie Domenichella vendono un appezzamento nel territorio di
Milazzo, contrada Furia.
Regesto: Giuliana, VII, 1494.
Maestro Pietruzzo e Domenichella Isaja, marito e moglie, abitadori in questa, insolido, in
perpetuum vendettero a Giovanni Andrea Brancuccio, presente, un luogo nel Territorio di Melazzo,
contrada Furia, consistente in celsi, ulivare ed altri alberi; confinante con esso compradore,
Giovannello Amalfa, Magnifico Andrea Trovato e Fiume puplico per il prezzo di quanto sarà
stimato, colla promessa della difesa ed obligazione speziale, come per atti sudetti sotto li 5 ottobre
IX Indizione 1560 al foglio 696 di detta Minuta V ed è fatta sollenne detta vendizione.
44. Santa Lucia, 1561, 8 giugno.
Presa di possesso di vari appezzamenti di terreno, fra cui uno nella contrada “Lo Giudecco” di
Milazzo.
Regesto: Giuliana, VIII, 1734.
39
Il Magnifico Mariano Carrozza e per esso il Presbitero Niccolò Runcio, di lui Procuradore
reconsieguì il posesso d’un luogo in questo Territorio, contrada Valli, d’altro, in questo sudetto
Territorio, contrada Padura, di altro, in questo medesimo Territorio, contrada delli Celli e di altro
Molino delli Parrini in questo Territorio; come pure d’altro luogo, nel Territorio di Melazzo,
contrada Massaria, d’altro, in detto Territorio, contrada Lo Giudeco, d’altro in detto Territorio,
contrada Cuccumona, d’altro in detto Territorio, contrada Latticonda, similmente d’altro luogo
nella contrada Reilla, juxta eorum consistentias et confines non divisa la causativa, per signa
denotantia etc., come per atti sudetti, sotto li 8 Giugno IV Indizione 1561, al foglio 662 di detta
Minuta V. (Notaio Domenico Impò).
45. Santa Lucia, 1562, 6 ottobre.
Il Magnifico Dettagiuto Impò riceve dal cognato Rainerio Isaja 19 onze in conto delle doti
matrimoniali promesse.
Regesto: Giuliana, VII, 4100.
Il Magnifico Dettagiuto Impò, maritali nomine confessò dal Magnifico Rainerio Isaja, di lui
cognato, presente, onze 19 di contanti; furono in conto delle doti promesseli come per madrimonio
per atti di Notar Bernardo Russo, della Terra di Monforte, die etc. e come per atti del sudetto Notar
Meo sotto li 6 ottobre VI Indizione 1562 al foglio 46 di detta Minuta XVII al n. 2.
46. Santa Lucia, 1563, 25 agosto.
Bernardino Maggio acquista una casa a Santa Lucia, contrada Valli.
Regesto: Giuliana, VII, 4142.
Filippo Ficarra, alias Scalinci, del quondam Angelo, in perpetuum vendette a Bernardino di Magio,
presente, una casa solarata in questa, nella contrada Valli, confinante con via puplica ed eredi del
quondam Lorenzo Mustazzo; pel prezzo di onze 16.20 come fu stimata, in conto furon fatti accolli
bollali e confessione di onze 2 di contanti, colla promessa della difesa, come per atti suddetti sotto li
25 Agosto VI Indizione 1563 dice 1562 al foglio 95 retro di detta Minuta XVII al n. 2.
47. Santa Lucia, 1564, 27 maggio.
Il “maestro” Giovanni Saja di Rometta acquista alcune piante di gelso in territorio di Rometta,
contrada S. Filippo.
Regesto: Giuliana, VII, 1485
Oliverio Mancuso, della terra di Rometta modo etc in perpetuum vendette a maestro Giovanni Saja
di detta terra, presente, tutti li celsi che tengono tra di loro in comuni et pro indiviso, nel Territorio
di essa Terra, nella contrada S. Filippo, confinante con detto compradore; intendendosi solamente
venduti detti celsi; pel prezzo di onze 15.15 che furono confessati di contanti; colla promessa
generale della difesa; come per atti suddetti sotto li 27 Magio VIII Indizione 1564 al foglio 527
retro di detta Minuta I ed è fatta sollenne
48. Santa Lucia, 1564, 1 settembre.
Bernardino Isaja e la moglie Sarella vendono un fondo nel territorio di Rometta, feudo di S.
Martino, contrada Marino.
Regesto: Giuliana, VII, 1574.
40
Bernardino e Sarella Isaja, marito e moglie, insolido, vendettero a Federico Giordano, del casale di
Venetico, modo etc. un luogo, nel Territorio di Rometta, nel Feudo di S. Martino, contrada Marino,
seu Pascanotto, consistente in celsi, terre scapole ed altri alberi; confinante con detto compradore e
Curbirna Grimari; pel prezzo di onze 12 ex accordio, che furon poste in dilazioni e mandato; colla
promessa generale della difesa, come per atti sudetti sotto il primo settembre VII Indizione 1564 al
foglio 149 di detta Minuta VI di sollenni.
49. Santa Lucia, 1566, 7 settembre.
Concessione ad enfiteusi perpetua di due case nella contrada “La Giudaica”.
Regesto: Giuliana, XI, 115.
Li Reverendi Presbiteri Francesco Rizzo, Arcidiacono, Ambrogio Ricca, Cherubino Impò, Giulio
Russo, Cataldo Leporino, Croceano Rizzo, Filippo Talaja, Giuseppe Rizzo, Niccolò Morina,
Giuseppe Pizzo, Presbiteri e Sacerdoti di questa Reverenda Magior Parrocchiale Chiesa,
capitulariter congregati etc., colla licenza del Signor Reverendo Don Girolamo Zafarana, Abate di
questa Abazia, vivae vocis oraculo, in perpetuum ad emphiteusim concedettero al Presbitero
Antonino Bartuccio, altro Presbitero, presente, due case in questa Terra, contrada la Giudaica, una
confinante colla casa di maestro Girolamo Trifirò e via puplica, ed altra confinante colla casa di
Filippo Ficarra ed altra casa di detta Venerabile Comunia; alla ragione di cenzo perpetuo di onze
1.5.10 l’anno, colli patti soliti, come per atti sudetti notaio Giorgio sotto li 21 settembre sudetto X
Indizione 1566 al foglio 41 di detto Bastardello 3.
50. Santa Lucia, 1571, 2 settembre.
I fratelli Clemente e Domenico Maggio vendono un fondo nel feudo di Cageggi, contrada Porticelli.
Regesto: Giuliana, VII, 2073.
Clemente e Domenico di Magio, fratelli, insolido,vendettero in perpetuum a Barnardino Calderone,
presente, un loro luogo, in questo Territorio, nel Feudo di Cageggi, contrada Porticelli, consistente
in sette mondelli di terreno, confinante con detto compradore, Andrea Impalà e detto Domenico; pel
prezzo di onze 1.18 netto che furono confessati di contanti, allo incontro vedesi la rattifica di
Angelo, fratello di detti venditori, colla promessa generale della difesa; come per atti sudetti sotto li
2 settembre XV Indizione 1571 al foglio 200 retro, di detta Minuta VIII.
51. Santa Lucia, 1582, 22 aprile.
Matrimonio di Giovanni Filippo Pagano con Giovanna Isaja.
Regesto: Giuliana, VII, 3107.
Madrimonio del Magnifico Giovanni Filippo Pagano d’una parte e la Magnifica Giovanna Isaja
dall’altra qual sudetto Madrimonio, si vede come se fosse piuttosto atto di accordo, colla rattifica
al fine; come per atti sudetti sotto li 22 aprile X Indizione 1582 al foglio 133 detta Minuta XII; e
vedesi cusito poscia.
52. Santa Lucia, 1584, 25 maggio.
Croceano Isaja acquista un “luogo di manganello” nel territorio di Santa Lucia, contrada
Canalicchio.
Regesto: Giuliana, VII, 3333.
Girolamo Oliva, in perpetuum vendette a Croceano Isaja, presente, un luogo di manganello, in
questo Territorio, contrada Canalicchio, con sua gebbia; confinante con via puplica e Zafari di
questa; pel prezzo di oze 2 ex accordio, che furono allo incontro confessate di contanti; colla
41
promessa generale della difesa; come per atti sudetti, sotto li 25 maggio XII Indizione 1584, al
foglio 62 di detta Minuta XIII.
53. Santa Lucia, 1586, 7 marzo
Acquisto di un terreno in Milazzo da parte di Croceano Isaja.
Regesto: Giuliana, VIII, 744.
Antonino, seu Nino Nanù, del quondam Girolamo, in perpetuo vendette a Croceano Isaja, presente,
un luogo nel Territorio di Melazzo, contrada Poverelli seu Gadarri, consistente in celsi e quercie,
confinante con detto compratore, Bernardino de Magio, Maestro Piero Vassallo e Vallone pubblico,
sogetto a tarì 12.3 l’anno di cenzo perpetuo dipendente di magior somma, dovuto a questa
Venerabile Magior Comunia; ed il di lei procuradore inquisito de jure directi dominij, confessò tarì
11 di contanti, che divisò di quinquagesima, pel prezzo di onze 15 lordo, vedi allo incontro la
relazione; inconto furono confessate onze 5 di contanti, colla promessa della difesa ed obligazione
speciale, come per atti sudetti sotto li 7 Marzo XIV Indizione 1586, al foglio 452 di detto
Bastardello 1 (Notaio Girolamo Sterrantino)
54. Santa Lucia, 1586, 21 luglio.
Acquisto di un terreno in territorio di Savoca da parte di Girolamo Mamuni.
Regesto: Giuliana, VIII, 755.
Domenico Bruschetta del quondam Giacomo della Terra di Mandanici, modo etc., in perpetuo
vendette a Girolamo Mamuni del quondam Francesco, di detta Terra, presente, un luogo nel
Territorio della Terra di Savoca, contrada Missaratina (?), consistente in celsi, vigna ed altri
alberi, confinante con detto compradore, Giovanni Mazzullo e Giovannello Cubeta, pel prezzo di
onze 10, v. fu stimato, che furon poste in dilazioni; colla promessa della difesa ed obligazione
speziale; come per atti sudetti sotto li 21 Luglio XIV Indizione 1586, al foglio 553 di detto
Bastardello I. (Notaio Girolamo Sterrantino).
55. Santa Lucia, 1586, 31 luglio.
Croceano Isaja vende tre “luoghi di manganelli di seta” a Santa Lucia.
Regesto: Giuliana, VIII, 760.
Croceano Isaja in perpetuum vendette a Domenichello Donato, presente, tre luoghi di manganelli di
seta, con sua gebbia ed acque pendenti, in questo Territorio, nella contrada Canalicchio, confinanti
con la via puplica e Zafari puplici di questa Università; li medesimi a detto Croceano venduti per
Girolamo Oliva, alias Occhi di buoi, per atti di Notar Antonino di Meo die etc.; pel prezzo di
quanto saranno stimati; colla promessa generale della difesa, come per atti del sudetto Notar
Sterrantino, sotto li 31 Luglio XIV Indizione 1586 al foglio 591 di detto Bastardello I. (Notaio
Sterrantino)
56. Santa Lucia, 1586, 3 dicembre.
Acquisto di altro terreno in Milazzo da parte di Croceano Isaja e della moglie Eleonorella.
Regesto: Giuliana, VIII, 798.
Antonino, seu Nino, ed Eleonorella Nanù, marito e moglie, insolido, vendettero in perpetuo a
Croceano Isaja, presente, un luogo nel Territorio di Melazzo, contrada Poverelli, consistente in
ulivare, quercie ed altri alberi, confinante con Filippo Milone e stretto vicinale, pel prezzo di onze
35. v. allo incontro la relazione; ed allo incontro furono confessate di contanti, colla promessa della
42
difesa ed obligazione speziale; come per atti sudetti sotto li 3 dicembre XV Indizione 1586, al foglio
297 di detto Bastardello II. (Notaio Girolamo Sterrantino)
57. Santa Lucia, 1586, 19 dicembre
Andrea Maggio e la moglie Diana vendono una vigna nel feudo di S. Filippo.
Regesto: Giuliana, VIII, 800.
Andrea e Diana di Magio, marito e moglie, insolido vendettero in perpetuum a Maestro Giulio
Trifirò, presente, pacto tamen de retrovendendo, un luogo in questo Territorio, nel Feudo e
contrada S. Filippo, consistente in vigna, confinante col Magnifico Tommaso Impò, Giuseppe Lipari
e Filippo lo Casciaro; sogetto alla solita vigesima, pel prezzo di onze 15 netto, v. allo incontro la
relazione, che furono allo incontro confessate di contanti, colla promessa della difesa ed
obligazione speziale; come per atti sudetti sotto li 19 dicembre XV Indizione 1586, al foglio 338
retro di detto Bastardello II. (notaio Sterrantino).
58. Santa Lucia, 1586, 31 dicembre.
Vendita di una casa nella contrada “Giudaica”.
Regesto: Giuliana, VIII, 802.
Cosmo Ilacqua del quondam Filippo, in perpetuum vendette a Filippo Cattafi di Giovannello,
presente, una casa solarata in questa, nella contrada Giudaica, seu Vallone di Mangarunà,
confinante col Presbitero Croceano Rizzo ed Angelo Barca; la istessa, comprata da Giuseppe
Trifirò, per atti di Notar Nicoletta Mendolia, die etc. pel prezzo di onze 21.4 lordo, v. allo incontro
la relazione; e di onze 14 il tetto sic, per “netto”; allo incontro, vedesi la confessione del prezzo e
la ratifica di Sollerina Ilacqua, moglie di detto Cosmo; colla promessa della difesa ed obligazione
speziale; come per atti sudetti sotto li 31 dicembre XV Indizione 1586, al foglio 362 di detto
bastardello II. (notaio Sterrantino).
59. Santa Lucia, 1587, 9 febbraio.
Vendita di un terreno in Santa Lucia da parte di Croceano Isaja e della moglie Catarinella.
Regesto: Giuliana, VIII, 811.
Croceano e Catarinella Isaja, marito e moglie, insolido vendettero in perpetuo a maestro Antonello
Crisafulli, presente, un luogo in questo Territorio, contrada Giribotta, consistente in celsi e
canneto, confinante con detto compradore, luogo delli Presbiteri di questa Venerabile Magior
Comunia ed eredi del quondam Domenico Masano; lo istesso a detto Croceano dotato per atti di
notar Giovanni Filippo Di Giorgio, die etc., pel prezzo di onze 13.15 netto, v. allo incontro la
relazione; colla obligazione speciale e promessa della difesa; come per atti del sudetto Notar
Sterrantino, sotto li 9 Febbraio XV Indizione 1587, al foglio 441 di esso Bastardello II.
60. Santa Lucia, 1588, 22 agosto.
Catarinella, vedova di Croceano Isaja, vende un terreno nel territorio di Milazzo, contrada
Poverelli, acquistato due anni prima da Antonino ed Eleonora Nanù.
Regesto: Giuliana, VII, 3582.
Catarinella Isaja, vedova del quondam Croceano, in perpetuum vendette a Filippo Milone,
presente, un luogo, nel Territorio di Melazzo, contrada Poverelli, consistente in ulivare ed altri
alberi; lo istesso, pel sudetto quondam Croceano comprato d’Antonino ed Eleonora Nanù, marito e
43
moglie per atti di Notar Girolamo Sterrantino sotto li 3 dicembre XV Indizione 1586, confinante con
detto compradore, stretto vicinale e Maestro Pietro Vassallo; pel prezzo di onze 26 ex accordio, che
furono accollate, colla promessa della difesa ed obligazione speziale; come per atti del sudetto
Notar Meo, sotto li 22 agosto I Indizione 1588 al foglio 193 di detta Minuta XIV.
61. Santa Lucia, 1588, 3 novembre.
Giuseppe Magio fu Angelo e la moglie Gaetana vendono un luogo nel feudo di Cageggi, Contrada
Porticelli.
Regesto: Giuliana, VII, 3604.
Giuseppe di Magio, del quondam Angelo, e Gaetana sua moglie, in perpetuum vendettero al
Venerabile Presbitero Giuseppe Pandolfo, presente, un luogo in questo Territorio, nel Feudo di
Cageggi, contrada Porticelli, consistente in diversi alberi; confinante con Giuseppe Giunta, detti
venditori e Bartolomeo di Magio; pel prezzo di onze 16 netto, che furon confessate di contanti; colla
promessa della difesa come per atti sudetti sotto li 3 novembre II Indizione 1588 al foglio 240 retro
di detta Minuta XIV.
62. Santa Lucia, 1588, 14 novembre.
Permuta di due fondi nel feudo di Cageggi, contrada Porticelli, tra Giuseppe Magio fu Angelo e
Giuseppe Giunta.
Regesto: Giuliana, VII, 3608.
Giuseppe Giunta di Andrea, d’una parte, e Giuseppe di Magio, del quondam Angelo, dall’altra,
fecero in perpetuum tra tutte e due le parti atto di permuta cioè: detto di Giunta, titulo
permutationis diede a detto di Magio un luogo in questo Territorio, nel Feudo di Cagegi, contrada
Porticelli, consistente in puoca vigna e celsi, confinante con Giuseppe di Magio del quondam
Florio, detto Giuseppe, Silvestro Martino e venerabile Presbitero Giuseppe Pandolfo; e detto di
Magio, eodem titulo, l’assegnò altro luogo in detta contrada, consistente in celsi, uliva e vigna;
confinante con detto Presbitero di Pandolfo, Pietro Currao e detto di Giunta; colla reciproca
difesa, a cambio reale; come per atti sudetti sotto li 14 novembre II Indizione 1588, al foglio 245 di
detta Minuta XIV.
63. Santa Lucia, 1589, 20 agosto.
Vendita di una casa a Santa Lucia, nella contrada Giudaica.
Regesto: Giuliana, VII, 3640.
Catarinella Ilacqua, vedova del quondam Matteo e Bernardo, di lei figlio, come pure Pietro e Maria
di Magio, marito e moglie, insolido, vendettero in perpetuum a Mariano Foti, cugino carnale di
detta Catarinella, presente, una casa terrana in questa, nella contrada Giudaica; confinante con
via puplica e detto di Foti; pel prezzo di onze 7 ex accordio; che furono allo incontro confessate di
contanti; colla promessa della difesa, come per atti sudetti sotto li 20 agosto II Indizione 1589, al
foglio 8 retro di detta Minuta XV.
64. Santa Lucia, 1589, 27 agosto.
Giuseppe Maggio e la moglie Gaetana vendono un fondo in contrada Timpanara.
Regesto: Giuliana, VII, 3645.
Giuseppe e Gaetana di Magio, marito e moglie, in perpetuum vendettero a Santoro Nicita, di loro
cognato e fratello, presente, un luogo, in questo Territorio, contrada Timpanara, consistente in
ulivare e vigna; confinante con Bernardo di Bella, Giovanni Coppola, Bartolomeo di Strano e
44
Giuseppe Giunta; pel prezzo di onze 15 netto, come allo incontro la relazione; che furono allo
incontro confessate di contanti; cioè parte di detto luogo, in detta somma di onze 15, e sogetto a
mondello uno di formento l’anno di cenzo perpetuo dovuto a questa Venerabile Chiesa di Santo
Antonino, come sovra al n. 3643, come diretto; colla promessa generale della difesa; come per atti
sudetti sotto li 27 agosto II Indizione 1589, al foglio 15 retro di detta Minuta XV.
65. Santa Lucia, 1591, 1 ottobre.
Giuseppe Magio fu Angelo e la moglie Gaetana vendono un loro fondo nel feudo di Cageggi,
contrada Porticelli.
Regesto: Giuliana, VII, 1495.
Giuseppe di Magio del quondam Angelo e Gaetana sua moglie, insolido, vendettero in perpetuum
ad Antonino Impalà, di loro cognato, presente, un luogo in questo Territorio, nel Feudo di Cagegi,
contrada Porticelli, confinante con Giuseppe Giunta, Filippo Pandolfo, Bartolomeo di Magio,
Giuseppe di Magio, Profilio Merulla e Pietro Cama, pel prezzo di quanto sarà stimato, colla
promessa generale della difesa; come per atti sudetti sotto il primo ottobre V Indizione 1591, al
foglio 703 retro di detta Minuta V ed è sollenne come sovra.
66. Santa Lucia, 1592, 28 febbraio.
Margaritella, vedova di Filippo Arizzi, rinuncia a una casa solarata nella contrada Vota di Coppola
in favore dello zio Bartolomeo Maggio.
Regesto: Giuliana, VII, 3794.
Margaritella Aurizzio, seu Arizzi, vedova del quondam Filippo, in perpetuum rinunziò a favore di
Bartolomeo di Magio, di lei zio, presente, una casa solarata, in questa, nella contrada la Vota di
Coppola; confinante con Antonina Impalà e via puplica; la istessa casa, pel sudetto di Magio
venduta a detto quondam Filippo die etc. come per atti sudetti sotto li 28 febbraio V Indizione 1592,
al foglio 274 retro di detta Minuta XV.
67. Santa Lucia, 1592, 28 febbraio.
Bartolomeo Maggio concede in enfiteusi alla nipote Margaritella Arizzi la casa di cui al precedente
atto.
Regesto: Giuliana, VII, 3795.
Bartolomeo di Magio, in perpetuum concedette ad emphiteusim a Margaritella Aurizzio sudetta, la
casa solorata oggi puoco pria rinunziatali, contrada Vota di Coppola; alla ragione di tarì 12
l’anno, colli patti come per atti sudetti sotto li 28 Febbraio V Indizione 1592, al foglio 274 retro di
detta Minuta XV.
68. Santa Lucia, 1592, 24 agosto.
Giuseppe Maggio fu Florio vende un terreno nel feudo di Cageggi, contrada Porticelli.
Regesto: Giuliana, VII, 3831
Giuseppe di Magio, del quondam Florio, in perpetuum vendette a Porfirio Merulla, presente, un
luogo in questo Territorio, nel feudo di Cagegi, contrada Porticelli, consistente in ulivare, celsi ed
altri alberi , confinante con Bartolomeo di Magio e detto di Merulla; lo istesso comprato da Pietro
Currao per atti del quondam notaio Girolamo Sterrantino, sotto li 26 ottobre IV Indizione 1590; pel
prezzo di onze 20 che furono parte accollate e parte confessate di contanti; allo incontro vedesi la
rattifica di Catarinella, moglie di esso venditore, come per atti sudetti sotto li 24 Agosto V Indizione
45
1592 al foglio 319 di detta Minuta XV, a cui eodem die al foglio 321 retro, siegue la dichiarazione
dell’accollo di un cenzo bollale di tarì 21 l’anno.
69. Santa Lucia, 1593, 28 febbraio
Margaritella Arizzi rinunzia a una casa in favore dello zio Bartolomeo Maggio.
Regesto: Giuliana, VII, 428
Margaritella Arizzi, vedova del quondam Filippo e balia de’ suoi figli, in perpetuum rinunziò dicto
nomine a favore di Bartolomeo di Maggio, di lei zio, presente, una casa solarata, in questa Terra,
nella contrada Vota di Coppola; Antonio Impalà e via pubblica confinanti; nolens de eo etc. come
per atti sudetti sotto li 28 febbraio VI Indizione 1593, al foglio 564 di detto Bastardello 5.
70. Santa Lucia, 1593, 28 febbraio.
Bartolomeo Maggio concede una casa alla nipote Margaritella Arizzi.
Regesto: Giuliana, VII, 429.
Bartolomeo di Maggio, in perpetuum concedette a Margaritella Arizzi, presente, la suddetta casa,
oggi puoco pria rinunziata; soggetta a tarì 5 l’anno di cenzo perpetuo dovuto a questa Venerabile
Maggior Comunia, come Benefiziale; alla ragione di tarì 12 l’anno di cenzo perpetuo col patto che
pagando onze 4 di contanti, si estingua il capitale di detti tarì 12 l’anno, come per atti sudetti sotto
li 28 Febbraio VI Indizione 1593 al foglio 564 di detto Bastardello 5.
71. Santa Lucia, 1594, 10 ottobre.
Giuseppe Maggio fu Angelo e la moglie Gaetana vendono una casa nel feudo di Cageggi, contrada
Porticelli.
Regesto: Giuliana, VII, 3929.
Giuseppe di Magio, del quondam Angelo, e Gaetana sua moglie, in perpetuum vendettero ad
Antonina Giunta, moglie di Giuseppe del quondam Andrea, di loro cognata e sorella, presente, una
casa terrana, pe’ medesimi posseduta in comuni in questo Territorio, nel Feudo di Cagegi, contrada
Porticelli, confinante con Giuseppe di Magio del quondam Florio, Silvestro Martino e detta
Antonina compradrice; pel prezzo di onze 21.25 come allo incontro le relazioni; ed allo incontro
vedonsi le confessioni del prezzo a compimento, colla promessa della difesa, come per atti sudetti
sotto li 10 ottobre VIII Indizione 1594 al foglio 99 retro di detta Minuta XVI.
72. Santa Lucia, 1605, 21 agosto.
Diana Magio, vedova di Andrea Magio, insieme al figlio Biagio acquista dai coniugi Girolamo e
Rosella Morina mezza casa nella contrada Potielli.
Regesto: Giuliana, IX, 915.
Girolamo e Rosella Morina, marito e moglie, insolido, vendettero in perpetuum a Diana di Magio,
vedova del quondam Andrea, e Biagio di lei figlio, insolido, presenti, mezza casa, in questa Terra,
contrada Potielli, confinante con Don Domenico Pellizzeri e strada publica; la istessa casa, pe’
medesimi posseduta in comuni, pel prezzo di onze 6 netto, ex accordio, che furono confessate di
contanti; colla generale promessa della difesa, come per atti sudetti sotto li 21 Agosto III Indizione
1605, al foglio 407 retro di detto Bastardello 5. A cui siegue dichiarazione per detta casa, fatta tra’
medesimi venditori, per esser’ella di detta Rosella.
46
73. Santa Lucia, 1605, 21 agosto.
Diana Magio e il figlio Biagio soggiocano un censo bollale di 15 tarì l’anno in favore di don
Domenico Pellizzeri.
Regesto: Giuliana, IX, 916.
Diana di Magio, suddetta, e Biagio, suo figlio, sogiocarono a favore di Don Domenico Pellizzeri,
presente, un cenzo bollale di tarì 15 l’anno, col suo capitale di onze 5 che furono confessate di
contanti; colla obligazione speziale et patto de retrovendendo; come per atti sudetti sotto li 21
Agosto III Indizione 1605, al foglio 409 retro di detto Bastardello 5.
74. Santa Lucia, 1606, 21 agosto
Soggiocazione fatta da Francesco e Catarinella Maimuni.
Regesto: Giuliana, II, 4773.
Giuseppe Pagano del casale del Gisso, modo etc., come legatario delli quondam Francesco e
Catarinella Maimuni, ratificò e ratifica una sogiocazione pe’ medesimi di Majmuni sogiocata, alla
rendita di onza 1 l’anno, col suo capitale di onze 10 a favore del medesimo, come per contratto
sogiocatorio per atti di Notar Giovanni Domenico Dominedò, sotto li 21 Agosto IV Indizione 1606,
e con altre condizioni, come per essa sotto li 4 Febbrajo IX Indizione 269 retro dell’anno 1611
(Notaio Nicoletta Mendolia).
75. Santa Lucia, 1606, 18 ottobre.
Il “maestro” Leonardo Magio e la moglie Parisa, insieme ai figli “maestro” Francesco e Pasquale,
vendono mezza casa nella contrada del Borgo, fuori le mura di Santa Lucia.
Regesto: Giuliana, IX, 1507.
Maestro Leonardo e Parisa di Magio, marito e moglie, come pure Maestro Francesco e Pasquale,
loro figli, insolido, vendettero in perpetuum a Stefano e Angelella di Marco, marito e moglie, di loro
gennero e cognato, rispettivamente, presenti, mezza casa fuori le mura di questa, nella contrada del
Borgo, confinante con altra di detti di Marco, a’ medesimi dotata, strada puplica e Mariano
Floripotima, sogetta detta mezza casa a grana 10 l’anno di cenzo dovuto a questa Università; pel
prezzo di onze 10.24, come allo incontro la relazione, che furono confessati di contanti; colla
promessa della difesa, come per atti sudetti sottoli 18 ottobre V Indizione 1606, al foglio 162 di
detta Minuta 7.
76. Santa Lucia, 1611, 31 agosto.
Retrovendita di una casa nella contrada “Giudaica”.
Regesto: Giuliana, II, 4810.
Rocco e Franceschella Pandolfo, marito e moglie, dal medesimo autorizata, colla promessa de
ratho pe’ loro figli, in perpetuum retrovendettero e retrovendono a Domenico Conti, del quondam
Pietro, presente etc, una casa solarata posta in questa, nella contrada della Giudaica, gli eredi del
quondam Antonino Pagano ed esso compradore confinanti; la istessa, per il sudetto Domenico
venduta alli sudetti di Pandolfo per atti sudetti die etc. pel prezo di onze 14, come fu primamente
venduta, e di onze 4.20 di miglioramenti, che furono confessati di contanti, colla promessa della
difesa fatto e culpa tantum etc.; come per atti sudetti sotti li 31 detto (agosto 1611) al foglio 715
retro (Notaio Nicoletta Mendolia)
47
77. Santa Lucia, 1611, 20 dicembre.
Vendita di una casa in contrada “Giudaica”.
Regesto: Giuliana, II, 4824.
Niccolò, Antonino, Cristofalo e Sebastiano Foti, fratelli, figli ed eredi del quondam Mariano, come
per testamento, per atti sudetti, die etc., in solido, colla promessa de ratho si è di loro rispettivi
eredi, in perpetuum in solutum et soluti nomine vendettero al Presbitero Alessandro Foti, di loro
zio, una casa solarata ereditaria, in questa, nella contrada della Giudaica, seu Bisterna; Maestro
Giacomo Allegruzzo, Teodoro Donato e strada puplica confinanti, pel prezo di quanto sarà stimata,
colla promessa della difesa, come per atti sudetti sotto li 10 dicembre 1611, al foglio 97. (Notaio
Nicoletta Mendolia).
78. Santa Lucia, 1615, 25 agosto.
Natale Maggio, procuratore della chiesa di S. Michele Arcangelo, riceve la soggiocazione di un
censo bollale.
Regesto: Giuliana, III, 522.
Domenico e Angelella Lipari, marito e moglie, insolido, per essi e suoi, sogiocarono un cenzo
bollale di vendita di onze 2 l’anno, col suo capitale di onze 20 a favore di questa Venerabile Chiesa
di S. Michele Arcangelo e per essa a favore di Natale di Maggio, di lei Procuratore, quali onze 20
capitale sudetto furono confessate di contanti, colla obligazione generale e speziale e patto
mediante de retrovendendo, come per atti sudetti sotto li 25 detto (agosto XIII Indizione 1615), al
foglio 463 retro.
79. Santa Lucia, 1621, 25 febbraio.
Assegnazione di due case solarate nella contrada “La Giudeca”.
Regesto: Giuliana, IX, 24.
Domenico e Franceschella Conti, marito e moglie, insolido, sogiocarono assegnarono a titolo di
padrimonio al Chierico Don Onofrio , di loro figlio, presente, due case solarate, in questa, nella
contrada la Giudeca seu Maccarrunà, confinanti con la casa di Niccolò Giovanni di Gregorio,
Francesco Merulla e strade pupliche, sogetto a stretto vincolo; e colle condizioni come per atti
sudetti sotto li 25 febbraio, IV Indizione, 1621, al foglio 82 retro di detto Bastardello I, al novero 2
perché ne à due.
80. Santa Lucia, 1621, 18 marzo.
Natale Magio vende un censo bollale di due tarì l’anno.
Regesto: Giuliana, IX, 28.
Natale di Magio, in perpetuum vendette a don Alessandro Foti, presente, un cenzo bollale di tarì 2
l’anno, col suo capitale di onze 20, sogiocateli pelli quondam Damiano e Catarinella Mastroeni,
olim marito e moglie, per atti del quondam Notar Nivoletta Mendolia, sotto li 4 Agosto VIII
Indizione 1609 una con onze 11 di dicorsi maturati; pel prezzo di onze 31 capitale sudetto e dicorsi,
che furono confessate di contanti; colla cessione di ragioni e promessa della difesa culpa propria
tantum; come per atti del sudetto Notar Monastra, sotto li 18 marzo IV Indizione 1621, al foglio 97
retro di detto Bastardello I, al novero 2, perché ne à due.
48
81. Santa Lucia, 1623, 23 febbraio.
Francesco Magio, in seguito alla morte della moglie Domenichella Ficarra, restituisce al suocero i
beni dotali a suo tempo ricevuti.
Regesto: Giuliana, IX, 111.
Francesco di Magio, come olim marito della quondam Domenichella Ficarra, dicto nomine in
perpetuum ristituì a Niccolò Ficarra, di lui suocero, presente, le doti promesseli come doti e
consegnate; come per madrimonio per atti di Notar Beniamino Coppolino, die ecc; et precise, un
luogo, in questo territorio, nel Feudo e contrada Cagegi, ed una casa solarata in questa, nella
contrada Porrazza, iuxta eorum etc. come per atti di detto Notar Monastra sotto li 23 Febbraio XI
Indizione 1623 al foglio 1066 retro di detto Bastardello III.
82. Santa Lucia, 1631, 10 febbraio.
Salvo lo Presti e Antonino Mamone mettono fine a una lite relativa a una casa in contrada Santo
Niccolò.
Regesto: Giuliana, IX, 2009.
Salvo lo Presti, d’una parte, ed Antonino Mamone, dall’altra, per una casa non divisa ove sia tra
di esse parti contesa, una con i suoi benfatti, per cui, ad istanza di detto Salvo, transontato si avea
la vendizione di detta casa, fattali pel sudetto di mamone, die etc., fecero in perpetuum tra tutte e
due le parti atto di accordo; colle condizioni e quittanza, come per atti sudetti sotto li 10 Febrajo
XIV Indizione 1631, al foglio 68 di detta Minuta I la contrada si è di Santo Niccolò, juxta; a cui
siegue al foglio 73 la principale vendizione della casa contesa.
49
APPENDICE SECONDA
NOMI DI EBREI LUCIESI
RICAVATI DAI DOCUMENTI RINTRACCIATI
Iosep Alpastani, 1490 (doc. 13)
Salamone Capone, giudeo, 1496 (doc. 20)
Stefano Elia, neofita, 1527 (doc. 33)
Fiore Galefi, neofita, 1527 (LA MANTIA, N. 160)
Vito Galisi, neofita, 1527 (LA MANTIA. N. 447)
Bernardino Isaja e la moglie Sarella, 1564 (doc. 48)
Croceano Isaja, 1584 e 1586 (docc. 52 e 53)
Magnifico Francesco Isaja, 1560 (doc. 42)
Magnifica Giovanna Isaja, 1582 (doc. 51)
Maestro Pietruzzo Isaja, 1560 (doc. 43)
Magnifico Rainerio Isaja, 1560 (doc. 42)
Salvo lo Presti, 1631 (doc. 82)
Andrea Magio e la moglie Diana, 1586 (doc. 57)
Angelo Magio, 1558 (doc. 40)
Bartolomeo Magio, 1588 e 1592 (docc. 61 e 66)
Bernardino Magio, 1563 (doc. 46)
Biagio Magio, figlio di Andrea, 1605 (doc. 72)
Bitinio/Bitino Magio o Maijo e la moglie Tirona, giudei, 1485 (doc. 9), 1496 (doc. 20)
Clemente e Domenico Magio, 1571 (doc. 50)
Diana Magio, vedova di Andrea, 1605 (docc. 72 e 73)
Maestro Ferdinando Maijo, giudeo, 1496 (doc. 20),1510 (doc. 25); neofita, 1512 (doc. 26)
Florio Magio, 1558 (doc. 39)
Maestro Leonardo Magio e la moglie Parisa, 1606 (doc. 75)
Giuseppe Magio di Angelo e la moglie Gaetana, 1588 (doc. 61)
Giuseppe Magio di Florio, 1588 (doc. 62)
Natale Magio, 1615, 1621 (docc. 78 e 80)
Pietro Magio e la moglie Maria, 1589 (doc. 63)
Francesco Maimuni e la moglie Catarinella, 1606 (doc. 74)
Antonella Maiolino, neofita, 1540 (GARUFI, p. 14)
Cola Maiolino, neofita, 1521(LA MANTIA, n. 117)
Antonino Mamone, 1631 (doc. 82)
Domenico Mamone e la moglie Agrippina, 1549 (doc. 38)
Girolamo e Romana Mazzara, giudei,1497 (doc. 24)
Isacco Mazzara, giudeo, 1496 (doc. 24)
Benedicto Muleto, neofita, ? (ASP, Ricevitoria, registri XX e XXI)
Flore Mustaza, neofita, ? (ASP, Ricevitoria, registro XX)
Rosa de Neapoli, neofita, 1540 (Garufi, p. 14)
Pietruzzo Patti, neofita, 1497 (doc. 22)
Maestro Giovanni Rubini, neofita, 1521 (doc. 28)
Desiata Santa Lucia, neofita, 1521 (LA MANTIA, n. 132)
Marquesia Stagno, neofita, 1521 (LA MANTIA, n. 349)
Magnifico Giacomo Staiti, neofita, 1497 (doc. 23)
Paolo Staiti e moglie, neofiti, 1520 (doc. 27)
50
APPENDICE TERZA
CONTRADE LUCIESI IN CUI GLI EBREI AVEVANO PROPRIETA’
Bernardimura, casa, 1521 (doc. 28)
Bisterna (= Giudaica), 1611 (doc. 77)
Canalicchio,manganelli di seta, 1584 e 1586 (docc. 52 e 55)
Casanova, gelseto, 1492 (doc. 20)
Conzarie, bottega e casa, 1527 (doc. 33)
Giribotta, gelseto e canneto, 1587 (doc. 59)
Giudaica, case, 1526 (docc. 30 e 31), 1534 (doc. 34), 1543 (doc. 36), 1549 (doc. 37), 1566 (doc. 49),
1586 (doc. 58), 1589 (doc. 63), 1611 (docc. 76 e 77), 1621 (doc. 79)
Maccarrunà (= Giudaica), case, 1621 (doc. 79)
Moschita, case, 1526 (doc. 29)
Pancaldo, piante e terreno, 1497 (doc. 22)
Pantana (feudo di Cageggi), terreno, 1558 (doc. 41)
Porticelli (feudo di Cageggi), uliveto e gelseto, 1558 (doc. 40), 1571 (doc. 50), 1588 (doc. 61 e 62),
1591 (doc. 65), 1592 (doc. 68) , 1594 (doc. 74)
S.Filippo, piante e terreno, 1497 (doc. 21)
Sotto Porta Valle, gelso, 1497 (doc. 23)
Timpanara, uliveto e vigneto, 1589 (doc. 64)
Valli, botteghe, 1510 (doc. 25); casa, 1563 (doc. 46))
Vallone di Mangarunà (= Giudaica), casa, 1586 (doc. 58)
Vota di Coppola, casa, 1592 (docc. 66, 67 e 69)
51
APPENDICE QUARTA
PROSPETTO DEI NOTAI LUCIESI I CUI ATTI SONO REGESTATI
NELLA “GIULIANA PARISI”
NOME DEL NOTAIO PAESE DI
ORIGINE
PERIODO
ATTIVITA’
A S. LUCIA
TOMO
DELLA
GIULIANA
Antonino Cortina Santa Lucia 1477-1522 VIII
Domenico Impò Santa Lucia 1503-1563 VIII
Giovan Filippo Giorgio Raccuja 1540-1595 XI
Antonino Meo Rometta (?) 1542-1599 VII
Giovan Filippo Guidotti Santa Lucia 1542-1599 VIII
Nicoletta Mendolia Massa (Messina) 1569-1621 I-II
Girolamo Sterrantino Santa Lucia 1585-1587 VIII
Giovan Domenico Dominedò Patti 1600-1608 IX
Giovanni Maria Cassisi Taormina 1604-1608 IX
Giuseppe Fulco Santa Lucia 1607-1626 VI
Giovan Domenico Lombardo Forza d’Agrò 1607-1648 III
Vincenzo Faraci Paternò 1616-1618 IX
Domenico Cirino Santa Lucia 1618-1651 V
Michele Monastra Santa Lucia 1619-1627 IX
Francesco Aricò Messina 1630-1633 IX
Giuseppe Impalà Santa Lucia 1634-1646 X
Francesco Pizzo Santa Lucia 1655-1686 IV
52
APPENDICE V
SANTA LUCIA, DA CASALE A CITTÀ.
BREVE EXCURSUS STORICO
Premessa
Appare chiaro a chiunque che per potere fare piena luce sulla storia degli Ebrei di Santa Lucia
occorre innanzitutto conoscere dettagliamente la storia dell’intera comunità luciese, della quale la
componente giudaica fu, prima in maniera evidente, poi in maniera sommersa, una parte vitale e
trainante. La stessa scelta del territorio luciese per un insediamento giudaico si giustifica con la
particolare situazione giuridica, amministrativa e religiosa di quella “terra”. Ritengo opportuno,
pertanto, tracciare (anche se solo per sommi capi) la storia di questo insediamento urbano, quale può
essere ricostruita attraverso la documentazione esistente.
1. Una storiografia da rivedere.
L’Abate benedettino Vito Amico, nell’accingersi a scrivere la storia della Prelatura di Santa Lucia,
dovette confessare che il periodo dalle origini fino al 1600 gli risultava così ingarbugliato da riuscire
quasi impossibile trovare il bandolo della matassa153. Il motivo di tanta confusione era semplice. Per
comprensibili interessi economici, era stata “montata” una storia fondata su documenti
dichiaratamente falsi154 o addirittura inesistenti. Una volta costruito, quel fantastico castello di carta
era piaciuto a tutti. E così gli storiografi successivi si sono limitati a ripetere la struttura esistente,
senza procedere ad alcuna verifica documentaria, ma anzi aggiungendo all’originario racconto
nuove fantasie spacciate per storia. È così che Gregorio Mostaccio, titolare per un breve periodo del
beneficio delle rendite della chiesa di Santa Lucia, diventa, chissà come, “Prelato di Santa Lucia e
Cappellano Maggiore del Regno”! È così che Federico II di Svevia diventa un frequentatore assiduo
di Santa Lucia, dove tiene le riunioni segrete della “Scuola Poetica Siciliana”! È così che il castello
costruito ex novo da Federico II d’Aragona nel 1322, diventa un castello arabo! È così che Pier delle
Vigne, caduto in disgrazia, trova miseranda morte nella torre del castello di Santa Lucia! Eccetera,
eccetera.
Il risultato è che su Santa Lucia esistono tanti bei racconti fantastici, ma, fino a questo momento,
questa gloriosa cittadina tirrenica è stata privata della possibilità di conoscere la sua vera storia.
Appare evidente, dunque, l’esigenza di procedere a una revisione critica della storiografia esistente
sulla scorta rigorosa della documentazione archivistica, finora esaminata solo in minima parte.
2. Le origini del casale.
L’abate Francesco Sacco, scrivendo nell’anno 1800 la voce “Santa Lucia” per il suo Dizionario
Geografico del Regno di Sicilia, affermava che “circa l’origine di questa Città nessuno autore ne
ha finora data qualche notizia, ma solamente si trova ch’esisteva ne’ tempi de’ Normanni”155.
In realtà la prima notizia che possediamo di un toponimo “Santa Lucia” nella piana di Milazzo si
riferisce a una chiesa che il Gran Conte Ruggero fondò, unitamente a quella di S. Filippo,
153
“At adeo incerta ad annum pene 1600 tricisque implexa ea est, ut explicari vix possit” (AMICO, p. 1346v). 154
Basti dire che gli storici locali luciesi hanno sempre prestato fede al Codice Arabo-Siculo dell’abate Vella (sulla cui falsità
la critica storica si è pronunciata da tempo) e agli scritti di mons. Airoldi ad esso collegati. Sulla “impostura” del Vella si
veda: A. BAVIERA ALBANESE, Il problema dell'arabica impostura dell'abate Vella, in D. SCINÀ, L'arabica impostura, Palermo
1978, pp. 87-153. 155
F. SACCO, Dizionario geografico del Regno di Sicilia, Palermo 1800, p. 188.
53
quest’ultima affidata ai monaci “basiliani”156. La data di questa fondazione non ci è nota, ma va
collocata fra il 1082 (anno della dotazione della Chiesa di Troina, fra i cui beni non compare la
chiesa di Santa Lucia) e il 1094 (anno in cui il Gran Conte conferma una precedente donazione nella
quale era compresa la chiesa di Santa Lucia, con relative terre e sette villani). Dal tenore del
diploma di conferma si rileva che la chiesa di Santa Lucia era di competenza di Goffredo
Burrello157.
3. La dipendenza dalla diocesi di Patti e Lipari.
Qualche anno prima del 1094, dunque, la chiesa di Santa Lucia, sita nella campagna di Milazzo, in
seguito a una donazione, passa dalla giurisdizione del vescovo di Messina a quella di Ambrogio,
abate del monastero di S. Bartolomeo nell’isola di Lipari e del monastero del S. Salvatore di Patti,
ma le decime restano assegnate al precedente proprietario. Quando poi, nell’ottobre dell’anno 1131,
Ugone, arcivescovo di Messina, stabilisce la dotazione della nuova diocesi suffraganea di Lipari-
Patti, la chiesa di Santa Lucia passa integralmente a far parte della nuova “mensa” vescovile, con
tutte le sue decime158.
Attorno alla chiesa e nei terreni di sua pertinenza si venne costituendo un agglomerato di civili
abitazioni, cioè un “casale”, di cui troviamo traccia nella documentazione esistente a cominciare dal
regno di Ruggero II, attraverso un diploma del 1136 che invita i baiuli di Milazzo a non sottoporre
ad alcun pagamento o servizio gli abitanti lombardi di Santa Lucia, i quali già sono soggetti alla
“marinaria”159, cioè alla fornitura annuale di 20 marinai per la flotta reale160.
Il casale di Santa Lucia dipendeva per l’amministrazione civile da Milazzo, anzi si chiamava
proprio “Santa Lucia di Milazzo”161. L’amministrazione ecclesiastica e fiscale rientrava, invece,
nelle competenze della diocesi di Patti e Lipari, di cui Santa Lucia era una “oboedientia”162.
Il diritto di possesso del vescovo di Patti e Lipari sulla chiesa di Santa Lucia si protrae fino al 1249,
anno in cui Santa Lucia, che nel frattempo è diventata “casale” (cioè un raggruppamento di case
sprovvisto di opere difensive e di autonomia amministrativa – oggi diremmo “una frazione”), in
seguito a una permuta, passa fra i beni della Regia Curia163.
4. La consistenza del casale e il passaggio al regio demanio.
Il 20 luglio 1249, in seguito a preciso incarico ricevuto dalla Regia Curia, il notaio Nicola di
Caronia, assistito da due funzionari (il giudice e il pubblico notaio di Milazzo), si recò nel casale di
Santa Lucia e interrogò quindici testimoni, stendendo un dettagliato verbale ancora oggi conservato
nell’Archivio Capitolare di Patti164. Compito dei suddetti funzionari era quello di stabilire quanto la
diocesi di Patti e Lipari ricavava dal suddetto casale (che in pratica era costituito da Santa Lucia e S.
Filippo), valutando dettagliatamente tutte le entrate (banco di giustizia, dogana, decima sugli
animali da allevamento, ricavato dei mulini, decime sulla produzione di frumento ed orzo, decima
sul mosto, giornate lavorative gratuite che gli abitanti devono prestare nei terreni della chiesa). Il
156
V. AMICO, Notitia vigesima prima Sancti Philippi de S. Lucia, in R. PIRRI, Sicilia sacra disquisitionibus et notitiis
illustrata, Palermo 1733 (rist. Sala Bolognese 1987), p.1057. 157
ACP, Fondazione, I, f. 54; R. PIRRI, op. cit., pp. 771-772. 158
R. PIRRI, op. cit., p. 773 159
R. GREGORIO, Considerazioni sopra la storia di Sicilia dai tempi normanni sino ai presenti, Palermo 1845 (rist. Palermo
1972), vol. I, p. 104, nota 4. 160
Come si ricava da un diploma di Federico II del settembre 1208 (Documenta Pactensia, 2.I. L’età sveva e angioina, a
cura di Paolo De Luca, Messina 2005, pp. 35-36). 161
ACP, Pretensioni varie, f. 82; C. A. GARUFI, Censimento e catasto della popolazione servile. Nuovi studi e ricerche
sull’ordinamento amministrativo dei Normanni in Sicilia, in “Archivio Storico Siciliano”, N.S., XLIX (1928), pp. 96-97. 162
ACP, Fondazione, I, f. 208; K. A. KEHR, Die Urkunden, cit., pp. 456-457; M. SCHIAVO, Memorie per servire alla storia
letteraria della Sicilia, vol. I, Palermo 1756, pp. 147 sgg. 163
ACP, Fondazione, I, f. 251; D. GIRGENSOHN - N. KAMP, Urkunden und Inquisitionen des 12. ud 13. Jahrhunderts aus Patti,
in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», XLV (1965), pp. 135-136; Documenta Pactensia
, cit., pp. 74-78. 164
ACP, Pretensioni varie, f. 87; D. GIRGENSOHN - N. KAMP, op. cit. , pp. 133-141; Documenta Pactensia , cit., pp. 59-66.
54
totale, calcolato secondo la moneta dell’epoca, risultò di 1519 tarì e 10 grana. Le famiglie residenti
nei due casali al momento del sopralluogo erano 118. Il verbale parla anche delle costruzioni
esistenti: la chiesa di Santa Lucia, un palazzo, poche abitazioni, un granaio, due stalle, 24
magazzini. Di castelli neanche l’ombra.
La descrizione dei confini dei due casali, per quanto dettagliata e minuziosa, non ci consente, a
distanza di 750 anni, di definire con precisione la loro ubicazione. Unici punti di riferimento sono i
casali di Gaidara (oggi Soccorso, frazione di Gualtieri Sicaminò) e Pancaldo (oggi S. Giovanni,
frazione di Santa Lucia del Mela), rispetto ai quali S. Filippo e Santa Lucia si trovavano sicuramente
ad occidente.
Ulteriori ragguagli sul sito di Santa Lucia anteriormente al 1322 ci vengono forniti dal cronista
Bartolomeo da Neocastro, il quale, raccontando il viaggio compiuto da Pietro I d’Aragona nel 1282
da Palermo a Messina, afferma che Santa Lucia, dove il nuovo sovrano trascorse una notte insonne,
impegnato a resistere alle profferte amorose di Macalda da Scaletta, si trovava “a due miglia da
Milazzo”, vale a dire ad occidente dell’odierna strada statale N. 113, dalla quale ancora nel 1861
Milazzo distava “tre sole miglia”165.
Determinante risulta, infine, la notizia fornita dal cappuccino Francesco Perdichizzi, il quale precisa
che la chiesa di Santa Lucia sorgeva un tempo “nella valle di Mangarrone, sotto S. Filippo”166.
Comunque sia, i funzionari incaricati della stima delle rendite che il vescovo di Patti e Lipari
ricavava dal casale di Santa Lucia (e S. Filippo), provvidero a trovare anche un altro luogo avente
press’a poco la stessa rendita, in maniera da procedere alla permuta richiesta. Fu così che dal 1249
al vescovo di Patti e Lipari venne assegnato il casale di Sinagra e una parte del bosco di Ficarra,
mentre Santa Lucia e S. Filippo passarono al regio demanio.
5. Santa Lucia ritorna sotto la giurisdizione del vescovo di Patti e Lipari.
Alla morte di Federico II (13 dicembre 1250) seguì un periodo di estrema confusione, in cui dovette
trovarsi coinvolta anche la chiesa di Santa Lucia, perché nella documentazione postfedericiana la
troviamo nuovamente sottoposta alla giurisdizione del vescovo di Patti e Lipari, come se il
passaggio al regio demanio non fosse mai avvenuto. Nel 1262, infatti, il re Manfredi ordina
l’esecuzione di un’inchiesta per accertare l’esenzione della diocesi pattese dall’obbligo di fornire
annualmente venti marinai alla flotta reale, obbligo discendente dal possesso del casale di Santa
Lucia167 e già oggetto di esenzione sin dai tempi di Guglielmo II168. La situazione rimane invariata
anche durante il dominio angioino. In quest’ultimo periodo, inoltre, vediamo il vescovo di Patti e
Lipari costretto a rivolgersi alla sede apostolica per contrastare le intrusioni del protopapa di
Milazzo, dipendente dall’arcivescovo di Messina, nel territorio luciese, evidentemente ancora
pertinente alla giurisdizione vescovile pattese169.
6. La fondazione e la fortificazione della “Terra” di Santa Lucia.
La situazione muta radicalmente nel 1322, a seguito di un provvedimento di Federico III d’Aragona
che dà un nuovo assetto alla situazione abitativa della piana di Milazzo. Di fronte a una situazione di
guerra quasi continua, il sovrano prende una decisione drastica: costruisce un luogo fortificato sul
cocuzzolo della “motta” di Mangarrone e invita gli abitanti del casale di Santa Lucia e dei casali
circonvicini a trasferirsi nel nuovo insediamento, dove essi godranno di privilegi particolari (gli
stessi diritti dei cittadini di Messina, lo status di “terra demaniale” non soggetta ad alcun barone, la
difesa garantita da un’apposita guarnigione in caso di attacco nemico).
Secondo una notizia riportata in un manoscritto dello storico luciese Silvestro Pulejo e della quale
ignoriamo la fonte, i casali che accettarono l’invito di Federico III furono (oltre, ovviamente, a Santa 165
Milazzo contro la Sotto-Prefettura a Barcellona. La delibera consiliare del 30 novembre 1861, in Milazzo nostra, Milazzo
1999, p. 26. 166
F. PERDICHIZZI, Melazzo sagro, (trascrizione, commento e note di F. Ruvolo), Milazzo 1996, pp. 102-103. 167
Cfr. Documenta Pactensia, cit., pp. 35-36 (diploma del settembre 1208). 168
D. GIRGENSOHN-N. KAMP, op. cit, pp. 165-166 (diploma del novembre 1177). 169
Cfr. Documenta Pactensia, cit., pp. 355-357 (atto del 3 dicembre 1280).
55
Lucia) quelli di Grazia, S. Nicolò, Murmuka, S. Biagio, S. Cono, Agrilla e S. Pier Trifone (da
leggere, forse, “S. Pier Trisino”, antico nome dell’attuale Pace del Mela)170.
La nuova aggregazione di diversi casali nasce con lo status giuridico-amministrativo di “terra”. Non
è, cioè un “casale” dipendente da un centro più grande, ma ha una propria identità amministrativa
autonoma, con il proprio capitano di giustizia e i propri giurati. È giuridicamente alla stessa stregua
di Milazzo, Rometta, Patti e Castroreale, quest’ultimo fondato nello stesso anno e con analogo
procedimento di aggregazione di casali sparsi.
7. Il castello aragonese.
Il documento di fondazione della nuova “terra” di Santa Lucia si trova trascritto integralmente nel
“Libro Rosso” o “Libro del Sindaco”, attualmente irreperibile. Padre Giovanni Parisi, che ebbe la
fortuna di poterlo esaminare, ne trascrisse solo la parte più importante171. Sapendo leggere il latino e
soprattutto sapendo capirlo, lo storico luciese si rese conto benissimo che la costruzione difensiva
voluta da Federico III era un castello costruito di sana pianta172. Tuttavia non volle arrendersi
all’evidenza documentaria e continuò ad insistere sulla tesi del castello arabo, anzi bizantino, se non
addirittura (perché no?) greco.
Per fedeltà alla verità storica, questa tesi deve essere definitivamente abbandonata. È fuor di dubbio,
infatti, che anteriormente al 1322 Santa Lucia non possedeva alcun castello o altra opera fortificata
per il semplice fatto che gli scrupolosissimi funzionari che nel 1249 rilevarono la consistenza del
casale non ne fanno parola. Sta a comprovarlo una caterva di documenti, tra i quali basterà citare
l’elenco ufficiale dei castelli di Sicilia esistenti sotto Carlo d’Angiò173, nel quale non compare Santa
Lucia, e la cronaca di Bartolomeo da Neocastro, il quale precisa che Pietro I d’Aragona nel 1282
passò la notte in una casa privata di Santa Lucia (non potendo ovviamente albergare in un castello
inesistente)174.
8. Il titolo di città demaniale.
Il notaio Giuseppe Parisi, compilatore della omonima “Giuliana”, attesta che a cominciare dall’anno
1613 l’entità territoriale corrispondente a Santa Lucia, che fino a quel momento veniva definita
“terra”, cominciò a chiamarsi “città”175. Era un’anticipazione del titolo ufficiale che arriverà nove
anni dopo con un provvedimento del vicerè Francesco del Castro176. Lo status di città demaniale era
talmente ambito e comportava tanti e tali “privilegi” che, quando Filippo IV nel 1629 decise di
cedere Santa Lucia a un privato acquirente e di trasformarla quindi in terra baronale, i luciesi non ci
pensarono due volte e si fecero in quattro per racimolare le 6400 onze necessarie per il riscatto della
propria città177.
9. Origine e vicende della Prelatura.
Una specie di “congiura” antistorica vorrebbe fare risalire l’istituzione della Prelatura di Santa Lucia
a Federico II di Svevia, che nell’anno 1206 ne avrebbe concesso il beneficio al suo cappellano
Gregorio Mostaccio. Niente di più falso.
170
Trovo questa notizia in PARISI, p. 272, nota 8, che cita un manoscritto del 1813, conservato nell’Archivio Arcivescovile di
Messina ma oggi irreperibile, dal titolo Saggio di Istoria, ossia raccolta di documenti relativi alla Cappellania maggiore ed
Abazia di S. Lucia, cominciando dal 1250, epoca della sua fondazione. 171
PARISI, p. 272, nota 8; v. supra, nota 46. 172
G. PARISI, Tutto sul castello di S. Lucia del Mela, Messina 1987, p. 52. 173
DI CHIARA, pp. 21-23 della Series Diplomatum (documento del 3 maggio 1272). 174
B. NEOCASTRO, op. cit., p. 78. 175
Giuliana, III, 387. 176
ACSL, Corte Giuratoria, 1621-1626, vol. I, f. 129r (provvedimento del 31 gennaio 1622). Milazzo aveva ottenuto il
titolo di “città” nel 1620 (cfr. G. MODESTO, Gli Arcipreti di Milazzo dal Concilio di Trento ai nostri giorni, in Milazzo
nostra, Milazzo 1999, p. 17). 177
PARISI, pp. 295-300.
56
Intorno al 1230178, essendo la sede vacante, il Mostaccio fu a un soffio dal diventare vescovo di Patti
e Lipari. I documenti gli danno il titolo di “eletto”179, termine col quale si indicava il vescovo
designato dal Capitolo, prima che ottenesse le necessarie conferme dal sovrano e dal papa.
Purtroppo all’ultimo momento qualcosa deve essere andato storto. Forse mancò al Mostaccio
l’assenso papale (evento non raro a quei tempi, a causa dei contrasti fra l’imperatore e il papa). È
probabile allora che Federico II, per compensarlo della mancata nomina, abbia deciso di assegnargli
il “beneficio” delle rendite del casale di Santa Lucia. Lo poteva fare perché, come re di Sicilia,
aveva la disponibilità dei beni ecclesiastici nel periodo di sede vacante. È ovvio che appena la
diocesi di Patti e Lipari riebbe un titolare, questi si affrettò a chiedere la restituzione del “beneficio”
di Santa Lucia. Da qui nacque una disputa che venne risolta solo nel 1252, due anni dopo la morte di
Federico II, con la rinuncia del Mostaccio al suddetto “beneficio” (di Santa Lucia e poi, come
abbiamo visto, di Sinagra), dietro congruo risarcimento180.
La vicenda Mostaccio sta tutta in questi termini. Mostaccio fu per un breve periodo “beneficiale” di
Santa Lucia, nominato direttamente da Federico II perché in quel frangente la sede vescovile di Patti
e Lipari era vacante. Nulla di più. I documenti non parlano né di Prelato, né di Abate, né di Regio
Cappellano, né tanto meno di vescovo di Santa Lucia. D’altro canto lo stesso Vito Amico lo ha
scritto in maniera chiarissima: “Da nessuna parte trovo scritto che Gregorio Mostaccio sia stato
Cappellano Maggiore”181.
Quando, nel 1322, il casale di Santa Lucia assunse il nuovo status di “terra demaniale” e di luogo
fortificato, i suoi abitanti non ricaddero più nella giurisdizione spirituale della diocesi di Patti e
Lipari, ma in quella del Maestro Cappellano Maggiore del Regno di Sicilia. Conseguentemente i
“beneficiali” di Santa Lucia non vennero più nominati dal presule pattese, ma dal titolare della
Regia Cappella Palatina di Palermo. E se l’assenza di un’autorità religiosa sul posto spinse talvolta
gli arcivescovi di Messina o i vescovi di Patti e Lipari a tentare di mettere le mani sulle rendite di
Santa Lucia, il Maestro Cappellano Maggiore di Palermo si premurò ogni volta a fare intervenire in
maniera energica il sovrano per difendere le proprie prerogative e soprattutto le prestazioni in
denaro e in natura spettanti ai suoi beneficiali182.
C’è di più. Una ricerca compiuta da mons. Carlo Santacolomba, che fu Prelato di Santa Lucia dal
1780 al 1801 e quindi poté esaminare documenti oggi preclusi all’occhio dei ricercatori, afferma in
maniera inequivocabile che, “i Beneficiali di Santa Lucia successori di Gregorio Mostaccio e
predecessori dei presenti Abati non sono stati, come tali, Maestri Cappellani del Regno, ma sibbene
dopocché fin dalla riferita loro fondazione siano stati sempre sudditi del Maestro Cappellano, ne
hanno finalmente usurpato il titolo”183.
Ad analoga conclusione sono giunti due storici molto autorevoli, come Rosario Gregorio e
Domenico Scinà. Il primo afferma esplicitamente, infatti, che “potè il beneficiale della terra di
Santa Lucia nella Piana di Milazzo, che era una delle cappelle reali e facea parte della diocesi del
cappellano maggiore, per lungo tempo arrogarsene il titolo e la dignità”184. Lo Scinà, da parte sua,
sostiene che l’Abate Vito Amico, nelle sue aggiunte al Pirri, “si mostrò più avido di raccogliere
notizie, che paziente nell’esaminarle… e carte e diplomi inserì dati a lui dall’abate di Santa Lucia
monsignor Barbara, che non sono degni di fede e per apocrifi si reputano”185.
A cominciare dal 1458, per motivi che fino ad oggi nessuno storiografo ha saputo spiegare, il
beneficiale di Santa Lucia si trova investito, di punto in bianco, del titolo di “Abate”186
. Da
questo momento inizia un’escalation che vedrà salire i beneficiali sempre più in alto. Nel 1552,
il regio visitatore Giacomo Arnedo, dà al prelato Girolamo Zaffarana la qualifica di Cappellano
178
Cfr. D. GIRGENSOHN-N. KAMP, op. cit, p. 39 179
R. PIRRI, op. cit, p. 777. 180
ACP, Fondazione, II, f. 239; D. GIRGENSOHN-N. KAMP, op. cit., pp. 148-151. 181
“Gregorium …Mustaccio nullibi dici Majorem Cappellanum” (V. AMICO, Notitia, cit, p. 1347r). 182
Si veda, per esempio, l’ordine di non molestare il clero di Santa Lucia inviato il 7 marzo 1406 dal re Martino I al
vescovo di Patti (DI CHIARA, Series Diplomatum, pp. 64-65). 183
BCP, ms. Qq.H.121, f. 359. 184
R. GREGORIO, op. cit, III, p. 139. 185
D. SCINÀ, Prospetto della storia letteraria di Sicilia nel secolo decimottavo, Palermo 1859 (rist. 1969), I, p. 196. 186
DI CHIARA, p. 46 (il relativo documento è riportato a p. 79 della sezione “Series Diplomatum”).
57
maggiore sulla parola del diretto interessato (“ut inquit dictus Reverendus Capellanus”), ma è
costretto ad ammettere l’inesistenza di qualsiasi documentazione al riguardo (“sed super hac re
nullam potuimus invenire scripturam”)187
. Poi, di novità in novità, si arriverà alla dignità
vescovile. Ma questa è storia relativamente recente. Scrive, infatti, padre Giovanni Parisi che “il
Prelato ordinario di S. Lucia in origine e per diversi secoli non era insignito del carattere
episcopale. Fu mons. Scipione Ardoino … che ottenne dal re di potere essere elevato dalla
Santa Sede alla dignità vescovile … nel 1769”188
.
10. Santa Lucia Vecchia e Santa Lucia Nuova.
Quanto fin qui esposto ci porta alla conclusione che la storia di Santa Lucia deve essere divisa in
due tronconi: prima e dopo del 1322. Santa Lucia Vecchia fu un casale aggregato a Milazzo, da cui
distava appena due miglia, privo di qualsiasi fortificazione, abitato da Lombardi, sottoposto
ecclesiasticamente alla giurisdizione del vescovo di Patti e Lipari e abbandonato nel 1322. Santa
Lucia Nuova fu, invece, una “Terra” autonoma, distante da Milazzo circa sei miglia, abitata da
gruppi di diversa provenienza, difesa da un castello nuovo di zecca e sottoposta, come cappella
reale, alla giurisdizione religiosa del Cappellano Maggiore del Regno.
L’economia del presente lavoro non mi consente di soffermarmi ulteriormente sulla storia di
Santa Lucia. Mi auguro che un’auspicabile sinergia fra gli enti preposti alla riscoperta e alla
conservazione del passato possa agevolare una paziente e minuziosa ricerca documentaria
mirata a restituire ai cittadini luciesi le loro vere e genuine radici.
187
DI CHIARA, Series Diplomatum, pp. 106-107. 188
PARISI, pp. 246-247.
58
BIBLIOGRAFIA
D. ABULAFIA, Le attività economiche degli ebrei siciliani attorno al 1300, in Italia Judaica–V. Gli ebrei
in Sicilia sino all’espulsione del 1492. Atti del V convegno internazionale, Palermo 15-19 giugno1992,
Roma 1995, pp. 89-95.
M. AMARI, Storia dei musulmani di Sicilia, Catania 1933-35, vol. I, p. 617; vol. II, pp. 29-43.
V. AMICO, Notitia sexta Cappellaniae Majoris S. Luciae de Milatio, in R. PIRRI, Sicilia sacra
disquisitionibus et notitiis illustrata, Palermo 1733 (rist. Sala Bolognese 1987), pp. 1346-1352.
V. AMICO, Dizionario topografico della Sicilia, vol. I, Palermo 1856 (rist. Bologna 1983), pp. 626-627.
A. BAVIERA ALBANESE, Il problema dell'arabica impostura dell'abate Vella, in D. SCINÀ, L'arabica
impostura, Palermo 1978, pp. 87-153.
S. BOESCH GAJANO, Per una storia degli Ebrei in Occidente tra antichità e medioevo. La testimonianza
di Gregorio Magno, in «Quaderni medievali», n. 8 (dicembre 1979), pp. 12-43.
N. BUCARIA, Sicilia judaica. Guida alle antichità giudaiche della Sicilia, Palermo 1996.
S. CAMBRIA, La Prelatura nullius di Santa Lucia del Mela, Palermo 1962.
G. CANDURA, Le 42 città demaniali nella storia della Sicilia, Catania-Caltanissetta 1973.
R. CANOSA-I.COLONNELLO, Storia dell’Inquisizione di Sicilia dal 1600 al 1720, Palermo 1989.
F. CHILLEMI, Le comunità ebraiche medievali nei Peloritani, in «Capo Peloro», III (1997), pp. 27-29.
F. CHILLEMI, Le giudecche dei Nebrodi tra assimilazione forzata ed espulsione, in S. BOTTARI (a cura
di), Problemi e aspetti di storia dei Nebrodi, Marina di Patti 1999, pp. 53-76.
C. COLAFEMMINA, Donne, ebrei e cristiani, in «Quaderni medievali», n. 8 (dicembre 1979), pp. 117-
125.
S. CUCINOTTA, La Madonna della Neve e le sue vicende. Documenti e notizie luciesi, Messina 1926.
P. DE LUCA, Le pergamene di età sveva nell’Archivio Capitolare di Patti, Messina 1997,
G.E. DI BLASI, Storia cronologica de’ Vicerè, Luogotenenti e Presidenti del Regno di Sicilia, rist.
Palermo 1974-75, vol. I, pp. 295-307.
S. DI CHIARA, De Capella Regis Siciliae, Palermo 1815.
G. DI GIOVANNI, L'ebraismo della Sicilia, Palermo 1748 (rist. Forni 1976).
G. DI MARZO, I Gagini e la scultura in Sicilia nei secoli XV e XVI, memorie storiche e documenti,
Palermo 1880, vol. II, pp. 136-137.
DISTRETTO SCOLASTICO 037 MILAZZO, I mestieri dell’artigianato e le botteghe dell’arte, Milazzo 1998.
P.G. DONINI, Le comunità ebraiche nel mondo, Roma 1988, p. 104.
I. ELBOGEN, Messina, in «Rivista israelitica», I (1904), pp.108-111
F.M. EMANUELE E GAETANI, MARCHESE DI VILLABIANCA, Le città demaniali della Sicilia, Palermo 1989.
T. FAZELLO, Storia di Sicilia, 2 voll., Palermo 1991.
N. FERORELLI, Gli ebrei nell’Italia meridionale dall’età romana al secolo XVIII, Torino 1915 (rist.
Bologna 1966).
C. FILANGERI, Mirto. La storia, in: COMUNE DI MIRTO, Mirto. Il suo patrimonio artistico e culturale,
Mirto 1988, pp. 9-13.
J.B. FREY, Corpus inscriptionum judaicarum, 2 voll., Città del Vaticano 1936-1952.
C.D. GALLO - G. OLIVA, Gli annali della città di Messina, tomo II, Messina 1758 (rist.anast. Forni
1980).
C. A. GARUFI, Fatti e personaggi dell’Inquisizione in Sicilia, Palermo 1978.
C. GEBBIA, Comunità ebraiche nella Sicilia imperiale e tardoantica, in «Archivio storico per la Sicilia
orientale», LXXV (1979), pp. 241-275.
C. GEBBIA, Presenze giudaiche nella Sicilia antica e tardoantica, Roma 1996.
M. GIL, The Jews in Sicily under Muslim Rule, in the light of the Geniza Documents, in Italia Judaica.
Atti del I convegno internazionale, Bari 18-22 maggio 1981, Roma 1983, pp. 87-134.
D. GIRGENSOHN – N. KAMP, Urkunden und Inquisitionen des 12. und 13. Jahrhunderts aus Patti, in
«Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», XLV (1965).
F. GIUNTA, Dossier Inquisizione in Sicilia, Palermo 1991.
59
S.D. GOITEIN, A Mediterranean Society, Berkeley 1967-1988, 5 voll.
S.D. GOITEIN, Sicily and Southern Italy in the Cairo Geniza documents, in “Archivio Storico per la
Sicilia Orientale”, LXVII (1971), pp. 9-33.
GREGORII I PAPAE, Registrum epistolarum, edd. P. Ewald-L. Hartmann, MGH, Epistolarum I, Berlino
1957.
R. GREGORIO, Considerazioni sopra la storia di Sicilia dai tempi normanni sino ai presenti, Palermo
1845 (rist. Palermo 1972).
E. IACHELLO (a cura di), L’isola a tre punte. La Sicilia dei cartografi dal XVI al XIX secolo, Catania
1999, p. 34 (carta n. 32) e p. 49 (carta n. 47).
Italia Judaica–V. Gli ebrei in Sicilia sino all’espulsione del 1492. Atti del V convegno internazionale,
Palermo 15-19 giugno1992, Roma 1995.
K.A. KEHR, Die Urkunden der normannisch-sicilischen Könige, Innsbruck 1902.
R. LA FRANCA, Caratteri insediativi e memoria dei luoghi ebraici di Sicilia, in Italia Judaica–V. Gli
ebrei in Sicilia sino all’espulsione del 1492. Atti del V convegno internazionale, Palermo 15-19
giugno1992, Roma 1995, pp. 253-.267.
B. E G. LAGUMINA, Codice diplomatico dei giudei di Sicilia, 3 voll., Palermo 1884-1895 (rist. 1990).
I. LA LUMIA, Gli ebrei siciliani, Palermo 1984.
V. LA MANTIA, Origine e vicende dell’Inquisizione in Sicilia, Palermo 1977.
F. LIONTI, Documenti relativi agli Ebrei di Sicilia, in «Archivio Storico Siciliano», N. S., VIII (1883),
pp. 149-169.
F. LIONTI, Gli ebrei e la festa di S. Stefano Protomartire, in «Archivio Storico Siciliano», N.S., VIII
(1883), pp. 463-482.
T. LO JACONO, Judaica Salem, Palermo 1990.
T. LO JACONO, Le stanze di Isacco, Salemi 1992.
A. MESSINA, Le comunità ebraiche della Sicilia nella documentazione archeologica, in «Henoch», III
(1981), pp. 200-219.
V. MESSORI, Ipotesi su Gesù, Torino 1976.
A. MILANO, Storia degli ebrei in Italia, Torino 1992.
M.G. MILITI, Vicende mercantili di Calabria in alcuni registri notarili messinesi del Quattrocento, in:
Messina e la Calabria nelle rispettive fonti documentarie dal basso medioevo all’età contemporanea
Atti del primo colloquio calabro siculo, Reggio Calabria-Messina 21-23 novembre 1986, Messina 1988,
pp. 351-360.
G. MODICA SCALA, Le comunità ebraiche nella contea di Modica, Modica 1978.
R. MOLINAROLO, S. Lucia del Mela, in Architettura judaica in Italia. Ebraismo, sito, memoria dei
luoghi, Palermo 1994, pp. 148-150.
B. NEOCASTRO, Historia sicula, in R. GREGORIO, Biblioteca scriptorum qui res in Sicilia gestas sub
Aragonum imperio retulere, tomo I, Palermo 1791, pp. 11-240.
G. PARISI, Alla ricerca di Diana Facellina. S. Lucia e il "Melan" nel mito e nella storia, S. Lucia del
Mela 1973, pp. 286-289.
F. PERDICHIZZI, Melazzo sagro, (trascrizione, commento e note di F. Ruvolo), Milazzo 1996.
I. PERI, Restaurazione e pacifico Stato in Sicilia (1377-1501), Bari 1988, pp. 91-120.
E. PISPISA, Messina nel Trecento, Messina 1980 (rist. 1987), pp. 135-136 e 295-296.
G. PITRÈ, Usi e costumi, credenze e pregiudizi del popolo siciliano, vol. III, Firenze 1944.
A. M. PRECOPI LOMBARDO, Le comunità ebraiche del Trapanese nei documenti editi e inediti del XV
secolo, in Italia Judaica-V. Gli ebrei in Sicilia sino all’espulsione del 1492. Atti del V convegno
internazionale, Palermo, 15-19 giugno 1992, Roma 1995, pp.463-500.
F. RENDA, La fine del giudaismo siciliano, Palermo 1993.
F. RENDA, Gli ebrei prima e dopo il 1492, in Italia Judaica-V. Gli ebrei in Sicilia sino all’espulsione del
1492. Atti del V convegno internazionale, Palermo, 15-19 giugno 1992, Roma 1995, pp. 31-54.
R.M. RIZZO PAVONE, Gli Archivi di Stato siciliani e le fonti per la storia degli ebrei, in Italia Judaica-V.
Gli ebrei in Sicilia sino all’espulsione del 1492. Atti del V convegno internazionale, Palermo, 15-19
giugno 1992, Roma 1995, pp.75-88.
C. ROTH, Storia dei marrani, Milano 1991.
60
P. SAMPERI, Iconologia della gloriosa Vergine Madre di Dio Maria Protettrice di Messina, Messina
1644 (rist. anast. Messina 199.), pp. 469-470.
D. SCINÀ, Prospetto della storia letteraria di Sicilia nel secolo decimottavo, Palermo 1859 (rist. 1969).
P. SELLA (a cura di), Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV. Sicilia, Città del Vaticano 1944
Q. SENIGAGLIA, La condizione giuridica degli ebrei in Sicilia, in «Rivista Italiana per le Scienze
Giuridiche», XLI (1906), pp. 75-102.
M. SGARLATA-L. SCIASCIA, Documenti sulla luogotenenza di Federico d’Aragona, 1294-1295, Palermo
1978, pp. 44-46.
S. SIMONSOHN, Prolegomena ad una storia degli ebrei in Sicilia, in Italia Judaica-V. Gli ebrei in Sicilia
sino all’espulsione del 1492. Atti del V convegno internazionale, Palermo, 15-19 giugno 1992, Roma
1995, pp. 15-30 (con vasta appendice bibliografica).
R. STRAUS, Die Juden im Konigreich Sizilien unter Normannen und Staufen, Heidelberg 1910 (trad.
italiana: Gli ebrei di Sicilia dai Normanni a Federico II, Palermo 1992).
A. TRAINA, Nuovo vocabolario siciliano-italiano, Palermo 1868 (rist. anast. Milano 1991, col titolo
Vocabolario siciliano-italiano)
C. TRASSELLI, Sull'espulsione degli Ebrei dalla Sicilia, in «Università di Palermo. Annali della Facoltà
di Economia e Commercio», VIII (1954), pp. 129-151.
C. TRASSELLI, Sugli Ebrei in Sicilia, in «Nuovi Quaderni del Meridione», VII (1969), n. 25, pp. 41-51.
C. TRASSELLI, Siciliani fra quattrocento e cinquecento, Messina 1981, pp. 135-157.
L. ZUNZ, Storia degli Ebrei in Sicilia, in «Archivio storico siciliano», N.S. IV (1879), p 69-113.
FONTI ARCHIVISTICHE
ARCHIVIO DI STATO DI PALERMO, Regia Cancelleria, vol. 51 (1415), f. 35v.
ARCHIVIO DI STATO DI PALERMO, Regia Cancelleria, anno 1428, f. 95-96.
ARCHIVIO DI STATO DI PALERMO, Protonotaro del Regno, vol. 119 (1485-1486), f. 19.
ARCHIVIO DI STATO DI PALERMO, Conservatoria, vol. 70, f. 71.
ARCHIVIO DI STATO DI PALERMO, Ramo Protonotaro, vol. 19, 11.11.1520.
ARCHIVIO DI STATO DI PALERMO, Tribunale del Santo Officio del Regno di Sicilia, Registri di
Ricevitoria.
BIBLIOTECA COMUNALE DI PALERMO, Tribunale del Santo Officio del Regno di Sicilia.
G. PARISI, Mende in cronologia, 11 tomi manoscritti del sec. XVIII conservati nell’Archivio Storico
del Comune di S. Lucia del Mela (comunemente intesi come Giuliana Parisi).