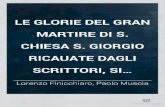Il patrimonio scultoreo di età moderna della chiesa di San Francesco all’Immacolata di Messina
Transcript of Il patrimonio scultoreo di età moderna della chiesa di San Francesco all’Immacolata di Messina
In copertina: Stampa raffigurante la chiesa di S. Francesco di E. Aldirani. 1841. Retrocopertina: Codice 544 della Biblioteca Antoniana di Padova. c. 208.
FRANCESCANESIMO E CULTURA NELLA PROVINCIA
DI MESSINA Atti del Convegno di studio
Messina 6-8 novembre 2008
a cura di Carolina Miceli e Agostina Passantino
BIBLIOTECA FRANCESCANA
OFFICINA DI STUDI MEDIEVALI PALERMO
2009
Francescanesimo e cultura nella Provincia di Messina : Atti del Convegno di studio : Messina / a cura di Carolina Miceli e Agostina Passantino. – Palermo : Biblioteca Francescana-Officina di Studi Medievali, 2009. (Franciscana ; 27) 1. Francescanesimo – Messina – Congressi – 2008 I. Miceli, Carolina II. Passantino, Agostina 271.3045811 CDD-21 ISBN 88-88615-91-1 CIP – Biblioteca Francescana di Palermo © Officina di Studi Medievali Via del Parlamento, 32 - 90133 Palermo e-mail: [email protected] www.officinastudimedievali.it – www.medioevo-shop.com Ogni diritto di copyright di questa edizione e di adattamento, totale o parziale, con qualsiasi mezzo è riservato per tutti i Paesi del mondo. È vietata la riproduzione, anche parziale, compresa la fotocopia, anche ad uso interno o didattico, non autorizzata dall’editore. ISBN 88-88615-91-1 Prima edizione italiana, Palermo, giugno 2009 Stampa: FOTOGRAF – Palermo Editing: Agostina Passantino Questo volume è pubblicato anche grazie ad un intervento finanziario dell’Università degli Studi di Palermo e del Dipartimento di Beni culturali storico-archeologici, socio-antropologici e geografici.
Il patrimonio scultoreo di età moderna della chiesa di San Francesco all’Immacolata di Messina
Giampaolo Chillè*
Magnifica, sontuosa, maestosa, bellissima, spaziosa, ornata, antica. Sono gli aggettivi con i quali per secoli è stata definita da storici, scrittori e viaggiatori la chiesa messinese di San Francesco all’Immacolata, celebre per essere stata raffigu-rata da Antonello da Messina nello sfondo della Pietà oggi al Museo Correr di Ve-nezia, e per le numerose e preziose opere d’arte che un tempo in essa si conserva-vano e che ne facevano una sorta di vero e proprio museo. Distrutta dal terremoto del 1908, che ne lasciava in piedi solo una parte del prospetto absidale, essa era già stata devastata da un violento incendio nel luglio del 1884 che, nel giro di poche ore, aveva letteralmente «mandato in fumo» quasi tutto il suo ricco patrimonio sto-rico-artistico. Particolarmente suggestiva è la descrizione di tale evento presente nelle pagine della Gazzetta di Messina del 24 luglio del 1884. «Le fiamme», scrive l’ignoto autore dell’articolo, «crepitanti si precipitano, in oscillanti lingue, fuori delle porte, delle finestre, dei passaggi che si aprono nelle rovinanti muraglie, e si riflettono in isvariati colori, quasi effetto d’una aurora boreale, sulle nuvole e sui prospetti delle case più lontane […]. Le mura scuociono e precipitano con fracasso. La chiesa, da cima a fondo, è una fiamma, una sola fiamma […]. Il pianto della fe-de non giunge a placarne gl’impeti […]. Il popolo è divenuto un popolo di pompie-ri […]. Il tempio dell’Immacolata, il tempio monumentale, dopo circa 7 secoli di vita, non è più. Tre ore appena bastarono a distruggerlo. Di esso non esistono che le mura soltanto, scotte e crollanti per giunta».1
Attraverso la consultazione e la lettura incrociata delle diverse fonti storiche locali e, soprattutto, dei preziosissimi contributi storici e documentali di Diego Ciccarelli, recentemente confluiti in un’interessante monografia,2 è possibile rico-
* Il presente contributo prende le mosse da uno studio sul patrimonio artistico siciliano, di
ambito francescano, intrapreso da chi scrive da diversi anni e in parte confluito, per quel che attiene alla chiesa messinese di San Francesco nell’opera multimediale «Città e Museo. Quattro chiese della Messina che non c’è più», edita dal Museo Regionale di Messina. Nel licenziarlo devo esprimere la mia gratitudine a Diego Ciccarelli, P. Giuseppe Fanara, Francesco Guerrera, Alessandro Mancuso e Teresa Pugliatti, per aver in vario modo facilitato le mie ricerche.
1 L’incendio, di natura dolosa, era stato appiccato, intorno alle 15,00 del 23 luglio del 1884, in punti diversi del tetto dell’edificio. Cfr. Incendio spaventevole!, in «Gazzetta di Messi-na», 24 luglio 1884, p. 3.
2 D. CICCARELLI, San Francesco all’Immacolata di Messina, Palermo 2008. Per le fonti stori-
44 Giampaolo Chillé
struire, in maniera abbastanza dettagliata e realistica, l’assetto che la chiesa di San Francesco presentava al suo interno poco prima della metà dell’Ottocento.3 Entran-do nel tempio dal portale maggiore, era sulla destra il sepolcro marmoreo in forma di altare di Stefano Patti, dello scultore Rinaldo Bonanno, e su esso la pala della Madonna dell’Itria di Alessandro Allori (Messina, Museo Regionale).4 Nella prima cappella di destra era un Martirio di Sant’Orsola, del messinese Andrea Suppa; nella seconda una Madonna col Bambino e i santi Diego confessore, Francesco d’Assisi e Ludovico d’Angiò, di Antonio Catalano l’Antico; nella terza un Cristo alla colonna, sempre del Catalano; nella quarta un prezioso bassorilievo marmoreo del XII secolo con la Madonna orante (Messina, Museo Regionale); nella quinta una tavola raffigurante San Francesco stigmatizzato, attribuita da alcuni a Salvo d’Antonio, da altri ad Alfonso Franco; nella sesta la Madonna degli Angeli di An-
che cfr.: G. BUONFIGLIO E COSTANZO, Messina città nobilissima descritta in VIII libri, Venezia 1606, rist. fotolit. a cura di P. Bruno, Messina 1976, cc. 29r-30r; P. SAMPERI, Iconologia della Gloriosa Vergine Madre di Dio Maria protettrice di Messina, Messina 1644, ed. con introduzione di G. Lipari, E. Pispisa e G. Molonia, Messina 1990, pp. 173-180; C.D. GALLO, Apparato agli Annali della Città di Messina, Napoli 1755, rist. anast. a cura di G. MOLONIA, Messina 1985, pp. 123-126; G. LA FARINA, Messina e i suoi monumenti, Messina 1840, rist. fotolit. a cura di P. BRUNO, Messina 1985, pp. 119-121; [G. GROSSO CACOPARDO] Guida per la città di Messina scritta dall’Autore delle Memorie de’ Pittori Messinesi, Messina 1826, pp. 81-87; L. FACCIOLÀ, Cenno storico del monumentale convento e chiesa di S. Francesco d’Assisi comunemente detti dell’Immacolata in Messina, Catania 1888; Messi-na e dintorni. Guida a cura del Municipio, Messina 1902, rist. anast. a cura di G. Corsi, Messina 1974, pp. 353-355; G. VADALÀ CELONA, Cenno descrittivo dei pregevoli quadri ad olio e di alcune sculture che ornavano gli altari del tempio di S. Francesco d’Assisi in Messina prima dell’incendio del 1884, in «Archivio Storico Messinese», IX (1908), fasc. I-II, pp. 221-224. Per gli studi moderni cfr.: D. CICCARELLI, Documenti inediti della R. Cancelleria e del Protonotaro del Regno di Sicilia riguardanti la chiesa di S. Francesco di Messina (1369-1514), in «Atti dell’Accademia Peloritana», Classe di Lettere Filosofia e Belle Arti, vol. L, Anno Accademico 1971-1972, Messina 1972, pp. 309-348; ID., Pergamene dell’Archivio di S. Francesco di Messina nel Tabulario di S. Maria di Malfinò (1320-1615), in «Atti dell’Accademia Peloritana», Classe di Lettere Filosofia e Belle Arti, vol. LII, Anno Accademico 1974-1975, Messina 1975, pp. 7-93; ID., San Francesco all’Immacolata, in G. BONANNO (a cura di), Cattedrali di Sicilia, Palermo 2000, pp. 89-92.
3 Già al tempo erano andate perdute preziose opere d’arte e importanti monumenti fune-bri, menzionati e talvolta descritti dai documenti e dalle principali fonti messinesi sei e settecen-tesche, dalle opere dei già menzionati Giuseppe Buonfiglio e Costanzo, Placido Samperi, Cajo Domenico Gallo, a Francesco Susinno. Cfr. F. SUSINNO, Le vite de’ pittori messinesi [ms. 1724], ed. a cura di V. Martinelli, Firenze 1960, pp. 49, 67, 82, 99, 105, 117, 118, 141, 177, 187, 220 e 222. Per la ricostruzione dell’assetto interno della chiesa cfr. anche G. CHILLÈ, La chiesa di San Francesco all’Immacolata, in G. CHILLÈ – S. LANUZZA, Città e Museo. Quattro chiese della Messina che non c’è più, CD multimediale realizzato nell’ambito dell’attività didattica del Mu-seo Regionale di Messina, Messina 2009.
4 Un altare dedicato a S. Maria dell’Itria è ricordato nella chiesa già nel 1534. Cfr. D. CICCA-
RELLI, Pergamene dell’Archivio di S. Francesco di Messina nel Tabulario di S. Maria di Malfinò (1320-1615), in «Atti dell’Accademia Peloritana», Classe di Lettere Filosofia e Belle Arti, vol. LII, Messina 1975, pp. 7-93 e in particolare p. 82, doc. CCXXVIII.
Il patrimonio scultoreo di età moderna … 45
tonello Gagini (Messina, Museo Regionale); nella settima era l’ingresso laterale della chiesa, contrassegnato esternamente da un lineare portale archiacuto del XIV secolo; e nell’ottava, infine, un Martirio di San Lorenzo, di Alonzo Rodriguez. In tale cappella si trovavano quattro monumenti funebri di membri della nobile fami-glia De Gregorio: quello di Paola De Gregorio Spatafora, pregevole lavoro del 1716, quello di Eleonora De Gregorio Donato, del 1719, e altri due dedicati a due diversi Don Lorenzo De Gregorio. Nel transetto destro era collocata una grandiosa tela del palermitano Giuseppe Manno, raffigurante il Transito di San Giuseppe, ac-canto alla quale era il cenotafio di Girolamo Cappellino, eseguito nel 1583. L’abside destra, dedicata al SS. Sacramento, era interamente decorata da affreschi di Filippo Tancredi, concordemente ricordati come una delle sue prove più alte. In essa era un altare baroccheggiante, decorato a marmi mischi, con una complessa «machina» lignea, «conforme fosse di marmo bene allustrata».5 L’abside centrale ospitava un sarcofago romano del III secolo dopo Cristo (Messina, Museo Regio-nale) - recante scolpito a bassorilievo il ratto di Proserpina e riutilizzato come urna sepolcrale di Federico III d’Aragona e di alcuni suoi congiunti,6 - e uno splendido coro ligneo del 1512, probabilmente opera del palermitano Giovanni Gili,7 oltre na-turalmente all’altare maggiore, accanto al quale era un crocifisso a tutto rilievo at-tribuito a Stefano Giordano e ai suoi piedi una statua dell’Addolorata. Nella zona
5 Alla realizzazione di questa collaborarono Carlo e Paolo Grimaldi assieme a Paolo Cirino.
Cfr. S. DI BELLA, Su alcuni intagliatori in legno a Messina nel secolo XVIII, in «Archivio Storico Messinese» 72 (1997), pp. 113-120.
6 In esso nel 1554, per volontà del viceré De Vega, erano stati aggiunti i resti mortali della madre Elisabetta e di Guglielmo e Giovanni d’Aragona. In parte nascosto e danneggiato dagli stalli del coro il sarcofago rimase nella chiesa di San Francesco sino al terremoto del 1908, nonostante ne fosse stato ampiamente riconosciuto il notevole interesse e già nel febbraio del 1876 venisse espres-samente richiesto il suo trasferimento nei locali del Museo Civico. Cfr. Messina, Archivio del Museo Regionale di Messina (A.M.R.M.), Lettera del Prefetto del 22 febbraio 1876, b. 2, fasc. 1.
7 Il coro, in noce, venne eseguito a spese di monsignor Giovanni Puxades, vescovo di Malta, le cui insegne campeggiavano nella parte centrale assieme alla seguente iscrizione: «Ioannes Puiades, Episcopus Melvitanus electus Romae, ultimo Aprilis 1512. Pontificatus Domini nostri Iulij secundi, Anno Nono, suis expensis, eo mortuo fieri fecit». F. CAGLIOLA, Almae Siciliensis Provinciae Ordinis Minorum Conventualium S. Francisci. Manifestationes novissimae sex explorationibus complexae, Venezia 1644, in Sicilia francescana secoli XIII-XVII a cura di F. ROTOLO, Palermo 1984, p. 68. L’attribuzione al Gili si ricava da un confronto tra quanto affermato dal Cagliola e i documenti rin-tracciati dal Di Marzo. Trattando del coro ligneo della chiesa palermitana di San Francesco, infatti, lo storico francescano scriveva che esso era stato eseguito «ab eodem magistro» (del quale tace il nome) che aveva realizzato quelli delle omonime chiese di Messina, di Lentini e della chiesa palermitana di San Domenico. Tale maestro venne identificato in seguito, sulla scorta di un documento rintracciato dal Di Marzo col maestro Giovanni Gili. Ne consegue che a quest’ultimo deve essere riferito anche il coro di Messina, che a questo punto deve immaginarsi abbastanza simile a quello di Palermo. Cfr. Ibid., p. 96 e G. DI MARZO, I Gagini e la scultura in Sicilia nei secoli XV e XVI. Memorie e documen-ti, Palermo 1880-1883, vol. II, p. 398, doc. CCCXII.
46 Giampaolo Chillé
presbiterale era anche un pregevole leggio in forma di pellicano della prima metà del Cinquecento. Nessuna opera di rilevo è ricordata dalle diverse fonti nell’abside di sinistra. Dietro ad essa era una piccola stanza nella quale era collocato il Monu-mento funebre di Francesca Lanza Cibo, straordinaria opera della prima metà del XVII secolo. Nello stesso vano era anche una piccola tavola del messinese Deodato Guinaccia raffigurante la Madonna del Rosario con San Gerolamo e altri santi. Nel transetto sinistro si trovava probabilmente l’organo, riccamente scolpito nel Seicento da abili maestranze messinesi. Volgendo le spalle all’altare maggiore e proseguendo verso l’ingresso principale della chiesa s’incontravano altre otto cap-pelle, perfettamente simmetriche a quelle già descritte. Nella prima era un San Bo-naventura di Andrea Suppa; nella seconda, nella quale si apriva una piccola porta che metteva in comunicazione la chiesa con il chiostro, era un quadro con San Francesco moribondo, di autore ignoto; nella terza, posti l’uno sopra l’altro, erano due dipinti: quello più in alto rappresentava le Sante Chiara e Agnese di Assisi, quello più in basso - opera di Vincenzo da Pavia - i Santi Cosma e Damiano; nella quarta una tela con la Madonna della Lettera e i Santi Placido e Francesco, di A-lonzo Rodriguez; nella quinta erano una pregevole Immacolata, di ambito antonel-liano, rivestita da una manta d’argento,8 e una grande tela rappresentante il teologo francescano Giovanni Duns Scoto nell’atto di predicare, di autore ignoto; nella se-sta un’ancona marmorea cinquecentesca e tre tele del siracusano Mario Minniti raf-figuranti la Natività, Sant’Elisabetta e Santa Margherita da Cortona; nella settima erano al centro un Sant’Antonio da Padova e sulle pareti laterali due tele raffigu-ranti Miracoli di Sant’Antonio, attribuite da alcune fonti a Nicola Francesco Maffei e da altre a Catalano l’Antico; nell’ottava, ed ultima, era un quadro con in alto la Vergine col Bambino e in basso un albero dai cui rami si diramavano tutti gli ordini religiosi, di autore sconosciuto. Accanto al portale maggiore, infine, in posizione simmetrica rispetto al Sepolcro di Stefano Patti, era il celebre Monumento funebre dell’ammiraglio Angelo Balsamo.
Importanti opere d’arte si conservavano anche nella sagrestia dove, assieme ad una Adorazione dei Magi assegnata dalle fonti al Dürer e ad un San Giovanni che addita Gesù nel deserto, di Deodato Guinaccia, era probabilmente anche la Deposizione attribuita a Colijn de Coter (Messina, Museo Regionale) e un gran numero di reliquie, tra le quali si ricordano un frammento della Croce di Cristo, il cordone di san Francesco, tre teste delle compagne di sant’Orsola, un osso del bea-to Gherardo, un osso del braccio di san Lorenzo, e vari frammenti di ossa dei santi Biagio, Cristoforo, Orsola e Stefano.
Annesso alla chiesa era uno splendido chiostro cinquecentesco, del quale si pubblica in questa sede una ricostruzione planimetrica (fig. 1), resa possibile grazie
8 Andata «ufficialmente» distrutta nel 1843 a causa di un piccolo incendio divampato nella
cappella, la tavola fu sostituita da una copia di Michele Panebianco.
Il patrimonio scultoreo di età moderna … 47
al ritrovamento di alcuni documenti della fine dell’Ottocento, dei quali si darà noti-zia in un altro contributo.9 Ad esso era possibile accedere sia dalla chiesa, attraver-so una piccola porta posta nella settima cappella di sinistra,10 come si è già detto, sia dalla sacrestia, passando per uno stretto vano, chiuso e trasformato in sala del tesoro dopo l’incendio del 1884 o forse poco dopo la soppressione del convento. Tra le arcate del chiostro - «ornate da vaghissimi freschi del Tancredi»11 e tra le quali ancora agli inizi del Novecento potevano scorgersi eccezionali testimonianze di portali e finestre medievali - erano gli ingressi alla cappella di San’Antonio, po-sta sul lato nord. Il suo interno, comprendente secondo la tradizione la cella dove il Santo aveva dimorato durante il suo soggiorno a Messina, era diviso in due zone, separate da un’inferriata, destinate una ai frati, l’altra ai fedeli.12 Interamente affre-scata dal Tuccari e arricchita di una ricca decorazione a stucco, la cappella ospitava due altari. Assai fastoso era quello maggiore, in legno scolpito, dipinto e dorato, eseguito nella seconda metà del XVII secolo; più semplice ma altrettanto raffinato era, invece, quello laterale, attribuito ad Antonello Gagini.
Di questo ingente patrimonio artistico sino ad ora menzionato, rimangono oggi poche testimonianze, rappresentative comunque di quanto in termini di devozione, arte e cultura abbia rappresentato per secoli la chiesa di San Francesco. Esse si conservano tra il Museo Regionale di Messina, dove sono confluite in seguito al terremoto del 1908, e l’attuale chiesa di San Francesco, interamente ricostruita secondo le antiche forme, in seguito ad un intervento di restauro effettuato negli anni Venti del secolo scorso.13 È mia intenzione soffermarmi in questa sede su alcune sculture di età moder-na, già nella chiesa o nel chiostro, alla luce di recenti studi e ricerche.14
Tra le opere conservate al Museo di Messina, di notevole interesse è la lunet-ta marmorea con la Natività (fig. 2), già ricordata nella terza cappella di destra del-la chiesa,15 un tempo dei marchesi Altamira.16 Praticamente ignorato dalla letteratu-
9 Cfr. G. CHILLÈ, Il chiostro della chiesa di San Francesco a Messina: da Antonello Freri a
Filippo Tancredi, in «Archivio Storico Messinese» in corso di stampa. La ricostruzione planimetrica riproduce l’assetto del chiostro e dei locali di pertinenza della chiesa alla fine del XIX secolo, dopo la soppressione del convento e la sua trasformazione in Intendenza di Finanza.
10 Tale apertura era esternamente caratterizzata da un lineare portale a sesto acuto con due esili colonne ai lati.
11 [G. GROSSO CACOPARDO] Guida per la città di Messina…, cit., p. 82. 12 G. LA CORTE CAILLER, Il mio diario (1893-1903), ed. a cura di G. Molonia, Messina 1998, p. 206. 13 T. PUGLIATTI, Il metodo di Francesco Valenti: casi di restauro successivi al terremoto del
1908 a Messina, in M. GUTTILLA (a cura di), Arte nel restauro, arte del restauro: storia dell'arte e storia della conservazione in Italia meridionale, Caltanissetta 2008, pp. 55-67.
14 Sono escluse, pertanto da questa trattazione, le opere di età romana e medievale e la Ma-donna del Gagini, trattata da Giovanni Molonia.
15 Cfr. G. VADALÀ CELONA, Cenno descrittivo dei pregevoli quadri…, cit., p. 223. In seguito all’incendio del 1884 essa fu trasferita nella cappella di Sant’Antonio. Ibid.
16 F. SUSINNO, Le vite de’ pittori…, cit., p. 117.
48 Giampaolo Chillé
ra artistica più recente, il rilievo è stata pubblicato per la prima volta da Enrico Mauceri, come opera di scuola gaginesca, nella guida del Museo del 1929,17 dalla quale apprendiamo che entrata far parte delle collezioni di tale istituzione, era stata collocata nella XIII sala, accanto al monumento Balsamo, dove rimase anche dopo il riordino delle collezioni curato da Maria Accascina. Il rilievo costituiva la parte superiore di una sorta di ricca cornice (frammenti di essa sono nei depositi del Mu-seo) che serviva forse a inquadrare un piccolo vano entro il quale era probabilmen-te, un tempo, il veneratissimo simulacro ligneo della Madonna del Parto, eseguito nel 1511, o poco dopo, su commissione di Cassandra Bonfiglio,18 e sostituito poi-ché danneggiato nei primi decenni del Seicento, dal già citato dipinto di Mario Minniti.19 La lunetta è ricordata e attentamente descritta da Carmelo La Farina in una lettera, datata 1 maggio 1834, indirizzata al canonico Giuseppe Alessi, erudito e collezionista ennese. L’intellettuale messinese, che inspiegabilmente giudica l’opera «niente pregevole per la parte dell’arte» e non «anteriore al 1600», scrive che «la rappresentazione può riguardarsi come in due parti divisa. Nella prima del-le quali, ch’è a diritta dello spettatore scorgersi il celestiale Fanciullo nudo, tra per la paglia, tra mezzo alla Vergine, ed a Giuseppe, che riverenti stannosi in atto pio di genuflessione: dietro al quale prostratto, e chino sta un pastorello, ed al fondo della scena due angeli stanno atteggiati di pietà. All’intorno soprastano delle sparte colline, e su ad esse delle sbandate pecorelle. La parte sinistra del quadro rappre-senta una casa sorretta nelle estreme parti da due colonne, e da quella banda in che mirasi la sacra Famigliuola veggonsi delle travi, che stando ferme sul suolo soffro-no il tetto dello edificio. Or nel muro di fronte che come per me si disse è tramez-zato da colonne, vi sono nella parte bassa delle fessure, come se fossero l’opera del tempo, ed è per esse che metton fuori le loro teste l’asino, ed il bue».20 L’opera è da identificare con «la bella scultura della nascita del Nazareno», menzionata da Gio-acchino Di Marzo in una cappella della chiesa di San Francesco e dallo studioso più correttamente datata alla prima metà del XVI secolo.21 Qualità formali, scelte compositive e decorative inducono ad avvicinare la lunetta al complesso «ambito» di Antonello Gagini, la cui produzione strettamente autografa è ancora oggi, nono-
17 E. MAUCERI, Il Museo Nazionale di Messina, Roma 1929, p. 79, fig. 58 e p. 87. 18 D. CICCARELLI, Pergamene dell’Archivio di S. Francesco…, cit., pp. 24 e 77, doc. CXVIII. 19 In merito alla statua lignea della Madonna del Parto scrive il Samperi: «vecchia già, e tarla-
ta si vede hoggidi in un angolo del Chiostro dell’istesso Convento, mantenendo ancora, come suole talvolta cadavero reale, non so che di riverenza e di Maestà. Se bene in sua vece, estinta che fu la Confraternita, affinché no se ne perdesse affatto la memoria, un’altra nuova Imagine della Madonna del Parto, di buona mano, nell’istessa Cappella si sostituì». P. SAMPERI, Iconologia della Gloriosa Vergine…, cit., p. 176.
20 Cfr. C. LA FARINA, Intorno le Belle Arti, gli artisti fioriti in varie epoche in Messina. Ricer-che ordinate in più lettere, (Messina 1835), ed. con premessa e note di G. Molonia e presentazione di G. Barbera, Messina 2004, pp. 111-112.
21 G. DI MARZO, I Gagini e la scultura…, cit., vol. I, p. 753.
Il patrimonio scultoreo di età moderna … 49
stante il progredire degli studi, non di rado problematica da identificare e distingue-re tra una moltitudine di opere di figli, allievi e collaboratori, che per lunghi decen-ni riproposero, sovente pedissequamente, i raffinati lavori del maestro. Lunette si-mili a quella messinese, ma bordate da cornici con motivi decorativi lievemente più articolati, completano molti dei retabli marmorei eseguiti dal maestro palermitano e dalla sua folta schiera di seguaci, ancora oggi in numerose chiese della Sicilia. Af-finità col rilievo della chiesa di San Francesco, possono cogliersi, in particolare, con la lunetta del trittico della chiesa madre di Alcamo (1519) e con la Natività del-la grande ancona marmorea della chiesa di Santa Maria Maggiore di Nicosia.
Oggi ricomposto nel nuovo Museo Regionale di Messina, il Monumento fune-bre dell’Ammiraglio Angelo Balsamo (†1507) è certamente tra le opere più rappre-sentative del Cinquecento messinese. A lungo riferito ad Antonello Freri, in relazione alle affinità che esso presenta a livello compositivo con il Monumento funebre del viceré Fernando de Acuña y Viney (†1494) nella Cappella di Sant’Agata del Duomo di Catania, il sepolcro Balsamo è stato recentemente ricondotto da Francesco Caglioti al carrarese Giovambattista Mazzolo, in maniera decisamente più realistica e convin-cente.22 Le analogie tra il Monumento Balsamo e il Monumento Acuña, del resto, si fermano quasi esclusivamente a un livello d’impaginazione strutturale, non ravvisan-dosi pressoché alcun nesso sotto il profilo stilistico e culturale. Ovvia è naturalmente la derivazione dell’opera messinese dal prestigioso sarcofago catanese, a sua volta ispirato a illustri modelli spagnoli, come ad esempio - per restare nell’ambito della stessa famiglia del viceré di Sicilia -, il Monumento di Don Pedro de Acuña (†1482) nella chiesa di Santa María de la Asunción a Dueñas, in Castilla y León. Un interven-to del Freri nell’esecuzione del monumento messinese, in realtà, comunque, non sol-tanto non è da escludere,23 come ha già giustamente notato Caglioti, ma è anche piut-tosto probabile, giacché oltre ad essere espressamente documentata la collaborazione tra lo scultore e il Mazzolo,24 lo è anche la sua attività nell’ambito della chiesa di San
22 Cfr. F. CAGLIOTI, Due opere di Giovambattista Mazzolo nel Museo Regionale di Messina
(ed una d’Antonello Freri a Montebello Jonico), in G. BARBERA (a cura di), Aspetti della scultura a Messina dal XV al XX secolo, «Quaderni dell’attività didattica del Museo Regionale di Messina» 13 (2003), pp. 37-60, al quale si rimanda per tutta la bibliografia precedente.
23 Essa giustificherebbe anche certe differenze di stile riscontrabili tra alcune parti del monu-mento e che già in passato avevano indotto a ipotesi diverse. Cfr. soprattutto E. MAUCERI, Antonello Freri scultore messinese del Rinascimento, in «Bollettino d’Arte» V (1925-1926), pp. 385-398; S. BOTTARI, Note sull’opera di Antonello Freri, in E. ASLAN (a cura di), Arte e artisti dei laghi lombar-di, I, Architetti e scultori del Quattrocento, Como 1959, pp. 77-88 e in ultimo F. CAMPAGNA CICALA, scheda n. 50, in F. ZERI – F. CAMPAGNA CICALA, Messina. Museo Regionale, Palermo 1992, p. 82. Ad Antonello Freri, probabile sodale del grande grecista Costantino Lascaris, si potrebbe, in particolare, riferire l’ideazione del rilievo del basamento del monumento, raffigurante il mito di Anfitrite.
24 Cfr. G. DI MARZO, I Gagini e la scultura…, cit., vol. I, p. 747 e vol. II, p. 425, doc. CCCXL; G. MOLONIA, Note sulla committenza siracusana ad artisti messinesi, in G. BARBERA (a cura di), Da An-tonello a Paladino. Pittori messinesi nel siracusano dal XV al XVIII secolo, Siracusa 1996, pp. 105-106.
50 Giampaolo Chillé
Francesco, e in ben due occasioni. Nel 1486, infatti, Antonello Freri si impegnava con i marammieri del convento di San Francesco a costruire vicino al pozzo di Sant’Antonio un nuovo pozzo e intorno ad esso un chiostro con colonne di marmo e arcate in pietra di Siracusa;25 e nel 1508 interveniva in veste di perito nella controver-sia sorta tra Antonello Gagini e la famiglia De Rosa, sulla decorazione scultorea della cappella che quest’ultima possedeva in chiesa.26 In merito alla possibile datazione del Monumento Balsamo, condivisibile è la sua posticipazione rispetto alla morte dell’ammiraglio di circa un lustro, o poco meno. Trattandosi di un’opera abbastanza impegnativa, infatti, assai probabile è che i lavori siano stati procrastinati o comun-que si siano protratti per un certo tempo oltre il previsto, come del resto era peraltro consuetudine. Il suo completamento è ipotizzabile sia avvenuto prima del 1513, anno nel quale dal Mazzolo era licenziato il monumento funebre dell’arcivescovo Bellora-do, e forse anche del 1511, quando la nobile Cassandra de Bonfilio per indicare in un atto la propria cappella all’interno della Chiesa di San Francesco ricordava quella «di lu magnificu quondam baruni di santu Basili».27 Committente dell’opera fu quasi cer-tamente Tonna, vedova di Nicolò de Balsamo e madre di Angelo, la quale già nel novembre del 1507 effettuava dei donativi per la propria cappella.28
Interessantissima testimonianza d’arte fiamminga, non unica un tempo nella chiesa di San Francesco,29 è il famoso Leggio in forma di pellicano, donato ai frati francescani da monsignor Ottaviano Preconio nel 1545, come informa una lunga iscrizione posta su esso. Originariamente collocata «sub arcu maiori» della eccle-sia,30 l’opera, in bronzo fuso e bulinato, è costituita da una base polilobata sulla quale si innalza un fusto - scandito da nodi ad anello e decorato a scaglie e scanala-ture a torciglione - reggente un globo sul quale poggia un pellicano, le cui ali spie-gate fungono da leggio. Già considerata in passato il risultato dell’assemblaggio di parti di epoche diverse, ritenendosi il pellicano (la cui conformazione stilizzata e poco naturalistica contrasta con la resa analitica e minuziosa del piumaggio) opera del XIII secolo e la base del XIV,31 essa è oggi più correttamente giudicata unita-
25 D. CICCARELLI, San Francesco all’Immacolata…, cit., p. 26. 26 G. MOLONIA, La “Madonna degli Angeli” di Antonello Gagini e il suo documento, in Ac-
quisizioni e documenti sul patrimonio storico-artistico del Museo Regionale di Messina, «Quaderni dell’Attività didattica del Museo Regionale di Messina» 9 (1999), pp. 71-79.
27 D. CICCARELLI, Pergamene dell’Archivio di S. Francesco…, cit., pp. 77-78, doc. CXVIII. 28 Ibid., pp. 75-76, doc. CXIV. Nella cappella era una antica «Imagine di Nostra Signora […]
un tempo […] di gran veneratione», verso la quale era orientata la statua orante dell’Ammiraglio Bal-samo. Cfr. P. SAMPERI, Iconologia della Gloriosa Vergine…, cit., p. 176.
29 Oltre ad alcuni dipinti, già menzionati, erano, ad esempio, «alcuni candelieri grandi di rame alla Fiamminga» contrassegnati dallo stemma della famiglia Marullo. P. SAMPERI, Iconologia della Gloriosa Vergine…, cit., p. 176.
30 F. CAGLIOLA, Almae Siciliensis Provinciae…, cit., p. 68. 31 E. MAUCERI, Bronzi medievali inediti, in «Cronache d’arte» II (1925), pp. 17-18 e ID., Il
Museo Nazionale…, cit., p. 75.
Il patrimonio scultoreo di età moderna … 51
ria32 per le stringenti affinità riscontrate con manufatti analoghi, come quello della cattedrale di Norwick o quello del Musée Royaux d’Art et d’Histoire di Bruxelles, e le attente osservazioni già formulate da Charles Chichele Oman e Jean Squil-beck.33 Tutto da chiarire resta, come ha già notato Diego Ciccarelli,34 il rapporto tra questo leggìo e quello ricordato in un documento del 1509 nel quale da un gruppo di devoti viene dato incarico ad alcuni messinesi residenti a Bruges di far realizzare per la chiesa di San Francesco un’aquila di bronzo «cum so pedi per uno legio di li epistoli et divini evangeli».35 Alla figura di monsignor Ottaviano Preconio ritengo debba collegarsi - oltre naturalmente alla realizzazione di una scala elicoidale che conduceva al campanile della chiesa, posto sopra l’abside maggiore36 - anche la preziosa stauroteca in cristallo di rocca e argento dorato (Messina, Museo Regiona-le), già appartenente alla chiesa di San Francesco e recentemente pubblicata da Ma-ria Pia Pavone Alajmo.37 Il reliquiario, infatti, non può che identificarsi con quello che custodiva «un buon Fragmento del Legno della S. Croce» donato, come ricorda il Samperi, «dall’Imperador Carlo V a Monsignor Preconio suo Predicatore»38 e conservato sino al 1908, assieme a diverse suppellettili d’oro e d’argento e a varie reliquie, prima nella sagrestia e in seguito alla confisca del convento da parte del governo e all’incendio del 1884 in un piccolo vano, ad essa attiguo, adibito a sala del tesoro.39 Particolarmente ricco doveva essere l’arredo liturgico della chiesa, in-teressanti notizie su di esso emergono da alcuni documenti recentemente da me rin-tracciati e attualmente in corso di studio, dei quali mi riservo di trattare in maniera più dettagliata in altra sede.40 Grazie ad essi mi è stato possibile identificare, come
32 F. CAMPAGNA CICALA, scheda n. 60, in F. ZERI – F. CAMPAGNA CICALA, in Messina. Museo
Regionale…, cit., pp. 92-93. 33 Cfr. C.C. OMAN, Niederländishe Messingpulte in Italien, in «Pantheon» 20 (1937), pp. 274-
277 e J. SQUILBECK, Le lutrin-pélican de Bornival, in «Bullettin des Musée Royaux d’Art et d’Istoire» 6 (1939), pp. 126-136.
34 D. CICCARELLI, San Francesco all’Immacolata…, cit., p. 32. 35 C. TRASSELLI, I Messinesi tra Quattro e Cinquecento, in «Annali della Facoltà di Economia
e Commercio dell’Università di Messina» 1 (1972), pp. 311-391 e in particolare p. 346. 36 Sull’arco che segnava l’accesso alla scala, scolpito su una piccola lapide, si leggeva infatti:
D.O.M./ PER CONCLYDIUM AD SACRA AERA FACILEM/ HONESTUMQUE ASCENSUM. OTTAVIANUS/ PRECONIUS
MESSANENSIS ORD. MINORUM/ ARCHIEPISCOPUS PANORMI EXIBENDUM/ CURAVIT. ANN. MDLXVI. Cfr. L. FAC-
CIOLÀ, Cenno storico del monumentale convento…, cit., p. 28. 37 M. P. PAVONE ALAJMO, scheda n. 1, in M. P. PAVONE ALAJMO (a cura di), Arti decorative al
Museo Regionale di Messina. Gli argenti, «Quaderni dell’attività didattica del Museo Regionale di Messina» 10 (2001), p. 17.
38 P. SAMPERI, Iconologia della Gloriosa Vergine…, cit., p. 177. 39 Le fiamme non arrecarono alcun danno né al tesoro né alla sagrestia. In essa a distanza di
soli due giorni dal drammatico evento si iniziarono a celebrare messe. Cfr. A S. Francesco d’Assisi!, in «Gazzetta di Messina», 26 luglio 1884, p. 3.
40 Si segnalano, tra gli altri, un Verbale di consegna all’ufficio valori di Messina di argenterie recuperate dopo il terremoto del 28 dicembre 1908, del 10 agosto del 1910, tratto dall’Inventario degli
52 Giampaolo Chillé
già appartenente alla chiesa di San Francesco, un messale dalla legatura in velluto rosso e applicazioni d’argento, conservato al Museo Regionale e del quale si igno-rava la provenienza.41
Originariamente collocato nella parte destra del transetto,42 e successiva-mente trasferito in un vano posto dietro la tribuna sinistra (probabilmente la sa-crestia),43 il Monumento funebre di Francesca Lanza Cibo era tra le opere d’arte di maggiore interesse presenti nella chiesa e senza dubbio la più scenografica.44 Parzialmente danneggiato dall’incendio della basilica del 1884, fu ricomposto nel 1905 a spese di Mons. Domenico Lancia di Brolo, arcivescovo di Monreale e di-scendente della nobile defunta.45 È stato realizzato su commissione di Giovanni Lancia, marito inconsolabile della donna (morta a soli quindici anni, nel 1618), «mutui aeternique amoris significationes», come si apprende dal lungo epitaffio. Eseguito in rame e bronzo, dorati e finemente lavorati, appare oggi mancante di diverse parti, andate perdute nel corso dei secoli e in seguito al terremoto del 1908. Il ricchissimo sarcofago, sostenuto da due leoni, è posto su un’alta base a cassettone sulla quale sono le insegne nobiliari della defunta. L’arca funeraria era fiancheggiata in origine da due splendidi putti reggenti fiaccole capovolte, dei quali si conserva solo quello di sinistra. Priva oggi anche del coperchio, presenta nella parte superiore, ai lati, altri due putti reggi fiaccola, e al centro, un delicato busto-ritratto della giovane estinta. Un’iscrizione, andata perduta ma ricordata dal La Farina e dal Grosso Cacopardo, ne sottolineava il triste destino. In essa si leg-geva: «Ver erat aetatis, virtutum advenerat aestas / Cum florem et fructum mors inopina tulit. / Attamen haud raptam properato funere credas, / Nam sat mature quae bene vixit obit».46 Riccamente e minutamente decorato in ogni parte con raf-finati motivi vegetali, puttini, mascheroni, conchiglie, drappi, arpie ed elementi di chiaro valore simbolico, il sarcofago era ornato, in origine, da diverse gemme preziose di proprietà della Lanza Cibo, asportate già nel Settecento e in parte riu-
oggetti preziosi rinvenuti negli scavi delle Chiese dipendenti dall’Amministrazione del Fondo per il Culto compilato in ordine alle disposizioni in partite dall’Onorevole Intendenza con nota 25 Luglio 1909 e un Elenco degli arredi sacri (argenterie, dipinti ed altro) depositati nei locali della Cittadella di Messina per conto della Amministrazione del Fondo per il Culto e dei quali viene effettuata la conse-gna al Direttore del Museo Nazionale di Messina, cav. Enrico Mauceri in attesa di relativo decreto di devoluzione, del 4 luglio 1916. Cfr. A.M.R.M., b. 2, fasc. 1 e b. 4, fasc. 8.
41 Su tale opera cfr. M. P. PAVONE ALAJMO, scheda n. 37, in M. P. PAVONE ALAJMO (a cura di), Arti decorative…, cit., p. 66.
42 F. CAGLIOLA, Almae Siciliensis Provinciae…, cit., p. 68. 43 Con ogni probabilità tra il secondo e il terzo decennio del Settecento, in occasione dei lavo-
ri di restyling barocco della chiesa. 44 Su tale opera cfr. in ultimo M. P. PAVONE ALAJMO, scheda n. 8, in M. P. PAVONE ALAJMO
(a cura di), Arti decorative…, cit., p. 26, con bibliografia precedente. 45 G. LA CORTE CAILLER, Il mio diario (1903-1906), a cura di G. Molonia, Messina 2002, p. 576. 46 G. LA FARINA, Messina e i suoi monumenti…, cit., p.121.
Il patrimonio scultoreo di età moderna … 53
tilizzate per decorare l’antica corona d’oro della statua dell’Immacolata.47 Sebbe-ne realizzato in materiale non prezioso, il monumento appare concepito come una vera e propria opera di oreficeria, come una sorta di grande scrigno nel quale cu-stodire i beni più cari, nell’intimità di una dimora privata. In assenza di documen-ti che forniscano l’iter esecutivo, esso si può, ritenere eseguito, com’è stato già opportunamente notato,48 da esperte e raffinate maestranze di orafi e argentieri messinesi, certamente su progetto di uno scultore fortemente influenzato dalla cultura artistica toscana tardo-manierista. Estremamente ricco e fastoso, presenta evidenti analogie, sia a livello compositivo sia decorativo, con alcuni monumenti funebri eseguiti in marmo a partire dagli ultimi decenni del Cinquecento, ed in particolar modo con il Monumento funebre di Antonio Marchesi e Antonia Barre-si e con quello gemello di Francesco Marchesi e Anna Staiti, già nel coro della chiesa di Santa Maria di Gesù Inferiore e oggi al Museo Regionale di Messina, realizzati da Rinaldo Bonanno e aiuti su disegno di Andrea Calamech, e in asso-luto tra i più fastosi e sontuosi della città, tanto da poter essere considerati il mo-dello di riferimento di tutte le opere di analogo genere che, in forme di gran lunga semplificate, vennero eseguite a Messina e in provincia per oltre un secolo. Sulla scorta di quanto riportato negli inventari del Museo Regionale di Messina, sono stati più volte pubblicati o segnalati come già appartenenti alla chiesa di San Francesco d’Assisi due raffinati bassorilievi raffiguranti la Presentazione di Gesù al Tempio e la Guarigione del paralitico, e due belle statue, identificate come l’Allegoria della Vittoria e l’Allegoria della Forza. Di grande interesse e indiscu-tibile qualità tali sculture - messe tra loro in relazione per palesi ragioni stilistiche - sono state in passato attribuite a Martino Montanini da Elvira Natoli49 ed a Ri-naldo Bonanno da Alessandra Migliorato50 che ha anche ipotizzato potessero ap-partenere alla cappella Patti, in relazione ad alcuni documenti rintracciati da Be-nedetta Saccone attestanti l’esecuzione di quest’ultima ad opera di Rinaldo Bo-nanno, tra il 1587 e il 1589.51 Espunte da chi scrive dal catalogo delle opere
47 Il prezioso ornamento, per ragioni ancora da chiarire, fu sostituito nel 1905. La nuova coro-
na fu irreparabilmente danneggiata dal terremoto del 1908. G. LA CORTE CAILLER, L’Immacolata in Messina, in «Il Marchesino» 46 (8-9 dicembre 1906), pp. 2-3.
48 Cfr. E. NATOLI, Problemi di scultura a Messina nel secolo XVII, in Cultura arte e società a Messina nel Seicento, Messina 1984, pp. 51-54 e in particolare p. 52.
49 Cfr. EAD., Nuove attribuzioni a Martino Montanini, in «Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Arte Medievale e Moderna Facoltà di Lettere e Filosofia Università di Messina», 11 (1987) ma 1989, pp. 19-32; EAD., Due bassorilievi di Montanini nel Museo Regionale di Messina, in G. BARBE-
RA (a cura di), Aspetti della scultura…, cit., pp. 109-112. 50 A. MIGLIORATO, Revisioni e nuovi contributi su Rinaldo Bonanno, in G. BARBERA (a cura
di), Aspetti della scultura…, cit., pp. 119-134 51 B. SACCONE, Rinaldo Bonanno scultore e architetto messinese, in «Commentari» XI
(1960), pp. 117-180 e in particolare p. 136. La cappella Patti, o meglio la cappella-altare di Stefano Patti, aveva in realtà una configurazione assai semplice ed era totalmente priva di statue o apparati
54 Giampaolo Chillé
d’arte della chiesa di San Francesco, nell’ambito di uno studio sul suo patrimonio storico-artistico, rispetto al quale è apparsa evidente la loro totale estraneità,52 le sculture sono risultate appartenere, in maniera assolutamente inequivocabile, ai già citati monumenti Marchesi della chiesa di Santa Maria di Gesù Inferiore, sul-la scorta delle accurate descrizioni di questi ultimi fatte da Giuseppe Grosso Ca-copardo e Gioacchino Di Marzo nei loro scritti, costantemente citati nell’ambito dei contributi specifici sulla scultura della maniera a Messina, nei quali, peraltro, i monumenti Marchesi sono sempre menzionati.53 Stupisce non poco, pertanto, che le sculture in questione non siano state già da tempo riconosciute come quelle descritte dai due studiosi, giacché immediata risulta in realtà la loro identifica-zione. Il Grosso Cacopardo, in merito alla struttura dei monumenti Marchesi, scriveva, infatti, che sul coperchio di ciascuna urna era «una base ellittica anch’essa ripiena di bassi-rilievi figurati, e sopra questa base» una «statua al na-turale di una Virtù», specificando anche subito dopo che nella base ellittica del monumento di destra era raffigurata la Presentazione al tempio mentre in quella di sinistra era il Miracolo del paralitico risanato.54 Altrettanto chiaro è quanto riferisce il Di Marzo il quale, descrivendo anch’egli i monumenti (per i quali suggeriva però una scorretta attribuzione a Giovambattista Mazzolo), affermava che sul coperchio posava «una base ellittica con bassirilievi figurati, nella quale in cima» si ergeva «la statua al naturale di una virtù», specificando anche cosa rappresentavano i vari «rilievi di storia» presenti sulle «urne e sovr’esse».55
Meno note, ma altrettanto interessanti, sono le opere scultoree presenti ancora oggi nella chiesa di San Francesco o negli spazi a essa annessi. Si tratta di tre statue e di diversi capitelli, ricordati da varie fonti e meritevoli di singoli approfondimenti.
La più conosciuta è senza dubbio quella della Vergine Maria, di legno e ar-gento, vero e proprio emblema della «storica» devozione locale all’Immacolata,56 proclamata nel 1647 dal Senato Patrona della città di Messina. Se si eccettua un in-teressante riferimento a tale opera effettuato da Grazia Musolino, nell’ambito di uno studio sui rapporti tra produzione tessile ed orafa nel messinese, non si riscon-tra nella letteratura artistica recente alcun contributo specifico.57 Importanti infor- decorativi vari. Cfr. L. FACCIOLÀ, Cenno storico del monumentale convento…, cit., p. 11.
52 G. CHILLÈ, La chiesa di San Francesco…, cit.. 53 Cfr. in ultimo S. LA BARBERA, La scultura del Cinquecento, in Storia della Sicilia, vol. IX,
Arti figurative e architettura in Sicilia 1, Roma 2000, pp. 419-484 con bibliografia precedente e S. LA
BARBERA, La scultura della Maniera a Messina. Note di letteratura artistica, in G. BARBERA (a cura di), Aspetti della scultura…, cit., pp. 135-154.
54 [G. GROSSO CACOPARDO] Guida per la città di Messina…, cit., pp. 118-120. 55 G. DI MARZO, I Gagini e la scultura…, cit., vol. I, p. 789. 56 Un altare dedicato all’Immacolata esisteva nella chiesa di San Francesco già nel 1497. D.
CICCARELLI, Pergamene dell’Archivio di S. Francesco…, cit., p. 24 e p.69, doc. C. 57 Cfr. G. MUSOLINO, Motivi tessili nella produzione delle botteghe orafe messinesi, in C.
CIOLINO (a cura di), La seta e la Sicilia, Messina 2002, pp. 207-215 e EAD., Mante e simulacri
Il patrimonio scultoreo di età moderna … 55
mazioni sulla statua - sia sotto il profilo strettamente storico sia sotto quello artisti-co - sono presenti nel volume di Diego Ciccarelli dedicato alla chiesa di San Fran-cesco, già più volte citato e al quale si rimanda per tutti gli spostamenti cui l’opera fu sottoposta tra la fine del XIX e la prima metà del XX secolo.58 Il simulacro è sta-to descritto con una certa enfasi dal padre Serafino Maria Cavallari, dei Minori Conventuali, in un suo contributo sui solenni festeggiamenti tenutisi a Messina nel 1855, per la definizione del dogma dell’Immacolata. Nelle sue pagine si legge che «chi non ha visto questa Immagine non può far concetto di sua venustà: le forme del volto, il colorito della carnagione, la piegatura degli occhi, a detto di sommi ar-tisti, sono d’una finezza indefinibile. È di colossale statura, vestita in argento di squisito lavorio, con in capo una corona all’imperiale ricca di grosse pietre bellis-sime, ed un serto di 12 stelle pure in argento: ha sotto al piè sinistro la luna e sotto al destro la testa d’un orrido dragone che, quasi tutto ne sentisse il peso della pos-sanza di Lei che lo calpesta, spalancate a le fauci e vibrante la lingua».59 Miracolo-samente sfuggito alle fiamme dell’incendio del 188460 e alla distruzione della chie-sa causata dal terremoto del 1908, il simulacro è stato sottoposto tra il 1949 e il 1950 ad un radicale e oggi improponibile intervento di «restauro»61 resosi necessa-rio in seguito alla rottura del capo della vergine, durante la processione dell’8 di-cembre del 1948.62 Tale intervento ha comportato la totale sostituzione della parte lignea dell’opera con una nuova scultura eseguita dal messinese Carmelo Scatta-reggia. Era opinione del Facciolà che la scultura originale fosse stata eseguita dal pittore messinese Antonino Bova, durante il suo soggiorno forzato presso il con-vento di San Francesco, nel tentativo di sfuggire alla giustizia che, come informa il Susinno, lo accusava di aver ucciso «con una archibugiata un suo rivale».63 Priva di fondamento, tale ipotesi non si ritiene oggi condivisibile. Certo è invece che a far realizzare il fastoso «abito» d’argento che avvolge la Vergine (su esso sono im-pressi lo stemma di Messina, le iniziali dell’artefice N. I. e la sigla consolare S. S. C. seguita dalla data [1]748), furono nel 1749 gli eredi del nobile Domenico Maio-
d’argento nelle chiese delle diocesi messinesi, in «Paleokastro. Rivista trimestrale di studi sul territo-rio del Valdemone» 14 (luglio-agosto 2004), pp. 5-14, articolo nel quale è riproposto, senza alcuna variante, quanto scritto in merito alla statua dell’Immacolata nel precedente contributo.
58 D. CICCARELLI, San Francesco all’Immacolata…, cit., pp. 44-45, 64 e 68.
59 S.M. CAVALLARI, Le feste per la dommatica pontificia definizione della Immacolata Conce-zione di Maria Vergine, celebrate dai PP. Minori Conventuali di S. Francesco in Messina nei giorni 23, 24, 25 febbraio 1855, Messina 1855, pp. 11-12.
60 Per un’appassionata descrizione del salvataggio del simulacro cfr. Incendio spaventevole!, in «Gazzetta di Messina», 24 luglio 1884, p. 3.
61 G. MUSOLINO, Motivi tessili…, cit., p. 213. 62 La processione della Madonna Immacolata sospesa per un infausto incidente, in «Notizia-
rio di Messina», 9 dicembre 1948, p. 2. 63 F. SUSINNO, Le vite de’ pittori…, cit., p. 222.
56 Giampaolo Chillé
lino, per onorare un voto da questi fatto durante l’epidemia di peste del 1743.64 Connotato da una fattura accurata e ricercata, il manto d’argento della Vergine pre-senta un movimentato decoro fitomorfo, su uno sfondo rigato e a scaglie, che ri-chiama alla memoria i raffinati ricami di tessuti degli inizi del Settecento.
Un’altra interessantissima statua, raffigurante Sant’Antonio da Padova e già collocata sull’altare maggiore dell’omonima cappella, si conserva nei locali del convento (fig. 3). Eseguita in gesso e cartapesta e di intonazione piuttosto popolare, essa è rivestita nella parte anteriore, da un lamina d’argento, riccamente lavorata, che riproduce con estrema finezza e dovizia di dettagli, l’ideale saio del Santo.65 Il modello decorativo che connota i preziosi «tessuti» utilizzati per «confezionare» l’abito presenta un’impostazione a rete con maglie ovali chiuse - formate da un cordone ricoperto da foglie d’acanto e ornato da un nastro - con fiori nei punti di tangenza. Al centro delle maglie sono composizioni fitomorfe, piuttosto articolate e con un’infiorescenza centrale. Nella parte superiore del saio, dove le maglie ap-paiono più piccole rispetto a quelle della parte inferiore, i decori centrali sono più fitti ed elaborati, e arricchiti da una sorta di perlinatura lungo alcuni dei rami fo-gliacei che li compongono. I motivi decorativi dei tessuti riproposti, come spesso accade nella loro trasposizione su lastre d’argento, non rispecchiano affatto la mo-da del tempo ma si richiamano a modelli precedenti, verosimilmente databili intor-no agli anni Settanta del Seicento. L’accentuato rilievo dei decori rispetto al fondo e il ricercato effetto chiaroscurale che ne consegue lascerebbero pensare ad un raf-finato velluto cesellato, di produzione toscana o veneziana, come del resto sembre-rebbe confermare anche lo schema dell’ornato. È noto, infatti, che per ragioni tec-niche legate alla programmazione dei telai, i velluti conservavano per più tempo rispetto ad altri tessuti i disegni più tradizionali. Il mediocre stato di conservazione della lamina e lo spesso strato di sporco e polvere che la riveste non impediscono di rilevare in essa una qualità straordinariamente alta, giustificata, sulla scorta dei punzoni rintracciati, dalla possibile attribuzione ad uno dei più straordinari artefici del barocco europeo: Filippo Juvarra. Accanto allo stemma della città di Messina affiancato dalle lettere M e S, alle iniziali del console vidimatore AFC66 e all’anno
64 Si apprende dalle seguenti iscrizioni presenti sulla lamina d’argento: «Votum a. n. Dom.
Maiolino anno 1743 pestis», «Votum pro media statua fattu a nob. Dom. Maiolino», «Et ab haeredi-bus solutum anno 1749». D. CICCARELLI, San Francesco all’Immacolata…, cit., p. 44.
65 Priva di qualsiasi ornamentazione è invece la parte posteriore, coperta un tempo da un manto serico. Il rivestimento parziale del simulacro, non inusuale, trova una spiegazione immediata nel fatto che questo era collocato entro una nicchia presente nella parte superiore dell’altare, a forma di tabernaco-lo, ed era pertanto visibile solo frontalmente. D’argento erano anche il Bambino e il giglio, tradizionali attributi iconografici del Santo, andati perduti probabilmente in seguito al terremoto del 1908.
66 In assenza di documenti che possano far chiarezza su tale punzone, esso può essere riferito tanto ad Antonio Frassica, quanto ad Antonio Frassica o Andrea Franca. Cfr. M. P. PAVONE ALAJMO, scheda n. 31, in M. P. PAVONE ALAJMO (a cura di), Arti decorative…, cit., p. 57.
Il patrimonio scultoreo di età moderna … 57
di esecuzione, il (1)700, è presente, infatti, sull’opera il punzone FLIV, già ritenuto del grande maestro messinese da Maria Accascina.67 Il marchio FLIV può essere riscontrato anche su un paliotto della chiesa di Santa Maria degli Angeli di Castro-reale,68 su un calice della cattedrale di Messina69 e su un reliquario del Museo Re-gionale di Messina,70 opere tutte assai raffinate e stilisticamente coerenti,71 con le quali il saio d’argento del nostro Sant’Antonio evidenzia strette affinità tanto sul piano culturale quanto su quello esecutivo. L’opera fu eseguita su commissione di fra’ Matteo Fiorillo di Santa Lucia del Mela, promotore nel 1700 della decorazione di tutta la cappella del Santo, con stucchi, affreschi e arredi sacri di vario tipo «con una spesa di 12,000 scudi».72
Legata alla grande devozione locale verso sant’Antonio è anche la sta-tua marmorea oggi posta nel giardino retrostante alle absidi della chiesa (fig. 4), ma un tempo collocata al centro del chiostro, tra verdeggianti alberi di arancio. Caratterizzata da una certa eleganza formale essa è menzionata dalle varie gui-de della città, senza alcuna attribuzione. Proclamato patrono di Messina nel 1648, con un appassionato decreto del Senato cittadino, il Santo è rappresentato stante, con il Bambino tra le braccia e senza gli attributi iconografici più con-sueti, quali il giglio e il libro. Piuttosto convenzionale nell’impostazione gene-rale, la scultura è connotata da un morbido modellato che traduce, attraverso la levigatezza del marmo e le sue pieghe, effetti pittorici e chiaroscurali. Sorve-gliate sono le espressioni dei volti e accurata è la resa dei particolari, dal cingo-lo alle unghie delle mani, all’abbottonatura della camicia che fuoriesce dalle maniche del saio. Caratteri stilistici, espressivi e compositivi vagamente simila-ri possono riscontrasi nell’opera del messinese Giuseppe Buceti, autore della famosa Immacolata di marmo, oggi nell’omonima piazza, e anche egli in parte influenzato dalla scultura partenopea della prima metà del Settecento, come lo sembrerebbe l’ignoto autore del nostro Sant’Antonio.
In attesa di una loro degna collocazione, infine, vanno segnalati presso la
67 Cfr. M. ACCASCINA, I marchi delle argenterie e oreficerie siciliane, Busto Arsizio 1976, p. 105.
L’attribuzione del punzone FLIV a Filippo Juvarra è stata, recentemente messa in discussione in G. MUSO-
LINO, Argentieri messinesi tra XVII e XVIII secolo, Messina 2001, pp. 179-180 e EAD., L’argenteria del Settecento a Messina tra barocchetto e formule rococò, in S. GRASSO - M.C. GULISANO (a cura di), Argenti e cultura rococò nella Sicilia centro-occidentale 1735-1789, Palermo 2008, pp. 95-121.
68 Cfr. B. MACCHIARELLA FIORENTINO, scheda n. 47, in C. CIOLINO (a cura di), Orafi e argen-tieri al Monte di Pietà. Artefici e botteghe messinesi del sec. XVII, Messina 1988, p. 250.
69 Cfr. M.P. PAVONE ALAJMO, scheda n. 40, in C. CIOLINO (a cura di), Orafi e argentie-ri…, cit., p. 236.
70 Cfr. M.P. PAVONE ALAJMO, scheda n. 123, in M. C. DI NATALE (a cura di), Splendori di Si-cilia. Arti decorative dal Rinascimento al Barocco, Milano 2001, pp. 439-440.
71 Per un elenco delle opere note sulle quali è possibile riscontrare il marchio FLIV cfr. G. MUSOLINO, Argentieri messinesi…, cit., pp. 170-175.
72 G. LA FARINA, Messina e i suoi monumenti…, cit., p.121.
58 Giampaolo Chillé
chiesa di San Francesco una serie di capitelli (fig. 5) posti un tempo a coronamento delle colonne dell’antico chiostro, portato a compimento, dopo trentacinque anni di lavori, nel 1566 a spese del pubblico censo, come si leggeva un tempo su una lapi-de posta tra le arcate.73 Ricordato da tutte le fonti locali come uno dei chiostri più belli di Messina, esso era scandito da trentasei colonne di candido marmo sulle quali erano impostati archi a tutto sesto. Alla sua costruzione, forse promossa dalla nobile famiglia Marullo di Condoianni, parteciparono le più importanti famiglie messinesi del tempo, le cui insegne compaiono ancora oggi su vari capitelli. Come si è già avuto modo di notare in altra sede, artefici della realizzazione del chiostro - avvenuta secondo un’antica tradizione orale (tramandata sino alla fine dell’Ottocento dai frati del convento) su disegni di Polidoro da Caravaggio - è ipo-tizzabile siano stati Giovambattista e Giovandomenico Mazzolo, sulla scorta dei documenti noti e delle affinità, che sotto il profilo stilistico, decorativo e culturale possono cogliersi con i capitelli del portale laterale del duomo di Messina e con quelli del portale settentrionale del duomo di Catania,74 per i quali sono stati fatti in passato nomi differenti ma che recentemente sono stati messi in relazione, seppur cautamente, con l’opera di Giandomenico Mazzolo.75 Alla fine del Quattrocento altri due abili artisti erano stati ingaggiati dai frati di San Francesco per lavori rela-tivi alla costruzione del chiostro: Antonello Freri e Domenico Gagini.76 Non cono-sciamo l’esito dei loro lavori, certo però è che anch’essi con la loro attività contri-buirono a fare di San Francesco uno degli edifici religiosi più rilevanti della Sicilia, straordinario centro di vita spirituale, culturale e artistica.
73 Si veda pubblicata in G. BUONFIGLIO E COSTANZO, Messina città nobilissima…, cit., c. 30r. 74 G. CHILLÈ, Il chiostro della chiesa di San Francesco…, cit. 75 A. MIGLIORATO, Giandomenico Mazzolo: ipotesi per un percorso, in G. BARBERA (a cura
di), Miscellanea di studi e ricerche, in «Quaderni dell’attività didattica del Museo Regionale di Mes-sina» 12 (2002), pp. 9-23.
76 G. CHILLÈ, Il chiostro della chiesa di San Francesco…, cit.
Indice generale
I Premessa 1 Adriana Arena La chiesa e il convento di San Francesco a Patti 13 Sergio Bonanzinga Riti musicali popolari e devozioni “francescane” a Messina
43 Giampaolo Chillè Il patrimonio scultoreo di età moderna della chiesa di San Francesco
all’Immacolata di Messina 59 Diego Ciccarelli La visita del p. Antonio Fera vicario generale OFMConv. (1579-1580) 65 Francesco Costa Giovanni Reitano da Messina, oratore († 1693) 87 Ilenia Craparotta Un predicatore di Patti: Serafino Cavallari 91 Elvira d’Amico La Pala dell’Immacolata e santi nella chiesa di San Papino dei Padri
Riformati Francescani di Milazzo 95 Fernando Dominguez Reboiras Causa, finis et quies huius mundi: el discurso cristològico de Raimundo
Lulio en Messina 125 Antonella Doninelli Appunti per una storia delle presenze degli Spirituali a Messina 131 Nicoletta Grisanti Un trattato di medicina del protomedico Antonino Oliveri. Messina 1624
139 Stefania Lanuzza Il convento dei Cappuccini di Messina 153 Giuseppe Lipari Ad uso di… I libri di p. Antonino da San Marco 161 Salvatore Mangione San Fratello 163 Carolina Miceli Un amanuense messinese del Trecento 173 Alessandra Migliorato San Francesco stigmatizzato in due dipinti cinquecenteschi di nuova
attribuzione 181 Giovanni Molonia La Madonna degli Angeli di Antonello Gagini nella chiesa di San Francesco
d’Assisi di Messina 187 Rosario Moscheo Il commento al De Sphaera di p. Celestino de Oddis 207 Elvira Natoli Martino Montanini e la committenza francescana a Messina 213 Annunziata Maria Oteri La cultura neomedievalista a Messina nell’Ottocento e i restauri della chiesa
di S. Francesco d’Assisi
225 Giuseppe Pantano Fra Bartolomeo da Montalbano. Biografia del venerabile Bartolomeo
Buccheri, frate laico dei Minori Osservanti Riformati 249 Luca Parisoli L’attesa escatologica in Pietro di Giovanni Olivi 261 Agostina Passantino Salvato dal terremoto del 1908: un libro di “Bolle e Monacati”. Dal
Monastero di S. Barbara al Convento di S. Francesco di Messina
269 Teresa Pugliatti San Francesco Stigmatizzato di Filippo Paladini nel Museo Regionale di
Messina 273 Carmen Puglisi - Rosaria Stracuzzi I manoscritti della Biblioteca Provinciale dei Cappuccini di Messina 285 Ivana Risitano Il Viaggio del cielo di Serafino Caruso 299 Carmela M. Rugolo La fondazione del convento dei Cappuccini di Lipari 313 Daniela Santoro Intrecci di potere: aristocrazia messinese e Francescani tra XIV e XV secolo 321 Giacomo Scibona P. M. Vincenzo Federico Pogwisch, minore conventuale, archeologo 325 Elena Scrima La Biblioteca dei Cappuccini di Francavilla di Sicilia alla fine del XVI
secolo: libri e letture tra proibizioni e prescrizioni 361 Angelo Sindoni Francescanesimo, istruzione e cultura a Messina dopo la Soppressione degli
Ordini Religiosi (1866-1867) 369 Francesco Paolo Tocco Costanza di Svevia e il Francescanesimo femminile a Messina. Alle radici di
una mistificazione 383 Elisa Vermiglio La presenza francescana a Messina tra il XIV e XV secolo: lasciti, donazioni
e testamenti 401 Illustrazioni 473 Indice dei nomi e dei luoghi



























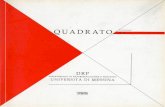

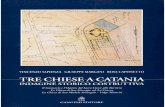




![[Salis M.] Ittiri, chiesa di San Pietro](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63235bf65f71497ea9044b23/salis-m-ittiri-chiesa-di-san-pietro.jpg)