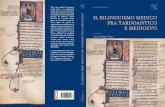Donne al louterion nella ceramica italiota, Qui fresca l’acqua mormora (Sapph. Fr. 2,5). Un...
-
Upload
unisalento -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Donne al louterion nella ceramica italiota, Qui fresca l’acqua mormora (Sapph. Fr. 2,5). Un...
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’ANTICHITÀ
CULTURA E RELIGIONEDELLE ACQUE
Atti del Convegno interdisciplinare«Qui fresca l’acqua mormora …» (S. Quasimodo, Sapph. fr. 2,5)
Messina 29-30 marzo 2011
a cura di
anna CalDerone
G I O R G I O b R E T S C H N E I D E R E D I T O R ER O M A • 2 0 1 2
COPYRIGHT © 2012 by GIORGIO BRETSCHNEIDER EDITOREVia Crescenzio, 43 - 00193 Roma - www.bretschneider.it
È vietata ogni forma di totale o parziale riproduzione, duplicazione, elaborazione, diffusione, distribuzione o altro diverso utilizzo,
con qualsiasi modalità o strumento, senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Editore.
Donne al louterion nella ceramica apula e lucana
Francesca silvestrelli
le immagini raffiguranti la toletta di figure femminili alla fontana o al semplice louterion hanno, negli ultimi anni, ricevuto grande attenzione con studi riservati soprattutto alla ceramica attica 1; minore è, invece l’interesse nei confronti dell’articolazione del tema nelle produzioni dell’italia meridio-nale 2, dove esso è caratterizzato da percorsi in parte originali. in considera-zione del grande numero di attestazioni ci si limiterà ad analizzare, in questa sede, le immagini presenti nella ceramica lucana e, soprattutto, apula.
il tema compare già nella seconda metà del V secolo a.c. con una ri-dotta serie di vasi che raffigurano una o più donne sorprese dai satiri 3. Se si eccettuano due pelikai, queste scene decorano oinochoai, skyphoi e, soprat-tutto, crateri a campana. le fanciulle sono raffigurate intorno al lou terion all’interno del quale è talvolta un volatile 4 o occupate nelle varie fasi del bagno e della cosmesi mediante le quali giungeranno all’acquisizione del-la charis. esse, infatti, si lavano le mani 5 (come atena che, in cratere a pari-gi, si prepara al giudizio di paride lavandosi alla fontana 6), o i capelli, come in un vaso un tempo appartenuto alla collezione Hamilton 7. in una pelike del pittore di Dolone 8 la fanciulla tende una mano verso il getto d’ac-
1) per l’interpretazione delle figure femminili in queste scene si vedano PFisterer-Haas 2002, particolarmente pp. 40-47 e MenicHetti 2006a e id. 2008, con bibliografia preceden-te. Si vedano inoltre Kreilinger 2007, pp. 181-220. Hosoi 2007. sabetai 2009 pp. 103-106. stäHli 2009. sutton 2009. per le ciste prenestine: MenicHetti 1995.
2) Sulla ceramica italiota ginouvès 1962, pp. 95; 114-116; 118;171-172; Kreilinger 2007, pp. 81-89 e 96. Kossatz-deissMann 2007.
3) Scene analoghe sono attestate nella ceramica attica (ginouvès 1962, 115; PFisterer-Haas 2002, 23-25; Kreilinger 2007, pp. 175-178) e nelle ciste prenestine (MenicHetti 1995, pp. 61-64; id. 2006a, pp. 59-61).
4) Bari, collezione polese 6327: lCS Suppl. iii, 41, a16. cfr. anche la chous apula sul mercato d’arte: rVAp i, 4/256a (pittore di reggio 7001).
5) oinochoe lCS 24,81 (pittore di pisticci); Kreilinger 2007, p. 83, fig. 149.6) parigi, cabinet des médailles 422: lCS Suppl. iii, 3/D19 e MenicHetti 2006b, pp.
266-267. 7) Kreilinger 2007, fig. 148. 8) lCS 71, 360 (Gruppo di minniti). denoyelle 2002, p. 110, fig. 28 a-b (pittore di
Dolone).
FranceSca SilVeSTrelli114
qua in un gesto che richiama quello, ben più familiare, della donna che si guarda allo specchio, giocando così sulla sovrapponibilità delle due superfi-ci riflettenti 9. lo specchio, tenuto in mano dalle fanciulle o posto nel cam-po figurato, costituisce, d’altra parte, un attributo costante e certifica la con-quista della bellezza attraverso la pratica della toletta che prepara le giovani donne al mutamento di status.
Fanciulle e satiri non interagiscono; se nella chous del pittore di pisticci i due protagonisti sono separati in modo tangibile dalla colonna, un’analo-ga suddivisione è ottenuta, nella pelike del pittore di Dolone, mediante lo svolgimento della scena sui due lati del vaso. in altri casi, è il gioco degli sguardi delle donne, che non incontrano mai quelli dei satiri, a sottolinea-re la separazione tra i due mondi. È quanto accade, ad esempio, in un cra-tere a campana del pittore di amykos 10. in uno spazio esterno 11, tre satiri danzanti circondano due fanciulle, completamente ignare della loro presen-za; una delle donne, vestita con il chitone, si osserva allo specchio, la secon-da, ancora nuda, si risistema una benda. in una pelike del pittore di Sisifo 12, una donna inginocchiata si pettina 13, mentre la seconda fanciulla è oggetto dell’interesse di un satiro che, nascosto dietro ad un albero, sembra essere sul punto di toccarla. il lato posteriore del vaso presenta, invece, tre giova-ni atleti. i due lati della pelike pongono quindi in opposizione due mondi, quello maschile e quello femminile, rappresentato il primo dall’atletismo, il secondo dalla charis e di cui i satiri costituiscono l’elemento di congiunzio-ne; essi si pongono all’esterno, manifestazione dello sguardo maschile che entra in uno spazio, quello femminile, che gli è altrimenti precluso 14.
la fontana e, per estensione, anche il louterion, oltre ad essere lo stru-mento mediante il quale la donna acquisisce la charis e, con essa, la nuo-va condizione che la prepara al mutamento di status implicito nel matri-monio 15 sono anche il luogo che esplicita i possibili rischi che la fanciulla può incontrare alle soglie della maturità sessuale. i satiri, spesso raffigura-ti danzanti, sottolineano il pericolo, ma visto in un’ottica di neutralizzazio-ne dell’aggressione 16.
essi possono tuttavia anche tentare un’interazione. in un cratere a cam-pana del pittore delle lunghe Falde un satiro nascosto sotto il louterion si av-
9) Su questo tema si veda MenicHetti 2006b, p. 261.10) ciancio 1997, n. 222. 11) Sull’ambiguità delle scene ambientate all’esterno, nelle quali si è proposto di riconosce-
re delle ninfe, cfr. ginouvés 1962, pp. 115 e 123, Kreilinger 2007, p. 68 e sutton 2009.12) rVAp i, 1/89, tav. 7.113) per lo schema della bagnante inginocchiata e le sue valenze si veda sutton 2009,
pp. 273-274. 14) lissarague 1998, p. 184. Sulle ciste prenestine: MenicHetti 1995, p. 62.15) MenicHetti 2006a, pp. 54-55. sabetai 2009, pp. 107-108. 16) isler-Kerényi 2001, p. 123.
115Donne al louterion nella ceramica apula e lucana
vicina a toccare la donna, invadendone lo spazio 17 mentre due crateri luca-ni 18 (Tav. Viii, a) mostrano un satiro in atto di rubare la veste. in un cratere a calice del pittore di Hearst 19 protagonista del furto, questa volta del man-tello e dei sandali, è invece Hermes che, con questa azione, impedisce alla fanciulla di completare la toletta e conseguire il nuovo statuto 20. un satiro ha un alabastron e un frutto tondo nel quale si potrebbe riconoscere una mela cotogna 21, che torna anche in mano ad uno dei giovani ammantati del lato posteriore, segnalandone l’importanza dal punto di vista semantico.
il tema della donna al louterion sorpresa dai satiri sembra esaurirsi con il primo quarto del iV secolo a.c.; l’elemento dionisiaco non scompare tutta-via completamente. uno skyphos 22 presenta due fanciulle nude, una delle quali immerge le sue mani nella vasca e, sul lato posteriore, un satiro e una mena-de danzanti 23. Singoli attributi, come i grappoli d’uva, tornano inoltre in nu-merosi vasi, mentre in una situla sul mercato d’arte 24 una fanciulla si sistema la capigliatura guardandosi allo specchio al di sotto di una pergola di vite.
le donne nude alla fontana o, più frequentemente, al semplice louterion possono essere rappresentate anche in assenza di satiri. le fanciulle sono sole, come accade soprattutto nella ceramica di Gnathia 25, in coppia 26 oppure accompagnate da eros 27 o da un’altra figura femminile vestita 28. esse pos-
17) rVAp i, 4/129. lo stesso gesto è presente in unas kalpis attribuita ad eutimide (ArV 2 28,13 e PFisterer-Haas 2002, p. 22, fig. 23 a-c e p. 67, rB3) e in una cista prenestina: Me-nicHetti 1995, p. 62, fig. 26.
18) cratere a campana Taranto, museo archeologico nazionale 171310, da rutigliano, tomba 28/1978: ciancio 2007, p. 413 (pittore dell’anabates). cratere a campana in Giappone, collezione privata: lCS Suppl. iii, p. 69, n. BB31 (pittore di Brooklyn-Budapest).
19) lecce, museo provinciale castromediano 629. rVAp i, 1/36, fig. 2,1 e 3,1-2. 20) Kossatz-deissMann 2007, p. 183. 21) ead. 2007, p. 186.22) parigi, louvre: rVAp i, 7/60a (pittore di Felton); CVA louvre 25, tav. 60; Kreilin-
ger 2007, 86, fig. 201. 23) Si vedano anche lo skyphos di tipo c ad altenburg, Staatliches lindenau-museum:
CVA altenburg 3, tav. 100 (terzo quarto del iV secolo a.c.) e lo skyphos di tipo a con gio-vane donna al louterion che versa un unguento contenuto in un alabastron e, sul lato opposto, un satiro seduto su di una roccia che suona il flauto: Kreilinger 2007, fig. 199.
24) scHauenburg 2004, pp. 773-775, 779, fig. 1-3.25) Si vedano, ad esempio, la pelike del museo archeologico nazionale di metaponto
proveniente da metaponto, pizzica, tomba 1/1985, la lekythos e l’alabastron in collezione pri-vata: scHauenburg 2010, figg. 27, a-b e 28, 1-b o il frammento a Basilea, collezione cahn H.c. 1306: Céramique de la Grande Grèce, p. 304, n. 133.
26) esse sono frequenti nella ceramica pestana e in quella campana: Kreilinger 2007, pp. 83-85, figg. 150-155, 158, 161, 169, 171-174, 179. Sui lebetes gamikoi pestani rinvenuti nel santuario di Hera a poseidonia cfr. cassiMatis 1993, pp. 125-126.
27) Pelike a Stoccolma, museo nazionale a 29: rVAp i, 3/111 (vasi connessi al Gruppo di Sydney 71) e liMC iii, s.v. eros, n. 654, tav. 646 (H. cassimatis).
28) Pelike a Tolouse, musée S. raymond 26.316: rVAp i, 3/120 (Gruppo del Vaticano V 5). cratere a campana lecce, museo provinciale S. castromediano 612: rVAp i, 5/3 (pittore di lecce 614) e Kreilinger 2007, p. 86 fig. 204.
FranceSca SilVeSTrelli116
sono essere raffigurate mentre fanno il bagno ad un uccello 29 oppure colte nel momento in cui si spogliano o si rivestono 30 o in quelle azioni attra-verso le quali esse giungono al completamento della toletta e all’acquisizio-ne della charis: esse immergono le mani nella vasca 31, si lavano i capelli 32, versano un’essenza da un alabastron per profumarsi 33. in alcune scene si si-stemano l’acconciatura, ammirandosi in uno specchio 34, azione che sancisce l’avvenuta acquisizione del potere di seduzione 35. Alabastra, lekythoi e spec-chi, semplicemente tenuti in mano dalle donne 36 o raffigurati sullo sfondo, sono gli attributi costantemente presenti. Se nel primo quarto del iV a.c. queste scene possono ancora apparire in crateri a campana, in oinochoai o in skyphoi, a partire dalla fine del primo quarto del iV a.c. esse sembrano preferire forme quali le lekythoi ariballiche, i lebetes gamikoi e, soprattutto, le pelikai; sembra inoltre possibile notare un progressivo arricchimento delle rappresentazioni, che coinvolgono ora un numero superiore di personaggi femminili. il louterion mantiene la funzione di asse principale della rappre-sentazione intorno a cui la scena si organizza e con cui di norma i perso-naggi interagiscono. eros, che acquisisce un ruolo di crescente importanza, può partecipare attivamente, riempendo la vasca con l’acqua contenuta in una hydria, come in una pelike conservata a parigi 37, o versando dall’alabastron un’essenza sulle mani della fanciulla 38. i vasi presentano, sul lato po-steriore, scene collegabili con quelle del lato anteriore. Sia nella pelike di parigi sia nel lebes gamikos del Gruppo del Vaticano V2, ad esempio, il lato opposto del vaso raffigura una giovane donna riccamente abbigliata e in-gioiellata a colloquio con un giovane.
a partire dalla fine del primo quarto del iV a.c. il louterion può esse-
29) Chous sul mercato d’arte: rVAp i, 4/256a (pittore di reggio 7001). Pelike a Taranto, museo archeologico nazionale 3588-B: liMC iii, s.v. eros, n. 654g (H. cassimatis) e Krei-linger 2007, 86, fig. 209 (ultimo quarto del iV secolo a.c.).
30) Pelike di madrid, palacio de liria, rVAp i, 3/119 (Gruppo del Vaticano V5).31) cratere a campana a Bari, collezione macinagrossa 16: rVAp i, 5/246 (pittore di iris)
e Kreilinger 2007, 86 fig. 203. Pelike napoli, museo archeologico nazionale 2318 (81715): rVAp i, 5/266 (pittore di iris). per il tema in ambito lucano cfr. il lebes gamikos a napoli, museo nazionale, Stg 570: lCS 137, 749 (pittore delle coephore).
32) Frammento della collezione cahn, supra nota 25. 33) Skyphos sul mercato d’arte: Kreilinger 2007, fig. 199. 34) Situla, supra nota 24. 35) Sulla funzione dello specchio come elemento che certifica la bellezza femminile e
la charis cfr. MenicHetti 2006b, pp. 262 e 269. Sulle azioni alla toletta cfr. bodiou, MeHl 2008, pp. 27-29.
36) lekythos ariballica Tübingen 28.5411: CVA Tübingen 7, tav. 3,3 (380-360 a.c.); le due fanciulle hanno in mano uno specchio e un alabastron.
37) parigi, petit palais 333: rVAp i, 9/158 (pittore di Schlaepfler, secondo quarto del iV secolo a.c.) e Kreilinger 2007, p. 86 fig. 207. Si veda anche la pelike a londra, Victoria and albert museum 4799.1901: rVAp i, 15/45, tav. 143,1-2.
38) lebes gamikos Karlsruhe B41: rVAp 8/254 (Gruppo del Vaticano V2, da ruvo) e Krei-linger 2007, p. 86 fig. 208. per la provenienza da ruvo: Montanaro 2007, pp. 891-893.
117Donne al louterion nella ceramica apula e lucana
re sostituito, con funzione del tutto analoga, da una patera, poggiata a ter-ra o su di un pilastro 39. in una pelike apula, ad esempio 40, accanto al diphros posto su di una pedana 41 una fanciulla, nuda ma ornata dei gioielli, versa dell’olio profumato da un alabastron mentre una donna vestita le porge un diadema. anche in questo caso il lato posteriore del vaso mostra la donna, ormai pronta per l’incontro con l’uomo.
in alcune raffigurazioni la toletta avviene in un spazio aperto suggeri-to da rocce, alberi, fiori e uccelli. eros è spesso raffigurato in volo sulla va-sca 42 o seduto al suo interno, quasi a esaltarne la sua funzione di elemento di seduzione 43. egli può avere in mano un nastro, talvolta ricamato, for-se allusivo alla cintura che lo sposo scioglierà nella prima notte di nozze 44. Queste raffigurazioni, diffuse nel secondo quarto del iV secolo a.c., si pre-stano ad essere ospitate in pelikai, spesso di grandi dimensioni, avvicinabili per temi e monumentalità della forma alla serie delle cosiddette pelikai nu-ziali 45. una pelike del pittore dell’ilioupersis raffigura, sui due lati del vaso, fanciulle impegnate nella carpologia e nella toletta. la presenza del serpen-te consente di identificare la scena del lato principale come una raffigura-zione del Giardino delle esperidi, costruita intorno all’albero dal quale due esperidi raccolgono dei frutti. eracle non è tuttavia presente e l’immagi-ne fornisce una dimensione mitica ad un’attività, come quella della rac-colta dei frutti, costantemente associata alle parthenoi. parallelamente, punto focale della scena raffigurata sul lato posteriore è il louterion su cui è eros mentre le fanciulle, probabilmente le stesse esperidi 46, si dispongono intor-no ad esso su vari piani.
in una pelike del pittore di Dechter databile al secondo quarto del iV secolo a.c. 47 eros, seduto sul louterion, guarda in direzione di una giova-
39) ginouvès 1962, pp. 170-171. Si vedano, ad esempio, il dinos di ruvo, museo Jatta 1618: rVAp i, 8/67, tav. 64.3 (pittore dell’ilioupersis) e la lekythos ariballica a Vicenza, colle-zione Banca intesa 478: sena cHiesa, slavazzi 2006, n. 252 (pittore di Truro).
40) oxford, ashmolean museum G 269: rVAp i 15/22, tav. 140,1 (Gruppo di oxford G 269).
41) per la funzione della pedana cfr. giacobello 2008, p. 272.42) Pelike a minneapolis, university of minnesota 73.10.14: rVAp i, 7/71, tav. 58,3 (pittore
di Felton). Pelike apula a catania, museo Biscari 4402: rVAp i, 8/20 (pittore dell’ilioupersis). Pelike apula a metaponto, museo archeologico nazionale 27932: rVAp ii, 18/369 (Gruppo di Zurigo 2657, da Ferrandina).
43) ginouvès 1962, p. 173. Pelike apula a catania, museo Biscari 4225: rVAp i, 10/75 (pittore di Dechter).
44) Pelike a catania, supra 42. Sul possibile significato del nastro cfr. baggio 2004, pp. 136-138.
45) sena cHiesa 2005.46) pelike catania 4402, supra nota 42. le esperidi compaiono associate al louterion an-
che in una lekythos ariballica di assteas a new York, collezione privata: liMC V, s.v. Hespe-rides, n. 5a (i. mcphee).
47) catania 4225, supra nota 43.
FranceSca SilVeSTrelli118
ne donna nuda con in mano uno specchio. alle sue spalle, appoggiata ad un albero, è la veste. a destra del louterion una seconda fanciulla nuda ha in mano una benda, mentre due donne con chitone ed himation siedono ai piedi della vasca. in alto, una figura femminile si affaccia da una finestra. Sul lato posteriore del vaso, da leggere in sequenza, una donna, probabilmen-te la sposa, seduta sul klismos posto su di una pedana viene presa per mano da una figura femminile con velo e corona. la colomba che porta la coro-na, l’erote con l’alabastron e quello con la benda, la figura femminile con la cassetta e il kalathos sono tutti segni che rimandano all’ambito nuziale.
il tema della donna nuda al louterion sembra incontrare, dopo la metà del iV secolo a.c., minore interesse 48, pur continuando ad essere raffigu-rato nella ceramica di Gnathia. in una serie di immagini che si diffondo-no nella ceramica apula a partire dal secondo quarto del iV secolo a.c. in hydriai, pelikai, lekythoi e bottiglie una 49 o più fanciulle 50, tutte vestite, tal-volta accompagnate da eros 51, si dispongono accanto al louterion. la prota-gonista principale, riccamente abbigliata, siede sul diphros, come in una pelike a le Hague 52 e in una hydria a Basilea 53, dove, alle spalle della futura sposa, un’ancella porta un kalathos, possibile allusione ai doveri domestici che l’attendono. alternativamente, ella si appoggia al louterion mentre eros la incorona, come in una hydria dell’officina del pittore di licurgo (Tav. Viii, b) 54. rispetto alle immagini precedentemente descritte, mutano anche
48) Pelike da Ferrandina, supra nota 42 e lekythos a parigi, cabinet des médailles 1037: rVAp ii, 26/287, tav. 315,4 (Gruppo di menzies). Sono tuttavia attestate scene con la toletta presso un bacile: si vedano, ad esempio, la lekane apula a Trieste, museo civico S 478 (CVA Trieste, iV D, tav. 30) o la pisside del pittore di Baltimora: scHauenburg 2010, p. 21, fig. 34.
49) Pelike a Taranto, museo archeologico nazionale: rVAp i, 5/116 (pittore di Truro). Kylix a Bassano, collezione chini 144: rVAp ii, 24/27. pisside globulare apula: christie’s new York, Antiquities, 13 June 2000, p. 49, n. 285.
50) Pelike a napoli, museo archeologico nazionale 2117 (81770): rVAp i, 6/172 (pit-tore di Digione). lebes gamikos a Bari, museo archeologico 1330-1: rVAp i, 8/159 (pittore di atene 1714). lekythos a Dresda, Skulpturensammlung Dr 531: CVA Dresda 1, tav. 31,1-3 (pittore di licurgo). Chous a roma, collezione privata: rVAp i, 11/281. Bottiglia a metaponto, museo archeologico nazionale 128725: rVAp ii, 26/15b (Da metaponto, pizzica D’onofrio, tomba 38). lebes gamikos a Vienna, Kunsthistorisches museum 4012: rVAp ii, 28/70, pittore di Berlino F 3383). Si veda inoltre la pelike a Taranto, museo archeologico nazionale 8144: lCS p. 140, n. 779 (pittore di roccanova)
51) Hydria a norimberga, Kunstgewerbenmuseum 3517: rVAp i, 7/75 (pittore di Felton). lekythos a Würzburg, martin von Wagner museum 826: rVAp i, 11/47 (Gruppo Waterspout) con eros seduto all’interno del louterion. Pelike rVAp ii, 18/157 (Gruppo di atene 1450). Pelike roma, musei Vaticani Y 22: rVAp ii, 18/224 (officina del pittore di Dario). Pelike apula a policoro, museo nazionale della Siritide 216512: Magna Graecia, p. 429, iii.297 (da Sant’ar-cangelo, San Brancato, Tomba 504, seconda metà iV secolo a.c.). oinochoe a Taranto, museo archeologico nazionale 61503: rVAp ii, 26/45 (Gruppo degli askoi di Trieste).
52) Pelike a le Hague, collezione Schneider-Herrmann: rVAp i, 15/53 (Sottogruppo Schneider-Herrmann).
53) Hydria a Basilea: Peintre de Darius, pp. 179-181 (pittore perrone).54) napoli, collezione privata: rVAp i, 16/53.
119Donne al louterion nella ceramica apula e lucana
gli attributi: i vasi tipici della toletta, quali aryballoi e lekythoi, assumono mi-nore importanza mentre ventagli, cassette, palle, parasoli, kalathoi e xilofo-ni 55. il potere di seduzione acquisito dalla donna mediante la toletta, cui si allude grazie alla presenza del louterion è reso evidente dalla preziosità delle vesti e degli ornamenti e dalla costante presenza dello specchio.
la fanciulla è dunque pronta per l’incontro con l’uomo e il louterion, liberato dalla sua funzione pratica, cessa di avere parte attiva nelle scene e può così acquisire un valore allusivo. Questa trasformazione apre la stra-da a nuove, possibili soluzioni. l’elemento più significativo, che appare già alla fine del V secolo a.c. 56 e si diffonde soprattutto a partire dal secon-do quarto del iV secolo, è costituito dall’ingresso dell’uomo in uno spazio che gli era precedentemente precluso, tema questo privo di una tradizione iconografica consolidata 57. la trasformazione del louterion da elemento che contribuisce alla costruzione dell’incontro con l’uomo a spazio in cui l’in-contro stesso ha luogo, che appartiene principalmente alla ceramica italiota, darà nuova linfa vitale a questo soggetto, destinato ad avere successo fino alla fine della produzione della ceramica apula 58.
in una pelike dell’officina del pittore di licurgo una fanciulla appoggia-ta al louterion si rivolge ad un giovane seduto di fronte a lei 59. la presen-za del tridente e dell’hydria riempita dall’acqua che sgorga da una protome leonina, allusione alla fontana presso cui avviene l’incontro tra amimone e poseidone, consentono di leggere l’immagine in chiave mitologica 60. la valenza paradigmatica di questo mito 61 viene ulteriormente accentuata dal louterion cui amimone si appoggia, che allude alla fase di preparazione che ha reso possibile l’incontro.
la pelike di Taranto riprende e nobilita uno schema destinato a tornare in moltissimi vasi, soprattutto in pelikai prodotte nell’ambito dell’officina del pittore di Dario 62. esse mostrano la coppia accompagnata da eros, che in-
55) Su questi attributi si veda baggio 2004 e, per il parasole, ead. 2008. 56) anfora di tipo panatenaico lCS Suppl. iii, p. 21 n. 297d (pittore di arnò) Pelike a
Bari, collezione colombo: rVAp i, 3/113b (Gruppo chaplet). lebes gamikos rVAp i, 4/155a (pittore delle lunghe Falde) e pelike a Zurigo: rVAp i, 7/31 pl. 77 (pittore della pelike di mosca).
57) alcuni precedenti possono essere rintracciati in vasi attici del secondo quarto del V secolo a.c. in cui sono state riconosciute coppie di sposi (PFisterer-Haas 2002, pp. 51-53) e nelle raffigurazioni della fine del V secolo a.c. con atalanta e peleo: ginouvès 1962, pp. 117 e 129.
58) in questa formulazione esso viene recepito anche dai tardi pittori lucani, quali soprat-tutto il pittore di roccanova con vasi provenienti dalla lucania interna. Si veda, ad esempio l’hydria a Taranto, museo archeologico nazionale 8140: lCS p. 139, n. 776, tav. 66.1.
59) Taranto, museo archeologico nazionale 124520: rVAp i, 16/52, tav. 155.60) HoFFMann 2002, pp. 138-139. 61) sabetai 2009, pp. 195 e 111.62) Pelike rVAp ii, 18/147f (Gruppo di egnazia). Patera rVAp Suppl. ii, 18/331a, tav.
Xlii,1 (pittore degli inferi). Pelike collezione ragonesi: rVAp ii, 18/209a. Pelike monopoli,
FranceSca SilVeSTrelli120
corona alternativamente la donna o l’uomo. È importante sottolinea re che, in queste scene, l’apertura dello spazio all’uomo è segnalata anche dal gio-co degli sguardi, che ora frequentemente si incontrano.
le immagini possono essere arricchite anche da altri personaggi, per-lopiù femminili, come accade ad esempio in una pelike del pittore di li-curgo 63 (Tav. iX, a) in cui il potere di seduzione della donna protagonista della scena è reso evidente non solo dalla bellezza delle vesti, che lasciano intravedere il seno, e degli ornamenti, ma anche da attributi quali la iynx, che ella tiene in mano.
in queste scene, il louterion può non costituire più il perno intorno a cui la composizione si organizza. in una lekythos del pittore di lecce della fine del secondo quarto del iV a.c. 64, ad esempio, un giovane e una fanciulla si incontrano presso un albero; alle spalle della coppia, eros si appoggia al louterion, accanto al quale è arrotolata la veste, che esplicita il collegamento con il momento del bagno, di cui l’incontro costituisce l’esito. in una lekythos del Suckling painter 65 la vasca è invece usata come altalena da eros, mentre al centro della scena vediamo la coppia sdraiata sulla kline nel momento con-clusivo del conubium. non stupisce dunque che, in alcune immagini, il louterion possa assumere anche una funzione prolettica, come, ad esempio, nel cratere a calice del pittore di Dario con l’arrivo di Bellerofonte presso io-bate 66 e nella lekythos dello stesso pittore con scena del ratto di elena 67.
anche l’incontro tra elena e paride può aver luogo nello spazio del louterion, come accade in un’anfora apula del pittore della patera in cui elena, appoggiata alla vasca, si guarda allo specchio, aggiustandosi una benda po-sta tra i capelli. la scena è costruita in modo da evidenziare l’isolamento dei due mondi, quello femminile, centrato su elena, il cui sguardo è rivolto allo specchio, e quello maschile, in cui paride è rappresentato come guer-riero e cacciatore 68. in un cratere a volute del pittore di Baltimora elena, seduta in trono, è mostrata in atto di svelarsi. ella ha in mano lo specchio, ma il suo sguardo è ora rivolto a paride, che, appoggiato al louterion, le of-fre un uccello tenuto al laccio 69.
collezione meo evoli l 149: rVAp ii, 18/342; pelike a roma, musei Vaticani Z5: rVAp ii, 18/352; pelike a los angeles, national county museum: rVAp ii, 18/355 (tutte del Gruppo Tarrytown). patera a San pietroburgo, Hermitage 391: rVAp ii, 23/78 (pittore della patera).
63) ruvo, museo Jatta 415: rVAp i, 16/3.64) Germania, collezione privata: rVAp i, 5/227. 65) monaco, antikensammlungen 3271: rVAp i, 15/3. 66) cratere a calice a Fort Worth, Kimbell art museum: rVAp ii, 18/64a e Mugione
2007, pp. 19-20. la fanciulla in corsa verso il louterion è philonoe, destinata a sposare Belle-rofonte.
67) lekythos apula a Basilea: Peintre de Darius, pp. 136-149. 68) rVAp ii, 23/48; MenicHetti 2008, pp. 224-225.69) Ginevra, collezione Sciclounoff: rVAp Suppl i, 27/15a e liMC iV, s.v. Helene n. 103
tav. 311 (l. Kahil). Sul tema del volatile tenuto al laccio si veda MenicHetti 2008, p. 221.
121Donne al louterion nella ceramica apula e lucana
Giovani appoggiati al louterion in una immagine speculare a quella del-la donna ricorrono, infatti, con pari frequenza. Questa inversione consente di concentrarsi sulla rappresentazione della figura femminile, che, splendi-damente abbigliata e ingioiellata, è spesso seduta sul diphros o sul trono. in una pelike del pittore dell’ilioupersis 70 un giovane incoronato da eros os-serva una fanciulla che si guarda allo specchio e, indossa, oltre al chitone e all’himation, anche un velo trattenuto da una corona. alle sue spalle, un’an-cella la protegge con il parasole. l’abbigliamento della fanciulla e gli attri-buti quali le cassette e il kalathos permettono di leggere la scena in chia-ve nuziale. alcune pelikai del Gruppo Tarrytown 71 (Tav. iX, b) mostrano la fanciulla che suona l’arpa. Questo strumento, di norma associato al mon-do femminile, appare in collegamento con scene matrimoniali già in vasi attici e italioti dell’ultimo quarto del V secolo a.c. nel caso di queste pelikai è probabilmente la stessa futura sposa a suonare lo strumento, grazie al quale ella si mostra dotata del dono della mousike, che ne accresce la desi-derabilità e il potere di seduzione e costituisce, nello stesso tempo, auspicio di armonia tra la coppia 72.
Solo di 52 dei circa 250 vasi schedati è conosciuta la provenienza, e ben inferiore è il numero di quelli di cui sia noto il contesto di rinvenimento; le informazioni in nostro possesso indicano che essi provengono di norma da tombe femminili sia di ambito coloniale (sia Taranto 73 sia, nella seconda metà del iV a.c., metaponto hanno restituito vasi con queste scene) sia di ambito indigeno, dove la peucezia 74 sembra avere un ruolo predominante.
il percorso delineato, che parte da raffigurazioni che hanno preceden-ti nelle immagini attiche per poi seguire strade autonome, consente di re-
70) rVAp Suppl. i, 8/23a, tav. iii, 1-2. 71) napoli, collezione privata: rVAp ii, 18/357, tav. 205.5-6. londra, British museum F
315: rVAp ii, 18/341. milano, collezione lagioia: rVAp ii, 18/356. patera a Tel aviv: rVAp ii, 18/363. Si veda anche la lekythos a parigi, cabinet des médailles 1048: rVAp ii, 26/20, tav. 3073 (Gruppo di cleveland).
72) per i vasi del Washing painter: bundricK 2005, pp. 190-192. Si veda anche il cratere a volute monaco, antikensammlung 3268: rVAp i, 1/51 (pittore di Sisifo).
73) Pelike Taranto, museo archeologico nazionale: rVAp i, 5/116 (pittore di Truro). Pelike del pittore di Dolone, supra nota 8. Pelike Taranto 125520, supra nota 59 e HoFFMann 2002, p. 202, tav. 28,2 (tomba 37). Pelike Taranto: rVap i, 16/21, tav. 151,4 e 152,3 (pittore di licurgo). Pelike Taranto 135010: rVAp ii, 18/202 e HoFFMann 2002, tav. 26,3-4.
74) numerosi vasi provengono da ruvo (Pelike a napoli, museo archeologico nazionale 2318: rVAp i, 5/266 (pittore di iris). patera napoli 2840: rVAp i, 8/65 (pittore dell’iliouper-sis). lebes gamikos Bari 1330-1: rVAp i, 8/159 (pittore di atene 1714. anfora napoli 1765: supra nota 68. Hydria napoli 3238: rVAp ii, 18/189 (Gruppo di new York 28.57.10). patera napoli 2566: rVAp ii, 22/536. lebes gamikos Karlsruhe B41, supra nota 38 e oinochoe Taranto 61503: rVAp ii, 26/45 (Gruppo degli askoi di Trieste). Da Gravina di puglia provengono il cratere a campana del pittore di amykos: ciancio 1997, p. 204 sgg., n. 222, quello del pit-tore di lecce 686: Taranto 128018, rVAp i, 3/72 e la pelike conservata a Taranto rVAp ii, 18/364a (Gruppo Tarrytown). rutigliano: cratere a campana del pittore dell’anabates, supra nota 18. per la lucania, cfr. supra nota 18.
FranceSca SilVeSTrelli122
cuperare degli insiemi coerenti. il tema incontra, nelle sue varianti, parti-colare favore nell’ambito delle produzioni del pittore dell’ilioupersis e di licurgo. È tuttavia con il pittore di Dario e con gli artisti della sua cer-chia, che prediligono lo schema dell’incontro della coppia al louterion, che esso conosce la sua maggiore diffusione; esso può essere usato come sog-getto autonomo, come accade in numerose pelikai dei gruppi di egnazia, new York 28.57.10, e soprattutto Tarrytown, oppure confluire, con diverse valenze, all’interno di scene più complesse. con quest’ultimo passaggio lo schema approda a nuove forme, quali i crateri a volute e altre forme mo-numentali, aprendo ulteriori possibilità di arricchimento.
abbreviazioni bibliograFicHe
ARV 2 = J. d. beazley, Attic redFigure VasePainters, i-iii, oxford 19632.
baggio 2004 = M. baggio, i gesti della seduzione. tracce di comunicazione nonverbale nella ceramica greca tra Vi e iV sec. a.C., roma 2004.
baggio 2008 = M. baggio, il mondo al femminile nel repertorio figurativo apulo. la prospettiva degli oggetti, in Vasi immagini collezionismo. la collezione di vasi intesa Sanpaolo e i nuovi indirizzi di ricerca sulla ceramica greca e magno greca. Atti Giornate di Studio Milano 2007, a cura di G. Sena chiesa, milano 2008, pp. 285-307.
bodiou, MeHl 2008 = l. bodiou, V. MeHl, De Myrrhinè à Marylin: se vêtir, se parfumer, se montrer ou le parfum comme parure, «metis» Vi, 2008, pp. 13-40.
bundricK 2005 = s. d. bundricK, Music and image in Classical Athens, cambridge 2005.
cassiMatis 1993 = H. cassiMatis, le lébès à anses dressées italiote, napoli 1993.
Céramique de la Grande Grèce = Céramique de la Grande Grèce. la collection de fragments Herbert A. Cahn, a cura di a. cambitoglou, J. chamay, Zürich 1997.
ciancio 1997 = a. ciancio, Silbíon. una città tra greci e indigeni. la documentazione archeologica dal territorio di Gravina in Puglia dall’ottavo al quinto secolo a.C., Bari 1997.
ciancio 2007 = a. ciancio, Ceramica a figure rosse protolucana e lucana, in Catalogo del Museo nazionale Archeologico di taranto ii,2. rutigliano i. la necropoli di Contrada Purgatorio. Scavo 1978, a cura di e. m. De Julis, Taranto 2007, pp. 407-415.
coliviccHi 2006 = F. coliviccHi, lo specchio e lo strigile. Scambio di simboli e scambio fra i sessi, in l’image antique et son interprétation, a cura di F.-H. massa pairault, roma 2006, pp. 277-299.
denoyelle 2002 = M. denoyelle, Some little Vases by the Creusa and Dolon Painters, in essays in Honor of Dietrich von Bothmer, a cura di a. J. clarke et al., amsterdam 2002, pp. 107-112.
engelMann 1899 = r. engelMann, Die Katzen im Altertum, JDAi XiV, 1899, pp. 136-143.
Frontisi-ducroux, lissarague 1998 = F. Frontisi-ducroux, F. lissarague, Signe, object, support: regard privé, regard public, «Ktema» XXiii, 1998, pp. 137-144.
123Donne al louterion nella ceramica apula e lucana
giacobelli 2008 = F. giacobelli, lo spazio interno nella ceramica apula, in Vasi immagini collezionismo. la collezione di vasi intesa Sanpaolo e i nuovi indirizzi di ricerca sulla ceramica greca e magno greca, Atti Giornate di Studio Milano 2007, a cura di G. Sena chiesa, milano 2008, pp. 267-284.
ginouvès 1962 = r. ginouvès, Balaneutikè. recherches sur le bain dans l’antiquité grecque, parigi 1962.
HoFFMann 2002 = a. HoFFMann, Grabritual und Gesellshaft. Gefassformen, Bildthemen und Funktionen unteritalischrotfiguriger Keramik aus der nekropole von tarent, leidorf 2002.
Hosoi 2007 = n. Hosoi, Des femmes au louterion. À la croisée d’une esthétique masculin et féminine au travers des objects, «image-re-vues» iV, 2007, document 7 (http://ima-gesrevues.org/145).
isler-Kerényi 2001 = c. isler-Kerényi, Dionysos nella Grecia arcaica. il contributo delle immagini, pisa-roma 2001.
Kossatz-deissMann 2007 = a. Kossatz-deissMann, Hermes der Kleiderdieb, in POTNIA QHRWN. Festschrift für Gerda Schwartz zum 65. Geburtstag, a cura di e. christof et al., Wien 2007, pp. 181-193.
Kreilinger 2007 = u. Kreilinger, Anständige nacktheit. Körperpflege, reiningungsriten una das Phänomen weiblicher nacktheit im archaischklassischen Athen, leidorf 2007.
laMbrugo 2008 = c. laMbrugo, Donne impossibili? i segreti femminili nello sguardo dell’uomo, in Vasi immagini collezionismo. la collezione di vasi intesa Sanpaolo e i nuovi indirizzi di ricerca sulla ceramica greca e magno greca, Atti Giornate di Studio Milano 2007, a cura di G. Sena chiesa, milano 2008, pp. 159-184.
lCS = a. D. trendall, the redFigured Vases of lucania, Campania and Sicily, oxford 1967.
lCS Suppl. iii = a.D. trendall, the redFigured Vases of lucania, Campania and Sicily. third Supplement, london 1983 («BicS Suppl.» 41).
lissarague 1998 = F. lissarague, Satyrs chez les femmes, in les mystères du gynecée, a cura di p. Veyne et al., paris 1998, pp. 179-198.
Magna Graecia = Magna Graecia. Archeologia di un sapere, Catalogo Mostra Catanzaro 2005, a cura di S. Settis, m. c. parra, milano 2005.
MenicHetti 1995 = m. MenicHetti, … Quoius forma virtutei parisuma fuit … Ciste prenestine e cultura di roma mediorepubblicana, roma 1995 («archaeologica» 116).
MenicHetti 2006a = m. MenicHetti, la donna alla fontana. Charis e matrimonio sulle ciste prenestine, in iconografia 2005. immagini e immaginari dall’antichità classica al mondo moderno, Atti Convegno Venezia 2005, a cura di i. colpo et al., roma 2006, pp. 51-64.
MenicHetti 2006b = m. MenicHetti, lo specchio di Hera e gli «specchi» di Atena su un vaso del Pittore di Dolone, in l’image antique et son interprétation, a cura di F.-H. mas-sa pairault, roma 2006, pp. 261-275.
MenicHetti 2008 = m. MenicHetti, lo specchio nello spazio femminile. tra rito e mito, in image et religion dans l’antiquité grécoromaine, Atti Colloquio roma 2003, a cura di S. estienne et al., napoli 2008, pp. 217-230.
Montanaro 2007 = a. c. Montanaro, ruvo di Puglia e il suo territorio. le necropoli. i corredi funerari tra la documentazione del XiX secolo e gli scavi moderni, roma 2007.
FranceSca SilVeSTrelli124
Mugione 2007 = e. Mugione, Bellerofonte: un eroe corinzio nell’immaginario delle comunità italiche, «eidola» iV, 2007, pp. 9-27.
Peintre de Darius = le Peintre de Darius et son milieu. Vases grecs d’italie méridionale, a cura di ch. aellen et al., roma 1986.
PFisterer-Haas 2002 = S. PFisterer-Haas, Mädchen und Frauen am Wasser. Brunnehaus und louterion als orte der Frauengemeinschaft und der möglichen Begegnung mit einem Mann, JDAi cXVii, 2003, pp. 1-79.
rVAp i = a. D. trendall, a. caMbitoglou, the redFigured Vases of Apulia i. early and Middle Apulian, oxford 1978.
rVAp ii = a. D. trendall, a. caMbitoglou, the redFigured Vases of Apulia ii. late Apulian, oxford 1982.
rVAp Suppl. i = a. D. trendall, a. caMbitoglou, the redFigured Vases of Apulia ii. First Supplement, london 1983 («BicS» Suppl. 42).
rVAp Suppl. ii = a. D. trendall, a. caMbitoglou, the redFigured Vases of Apulia ii. Second Supplement, london 1991 («BicS» Suppl. 60).
sabetai 2009 = V. sabetai, the Poetics of Maidenhood: Visual Constructs of Womanhood in VasePainting, in Hermeneutik der Bilder. Beiträge zu ikonographie und interpretation griechischer Vasenmalerei, a cura di S. Schmidt, J. H. oakley, münchen 2009, pp. 103-114.
scHauenburg 2004 = K. scHauenburg, Zur Beziehung von rotfiguriger Vasenkunst und Gnathiatechnik, in Studi di archeologia in onore di Gustavo traversari, a cura di m. Fano Santi, roma 2004 («archaeologica» 141) pp. 773-781.
scHauenburg 2010 = K. scHauenburg, Studien zur unteritalischen Vasenmalerei, Xiii, Kiel 2010.
sena cHiesa 2005 = G. sena cHiesa, le nozze dipinte. Sposi divini e sposi mortali, in Studi di archeologia in memoria di liliana Mercando, a cura di m. Sapelli ragni, To-rino 2005, pp. 231-243.
sena cHiesa, slavazzi 2006 = Ceramiche attiche e magnogreche. Collezione Banca intesa. Catalogo ragionato, a cura di G. Sena chiesa, F. Slavazzi, milano 2006.
stäHli 2009 = a. stäHli, nackte Frauen, in Hermeneutik der Bilder. Beiträge zu ikonographie und interpretation griechischer Vasenmalerei, a cura di S. Schmidt, J. H. oakley, münchen 2009, pp. 43-51.
sutton 2009 = r. F. sutton, the invention of the Female nude: Zeuxis, VasePainting, and the Kneeling Bather, in Athenian Potters and Painters 2, a cura di o. palagia, J. oakley, oxford 2009, pp. 270-279.





























![Thermal, oxidative and radiation stability of polyimides III. Polyimides based on N-[3-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)phenyl]acetamide and different diamines](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63448d5903a48733920af0ae/thermal-oxidative-and-radiation-stability-of-polyimides-iii-polyimides-based-on.jpg)