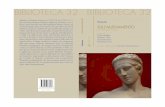"Space Oddity": poesia siderea come odissea filosofica, da John Donne a David Bowie
Transcript of "Space Oddity": poesia siderea come odissea filosofica, da John Donne a David Bowie
1
‘SPACE ODDITY’: POESIA SIDEREA COME ODISSEA FILOSOFICA
DA JOHN DONNE A DAVID BOWIE
di Francesca Orestano
All’interno della letteratura inglese, dal Seicento al Novecento, diversi testi convergono
verso il discorso filosofico, istituendo con esso legami di varia natura. La natura di
questi legami è la mia risposta al quesito: esiste la poesia filosofica? A un livello
elementare è già possibile asserire che l’assunto che vuole il discorso filosofico astratto,
logico, razionale, e la poesia autoreferenziale e ambigua, segnala comunque
l’appartenenza di entrambi all’ambito della discorsività, del linguaggio, cui si addicono
potenzialmente e in eguale misura oscurità e chiarezza. Per misurare l’uno e l’altra può
infatti valere la proposizione: “i limiti del mio linguaggio significano i limiti del mio
mondo”.1 Le proposizioni di Wittgenstein riconducono all’enunciato tutta la ricerca
filosofica, ma per estensione e funzione dialogica assimilano ad essa discorsi ‘altri’, che
articolano forme di conoscenza del mondo e ne attivano la ricezione come fatto
altamente logico o fondamentalmente illogico, illuminato o oscuro. Il filosofo si chiede:
“E se i nostri segni fossero così indeterminati come il mondo che rispecchiano?”2 Se si
accetta che “scopo della filosofia è la chiarificazione logica dei pensieri”, che essa “deve
delimitare il pensabile e con ciò l’impensabile” e “deve delimitare l’impensabile dal di
dentro, attraverso il pensabile”, ne discende che lo scarto tra poesia e filosofia sembra
risiedere nella questione logica, nell’estensione e consistenza che si vuol dare a questa:
la filosofia “significherà l’indicibile rappresentando chiaro il dicibile”,3 ma la poesia a
sua volta significherà il dicibile rappresentando chiaro l’indicibile.
A valle di questo panorama sorgono altre domande di natura letteraria: se è vero
che esiste il romanzo filosofico, e ne sono esempi il Candide di Voltaire o Rasselas the
Prince of Abyssinia di Samuel Johnson, perché non può esistere la poesia filosofica? E
infine, se si vuole ricondurre l’essenza o definizione della poesia alla presenza di una
gabbia conferita da una struttura formale alla materia del discorso, come si spiega che
1 LUDWIG WITTGENSTEIN, Tractatus logico-philosophicus e Quaderni 1914-1916, Torino, Einaudi, 1964,
p. 63, p.145. 2 Ivi, p.104.
3 Ivi, pp. 27-28.
2
filosofia e poesia condividono la forma del dialogo?4 Ciò riconduce al campo della
logica, e a quello che si vorrebbe esclusivo territorio della filosofia.
Poesia siderea, discorso filosofico
Il mio contributo ha al suo centro la poesia siderea e il profondo coinvolgimento che essa
attua nei confronti del discorso filosofico. La poesia siderea, cosmica, o delle stelle, si
costituisce nella tradizione occidentale come un luogo poetico nel quale, a partire dal
modello italiano, la poesia britannica trova linfa e orientamento per affrontare ciò che
appare tradizionalmente ordinato e chiaro, modernamente incerto e nebuloso. In
Letteratura europea e medioevo volgare, Piero Boitani intitola “Stelle” un capitolo che
spazia da Dante alla poesia americana del Novecento, segnalando come la poesia siderea
sia il locus dove la mente interroga, con l’universo, le proprie nozioni di esso, la propria
natura e la configurazione stessa del sapere. Il tema sidereo è già presente nella
Commedia, e “l’uso che Dante fa delle stelle è […] astronomico, metafisico, psicologico,
descrittivo ed estetico”;5 Petrarca, attraverso le stelle, integra al campo poetico quello
cosmico e quello etico, mentre Tasso, definito il maggior poeta delle stelle nel
Rinascimento, delinea un universo cristiano e pre-copernicano al cui centro vi è continua
metamorfosi, conflitto, corruzione e generazione dalla corruzione, vita e morte: Eraclito.
Al cielo appartiene la perfezione delle stelle, alla terra caligine, oscurità, orrore. Non
sono da meno gli epigoni della tradizione italiana che nel Rinascimento inglese
riscrivono la tragedia dell’uomo moderno. Per Christopher Marlowe, nella notte finale
che sigilla la tragedia del Doctor Faustus, il sangue di Cristo scorre attraverso il
firmamento stellato. Dai poeti italiani muove anche Sir Philip Sidney, che intitola
Astrophel and Stella un canzoniere amoroso ispirato al Petrarca. Ed è proprio Sidney, il
poeta astrofilo capace di pronosticare nel Sonetto 26 i moti amorosi di Stella
dall’inclinazione della sua stella, a difendere in prosa la poesia, prima nutrice di ogni
sapere, dall’accusa mossale da “all them that professing learning inveigh against
poetry.”6
4 FRANCESCA ORESTANO, Il dialogo come forma simbolica. Filosofia e ‘conversation’ nella narrativa
inglese, in MARIALUISA BIGNAMI, a c. di, Le trame della conoscenza. Percorsi epistemologici nella
letteratura inglese dalla prima modernità al postmoderno, Milano, Unicopli, 2007, pp. 47-66. 5 PIERO BOITANI, Letteratura europea e medioevo volgare, Bologna, Il Mulino, 2007, p. 368.
6 PHILIP SIDNEY, Defence of Poesie, in John HOLLANDER, FRANK KERMODE (a c. di) The Literature of
Renaissance England, Oxford, Oxford University Press, 1873, pp. 136-149. Trad.: “tutti coloro che
3
Si tratta della smagliante Defence of Poesie (1582?) che contro The School of
Abuse (1579) di un oscuro puritano, e generalmente contro tutti i “Mysomusoi”, sostiene
che la poesia sia superiore tanto alla storia, troppo occupata da dettagli di fatti, quanto
alla filosofia, ancorata a concetti astratti, e definita a volte “misty”, nebbiosa. Il poeta
opera nello stesso ambito del filosofo,
for whatsoever the philosopher saith should be done, he [the poet] giveth a
perfect picture of it […] so no doubt the philosopher with his learned
definition replenisheth the memory with many infallible grounds of wisdom,
which, notwithstanding, lie dark before the imaginative and judging power, if
they be not illuminated or figured forth by the speaking picture of poesy.7
Invero, aggiunge Sidney, “neither philosopher nor historiographer could at the first have
entered into the gates of the popular judgement, if they had not taken a great passport of
poetry”:8 prova ne sia che in Astrophel and Stella la conoscenza del cosmo e dei suoi
ritmi, orbite, grandezze, eternità delle stelle si lega al concetto di una Natura che non
agisce mai senza motivo, all’idea di un’enigmatica seppur evidente causalità – che le
stelle degli occhi della sua Stella confermano in misteriosa concordia. Ma è con la crisi
del Rinascimento che il tema cosmico sembra allargarsi sino a coincidere con lo stesso
spazio del sapere, del quale diventa oggetto e metafora: accomunati in tale campo
convivono Bruno e Galilei, Shakespeare e i poeti metafisici. Mentre la persecuzione
puritana prende le armi contro la poesia, le arti visive, il teatro e la Authorized Version
della Bibbia traccia il solco invalicabile del discorso religioso, la prima tradizione di
poesia cosmica, fondata sulla rassicurante concordanza della macchina del mondo, a
partire dal Primo Mobile sino al destino individuale, viene scossa da un terremoto che ne
mette fuori sesto tutti gli ingranaggi. Allora
ha luogo la grande rivoluzione astronomica che porta alla costruzione di un
nuovo paradigma e un nuovo modello dell’universo: quello per il quale la
scienza viene elaborata, a partire dall’esperienza, su basi matematiche, e quello
che al cosmo tolemaico sostituisce il copernicano.9
Di questo ribaltamento religioso ed epistemologico e dell’oscillare tra saperi scientifici,
filosofici, religiosi, poetici, in una condizione che mostra il vertiginoso immenso spazio
professando la conoscenza inveiscono contro la poesia”. Dove non diversamente indicato, le traduzioni
sono di chi scrive. 7 P. SIDNEY, Defence of Poesie, p. 140. Trad.: “Per ogni requisito indicato dal filosofo, il poeta ne dà una
perfetta rappresentazione […] il filosofo dunque con le sue erudite definizioni nutre la memoria con solida
infallibile saggezza che, tuttavia, rimane oscura per le facoltà del giudizio e dell’immaginazione se non
viene illuminata o raffigurata dalla parlante immagine poetica.” 8 Ivi, p.138. Trad.: “Né il filosofo né lo storico avrebbero potuto accedere all’area del giudizio popolare
senza essere muniti del passaporto della poesia”. 9 P. BOITANI, Letteratura europea e medioevo volgare, p. 390.
4
del nuovo firmamento e l’abisso di instabilità che dal macrocosmo si propaga alla
condizione umana, è ben consapevole Shakespeare nel 1605, quando fa dire ad Amleto:
There are more things in heaven and earth, Horatio,
Than are dreamt of in your philosophy.10
La poesia delle stelle permane allora a segnalare lo snodo critico tra sapere e religione,
tra astronomia e astrologia, realtà e fantasmi, offrendo quello spazio infinito dove il
poeta può speculare, ribaltare ogni nozione, attenersi alla tradizione o spingersi da
pioniere sino ai poli celesti e sin là dove l’immobile sole sembra aver rubato il posto nel
cielo al Primo Mobile. Non solo la poesia delle stelle e dei pianeti è quella prediletta dai
cosiddetti metafisici –vissuti in Inghilterra nel burrascoso Seicento: John Donne, Henry
Vaughan, Andrew Marvell, Carew, Suckling, Traherne, Cleveland, Cowley, per citare i
più famosi – ma, ancor più rilevante al nostro tema, la poesia dei metafisici viene
costantemente associata alla filosofia, pur se in guisa di una critica negativa, formulata
dalla sponda del Settecento neoclassico.
È Samuel Johnson, in Lives of the English Poets (1779-1781), a inserirli nel
canone letterario inglese coniando il termine ‘metafisici’.
About the beginning of the seventeenth century appeared a race of writers
that may be termed the metaphysical poets; […] The metaphysical poets
were men of learning, and to show their learning was their whole
endeavour […]. Those, however, who deny them to be poets, allow them to
be wits. […]
But Wit […] may be more rigorously and philosophically considered as a
kind of discordia concors; a combination of dissimilar images, or discovery
of occult resemblances in things apparently unlike. […] The most
heterogeneous ideas are yoked by violence together; nature and art are
ransacked for illustrations, comparisons, and allusions; their learning
instructs and their subtilty surprises; but the reader commonly thinks his
improvement dearly bought, and though he sometimes admires, is seldom
pleased.11
10
WILLIAM SHAKESPEARE, The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark, Cambridge, Cambridge
University Press, 1936, p.32, Atto I, 5, vv. 167-168. Trad.: “Vi sono più cose in cielo e in terra, Orazio, di
quante se ne sognano nella vostra filosofia”. 11
SAMUEL JOHNSON, Lives of the English Poets, 2 voll., Oxford, Oxford University Press, 1912, I, pp. 13-
15. Trad.: “Verso l’inizio del diciassettesimo secolo apparve una razza di scrittori che possono essere
definiti poeti metafisici; […] I poeti metafisici erano uomini di cultura, e fare mostra di tale cultura fu la
loro massima ambizione […] Coloro che negano che siano dei poeti ammettono che siano degli spiriti di
acuta intelligenza. […] La loro intelligenza […] può essere considerata in modo rigorosamente filosofico
come una sorta di discordia concors: una combinazione di immagini dissimili, ovvero la scoperta di
occulte affinità tra cose apparentemente diverse […] Le idee più eterogenee sono aggiogate insieme a
forza; la natura e l’arte saccheggiate per illustrazioni, paragoni, allusioni; il loro sapere istruisce, la
sottigliezza sorprende, ma il lettore di solito ritiene di acquisire il suo vantaggio a un prezzo troppo alto e,
anche se a volte ammira, raramente gode.”
5
Così Johnson nel Settecento, lamentando che le “strong lines” dei metafisici indulgevano
troppo sovente alle sottili speculazioni della filosofia, a scapito di sentimenti e emozioni.
E certo i metafisici scrivevano di filosofia anche quando volevano corteggiare la donna
amata o falciare un prato, o comporre un mazzolino di viole, o immaginare un banchetto
senza cibo: spesso la loro poesia si distingue per la capacità, particolarmente sviluppata
in Donne, Marvell, Vaughan, di saper immaginare e descrivere, insieme a un modello di
fede o di passione, una mappatura geografica, un sistema astronomico e sociale, anche il
suo rovescio o inverso, con una fulminea reciprocità di pensiero, sfoggiando una
capacità disgregatrice, analitica, che Johnson disapprova in poesia, perché richiede la
frammentazione del reale in particelle – o se si vuole enunciati fatti di sottili distinzioni
logiche –, che funzionano come il prisma, colpito da un unico potente fascio di luce ma
sorgente di una cangiante confusione di singoli colori.
Johnson osserva che essi toccano problemi di pertinenza filosofica: identità,
mente e corpo, nozione di conoscenza; la loro religione oscilla tra cattolicesimo e fede
anglicana, empirismo, neoplatonismo ed ermetismo; tra loro i pitagorici e gli gnostici; i
loro amori sono geografici, ottici, vegetali; l’ordine presuppone il caos e viceversa; un
uomo buono è come un telescopio, avvicina la virtù; gli amanti fedeli un compasso; le
lacrime simili a mappamondi dove si iscrivono Europa, Africa, Asia sinché il globo
stesso inondato dal pianto svanisce alla vista.
Nella poesia di John Donne An Anatomy of the World (1611), il tema della morte
di una persona amata (la figlia del suo benefattore Robert Drury, Elizabeth, morta a 14
anni) e della sua assenza dal mondo apre una riflessione sulla lunghezza della vita
umana, dove quella vissuta da Matusalemme si è ora contratta nel breve spazio del
funzionamento di un orologio, mentre la decadenza è affare di una sola generazione; si
vorrebbe essere uomini, ma si è pigmei, e ciò che Dio creò dal nulla torna logicamente al
nulla originario. Se il processo di corruzione della materia appare come un fenomeno
iniziato con la prima ora dell’universo, la conseguenza è un’inversione violenta della
prospettiva di certezze sino ad allora nutrite, una solitudine cosmica della mente tra sole
e terra, ormai perduti al loro ordine rassicurante e prevedibile, così come l’intelligenza
dell’uomo, non più riflessa dalla bontà dei suoi ordinamenti politici e sociali. Privato
della speranza di virtù, il mondo è una struttura sconnessa, “quite out of joint”, fuori
sesto, così come la nozione stessa di conoscenza:
And new philosophy calls all in doubt,
The element of fire is quite put out;
The sun is lost, and th’earth, and no man’s wit
6
Can well direct him where to look for it.
And freely men confess that this world’s spent,
When in the planets, and the firmament
They seek so many new; then see that this
Is crumbled out again to his atomies.
’Tis all in pieces, all coherence gone,
All just supply, and all relation;
Prince, subject, father, son, are things forgot. (vv. 205-215)
12
La nuova filosofia è quella delle teorie di Copernico, Tycho Brahe, Keplero, Galileo: la
sfera del fuoco ne è stata spenta e, perso il sole, anche la terra è alla deriva. L’universo
torna al caos primigenio degli atomi. Le relazioni umane, come quelle tra corpi stellari,
sono pervertite: ma così è anche per la bellezza, le proporzioni che la regolano, la
perfezione geometrica delle sfere celesti.
We think the heavens enjoy their spherical,
Their round proportion embracing all.
But yet their various and perplexed course,
Observed in divers ages, doth enforce
Men to find out so many eccentric parts
[…]
And in these constellations then arise
New stars, and old do vanish from our eyes:
As though heaven suffered earthquakes, peace or war,
When new towers rise, and old demolished are. (vv. 251-262)
13
Il disordine cosmico turba la relazione dell’uomo con il cielo. Da un lato ne viene
esaltata la nuova mentalità scientifica che si avventura alla scoperta e conquista dello
spazio, poiché l’uomo ora cattura le nuove stelle e i loro oscuri movimenti in una rete
poderosa, fatta di meridiani e paralleli:
So, of the Stars, which boast that they do run
In Circle still, none ends where he begun.
All their proportions lame, it sinks, it swells.
For of meridians, and parallels,
Man hath weaved out a net, and this net thrown
Upon the heavens, and now they are his own. (vv. 275-280)14
12
JOHN DONNE, An Anatomy of the World. The First Anniversary. To the Praise of the Dead and the
Anatomy, in John Donne, The Complete English Poems, a c. di A. J. Smith, Harmondsworth, Penguin,
1977, pp. 269-283. Trad.: “La nuova filosofia pone tutto in dubbio, l’elemento del fuoco è spento, il sole è
perso e così anche la terra, e l’ingegno non mostra più dove trovarli. E gli uomini spontaneamente
confessano che questo mondo è spento, quando nei pianeti e nel firmamento ne studiano tanti e nuovi; e
vedono il nostro in briciole, ridotto in atomi; tutto è in pezzi; svanito l’ordine, la distribuzione delle forze,
le giuste relazioni. Principe, suddito, padre, figlio: cose dimenticate.” 13
Ibidem. Trad.: “Riteniamo felici i cieli che nella loro sfericità tutto abbracciano, ma invece il loro corso,
mutevole e intricato, osservato in diverse età, costringe gli uomini a cercarne le irregolarità […] e in
queste costellazioni adesso sorgono stelle nuove, mentre le vecchie svaniscono alla vista, come se il cielo
patisse terremoti, pace o guerra, quando nuove torri s’alzano e le antiche son demolite.”
7
Ma dall’altro lato, l’antica mentalità alchemica e astrologica, l’afflato che dagli atomi in
pioggia dai cieli tolemaici costellava la terra, impregnando fiori e alberi con incantesimi,
le arti magiche del passato, vengono ricordate con nostalgia tanto più acuta perché
quello scambio tra cielo e terra è cessato e perduto per sempre. E con esso i saperi che lo
fondavano e se ne sprigionavano:
What artist can now boast that he can bring
Heaven hither, or constellate anything,
So as the influence of those stars may be
Imprisoned in an herb, or charm, or tree,
And do by touch, all which those stars could do?
The art is lost, and correspondence too.
For heaven gives little, and the earth takes less,
And man least knows their trade, and purposes. (vv. 391-398)15
Spettatori consapevoli di uno scenario epistemico che pullula di saperi antichi e moderni
entrati in competizione e conflitto perché il loro discorso venga legittimato come
autorevole, i poeti metafisici, e John Donne in particolare, propongono una serie di arditi
confronti tra nuove filosofie e teorie che contrapposte, giustapposte, si risolvono in una
serie di atti di dubbio, più che di fede. Le fedi professate peraltro sono varie, siamo in
piena riforma e controriforma, e molti tra i poeti metafisici, convertiti dal cattolicesimo
alla chiesa anglicana, abbracciano poi varietà di culto in conflitto con essa. E poiché la
prospettiva, così come la teleologia religiosa, è una forma simbolica che ordina lo spazio
e gli oggetti che ricadono in esso secondo una precisa formula, è possibile osservare
come lo spazio di questi poeti risulti spesso oscillante tra prospettiva e anamorfosi, o
dotato di una inquietante simultaneità di prospettive diverse del pensiero e del
ragionamento filosofico. Questo spazio poetico, spesso rappresentato come spazio
cosmico, sidereo, è attraversato da una moltitudine di ipotesi che dalla religione e
filosofia spaziano all’astronomia, dall’astrologia alla metafisica e da essa alla visione
dell’universo sociale e politico: ma anche qui le incertezze sono più che le certezze,
poiché un re per diritto divino verrà processato, giustiziato e rimpiazzato da un re eletto
per volontà del parlamento, una società feudale da una classe di commercianti e
14
Ibidem. Trad.: “E tra le stelle, che ancora vantano la loro orbita circolare, nessuna chiude il cerchio là
dove l’ha iniziato. Le loro sbilenche proporzioni si restringono o si gonfiano, perché l’uomo, con
meridiani e paralleli, ha intessuto una rete e l’ha lanciata sui cieli che adesso sono sua preda.” 15
Ibidem. Trad.: “Quale astrologo, alchimista, artista può vantarsi di ravvicinare a noi il cielo o dare voce
alle stelle? In modo che le loro virtù, racchiuse in una pianta, amuleto, albero, al semplice tocco
trasmettano il potere della stella? Quell’arte si è persa, con le sue corrispondenze. Il cielo dà poco, la terra
prende ancor meno, e men che mai l’uomo ne conosce scambi e scopi.”
8
speculatori in buoni del tesoro, Tolomeo da Copernico. Verso il 1660 Johannes Vermeer
dipinge L’astronomo.
La poesia dei metafisici non si distingue solo per aver saccheggiato – come dirà
Johnson – scaffali di intere biblioteche, ma per le costruzioni che essi ne erigono,
mostrando le possibilità infinite che provengono da confronti, associazioni,
combinazioni di saperi diversi, e dalle ulteriori possibilità che questi trovano nella forma
dell’enunciato, sempre soggetto a negazioni, paradossi, inversioni e capovolgimenti
peraltro legittimati dalla logica. Infatti, se un corpo è tempio, è anche tomba; l’eternità
del tempo è uno spazio deserto, che quindi nessuno abita; il terremoto che procura danni
catastrofici è meno percepibile dell’oscillazione del polo celeste, causa della precessione
degli equinozi; una stanza colpita da un raggio di sole diventa il centro dell’universo
tolemaico ma il nuovo sole, la donna amata, simile al sole copernicano, può cambiare la
disposizione geografica di pianeti e continenti. E infine, un corpo abituato ad alimentare
la fede religiosa mediante immagini, incensi, drappi, musiche e fiori, viene incarcerato
dall’anima che trionfa nel digiuno; un occhio abituato al volgere del mappamondo vede
l’universo nella goccia di rugiada; Cromwell e il re, due immagini di Cesare,
conquistatore e tiranno, sono le due facce del potere sulla stessa antica medaglia. Eredità
ed evoluzione sono estremi che si toccano. I frammenti che risultano dal lavoro analitico
di questi poeti si dispongono secondo ipotesi o proposizioni che l’enunciato consente di
erigere in quanto costruzioni di pensiero logico, pur se non sempre o non ancora iscritte
nel grande libro dei saperi vigenti e legittimi.
Il Novecento e l’avventura metafisica: la ‘mente del modernismo’ tra poesia e filosofia
Se Johnson criticava l’eccesso di pensiero, erudizione e filosofia dei metafisici, cui
faceva da contrappunto la loro mancanza di sentimenti e chiarezze d’ordine morale, per
converso un filosofo americano, Emerson, non nasconderà il suo entusiasmo verso di
essi:
Cowley and Donne are philosophers. To their insight there is no trifle. But
philosophy or insight is so much the habit of their minds that they can hardly see
as a poet should the beautiful forms and colors of things, as a chemist may be less
alive to the picturesque. At the same time their poems like life afford the chance
of richest instruction amid frivolous and familiar objects; the loose and the grand,
9
religion and mirth stand in surprising neighborhood and, like the works of great
men, without cant.16
Dopo l’oscuramento romantico, la figura di John Donne torna alla luce prima come
autore di sermoni religiosi, e quindi nella sua vocazione di poeta. È a questa che
Emerson risponde, innescando negli Stati Uniti un interesse per Donne, il poeta filosofo,
non gravato dai problemi della sua biografia ecclesiastica. A Emerson si uniscono Henry
David Thoreau, Margaret Fuller, Henry Wadsworth Longfellow, e James Russell
Lowell. 17
La storia delle edizioni critiche di Donne nell’Ottocento è stata tratteggiata da
Haskin, ed è significativo che il monumento al poeta venisse reintegrato negli anni
Settanta agli onori della cattedrale di St. Paul nel Poets’Corner, luogo canonico della
poesia britannica, dopo aver languito per due secoli, dimenticato, giù nella cripta.
Edmund Gosse e Leslie Stephen, i guru della biografia letteraria di fine secolo,
avrebbero ratificato la promozione. Ma è tra gli artisti del primo Novecento che Donne
trova lettori attenti al dato poetico e filosofico, più che alle questioni religiose: tra loro
Rupert Brooke, Wilfred Owen, William Butler Yeats, James Joyce, T.S. Eliot, Virginia
Woolf. Donne diventa un autore caro alla sensibilità moderna, che si rispecchia nella sua
odissea filosofica: “By the Thirties, Donne was thought of as a poet who had taken an
active, and disillusioning, interest in the new science; and the phrase ‘new Philosophy
calls all in doubt’ was frequently quoted.”18
Gli autori del primo Novecento tornano a speculare, come un tempo i metafisici,
sulle stelle, in prosa e in poesia. Non c’è dubbio che le stelle brillino su uno scenario
dove la filosofia si interroga con scetticismo sulle costruzioni dell’epoca precedente,
delle quali si constata il crollo, mentre nuove scienze propongono inedite combinazioni
di frammenti dei saperi passati. Nel saggio sulla “mind of modernism”, la mente del
modernismo, McFarlane osserva il deteriorarsi di prospettive sicure nell’analisi del
microcosmo e del macrocosmo quando le scoperte di Niels Bohr, Wilhelm Conrad
16
RALPH WALDO EMERSON, “Journals and Miscellaneous Notebooks, V” in A. J. SMITH (a c. di), John
Donne. The Critical Heritage, London, Routledge and Kegan Paul, 1975, p. 304. Trad.: “Cowley e Donne
sono filosofi. Dinanzi al loro discernimento nulla è privo di valore. Ma la filosofia o il discernimento sono
a tal punto il loro abito mentale che essi sono incapaci di guardare alle cose cogliendo, come il poeta, belle
forme e colori – così come il chimico non vede la qualità pittoresca delle cose. Ma allo stesso tempo le
loro poesie, proprio come la vita, danno la possibilità di ricavare insegnamento dagli oggetti più futili e
familiari; ciò che è approssimativo e ciò che è importante, la religione e l’allegria convivono in
sorprendente prossimità e, come nell’opera dei grandi, senza parole difficili.” 17
DAYTON HASKIN, Donne’s Afterlife, in ACHSAH GUIBBORY (a c. di), The Cambridge Companion to
John Donne, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, pp. 233-246, qui p. 239. 18
D. HASKIN, Donne’s Afterlife, p. 241. Trad: “Negli anni Trenta Donne era ritenuto un poeta che aveva
mostrato attivo interesse e disincanto nei confronti della nuova scienza; e la sua frase ‘la nuova filosofia
pone tutto in dubbio’ veniva citata di frequente.”
10
Röntgen, Max Planck, Albert Einstein modificano i concetti della fisica tradizionale, e il
procedimento dell’ipotesi rimpiazza nel discorso scientifico la procedura del metodo
sperimentale.19 Natura dello spazio e della materia, atomi e galassie nelle rispettive
orbite microscopiche e sconfinate, linguaggio e sogni, religioni e antropologia,
sociologia e psicanalisi analizzano e frammentano i saperi proponendo nuove strutture di
legittimazione.
In questo contesto i metafisici vengono riproposti al centro del firmamento
poetico e critico di T.S. Eliot, e riletti alla luce delle incertezze moderne, poiché essi
rispecchiano nel loro gioco intellettuale non solo la poetica dell’impersonalità, ma anche
la possibile simultaneità cubista di prospettive diverse, logiche, scientifiche, estetiche e
musicali, profumi di incenso e odori del cibo quotidiano. Riprendendo nel 1921 in The
Metaphysical Poets il giudizio di Samuel Johnson,20
Eliot ne rivaluta la qualità analitica
che permette di affrontare la difficile rappresentazione di mondo interiore e cosmo
attraverso elementi discordi e punti di vista eterogenei che la mente pone a confronto, in
giustapposizione piuttosto che in sintesi. La poesia che ne deriva deve essere per
conseguenza complessa, frutto di molteplicità prospettiche che visualizzano il perfetto e
il deforme, l’andata e il ritorno dalla proposizione all’ipotesi, un ventaglio di
dimostrazioni possibili. Eliot ne descrive l’arduo e potente effetto come “telescoping of
images and multiplied associations”21 caratteristica di quel periodo – e forse anche del
proprio. Johnson, sostiene Eliot, con l’intento di criticarli toccava il loro vero pregio: la
dimensione analitica, la dissoluzione della realtà in frammenti, o particelle, o atomi, o
enunciati, o proposizioni e aforismi. Si tratta, a ben vedere, della stessa poetica della
Waste Land: “these fragments I have shored against my ruin.”22 Ma è il metodo, fondato
sulla nozione di rovina, il dato interessante. Secondo Eliot, un pensiero per John Donne
era un’esperienza concreta: modificava la sua sensibilità. E così dovrebbe funzionare la
mente poetica: dalle esperienze più disparate trarre nuove combinazioni, nuovi mondi,
nuovi canoni poetici e artistici, nuove concezioni della storia. “The poets of the
seventeenth century possessed a mechanism of sensibility which could devour any kind
19
JAMES MCFARLANE, The Mind of Modernism, in MALCOLM BRADBURY (a c. di), Modernism, 1890-
1930, Harmondsworth, Penguin, 1976, pp. 71-94. 20
Si veda anche RONALD SCHUCHARD ( a c. di), The Varieties of Metaphysical Poetry: The Clark Lectures
at Trinity College, Cambridge, 1926, and the Turnbull Lectures at the Johns Hopkins University, 1933, by
T.S. Eliot, New York, Harcourt Brace, 1993. 21
T.S. ELIOT, The Metaphysical Poets, in Selected Prose of T.S. Eliot, a c. di Frank Kermode, London,
Faber and Faber, 1975, pp. 59-67, qui p.60. Trad.: “Concentrazione di immagini e associazioni
molteplici”. 22
T.S. ELIOT, La terra desolata, con il testo della prima redazione, introduzione, traduzione e note di
Alessandro Serpieri, Milano, Rizzoli, 1982, pp. 192-193, v. 110. Trad. Serpieri: “Con questi frammenti ho
puntellato le mie rovine”.
11
of experience.”23 Al fertile cannibalismo dei metafisici, che seppero digerire e
metabolizzare, associandole nel loro carattere eterogeneo, le disparità di un’epoca
frammentata e contraddittoria, seguì per Eliot un’epoca di dissociazione della sensibilità:
non fu più possibile quel poderoso atto digestivo, i poeti si rivoltarono contro il
raziocinio, ed ebbe inizio la poesia come esclusiva espressione di sentimenti e
reminiscenze personali. Ma perorando adesso la causa per la propria epoca e per la sua
produzione poetica, Eliot afferma
The possible interests of a poet are unlimited […]. A philosophical theory which
has entered into poetry is established, for its truth or falsity in one sense ceases to
matter, and its truth in another sense is proved. […] It is not a permanent
necessity that poets should be interested in philosophy, or any other subject. We
can only say that it appears likely that poets in our civilization, as it exists at
present, must be difficult. Our civilization comprehends great variety and
complexity, and this variety and complexity, playing upon a refined sensibility,
must produce various and complex results.24
Certo, dal suo pulpito moderno T.S. Eliot osserva che non è necessario che i poeti si
interessino di filosofia; tuttavia epoche complesse richiedono una sensibilità in grado di
affrontare oscurità e chiarezza, strumenti adatti a elaborare l’eterogeneo, il difficile,
l’ambiguo, senza semplificarlo ma restituendolo come esperienza della mente poetica e
della sua complessità capace di fronteggiare l’irrisolto problema della verità. La verità
filosofica sembra articolarsi in un luogo non distante dalla poesia moderna, entrambe
offrendo una salvezza ambigua nello spazio dove tutte le direzioni sono possibili
partenze e ritorni. Secondo Eliot l’intersezione tra filosofia e poesia è più fertile quando
instabilità politica e religiosa, mancanza di certezze metafisiche e fisiche, rivolgimenti e
terremoti nelle teorie che ci legano al cosmo modificano le nozioni relative alla
posizione dell’uomo nello spazio. Non a caso i saggi di Eliot avrebbero stimolato nuove
indagini su Donne orientate a indagare la sua poesia dentro nuovi contesti filosofici:
his theory of the ‘impersonality of the artist’ helped to move the center of gravity
away from biographical concerns and to stimulate a range of contextual studies.
Historians of ideas sought to place Donne’s writings in relation to medievalism,
23
T.S. ELIOT, The Metaphysical Poets, p.64. Trad.: “La sensibilità dei poeti del Seicento era un
meccanismo capace di divorare ogni tipo di esperienza”. 24
T.S. ELIOT, The Metaphysical Poets, p.65. Trad.: “Gli interessi di un poeta sono potenzialmente
sconfinati. […] Una teoria filosofica assunta dentro la poesia viene convalidata perché la sua verità o
falsità cessa di essere importante in un senso, mentre la sua verità in un differente ambito viene dimostrata
[…] Non è certo una necessità assoluta che i poeti si interessino di filosofia o di qualsiasi altro argomento.
Possiamo solo affermare che verosimilmente i poeti della nostra civiltà, così come esiste oggi, devono
essere difficili. Nella nostra civiltà vi sono grande varietà e complessità e questa varietà e complessità,
agendo su una sensibilità raffinata, devono produrre vari e complessi risultati.”
12
Neoplatonism, Petrarchism, the new science, alchemy, and other movements […]
encouraging readers to consider the poetry in wider European contexts. 25
Cultura pop, tema sidereo: l’odissea spaziale
In Albion. The Origins of the English Imagination26
Peter Ackroyd cita i versi di The
World del poeta metafisico Henry Vaughan:
I saw Eternity the other night
Like a great Ring of pure and endless light,
All calm, as it was bright,
And round beneath it, Time in hours, days, years
Driv’n by the spheres,
Like a vast shadow moved, in which the world
And all her train were hurled.27
L’immagine del grande doppio anello, immobile e ruotante, luminoso e oscuro, eterno e
temporale, rappresenta la cultura inglese dove antichità e contemporaneità, letteratura
alta e popolare, poesia e filosofia, scienza e musica sono esperienze diverse ma sempre
associate, contigue. La nozione di base è che “Englishness is the principle of diversity
itself. In English literature, music and painting, heterogeneity becomes the form and type
of art.”28 E appunto questa categoria dell’eterogeneità, già invocata da Johnson e poi da
Eliot (sebbene con diverso intendimento) per definire il carattere della intelligenza – wit
– dei metafisici e della poesia modernista, permette di recuperare al tema sidereo della
poesia filosofica l’ambito della cultura e della musica pop, riconducendo i Beatles,
David Bowie, i Pink Floyd nel solco della tradizione britannica. L’intersezione avviene
fuori dal recinto della cultura accademica, ma è stato osservato che “outside English
25
D. HASKIN, Donne’s Afterlife, p.242. Trad.: “La sua teoria della ‘impersonalità dell’artista’ allontanò il
centro di gravità dai problemi biografici, stimolando una serie di studi relativi al contesto. Gli storici delle
idee posero gli scritti di Donne in relazione a medievalismo, neoplatonismo, petrarchismo, la nuova
scienza, l’alchimia e altri movimenti […] incoraggiando i lettori a considerarne la poesia nel più ampio
contesto europeo.” Si veda anche la nutrita bibliografia di L. E. SEMLER, Select Bibliography, in A.
GUIBBORY (a c. di), The Cambridge Companion to John Donne, pp. 259-273, e in particolare le sezioni
dedicate a “Religion and politics”, “Philosophy and the new science”, “Language, logic, rhetoric, genre
(and Petrarchism)”, pp.267-271. 26
PETER ACKROYD, Albion. The Origins of the English Imagination, London, Chatto & Windus, 2002, p.
xix. Si veda anche PIERPAOLO MARTINO, Down in Albion. Studi sulla cultura pop inglese, Roma, Aracne,
2007, p. 13. Vaughan è citato nel capitolo dove si definisce la cultura pop contemporanea. 27
HENRY VAUGHAN , The World, in The Metaphysical Poets, pp. 271-272. Trad.: “L’altra notte ho visto
l’Eternità, come un grande anello di pura luce infinita, immobile, lucente, e sotto, intorno ad esso il
Tempo, con le sue ore, giorni, anni sospinti dalle sfere, simile a una vasta ombra ruotava, dove il mondo si
slanciava con tutto il suo seguito.” 28
P. ACKROYD, Albion. The Origins of the English Imagination, p. 448. P. MARTINO, Down in Albion.
Studi sulla cultura pop inglese, p. 14. Trad.: “La categoria della Englishness incarna il principio della
diversità. Nella letteratura, musica, pittura inglesi, l’eterogeneità conferisce forma e tipo all’arte.”
13
departments Bob Dylan and Van Morrison have invoked Donne in their music”.29 Qui
non si tratta solo di rimarcare la fertile eterogeneità della Englishness30 che rende
possibile la connessione tra poesia filosofica e cultura popolare, quanto la presenza
tematica dello spazio cosmico, descritto in testi incentrati su razzi e astronauti vaganti
nello spazio, come luogo dell’infinitamente possibile, luogo della conquista e della
perdita – di sé, del mondo. Il tema sidereo, con la speculazione filosofica a esso
connaturata, appartiene tanto alla poesia dei metafisici inglesi del Seicento quanto alla
canzone moderna.
Ciò accade particolarmente negli anni Sessanta, quando i viaggi di esplorazione
dello spazio prendono la forma di una vera e propria competizione tra USA e URSS per
la ‘conquista’ della luna, cui si intersecano le oscillazioni della guerra fredda, le
ambiguità ideologiche e politiche evidenziate dalla questione del Vietnam, i nodi del
pensiero che contrappongono le religioni occidentali alle filosofie orientali. Questi temi
impregnano il dibattito culturale, lo spettacolo e la canzone, che, come la rapsodia
classica del passato, trova i suoi momenti di coinvolgimento popolare più intensi e
spettacolari in grandi festival di canto e declamazione. Il cinema non è da meno. Nel
1968 il film di Stanley Kubrick 2001: Space Odyssey affronta in tutta la sua densità e
ironia il tema spaziale, e ispira a sua volta un rapsodo a comporre su quelle linee. La
canzone Space Oddity – la “Stranezza spaziale” fa eco all’Odissea del titolo di Kubrick –
è composta da David Bowie nel 1969.
Ground Control to Major Tom
Ground Control to Major Tom
Take your protein pills and put your helmet on.
[…]
Commencing countdown engines on
Check ignition
And may God’s love be with you.31
29
D. HASKIN, Donne’s Afterlife, p.244. “Al di fuori dei dipartimenti di Inglese Bob Dylan e Van Morrison
hanno invocato Donne nella loro musica”. 30
Cito per il lavoro critico in Italia ALESSANDRA MARZOLA (a c. di), Englishness. Percorsi nella cultura
britannica del Novecento, Roma, Carocci, 1999, e CARLO PAGETTI e ORIANA PALUSCI (a c. di), The Shape
of a Culture. Il dibattito sulla cultura inglese dalla Rivoluzione industriale al mondo contemporaneo,
Roma, Carocci, 2004. 31
L’album dove in origine figura la canzone Space Oddity si intitolava David Bowie, distribuito in
Inghilterra nel 1969. Nel 1972, in coincidenza con l’atterraggio sulla luna, viene intitolato Space-Oddity e
esce negli Stati Uniti. La BBC lo usa come colonna sonora durante la trasmissione che commenta
l’allunaggio. Nel 1980 Bowie pubblica Ashes to Ashes, dove ricompare il personaggio Major Tom. Il tema
spaziale è ripreso nell’album del 1972, The Rise and Fall of Ziggie Stardust and the Spiders from Mars, in
Starman. Trad.: “Torre di controllo al maggiore Tom, Torre di controllo al maggiore Tom, prendi le tue
pillole di proteine, indossa il casco. […] Inizia il conto alla rovescia, accendi i motori, controlla
l’accensione e che l’amore di Dio t’accompagni.”
14
Munito di proteine in pillole e di fede religiosa nel sostegno che Dio darà all’impresa
spaziale, Major Tom scandisce con la torre di controllo il conto alla rovescia; il razzo
parte, la capsula solca lo spazio sidereo fra stelle dall’aspetto strano e diverso. Sotto di
lui la Terra tutta azzurra e lontanissima:
This is Major Tom to Ground Control
I’m stepping through the door
And I’m floating in a most peculiar way
And the stars look very different today
For here am I sitting in a tin can
Far above the world
Planet Earth is blue
And there’s nothing I can do.
Though I’m past one hundred thousand miles
I’m feeling very still
And I think my spaceship knows which way to go
Tell my wife I love her very much she knows.32
La torre di controllo lancia messaggi, ma il circuito si spegne, la comunicazione si
interrompe e l’astronauta solo nello spazio siderale sa di non poter tornare sul suo
pianeta, sa di essere solo e perso alla terra. Il dramma si consuma nella bellezza
indifferente dello spazio stellato, dove nessuno può aiutare Tom, né Dio né gli scienziati
della NASA. La conquista tecnologica si volge in perdita umana, ma verrà descritta
come un successo nella master narrative dell’epopea spaziale.
L’unisono tematico tra le voci dei metafisici e le liriche di alcune canzoni
moderne, e tra Donne e Bowie in particolare, si fonda sul fatto che il tema sidereo viene
interpretato attraverso avventure religiosamente, filosoficamente e scientificamente
orientate, ma dense di incertezza. Major Tom non trova la strada del ritorno, così come
per Donne il sapere umano, mentre lanciava una rete di meridiani e paralleli sullo spazio,
perdeva quei saperi e quelle arti che glielo rendevano vicino e leggibile. Il tema sidereo
contiene inoltre come punctum del discorso poetico filosofico il sublime riferimento alla
luminosa, enigmatica, indicibile bellezza delle stelle, visibili ma estranee al dramma
umano. L’odissea spaziale non garantisce direzionalità, orientamento, controllo. La
certezza tecnologica dei primi versi si ribalta ironicamente nel guasto dei circuiti, il mito
popolare dell’astronauta, eroe dell’ideologia della conquista lunare, nella modesta
32
Trad.: “Qui maggiore Tom a torre di controllo, sto uscendo dal portello, e galleggio in un modo molto
strano, e le stelle oggi sembrano diverse, qui seduto in un barattolo di latta, lontano dal mondo, la terra è
azzurra e non posso fare nulla. Anche se lontano più di centomila miglia mi sembra di essere fermo, la mia
astronave sa dove andare, credo. Dite a mia moglie che la amo tanto, lo sa.”
15
aspirazione domestica. La velocità del veicolo contrasta con il suo essere passivo,
immobile.
In Mythologies, le riflessioni di Roland Barthes sul mito contemporaneo si
appuntano su “L’homme-jet”, “une race nouvelle de l’aviation, plus proche du robot que
du héros”33
con interessanti spunti per il nostro tema:
Mais ce qui frappe d’abord dans la mythologie du jet-man c’est l’élimination
de la vitesse: […] crise immobile de la conscience corporelle. Il est normal
qu’à ce point le mythe de l’aviateur perd tout humanisme. […]Sa particularité
raciale se lit dans sa morphologie: la combinaison anti-G en nylon gonflable, le
casque poli engagent l’homme-jet dans une peau nouvelle. […] Il s’agit là
d’une véritable conversion raciale, d’autant plus plausible que la science-fiction
a déjà largement accrédité ce transfert d’espèces.34
Attento alle trasformazioni morfologiche che incombono alla razza umana nel destino
spaziale, Barthes associa alla mutazione un’ulteriore dimensione di complessità che, già
implicita nel destino di Major Tom o nelle inquietudini di John Donne, riprende il
pensiero del passato per leggere il presente: “La société finit par retrouver dans
l’homme-jet le vieux pacte théosophique qui a toujours compensé la puissance par
l’ascèse, payant la semi-divinité avec la monnaie du ‘bonheur’ humain.”35
Particolarità
del mito dell’uomo-jet è quella di essere privo di quegli aloni romantici e individualisti
che competevano alla sacralità del ruolo dell’aviatore: l’astronauta è un eroe del
compromesso, un essere intermedio tra uomini e Marziani: “L’homme-jet est un héros
réifié, comme si aujourd’hui encore les hommes ne pouvaient concevoir le ciel que
peuplé de semi-objets.”36
Situato con ironia tra l’enfasi religiosa e l’ideologia del discorso scientifico, il
dramma di Major Tom si interseca alle certezze di chi l’ha mandato in orbita (o messo in
lattina, il che è uguale) e, vittima dell’inefficienza della tecnologia spaziale, viene
ricompensato tanto dall’essere l’idolo dei media (“And the papers want to know whose
33
ROLAND BARTHES, L’homme-jet, in Mythologies, Paris, Editions du Seuil, 1957, pp. 87-90, qui p.87.
Trad.: “Una nuova razza nella storia dell’aviazione, più prossima al robot che all’eroe”. 34
R. BARTHES, L’homme-jet, pp.88-89. Trad.: “Ma ciò che colpisce da subito nella mitologia del jet-man
è l’eliminazione della velocità: […] crisi immobile della coscienza corporea. È normale che a questo punto
il mito dell’aviatore perda ogni carattere umanista […]. La sua particolarità razziale si legge nella
morfologia: la tuta anti-G in nylon gonfiabile, il casco lucente avvolgono l’uomo-jet in una nuova pelle.
[…] Si tratta di una vera trasformazione della razza, ancor più plausibile in quanto la fantascienza ha già
largamente accreditato questi mutamenti di specie”. 35
R. BARTHES, L’homme-jet, p.89. Trad.: “La società finisce per ritrovare nell’uomo-jet l’antico patto
teosofico che da sempre compensa il potere con l’ascesi, ripagando la semi-divinità con la moneta della
felicità umana.” 36
R. BARTHES, L’homme-jet, p.90. Trad.: “L’uomo-jet è un eroe reificato, come se ancor oggi gli uomini
non potessero concepire il cielo se non popolandolo di quasi-oggetti.”
16
shirts you wear”: “i giornali vogliono sapere che marca di camicia porti”) quanto dalla
bellezza sublime e incalcolabile del cosmo nel quale è destinato a perdersi e permanere,
asceta passivo e immobile nella sua “tin-can”.
Osservato e costruito dallo spazio, il discorso di questa lirica degli anni Sessanta
pone quesiti poetici e filosofici, riprende il confronto tra microcosmo e macrocosmo nel
moderno jet-man, eroe che è allo stesso tempo oggetto-macchina e spirito alato. La
poesia dei metafisici si associa alla canzone degli anni Sessanta attraverso le filosofie
dell’incertezza, che disegnano il nostro rapporto con lo spazio sidereo come Odissea,
come “Space Oddity”.