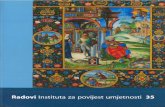The Morality of Rhetoric in Giovanni Pico della Mirandola's ...
La non classicità della metodologia filosofica di Giovanni Duns Scoto
Transcript of La non classicità della metodologia filosofica di Giovanni Duns Scoto
,
Annus DOOilX - Oaober-December 2014 - Fasc. 4
AI{TOI.IIAI.IUMPERIODICUM TRIMESTRE
PONTITICIAI UNIVIN§ITATI§ ANTONIANUM
Lt rivista Antonianum è pubbhc*a. di 1926 dall'Antonianum di Roma - ora la Ponti6-clr Univcrsita "Antonianum" - a scadenza rimesuale. I numeri appaiono in Marzo, Giugno,§crtcmbrc c Diccmbre.
Gll rticoli c lc rccensioni pubblicad in lntonianam sono sottoposti alla normativa vi-Bcntc dcl copyright; è dunque vietata la riproduzione totale o parzialeàel materiale stampato,rlr nclh vcrsionc originale che in traduzione. La Direzione acioglierà le richiesre di pubblica-zlonc dci nostri arri;li in alrre riviste o libri e risponderà caso per caso.
,rr rr, ,^ uurur^zione degli erticoli la rivista segue le proceduie internazionali di blind peer
Pcr i prczzi e le condizioni di abbonirmento, si veda l'ultimapagiaa.
_ Thc pcriodical Antoniznum has been published quarrerly since 1926 by the PontficalAthcnacum Antonianum. The editions appear in March,June, September, and December.
Thc articles and reviews published in lntonianum are subiect ro currenr coovrishtnorms; rhus the rotal or partiaf reproduction of the printed material, whether in the <iÉgi'nalor in translation, is forbidden. The management willconsider requesrs for publication oTourarticlcs in journals or bool« on a case byiase basis.
Articlcs submitred for publicadon will be reviewed according to the inremationalstandards ofdouble blind peàr review
For subscription prices and conditions, please see the last page.
lndexes and Databases: Our periodical is indexed in rhe followins intemationaldatabases: IBZ (lnternationale Bibliographie der Zeitschriftenliterarur); IBR{InternadonaleBibliographie der Rezensionen); ITh (lnàex Theologicus); SwesNet; R&TA iRelisious andTheological Absrracc); Religion Irdex One: Periòdicals, rhe Index to Book Réviews inReligion, Religion Indexes: Tèn Year Subset in CD-ROM, and the ATLA Religion Darabaseson CD-ROM; PCI (Periodical Contents Index), FRANCIS; Dialnet; Universidad de laRioja (Spagna).
Indexed selecrively by: Old Tèsrament Absracts; CBQ (Catholic Biblical Quarterly)IZBG (lnternationale Zeitschriftenshau der Bibelwissenschaft und Grenzsebiete),-Ih§(/AI(Theologisches !7ònerbuch zum AT); Biblica.dbfl Bibliogra6a can"onisrica, ,q,IDA(Anicoli italiani di periodici accademici), IMB (lnternationii Medieval Biblioeraphy),DCB (Database of Classi.al Bibliography): Sociofile (Sociological Abstracts); HlsroriialAbstracts; Philosophers Index.
E-mail: [email protected]:00-39-0670373605§7'eb site : www.antonianumroma.org/rivisranron ianum.php
2014 ANTONIANUMPeriodicnm Trimestre
Fasc.4
ISSN 0003-6064
"""fJJx;li^'fli1?X;!if ! jff ,,,,,,
PLr 0116 Hl^rts ANvt, SectetariusMeRv MproNE, AucusriN HEFNI.NDEZ, JoRGE HoRTA., Consilium directiaum
Auc usro Mt c -p,N cxtt, r4 drn in i s tra t o r
Denro ANusrRr - fucHARD CRoss - ANDREA DI MAIo - DrvtoJ,tecuR - PAoLo
Mlnrwrrr,r - Lurs NAvARRo -MARcoNoBrLE - TxrvorvNooNE - SrÉpHANE
Opprs - Lrurs Ovrsoo - Luce Pr,nrsol-I - ZSIGNIEv SucHEcKr, Scientiarum Coctus
INDEX
Giuseppe Buffo n, orlr., Ad lectores 539
ARIICULI
Bernard Forthomme, oru, Philosophie, theologie, sagesse franciscaine et
configurations scripturaires de la folie ...........-..
Vittorio Capuzzt, La data del mardrio di Peolo di Tarso nellt Lettera aiCorinti di Clemente romano ...
Martin Carbaio NÉiez, oFM, La gioia di evangelizzere. Potenzialità della
uia pabhritudinls e del Iinguaggio narrativo
Pél Ottd Harsinyi, oFM, Ricerca della felicità e mentalità consumistica.
Una lettura alla luce dell'antropologia del Concilio Vaticano II..-.............
Matteo Scozia, La non classicità della metodologia filoso6ca di Giovanni
Duns Scoto.......
DominikusJ. Kraschl, orlr, A Philosophical Argument for the Createdness
ofthe V'orld....
LES ESSAIS
Giuseppe Bufon, orM, Il Proprium del Concilio Vaticano II tra testi,
ermeneutiche e sdle. Appunti per una rifessione ............,............
P"g.
543
561
571
6rr
Criot6bel §olrrcr, oru, El cncucnrro corc cl ricsgo de convertirse en unchoque Frrnckco dc Asls y Alik el Kamil, sultÉn (rey) de Egipto............. 713
Andnof Putrn, La tutcla dci dirird soggcrrivi ncllbrdinamento giuridicodcllr Chicear ncllbttica dcl principio sistemico aequitas canonica (can.
221CrC)......... 7nAlckrander Horowski, Qcsdoni Disputate di Alessandro Di Hales: as-
pctto dottrinale
RECENSIONES
Innocenzo Cardellini, Nameri 1,1 - 10,10. Nuooa aersione, introduzbne e corilrueilto(Marco Nobile) 757; EnchZrnget I Salrni. Studi biblici, 173 (Mxco Nobile)759; Davide Riserbao,Duns Scoto, Fisicarnetafuiraeteologia. Saggisalsacramentodellbltare e l'anione ipo*atica (Ernesto Dezza) 761;§[alter Hoeres, Gradatio entisSein und Telihabe bei Duns Scotus und hanz Suirez (Y/itold Grzegoa Salamon)764; CesareYaiani, Storia e teologia dellbsperfunza Eiinale di Francesco dAssisi.
Fonti e ricerche 23 (Alessandro Mastromaneo) 766; Adrian Holderegger - Mari-ano Delgado - Anton Rotzetter (H.rg.), Franzishaniscbe Impulre f)r die interre-ligiiise Begegnaag: Religionsforum, l0 (Benedikt Mertens) 769;ForturatoFrezza,Liber Lclle. Il Libro di Angela da Foligno nel testo del codice di Ass;si con uersiontitaliana, note critiche e a??arato biblfuo traxo dal codiee di Bagnoregio. La misticacristiana tra Oriente e Occidente, 19 (Piero M essa) 774; I Francescani e la crociata.
ltti delfXl Conoegno storico di Greaio. Greai.o, 3-4 maggio 2013, a cura di AlavaroCacciotti e Maria Melli (Luca Demonds) 774.
CHRONICA
Cronaca XIII Inconrro del Centro Italiano di Lullismo (E. §7'. Platzeck), diSara Muzzi
Opera a Directione recepra
745
783
787
789lndices voluminis 89 (2014)
,Lntonianurn LXIOOX (20 14) 539-542
,4.d leaores
This final issue of .Lntoniarrilm for 2014 begins with two studics
of the philosophical teachingof the Subtle Doctor,John Duns Scotus.
One sees him as a thinker "alternative" to classical philosophy, thc 6rst
among §?'estern philosophers (of the second millennium) to have traced
an original route, in comparison with Aristotelian-Thomist thought;
and whose drought can now be taken up in the attempt to sustain ra-
tionally the faith as it is being challenged by modernity. Along similar
lines, the rational sustainability of revelation and the faith, there devel-
ops also the other ardcle of a philosophical nature. This one, with its
original argument for the existence of God, very much in sympathy wiùrhe Franciscan ffadition, inasmuch as it is founded on the very concept
of the creation and of the dependence of things and events on the MostHigh Good God. Likewise, the last two articles, on communicating dle
faith, and on the challenge of consumerism, considered as an obstaclc
ro true happiness, follow along lines dear to Franciscan thought, whichis attentive both to evangelisation and to themes of the economy and
ecology. In between the two groups of studies - respectively, of a philo-sophical nature and ofan ethical-anthropological kind - we insert, as itwere, another srudy, characterised by philological research, on a Biblicalsubject particularly close to the concerns ofourJerusalem-based Faculty
of Biblical Sciences and Archaeology.
The Autlor of the 6rst ardcle here published: Philosopbie, tbéolo'
gie, sagasefanci.scaine et conftgurations scripturaires de lafolie,isBernardForthomme OFM, who teaches at the Jesuits' Faculty of Theology inParis, the Centre Sèwes. He calls us to philosophical refection by ana-
lysing the con cepts of logos and fubri; - mind/spirit and folly. In frct, he
proposes comparingthem in suchawayas to highlight both the contrasts
and the interactions between them, as they are interpreted by different
schools of thought. As the Author expounds it, the thesis put forward
by Plato, Emmanuel Lévinas, Ronald Laing, Gilles Deleuzc, according
to which folly may rake over completely the hcart and the vcry spirit ofthe human being, meets with the opposition of the linc of thought on
rhis matter that is led by Aristode, Thomas Aquinas, Ockham, Fricdrich
Hegel and Philippe Pinel. This consideration forms only a prcamblc to
644 Pàl Ow6 Hars{nyi
dono indicano un nuovo sdle di vita (Cf. CY 34) in cui la ricerca della
verità, labellezza,la bonà e la comunione con gli altri per la crescita
comune sono famori che possono determinare sia le scelte in materia dispesa che il risparmio e gli investimend (C[ CV 51)%.
Conclusione
Solo alla luce di una visione autentica delluomo possiamo intrav-
vcdere gli effetti negativi del consumismo, giacché essi impoveriscono la
nostra umanità. IJn consumo sobrio non è prima di tutto una quesdone
di giustizia sociale, bensì costituisce un problema antropologico e mora-
lc in stretta relazione con la ricerca di senso e il bisogno di poter amare
cd csscrc amati. Occorre pertanto approfondire la nostra conoscenza sui
dcsidcri umani, sui vizi e sulle virtrì alla luce dell'antropologia rivelata
pcr poter valutare meglio le esperienze quotidiane acquisite nel mondo
dcl consumo.. Solo I'amore di Dio, effuso su di noi e mediato agli altri attraverso
ngovi stili di vita, può arginare la bramosia umana per i beni materiali e
pcr il piaccre proprio perché ciò a cui aneliamo lo possiamo ricevere da
Lui in misura superiore a ogni nostra aspettativa. Scoprire quesd doninclla vita quotidiana è una vera sfida, ma il successo, anche parziale"cipreserva dall'invidia, dallo scoraggiamento e dalla frusrazione. Acqui-sendo la capacità di vedere con occhi nuovi potremo prestar€ attenzione
e amore sempre più autentici agli altri di cui - in base alla nostra creatu-
ralità e alla nostra vocazione a far parte della vita della Santissima Tiinità
- abbiamo bisogno noi stessi, hanno bisogno i nostri cari e, infine, anche
il nostro prossimo.
P,fu0116 Hlns,(xvr oru
e3 Cf. B. LruntNr, 'Caritas in ueritate" as a Social Encyclical: a Modest Cbal-
lenge to Economie, Soeial, and Political Institutions, in Tlteological Studi.es 7l (2010), p.
515-54/+,qui 538-539.
Antonianun LXXXI X (20 I 4) 645 - 6 7 I
LA NON CLASSICITA DELLA METODOLOGIAFILOSOFICA DI GIOVANNI DUNS SCOTO
Sommario: Ilpresente articoh paò essere suddiuiso in due parti. Nelk prima mi sorro pro'
porto di preteitare la rnetodolo§afilosof.ca di Gioaanni Duns Scoto. Riconendo princi'palrnente alh analisifatte da,4ntonie l/os ho proaato a mettere in eai.denza comc Scolo-sia
il primo pensatore nella storia delle idee a ProPorre rigorosamcilte una modalità argo-
meniatiua i razionale alternatiua a quella dassica proposta da,4ristotcle e atsunta dagli
aristotelici e ehe iguarda tutti e ne gli arnbiti della ricercaflosofica (logica, *ica cfui-ca). Lefndli,tà di una tale proposta sono da rintacciarc nellbsigenza scotista di propone
argomintazioni cbe siano maggi.orruente persuasiue per la comprensionc razionalc dcgli
argoruenti difede. In questo senso, nella seconda para dellhrticolo, mostro la diuersità ar-
gomentatiua tra Tbmmaso e Scoto in nerito alk questione sul principio d'indiuiduazione,
Suruario: El presente articulo paede diuidirse en dos partes. En la primera, be qucido
presentar la rnendologiaflos,if.ca d.eJuan Duns Scoto. He intentado, reeuniendo princi--palme
nte a los anàlisis realizados por lntonie Vos, ltacer euidente airno Scoto sea el primer
pensador en las hi"stori.a de las ideas en proponer rigurosamente ana rnodalidad argumcn'-tatiaa
y racional altematiua a la clrisica, qae ba sido propuesta por ,4ristdtehs 7 asumida
por los aristotélicos y que tiene que aer con los tres àmbhos d.e la inaestigacùin flw,if.ca(hgka, éticayfuica). Los objetiuos de una propuesta de talgénero se deben encontrar en la
exigencia escotista de proponer argurnentos qile sean md.lor?nente Persuasiuos pam la com'
prinsidn racional de los argurnentos defe. En ate sentido, en la segunda parte del articulo,-indieo
la diuersidad argurnentatiud entre Tbmtfu 1 Scoto a propdsito de h cuestùin relatiua
al principio de indiuiduacùin.
Introduzione
Quando si vuole fornire una Panoramica sul pensiero filosofico ge-
nerale di un autore, solitamente - a Partire dallo Stoicismo - si tende a
considerare in modo sistemarico gli studi ed i contribuid che I'autore in
quesdone ha compiuto in ambito logico, etico e fisico. Una tale distin-
zione degli studi filosofici era, infatti, stata formulata da Zenone di Ci-
zio (334-262a.C.), fondatore dello Stoicismo. Nella fattispecie, Zenonc
aveva proposto quesca triparrizione della filosofia in qutnto ritcncva e he
Mlttco Scozir
<<Logic, said hfu followcrs, is thc boncs of philosophy, ethics the Xesh,
and physlc thc roul»r.Anrlogrmcntc, quando si vuole sviluppare un discorso sulla meto-
dologlr filosoficr dl un autorc, sara opportuno - a mio awiso - andare a
rlntncclrrc ll "filo rossd'dcll'approccio razionde, che legp i contributi che
ll mcdcsimo autorc ha dato nei rre ambiti suddetti. lnfatd, quando parlia-mo di mctodologia, intendiamo la modalità argomentativa e la strurrurarazionalc del discorso utilizzato da un autore pergiungere alle conclusioniplausibili (owero non conffastand con le premesse poste) che - messe in-sieme - vanno a costituire il sistema filosofico dell'autore stesso.
Pertanto, fatte queste due brevi - ma a mio awiso necessarie - pre-messe, vengo alltsposizione del proposito del mio articolo. Studiando,da diversi anni, in modo sistematico il pensiero di Giovanni Duns Scoto
- prediligendo in un primo approccio l'aspetto logico, ma di richiamoanche quello fisico ed etico (convinto dell'intrinseca unità della partecon il tumo) - ho avuto modo di cogliere frammentariarnente, tra la let-
. tura dei testi originali di Scoto (mi riferisco all'Ordinatio2) e di quelli su
Scoto, la metodologia di fondo che caratterizza I ragronare del DoctorSubtilis.Tirttavia, il bisogno di fissare unirariamenre la metodologia sco-
tista,mi si è presentato nel momento in cui ho dovuto tenere un semi-narig3 - all'interno di un corso di "Metodologia della Ricerca Filosofica'(della "Pontificia Universita Antonianunm" per fA.A.2OL3/Z0L4) - ri-guardantc il metodo filosofico utilizzato dall'autore che principalmenteclrlttcrizzava la mia ricerca di Dottorato. L:n quellbccasione ho avuto
modo di prcscntarc schematicamente I unitarietà del metodo scotista,ricomponcndo (quasi come un puzzle) i vari frammenti ai quali mi ero
tccostrto ncl corso dcgli anni. Avendo of[efto, in un primo momento,quest! ricostruzionc mctodologica, mi è risultato piri agevole compren-dcre lc diffcrenti applicazione del metodo che lo stesso Scoto farà - divoltn ln volta - ncllc varie perti dell'Ordinatio dove espone la propriamsdilita di risolvcrc lc qucstioni teologiche che venivano poste.
t A. KnxNf ,{ new History of Westun Philosophy. Ancient PhilosopÉ7, Clare ndonI,rcss, Oxford 2004, p. 9 6.
I I rifcrimcnti chc farò in qucsto articolo scguono l'edizionc d ella Ciuitas Vatkana.3 Il scminario si tcnne il27 mrrzo 2014 prcsso lhula 6 della "Pontificia Univer-
La non classicità della metodologia filosofica di Giovurnl Dunr Scoro
Pertanto, in questo breve articolo, intcndo ripcrcorrcre I momendaffronrati in quel seminario, sperando di offrirc un conrlbuto rnlldo c
gadito ai futuri lettori, nella consapcvolczza,chc tutto è pcrÉttlblle (eniente è definitivo) ed ogni contributo - ncl suo piccolo - pcrmcttc rllscomunità filosofica di compicrc un piccolo prcso in rwntl veruo lr cono-scenza di un autore.
Uno sguardo d'insieme
Quello che vorrei assumere come punto di partenza è un tcsto, che
a me pare si possa ragionevolmente considerare comc il "manifesto"
dell'approccio filoso6co e metodologico dcl Doctor SubUlls.Il testo cuifaccio riferimento è la uaduzione (con un commento analidco) dellaLectura I Distinctio XXXIX di Giovanni Duns Scotoa. Questo volume
viene pubblicato nel 1994 dalla scuola olandese coordinata da AntonieVos e si caratterizzacome innovativo rispetto agli studi scotisti fatti inprecedenza, in quanto rintraccia - in modo sistematico - gli elemen-
ti del pensiero di Scoto nei quali è possibile individuare un approccio
logico-modale non-classico. Infatd, ciò che è pacifico oggi, ma anche (a
mio awiso) dal XIII secolo in poi, è che làpproccio filosoEco dominante
in epoca scolasdca fosse quello aristotelico. Nella fattispecie, Tommaso
dAquino - forte dell'idea che i principi naturali della ragione (esposti
punualmente dallo Stagirita) non possono essere in contrasto con la ve-
rità della fede cristiana - ritiene possibile un uso cristiano dell'aristorcli-
smo. Pertanto, propone di risolvere le questioni teologiche (esposte nel
suo Cornmento alle Sentenze di Pieno Lombardos) ricorrendo agli stru-
menti filosofici che erano stati posti dallo Stagirita; in modo piri pun-
tuale, possiamo dire che Tommaso fa dell'aristotelismo lbssatura del suo
discorso razionale. Ora, per I'epoca in cui vive Tommaso, questo modo
di pensare - all'interno dellbccidentc ladno (pongo questa sottoline-
atura, in quanto la Falsafa aveva già una considerazione più solida del
{ Jourv DuNs Scotus, Contingency and Frcedom. Lectura 139, Kluwcr Aca.
demic Publishers, Dordrccht 1994.5 Per i riferimenti a qucsto testo tommasiano utilizzerò I'Opcra Omnia ncll'Edi-
zione Parmensis.
Matteo Scozia
pensiero di Aristotele6) - era di indiscussa innovazione, in quanto ab-bandona la via agostinian{ afavore dell'umana filosofia aristotelica che
considera le creature per quello che sono, in piena autonomia rispettoalla fede per cui esse sono significadve solo come segni e tramiti del prin-cipio divino. Ancora, Tommaso era convinto che bisognasse superare Ia
giusdficazione della fede ricorrendo alllAuctoritas per far spazio ad unacomprensione razionale della fede stessa, come era già stato fatto da An-selmo (principalmente nel Monologion e nel Proslogian, ma anche nelle
opcre della maturità). Pertanto, Tommaso propon€ una trattazione edun'analisi dettagliata delle tradizionali temadche teologiche mediante lostrumento dell'approccio logico aristotelico.
Come ho detto sopra, un ulteriore momento di snodo nell'approc-cio razionale alla fede, viene dato da Giovanni Duns Scoto, il quale -convinto che teologia e filosofia vadano disdnte, perchè non tutro è
esauribile nella spiegazione razionale - considera lhpproccio aristotelicoal pari (per essenza) di qualsiasi altro ragionamento; nella fattispecie,
. quello di Aristotele è uno dei possibili modi di risolvere razionalmenrei problemi filosofici, ma per Scoto questo non sarà quello pirì valido e,
pertanto, nell'esporre le sue posizioni argomenterà in un modo razio-nalmente differente da quello dello Sagirita (che era stato assunto da
Tommaso) e, dunque, possiamo dire in modo non-classico.La struttura generale dell'approccio non-classico, dunque, viene si-
stematizzata da Antonie Vos nel volume di cui ho riferito sopra. Nellafartispecie, in questo testo viene affrontato da Scoto il problema dellaconoscenza divina dei futuri contingenti. Posto che il testo è cruciale ed
è impossibile delinearne I'importanza in un articolo, mi limiterò a direcome la visione che emerge dal resto - e che permette di individuarel'innovazione del ragionamento scotista - è quella di un realismo mo-dale (quello di Scoto) che, accertato il fatto della contingenza del mon-do, permette di dare conto dellàutonomia della volontà come postulatometafisico non in conrrasto con tale fatto. Nella fattispecie, è possibile
6 Cfr. C. DANcoNe (a cura di), Snria dellaflosofa nell'Islam medieuale (Yolu-me primo), Piccola Biblioteca Einaudi, Torino 2005.
7 Questa, prima dell'innovazione tommasiana, rappresentava il metodo domi-
nante, incarnato - sempre a Parigi - da Bonaventura da Bagnoregio, il quale riteneva
necessarial'Auctoritas agostiniana e, dunque, il primato che il santo Vescovo d Ippona
aveva attribuito a Platone nella cosruzione della sapienza 6losofica cristiana.
sviluppare un discorso che ponga in evidenza i punti essenziali del com'menro di Vos e, dunque, permetta di cogliere lapeculiarità del testo.
Il punto di partenza dal quale muove Vos è la convinzione che iltesto scotista in andisi <<is the final stage of the emancipation of Chri-
stian theology from ancient necessitarianism>>8; nello specifico, Vos ri-tiene che vi siano argomentazioni sufficienti per sostenere la rottura con
l'approccio logico classico. Tuttavia, voglio precisare - solo introduttiva-
mente, in quanto ci ritornerò piri avanti - che ilpassaggio dall'approccio
non-classico a quello paraconsistente (che sarà quello nel quale Luca Pa'
risoli inquadrerà il pensiero scotista) non è immediato, ma sarà il risulta-
to di due passaggi distinti del ragionamento; ma procediamo per ordine.
I punti basilari dell'aristotelismo logico, dai quali Scoto intendc
prendere le distanze, sono, <.The so called' principle of plenitudc'l cvcry
genuine possibiliry will be actualised. The equivalence of immutability
and necessity as well as the equivalence of mutability and contingen-
cy. Tiue knowledge as determinate, infallible, immutable and necessary
knowledge of necessary states ofaffairs»e. Questi tre Punti erano crucia-
li nell'approccio logico modale aristotelico e Permettevano di delineare
la semantica degli assiomi modali del Possibile e del Necessario, tispet-
dvamen[e, nel Mutabile e neltlrurnutabile. Qrcsta sistematizzazione
dei principali assiomi modali Portava a parlare, per lo Stagirita, di una
contirugenza diacronicato,per la quale uno stato di cose (p) ipotizzato nel
presente per un tempo fururo (t1) si realizzerà o meno (dunque, sarà p
o - p) impedendo all'ipotesti non realizzatadi realizzarsi in t1, ma - di
contro - offrendo a quella medesima ipotesi la possibilità di rcalizzarci
int2.Il punto sul quale s'innesta, secondo Vos, la frattura tra pensiero
classico e pensiero scotisra non-classico è proprio la differente teoria del-
la contingenza che elabor a I Doctor Subtilis. tn particolare, la posizione
scotista s'inserisce in maniera razionalmente valida se si affronta il pro-
blema nel campo dellbntologia modale; da qui si può vedere [a soscan-
La non classicità della metodologia 6losofica di Giovanni Duns Scoto 649
8 JoxN DuNs Scorus , Contingeney and Freed.om. Lectura 1 39, Kluwer Aca-
demic Publishers, Dordrecht 1994, p. 19 -
e lbid.,p.20.r0 Cfr. S. KNuulrru^e., Time and rnodality in scholastieism, in S. KNuurrtln
(edlred by), Reforgrng the great ehain of being Studies of thc history ol'modal thmrìet,
Springer-science Business Media, Dordrecht'Boston-London l98l' p, 166'170'
650 Mrttco §cozlr
ziale diffcrcnza con lhpproccio classico. A qucsto proposito Vos evoca
i duc principrli (c diFcrcnd) modclli ontologici presenti nella filosofia
grccall pcr mosffcrc comc anchc la mapptura della realta veniva intesa
divcrsmcntc. Il primo è qucllo elaborato da Parmenide, per il quale frs-.rarc è lmmutabilc c nccessario c, quindi, la mutevolezza e la contingenza
sono solo fenomeni sensoriali apparend. Per questo modello Yos parla
diun Necessitarismo radicale ontologico e Io rappresenta graficamente nelmodo seguente 12:
time-aris-p
Il secondo modello, invece, è quello aristotelico basato sulla modal-tià suddetta e che, di conseguenza, avrà ripercussioni nella mappatura
della realtà; infatti, il possibile stato di cose 'p" a tl, essendo possibile,
potrà. essere tanto p quanto - p; ma, realizzandosi una delle due possi-
bilità in tl, quella non-attualizzata porà ffovare attualizzazione in unsecondo momento. Per questo Vos rappresenta il modello aristoteliconel seguente modo:
timc-axi$
Rispetto a questi due modelli, quello scotista risulta essere innovati-vo, in quanto propone una nuoya mappatura della realtà sulla base di una
nuova formulazione degli assiomi modali del Possi.bile e del Necessario.
Nello specifico, la contingenza scotista è differente da quella aristotelica,
rr Cfr.JottN DuNs Scorus, Contingency and Freed.om. Lectura 139, Kluwer
Academic Publishcrs, Dordrccht 1994, p. 23-25.
'' Vos spicga qucsto grafico nel seguente modo: .<Shaded spaces are states ofaf-fairs which have bccn actualised, empty spaces are states of affairs which are possible
but not actualiscd (empty spaces do not occur in the Parmenidian and Aristotelian
model)" (Jonu Duvs Scorus, Contingeney and Freed.om. Lectura I39,Kuwer Aca-
dcmic Publishers, Dordrecht 199 4, p. 23, nota 46).
P
-p
La non classicità della metodologia filosofica & Giovanni Duns Scoto 6rl
in quanto rl Doctor Subtilis ritiene che << a state of affairsp is contingentif - p is possible for the sarlte moment>>l3; pertanto, il passaggio è da
una contingenza diacronica (quella aristotelica) ad una sincronka, e ciòimplica che I Possibile non è piri inteso come Mutabile, ma come Realiz-
zazione sincronica dei contingenfr'. Da qui Vos ricava il modello scotista
per il quale:
lime-axis
ln questo punto del discorso vediamo come Vos assuma p oppure
- p, ma da qui non si può inferire né lhssunzione di p, né làssunzione
di - p. In quesro senso, quindi, siamo ancora in logica non-classica e
non in logica paraconsistente; per essere più diretti si può dire che una
logica di tipo paraconsistente ingloba nel suo sistema lhnnullamcnto del
principio di non-contraddizione in maniera logicamcntc valida, owcrofa della non validità del principio di non-contraddizione la sua pcculia-rità. tn generale <<una teoria è inconsistente se contiene sia a che -d,rr l{;
ora, quello che una logica di tipo paraconsistente intende sostenere è
la non validirà razionale di quella che viene definita <<Lege di Scoto, o
dello pwudo-Scoto>>15 - definita così perché studiata nelle In uniuersarn
logicarn quaestiones attribuiteun tempo a Duns Scoto, ma di certa opera
di un logico della scuola scotista - per la quùe uexfako {e paredigma-
ticamente: ex contradictione) sequitar qaodllbet,dallàssurdo segue qual-
siasi cosa, e la conraddizione è il caso per eccellenza di assurdorr16. Se-
guendo il ragionamento di Berto è possibile muovere a questa loigca una
critica, e cioè che <<il sistema consente di dimostrare tutto, e dunque,
anche il contrario di ructo, sicchè è deduttivamente inutile. Una singola
tr JonN DuNs Scorus, Contingency and Freedom, Lcctura 139, Kluwcr Aca-
demic Publishers, Dordrechr 1994, p. 25.1a F. Brnro, Tborie dellassardo : i riuali del principio di non contraddizione, Ca-
rocci, Roma 2006,p.97.t5 lbid.,p.98.t6 lbid.
652 Matteo Scozia
contradiction produce ui explosionr>r7. Tirttavia, una logica paraconsi-stente intende sostenre le contraddizioni evitando di invalidare I prin-cipio di esplosione;pertanto, <<Una logica esplosiva uivralizzaogni teoriainconsistente su di essa impiantata. Il problema di qualsiasi logica che
ammetta contraddizioni, o che funga da logica sottostante a una teoriainconsistenre, è dunque quello di riuscire in modo soddisfacente a evi-
tare I'esplosione. Diciamo che una logica che soddisfa questo requisitoè conforme alla Condizione Debole di Anti-triuialità. Qtesto è ciò a cuimirano le logiche paraconsistenti. Possiamo così dare la pirì generale de6-
nizionc di paraconsistenza logica dicendo: ana logica è paraconsistente se
c solo se non è esplosiuar>tg..
Fissato il principale intento di una logica paraconsistente è bene
dlrc alcunc cose per comprendere lo scarto che intercorre tra la posizio-ne di Vos ncl grafico scotista sopra presentato (logica non-classica) e una
logicr di tipo paraconsisrente.
Nclla fattispe cie, è opportuno distinguere tra due diversi gradi di pa-
' raconsistenza: a) debole, <<talvoltapresencatacome unaparaconsistenzaproof theoreticrr le, che non ritiene necessario <<ammettere la reabà dellacontraddizione né la possibilità di conuaddizioni vere>>20;b) forte, che
<<è caratteùzzata dall'ammissione di contraddizioni vere in senso pro-prio, in violazione di qualche forma di (PNC2), del Principio di Non-Contraddizione logico-semantico >>
21.
Rispetto alla seconda dpologia di paraconsistenza, che è quella nella
quale si può inserire il ragionamento di Scoto, dirò che a quesro livello delragionamento di Vos siamo ancora in una logica non-classica € non para-
consistente, owero il p-rincipio di non-contraddizione ancora non salm.
Ora, quello che bisogna dire sul modello scocista è che per essere
compreso, ol,vero inteso razionalmente, richiede la considerazione diuna nuova mappatura della realtà. Infami, la contingenza sincronica -secondo la lettura data da Vos nello specifico per quanto concerne le ri-percussioni rcologiche di un simile ragionamento - richiede che vi sia
t7 lbid.,p.99.tB lbid.,p.l00.le F. Br,nro, Teorie dell'assurdo: i riuali del principio di non contraddizione, Caroc-
ci, Roma 2006, p. 109.n fuid.2t lbid.
LanonclassicitadelametodologiafilosoficadiGiovanniDunsScoto 651
uriattualizzazione delle possibilità. Questo discorso è ben argomentato
da Simo Knuuuila il quale ritiene che la teoria della concingenza sincro-
nica scotista ha valore solo se la si basa su rre punti: << I ) la distinzione tra
possibilità logica e possibilità reale; 2) I attenzione alla possibilità di stati
alternativi di cose nello stesso istante di tempo; 3) I uso decisivo della no-
zione di "compossibilità", nozione che rimanda da un lato alla possibilità
del rcalizzarsi di diversi stati di cose nello stesso momento del tempo e,
dall'altro, alla possibilità intesa in senso logico come compossibihta ditutro ciò che non implica contraddizione ,>22. Pertanto, la teoria scotista
della contingenza sincronica può assumere pieno valore - impatrando
innovativamente in campo filosofico (logico) e teologico - se la si inqua'
dra in una semantica dei mondi possibili.
Prima di entrare nello specifico di questo approccio logico, ritcngo
quanro mai opportuno riferire sul ragionamento vossiano, Pcr guanto
concerne la distinzione scotista tre senso coruposto e senso diuisoi qucsto
punto del ragionamento, infatti, è imprescindibile per una picna com'
prensione dellàpproccio ontologico scotista.
Il luogo della Lectura nel quale abbiamo un'articolata argomenta-
zione della distinzione tra i due sensi è la parte nella quale Scoto spiega
come Causa contingentiae in rebas est ex parte uoluntatis diuirta*s. Qte'sto passaggio, a mio awiso, è fondamentale per mostrare come lapproc-
cio logico che emerge è rilevante e, tuttavia, non può ancora essere con-
siderato di tipo paraconsistente (pur sganciandosi dalla classicità); ma
procediamo per.ordine.
Il ragionamento si sviluppa all'interno di un discorso concernente
l'idea che la causa della condngenza nelle cose sia il volere divino; il vo-
lere, infatti, è una delle due modalità nelle quali per Scoto Dio è attivo(làltra modalità è la conoscenza). Ora, avendo rifiutato [a conoscenza
come causa della condnge nza, in quanto la conoscenza pre cede il volere
ed è necessaria ed immutabile (fermo resmndo che la conoscenza divina
dei fururi contingenti è priva di qualsiasi valore di verità, in quanco non
è una conosc renza prutica; possiamo dire che è una conoscenza neutra),
22 R. Fron Ic e., Gli suiluppi del XII/ secolo, in R. Froruce e S. PucctoNI (a cura
di), Logica e linguaggio nel rnedioeao, EULED, Milano 1993, p. 385.2r JonN DuNs Scorus , Contingency and Freedorn. Lectura / 39, Kluwcr Aca'
demic Publishers, Dordrecht 1994,p. 104-140.
Matteo Scozie
rl Doctor S*bAlX ponc lhttcnzionc sulla volonta, in quanto la scelta e
l'attudizzrzionc dei frtti contingcnd è fata dal volere divino.
Dctto clò Scoto sviluppa il ragionamento prima analizzando il vole-
rc umlnor chc prcscna trc possibili modi in cui si esplica la libertà per la
nortn volontà: « thc first type is the freedom in regard to opposite acls,
thc sccond onc is the freedom in regard to opposite o bjects,thethird one
is thc frecdom in regard rc opposite {ects of acts of the will>>24. Da que-
sta liberta, tuttavia, deriva qualcosa d'imperfetto e qualcosa di perfetto(il discorso prende in esame le prime due tipologie di libertà, in quantola terza è una libertà consequenziale). L imperfezione conceme la libertàad, a.ctus ol,positos,in quanro implica la mutabilità; la perfezione, invece,
riguarda la libertà ad obiecta opposita, in quanto (anche se Scoto non è
chiaro nelltsposizione di quesco argomento) questa concerne la contin-genza senza implicare la mutabilità. Da questa prospettiva emerge come
<<diachronic freedom 0 *d -p arcsuccessively factual) and synchronicfreedom (p and -p is simultaneouslypossible) are separated"25.
' A qoesto punto, la domanda che Scoto si pone riguarda la relazioneche intercorre tra questo schema e la contingenza. Innanzitutto, spiega
1l Doctor Subtilis, nella nostra volontà non può esservi un volere simulta-neo di due opposti, <<quia non sunt terminus simul unius potentiare>>x.
Tuttavia, chi possiede la libertà ad actus opposhos implica come conse-
guenza una duplice possibilità e contingenza:
Una prima tipologia è quella in base alla quale ..distinguuntu propo-sitiones de possibili quae fiunt de extremis contrariis er opposiris, utalburn
Potest esse nigrurnrrzT; questeproposizione è vera in base elsensurn dluislo-
zrs per il quale gli estremi si realizzano in tempi diversi, e perciò .. album inu pote$ esse nigrum in brr28 o, ancora (concludendo un caso interessante)
..voluntas amans illum, potest odire illumrr2e. È qui che Scoto chiama incausa il concetto di senso dlulso (che si oppone al senso cornposto);prima diproporre l'analisi vossiana, che permettera di accedere al livello successivo
2a JonN DuNs Scorus, Contingcncl and Frccdom. Lcctura [ 39, Kluwcr Aca-
demic Publishers, Dordrecht 1994,p. 109.
'zs lbid.,p.ll3.26 Lectura I, d. 39, q. l-5, n.4727 LecturaI, d. 39, q. l-5, n. 4828 LecturaI,d. j9,q. l-5,n.48» Lectara I, d. 39, q. l-5, n, 48
6)4
del ragionamento sui mondi possibili, vorei introdurrc i duc concctd ud'lizzando la spiegazione data da Simo Knuuttila:
<<Gli enunciati'Un uomo chc non sta scrivcndo può rcrlvcrrr r 'Unuomo seduto può camminarc'sono falsl, qurndo lr polrlbllld ò lnmncome se qualificasse la composizionc dci duc prcdlcrtl rcclProcrmcnte
esclusivi con lo stesso soggctto dcl mcdcsimo tcmPo. E Arlrtotele ponn'va che il principio megarico sccondo cui solo il rcdc è poulbllc ll brmllcprecisamente sulla falsita di qucsto gcncrc dl enuncletl lz rn* ymposi-
ir...l" ,t rr" proposizione può crr.t pte*. .nchc in scnsa dlubo. È pcrciò
vero che qualcuno che non sta scrivcndo può scrivcre...h possibilità può
riferirsi a una supposta attualità dci prcdicati ncllo stcsso tcmpo (in sen'
su composito) o in tempi diversi (in scnsu diuiso)...Ia distinzione include
così il passaggio dall'enunciato temporalmente dcfinito a uno temporal-
*.nt. it d.fir,ito, ma essa è celata sotlo una distinzione logica>'s'
ln questo modo credo sia possibile comprendere che I senso diuiso
è inteso da Scoto <<as a conjunction of two further propositions>>31. A
questo punto del ragionamento, Scoto si sta muovendo ancora in una
pro.p.r.ir" diacronica della possibilità, per la quale il volere-ed il non-
lrol.i. orr" medesima cosa si attualizza in istanti di tempo differenti.
Turtavia, un elemenro importante viene introdotto nell'analisi della
seconda tipologsadipossibilitas et contingentia: nellafattispecie, qui Sco-
to parla dilla Putenti.a logica. Aquesto proposito Yos sostiene che:
..rhis concerns nothing but the crucial fact that possibiliry proposidons
are true if they are composed of non-contradictory terms...the non-con-
tradiction ofthe rerms is sufficient condition for the possibility ofthe sta-
rcs ofaffairs as described in the proposition...Scotus adds...that the logical
possibility is about simubarueity or synclrony of a factual state of affairs
and,the possibility of the opposite. Applied to the will: Let us suppose an
La non classicità della metodologia filoso6ca di Giorannl Dunr Scoto 6r,
r0 S. KNUurr u"t, Ld criticd di Duns Scoto all'interpretazione <<statistica>> d.ella
mo dalità,in R. FED RIGA e S. P UG GION | (a cur?- di), L o§ca e linguaggio ne I medio -
euo, EllLLD,Milano 1993, p.4OG passim.rr JonN Duus Scorus, ContingenE and Freedom. Lectura 139, Kluwer Aca'
demic Publishers, Dordrecht L994' p. ll3.
656 Mattco Scozia
act of the will at one particular moment, then it remains true thar, if rhewill wills an objecq ar rhar momenr, it can scill nor-will that objecr>>32.
Ancora, voglio insistere sulla spiegazione scotista delle ragioni per lequali è valida una proposizione del tipo <<in eodem instanti in quo volun-tas habet unrun actum volendi, in eodem et pro eodem potest habere op-positum actum volendi»13. L'argomentazione del Doctor Subtilisi sibasasul fatto che tra il volere e il prodotto di una tale volizione non cè unarclazione essenziale, bensì accidentale. La motivazione di fondo è che :
<< If a cermin act of the will were essential to the will rhen the will wouldbc relatcd to this produced act in any possible situation. Ar any sepa-
ratc momcnt when the will has rhis act of the will, the possibility ofdre opposite act of the will would be absenc So, 'willing thar a' is an
eccidcntal property of a will-gifted person. The importance of rhis lineoftought is also, that in ir Scorus gives a new explanation ofthe con-ccpts of 'cssendal'and'accidenal'in terms of his rheory of synchroniccontingencyt la.
A questa tipologia di possibilià logica corrisponde quella che Scotodefinisce potenza reale (<<huic possibilitati logicae correspondet poren-tia realisr>35), come qualcosa che ha la potenza di attualizzarc. Vos, tut-tavia, pone I'attenzione sul fatto che il rermine reale aggiunto a quello dipotenza non deve rimandare necessariamente all'attualizzazione,ma - alcontrario - rendere l'idea dell'esistenza fatruale di unapotenza capace diattualizzar e le possib il i tà
Dunque, i due punti fondamentali per accedere alla semantica deimondi possibili (nellaccezione vossiana che tra poco andrò ad esporre)sono la sincronia delle possibilità logiche e la potenza reale.
Fissari quesd due punri, Vos mosrra come Scoto ritorna sulla distin-zione tra senso corupostl e senso diuiso per recuperare in chiave positiva ilsenso diuiso (precedentemenre messo in relazione con istanti temporalidifferenti e successivi) nella teoria della possibilità sincronica. Nello spe-
32 lbid., p.l 17 passim.33 Lectura I, d. 39, q. I-5, n. 50ra JouN DuNs Scorus, Contingency and Freedom. Lcctura 139, Kluwer Aca-
dcmic Publishcrs, Dordrcchr 1994, p. Ll9.lt Lcctura [, d. i9,q. l-5,n, 5l
La non classicità della metodologia filosofica di Giovanni Duns Scoto 6J7
cifico, considerando la proposizione ..voluntas volens in a, potest esse
nolens irr 4>>36, Scoto ridene che questa può essere considerata vera nel
seruso diuiso inteso come la congiunzione di due proposizioni; nello spe-
cifico, Vos esemplificail ragionamento scotista nel modo seguente :
<<lohn wilk something, and It is possible tbat Jobn does not-will it at the
same mnment.The possibiliry operator now only refers to the second one
ofthese conjuncts. In this divided sense the propositions is truc and statcs
that at the moment at which the will factually has an act of willing so'
mething, rhereisthe possibility (not the facruality!) of not-willing it>>37.
La proposizione scotista, dunque, è da interpretare <<non nel sen'
so che i predicati contrari si riferiscano a differenti istanti di temPo, ma
come un enunciato composto dalla congiunzione di due proposizioni,
di cui la prima asserisce un atto di volizione, mentre la seconda €sPrimc
la possibilità simultanea delllatto di volizione oppostorr3s. Ancora, solo
in questbttica il volere può dirsi realmente libero per Scoto, in quanto
..willing something is a free act, because not-willing it is possible at onc
and the same moment. So the freedom of the will turns out to be equi-
valent to the synchronic contingency of volitions>>3e. Da questa teoriz'
zazioneemerge che la contingenza sincronica scotista abbraccia tanto glioggerd quanto gli atti opposti.
Detto ciò Scoto è agevolato nell'analisi della libertà divina, Presen-
tando le argomentazione che concernono la libertà diacronica (prima)
e quella sincronica (dopo) in relazione a Dio. Inf*d, la volontà divina
- essendo perfema - non può avere la prima tipologia di libertà, owe-
ro quella (imperfema) che reakzzagli opposti in tempi diversi, bensì la
seconda, oyvero quella rivolta aLla realizzazione nello stesso isante de-
gli opposti. La libertàL divina, dunque, si realizza nel porre in essere nel
medesimo istante, da parte di un unico atto volitivo, possibili conrad-
36 Lectura I, d. j9, q. l-5, n. 5237 JouN DuNs Scorus, Contingency and Freedom. Lectura 139, Kluwer Aca-
demic Publishers, Dordrecht 1994, p. l2l-l13-i8 R. Fporuc t, Gli sai.luppi delXIt/secolo,inR. Frontce - S. PuccIoNI (a cura
di), Lo§ca e linguaggio nel medioeao, EULED, Milano 1993, p. 386're JonN DuNs Scorus, Contingency and Freedorn. Lectura / 39' Kluwcr Aca'
demic Publishers, Dordrecht 1994, p. 123.
Mrttco Scozia
dittori; ribadiscc Scoto chc la volontà divina, <<potest in eodem instantiacternitrtis ct pro codcm instand acternitatis velle et nolle aliquid, et sic
produccrc rltquid ct non producere ,rs.È fondamcntale tcnere presente come per Scoto, Dio in un solo amo
volidvo voglia una cosa e il suo contrario; questo è comprensibile se cisi riferisce alfasse temporale scotista esposto graficamente da Vos (di cuiho riferito sopra). Ancora, come quello schema possa essere collegatoalla teoria della contingenza sincronica in relazione al volere divino losi può capire se si introduce nel ragionamento una semandca dei mondipossibili. La letteratura su questo argomento è vasta e varia; tuttavia, sic-
come ho assunto il testo di Vos come cruciale nella formalizzezione dellamodalia non-classica scotista riferirò ciò che intende il curarore dellatraduzione del testo di Scoto quando applica alla teoria della contingen-za sincronica la semantica dei mondi possibili:
<<By'possible world' these semantics mean a maximal consistent set of. possible states of affairs. Maxi.mal, because every possible state of afFairs
is true or false in this world; ra nsi.stent,becatse the srates ofaffairs wirhinone world are logically possible simultaneously, that is, they are logicallytom-possible' and as such, they form a consistent world. One possible
world is, for instance, the factual world now existing and consisdng o{,
among other things, the Domtoren (cathedral tower) of Utrecht. The
same world without the Domtoren is a synchronically possible world:an alternative to the one factually existing. Similarly there are counrless
possible worlds, which are altematives for one anorhern4r.
Questo passaggio del testo di Vos mi pare spieghi in maniera chiarae sintentica cosa s'intende per mondo possibile in riferimento al ragio-namento scotista; se, infatti, abbiamo come riferimenro la logica classica,
il senso diuiso è possibile solo considerando istand temporali differen-ti; tuttavia, un discorso come quello sviluppato da Vos sulla base dellaLectura I Distinctio XXXX scotista - lo ripeto - presenra una logicarilevante, di sicuro stampo non-classico, ma non ancora collocabile traquelle paraconsistenti.
q Lectura I, d. 39, q. l-5, n. 54
ar JonN DuNs Scorus, Contingency and Frccdom.
demic Publishcrs, Dordrecht 1994, p. 30.
658
Lcclura 139. Kluwer Aca-
La non classicità della metodologia filosofica di Giovrnni Dunr Scoto 619
Quello che qui mi preme sottolineare è comc dr quccto ryProccloemerge una nuova meppatura della realtà rispctto alle clesEcltl fflttotc.lica; infatti, se per Aristotele la realta da considcrarc è solo quclh rrrr.r,/e (il nostro mondo), per Scoto oltre al nostro mondor cloè dlr rcrltlattuale, entra in gioco la realtàreale, owcro - Pcr $scrc rlntcticl - lrtotalità dei mandi possibili nei qurali c'è la possibllttà logka di rcili?.z.rc
le possibilità non attualizzate nel nostro mondo attualc. In tal modo,
dunque, emergono gli elementi che permcttono di parlarc di una teoria
modale non-aristotelica in Scoto, ma - come sto Per mostrarc - in senso
più generale di un approccio filosofico non-classicoa2. Prima di procede-
re, si tenga presente che nei testi scotisti non si roverà mai un termine
come rnorudo possibile, in quanto questa (come altre, di cui riferisce Vos
nel suo commento) è una deduzione logico-consequenzialea3 che deriva
dall'approcci o tfiiizzato da Scoto nelle analisi delle temadche teologi-
che classiche.
È, donqu., per questo motivo che il volume colletdvo della scuola
olandese di Antonie Vos può essere considerato come il punto centrale
dal quale far parcire la rifessione sulla metodologia del sistema filosofico
di Duns Scoto.
Da questo testo, dunque, che offre fidea dell'approccio generale da
pane di Scoto agli smdi filosofici, è possibile - in modo figurato - far discendere tre ulteriori testi che permettono di vedere come questo metodo
non-classico ricora nelle analisi logiche , etiche e fisiche d el Doctor Subtilis.
Per prima cosa, dunque, gli approfondimenti in ambito logico ven-
gono studiati in modo specifico da Simo Knuuttila. Il filosofo finlan-
dese ha, inf*ti, dedicato numerosi saggi e articoli scientifici, oltre che
relazioni di conferenze, sulfargomento; tuttaYa, il testo che ho ritenu-
to opportuno meffere in evidenza, in quanto mi pare renda conto in
a2 Lateoria della contingenza sincronica è, infaai, considerata da Vos come il
prologo metodologico a tutto il sistema filosofico scotista (C&. JoHN DuNs Sco-
rus, Contingeney and Freedorn. Lee tura I 39, Kluwer Academic Publishe rs, Dordrecht
1994, p.33-34;36). Pirì precisamente, lhpproccio non-classico sara lo sfondo della
rifessione 6loso6ca di Duns Scoto c questo cercherò di mostrarlo nella seconda parte
del prescnte articolo.ar Una valida formalizzazione di una teoria logico-modale contemporanca [a si
può trovare in: C.I. Lrwrs - C.H. LeNcr ox», Symbolic logic, Dover Publicadons,
New York 1959 (ll edizione).
Matteo Scozia
modo efficace dell'unitarietà della parte logica con le rotalirà del sisrema
scotista è: Modalities in Medieual Pbilosophyu. Qui Knuutrila va nellospeci6co della trattazione Logica di Duns Scoto, mostrando come nel-le intuizioni del Doctor Subtilis vt siano tanto una nuova formulazionedegli assiomi del Possibile e del Necasario, qutnto ragionevoli elementiper offrire una chiave di letrura del pensiero scotista che ricorra ai con-cetti logico-modali contemporaneia5 dei Mondi possibi# piuttosto che
dell' I d e n ti tà tran s mo n di#.[n secondo luogo, per quanto riguarda laspetto etico, ho proposro
di assumere come valido ed esauriente nelle analisi delle implicazionietichc c morali di un approccio logico-modale non-classico, il recente
volume di Luca Parisoli: La contraddizione uera. Giouanni Dans Scoto
tra la ncccssità della metafsha e il discorso dellaf.losofu praticaaT.
[nfine, per quanto riguarda la frsica" l'opera di maggiore interesse scienti-
fico alla quale ci si può riferire quando si considera l'appono dato da Scoto inquesto campo, è quella di Richard Cross, Tbe Phyia ofDuns Scotus$.
Pcr presentare, dunque, la metodologia filosofica di Giovanni DunsScoto ho volutamente evocato una mappatura totale delle applicazioniche si possono fare per quanto riguarda il nuovo approccio logico-mo-dale individuato da Antonie Vos nellbpera del Doctor Sabtilis. Owia-mente, questo modo di esporre la questione non yuole essere dispersivo,ma - al contrario - rendere conto delle varie applicazioni per mosrrare
I unitarietà di fondo del pensiero scotista e le necessarie connessioni trai diversi ambitiae. È chiaro, infatti, che se un approccio non-classico nei
14 S. Ktquuruu, Modalities in Medieual Phil^opb, Routledge, London-NewYo*,1993.
45 Cft. C.I. Luvrs - C.H. LeNcroyo, Symbolic logit, Dover Publications, NewYork 1959 (II edizione).
# Cfr. l) R. Cnrsuotw, Identity trough Possibb Worlds: Some Question, in<<Noùs», I (1967), p. I-8; 2) Io., Person and object, Open Courr Publishing Com-pany, La Salle 1979.
a7 L. Penrsor\ La connaddizione uera. Giouanni Duns Scoto tra la necessità della
netaf.sica e il discorso dellaf.losofapratica,lstitrto Storico dei Cappuccini, Roma 2005.a8 R. Cnoss, The Physics ofDuns Scotus,Clarendon Press, Oxoford 1998.ae Ci tengo a precisare come il discorso sul metodo che ho impostato non Eatta
direttamente lhspetto formale del ragionamento filosofico, bensì quello sostanziale. Itesri, infatti, che ho evocato mosffano i contenuti scotisti che permettono di rintrac-ciare la non-classicira dell'autore. Owiamente, questa è la pcculiarita che a me sembra
La non classicità della metodologia Glosofica di Giovanni Duns Scoto 661
termini posti da Vos è presente in Scoto, saranno necessariamente colle-gad ad esso i tre ambiti che costituiscono il sistema filosofico nella pro-spettiva stoica di cui ho reso conto nell'Introduzione al presente articolo.
Una particol arc applicazione dell'approccio generale
Alcuni potrebbero pensare che sia sufficiente I analisi svolta fin quiper rendere conto della metodologia scotista; tuttavia, ho ritenuto op-porftno offrire brevemente un'esemplificazionepratica di quanto demo
fino ad ora, owero di presentare una brevissima parte dell'Ordinatio sco-
tista nella quale vi è un chiaro rifiuto dell'approccio tradizionale aristo-telico rispetto a quanto - contrariamente - era stato fatto da Tommaso.
si possa rintracciare in Scoto; tuttavia, se si vuole rendere conto dellaspetto formale
che ricorre nelle analisi filo sofrche del Doetor Subtilis si può facilmente rispondere con
il considerare che Scoto, essendo originario di Duns nella contea di Berwick, in Scozia,
si è formato a Oxford e in altre località inglesi e scozzesi; inoltre, dopo aver studiato a
Parigi (inviato dall'Ordine nel 1291), uaill296 e il 1300 insegna a Cambridge, quin-di a Oxford frno al 1302 (seguirà, poi, il ritorno a Parigi e iI trasferimento a Colonia
dove morirà nel 1308). Il riferire questi dad biografici (Cfr. G. D'Oxorruo, Storia ddPensiero Medieuale, CittùNtova, Roma 201 I , p. 582) è utile per comprendere come iIcontesto metodologico (formale), che caranerizza la formazione (e la successiva pro-
duzione) di Scoto, è quello rintracciabile nelle Scuole Inglesi del XII secolo (Ck. Ibid.,p.315-325), che, a loro volta, si rifanno all'approccio razionale awiaro da Anselmo
dAosra. In questo periodo, due autori spiccano per limportanza del loro lavoror Ade-
lardo (maestro di Bath nel Somerset, morto prima del I109) e Giovanni di Salisbury
(m. I180). Al primo dobbiamo la traduzione di testi matematici, geomerici e asffo-
logici, che infuenzano le sue posizioni esposte nelLe Qtaestiones naturales (cioè che
scienza e religione non sono contrapposte) e - in un c€rto senso - prepalano la strada
allo scientismo che sarà ripico dei maestri di Oxford nel secolo seguente. AI secondo,
invece, dobbiamo una decisa presa di posizione per quanto concerne i 6ni della logica
(strumento basilare per làpproccio metodologico di stampo scientism); questa, infatti,dovrà essere orienrata all udlità pratica e - in modo specifico - al perfezionamento mo-
rale. Scoro sembra inserirsi perfettamente in questo contesto; infaci, egli ricorrc all'ap-
proccio scientifico di cui si è derro, malo orientaverso le finalitàmorali (in accordo con
quanro proposro da Giovanni di Sahsbury). Per un riscontro di quanto dctto rimando
ad una lettura complessiva del testo di Luca Parisoli evocato nel corpo dcl testo,
662 Mettco Scozla
Il passo chc ripropongo in qucsto articolo riguarda I Principio diIndiutduaslonr, di cui si trove il principalc riferimento nella trattazione
dclbDlstinctio III dclsccondo libro dellc Sentenzeso.
Nclla f*tispccic, Tommaso, chiedendosi «Utrum Angelus sit compi-
sutus ct( matcria ct forma>>5l, aveva articolato la risposta in tre momentiInnanzitutto, aveva spiegato come riguardo a questo problema
<<trcs sunt positiones>>52: l) quella di Avicebron, per il quale <<in omnisubstantia creata est materia, et quia omnium est materia unar>53; 2)
quella di Avicenna, per il quale <<materia non est in substantiis incorpo-reis, sed tantum est in omnibus corporibus, etiam unarrq; 3) quella diAverroè, per il quale <<corpora caelestia et elementa non communicantin materia>>t5.
Dopo aver esposto le tre posizioni, il Doctor Arugelicus, si schie-
ra esplicitamente a favore della terza (..istam eligimusrr56), in quanto<<videtur magis dictis Aristotelis convenire >>57. Pertanto, accetterà che
i corpi celesd e gli elementi non condividono la medesima mareria. Daciò seguirà per Tommaso che nell'Angelo cè una <<compositio ex actu et
potentia; et si ista potentia vocetur materia, erit compositus ex materia
et formarr58, intendendo - però - la materia non come la si trova neglielementi, ma in unhccezione differente che era stata assunta secondo la
prospertiva di Averroè.
Pertanto, avendo posto queste premesse risulterà necessariamente
consequenziale che all'interrogativo particolare riguardante ciò che in-
t0 In generale i Libri quaxaor Sententiarurn di Pieuo Lombardo costiuiscono la
formalizzazione della dottrina teologica cristiana e, dunque, lo srrumento di verifica per
I'eventualc ortodossia od eterodossia delle teorie dei pensatori successivi Qualsiasi autore
medicvale, infatti, nel conìmentare il tcsto lombardiano utilizzerà un metodo che è suo
proprio, ma le conclusioni alle quali giungc dovranno sempre essere in accordo con la
tradizionc contenura nel testo del Magistcr Sententiaram.5t In 2 Sententiarum, Dist. j, q. l, a. It2 In 2 Sententiarum, Dist, 3, q. 1, a. l, co.
53 In 2 Sententiarum, DhL j, q. l, a. 1, co.
ta In 2 Scntentiarum, Dist. j, q. l, a. l, co.
tt In 2 Sententiarurn, Dist. 3, q. l, a. l, co.
56 In 2 Sententiarum, Dist. j, q, l, a. l, co,
,7 In 2 Sententiarum, Dist. j, q. l, a. l, co.
58 In 2 Sententiarum, Dist. j, q. l, a. l, co,
dividua, Tommaso risponderà << sicut dicit commcntetor...Pcr msErlam
individuatur>>5e.
Il distacco dalla tradizione aristotelica, può cascrc ficilmcntc rln'rracciato nella formulazione che lo stesso Scoto proponc dcl Prlnclplo
di lndividuazione nella corispondenrc Partc dcl suo commcnmrlo dlc
Sentenz4.Il problema filosofico che viene Posto dal Doctor Subtilb è, infatti'
quello di capire cosa ci permetre di designarc un oggctto a discapito di
i..i. f" soluzione proposra non è immediara, ma arriva al tcrminc di un
ragionamento che scarta la mera auctoritas aristotelica, pcr rintracciare -in una serie di aigomentazioni piri solide e persuesive - una ProsPettiva
validamente altemadva a quella tommasiana. [o cercherò di ricostruire
sinteticamente questo ragionamento, riportando in maniera funzionale al
mio discorso i passaggi fondamentali della parte dellOrdinatio in analisi.
Il punto di p ^rin rdunque, non è la sostanza aristorclica (che, tut-
avia, àa rr, porr,o di vista esclusivamente terminologico e concetuale
viene utilizzata da Scoto), ma il contributo di Proclo sulla distinzione
ua [Jnità Nurnericbe e Meno che Nurnerichr6r. Questa è, a mio awiso, la
teoria base che permette di spiegare l'individuazione scotista. La distin-
zione di fondoita nel fatto che la prima upologia di unità permette di
conrare gli oggetri e descriverli linguisticamente, la seconda - invece -.orr..rrrè i numeri reali e permette di contare le forme62.
La non classicità della mctodologia 6loso6ca di Gioranni Dunr Scoto 661
5e In 2 Sententiarum, Dkt- j, q. 1, a. 1, ad jpassim '6o Cft. Ordinatio II, d. i, p. 1, q. l-7. Di questaparte dellordinatio cè un'inte-
ressanre rraduzione italiana (con commento analitico) curata da Antonello D'Angelo6
GrovANNr DuNs Scoro, Il Principio di Indiuiduazioza Socictà Ediuice il Mulino,
Napoli 201l.6t Cfr. L. Penrso tt, Unità numeriche e unità rneno-cbc-nurneiche nelh str*egia
realista: Gioaanni Duns Scoto e Pietro Tbrnmaso in Mediaeual Sopbia 7 (gennaio-gi]u-
gno 2010), p. 50-64.62 ..Aliqua esr unitas in re realis absque omni operatione intellectus, minor unitate
no*.r"li ,i.,n ,rnitare propria singularis, quae'unitai cst naturac secundum se, 'et sccun-
dum istam'unitatem propriam' natrrae ut natura est, natura est indiffcrcns ad unitatcm
singularirads; non igitur est de sc sic illa una, scilicet unitate singularitatis >, (Ordinatio II'
d. j, p. 1, q.1, z. 30). Su questo passaggio dell' Ordinatio scotbta, come - owiamcntc - §u
.loiiorr..rn.rrtl il principio di individuazionc, si è soffermato analiticamcntc Antoncllo
d'Angelo, spiegando che la distinzione procliana tra unità Numerica e Meno chc Numc-
,io J..*o dii motM fondamentali delb quaestio prima...le due si implicano, ma non
Matteo Scozia
Per Scoto è fondamentale considerare il f*to che la distinzione nonè numerica, ma di genere; ad esempio, l'essere uomo è diverso dall'essere
sedia e ciò è possibile in quanro cè una distinzione Meno che Numerica;se la discinzione fosse esclusivamente Numerica si potrebbe dire che essen-
zialmente ltssere uomo è uguale all'essere pietra e quesd due elemend sidifferenziano solamente dal punto di vista numerico63. Sul rifiuto di que-sta distinzione insiste Antonello dhngelo, il quale - nel suo commento alpasso dell'Ordinatio tnanalisi - sostiene che ..se ogni diversirà reale fossenumerica, allora essendo ogni individuo di pari grado, non si darebbe unadivcrsita numerica...ciò comporterebbe che non si darebbe neanche l'uni-tà minore comune a rutti gli individui: Socrate e Platone non sarebbero
l. . ,divcrsi in quanto individui e idenrici in quanto aventi in comune la narurautnana ma intratterrebbero il medesimo rapporro che cè tra uno di loroc la linca, numericamente diversi e in nulla comunicanti; grazie dunqueall'unita minore gli individui sono molti e non uno solo, sebbene non sia
può csscrci individudità senza l'unità minore, sì che quest'ultima è condizione dell'altra»(Gtov,r.NNr DuNs Scoro, 1/ Principio di Indiuiduazione, a r:.tra di Antonello d'Angelo,Societa Editrice il Mulino, Napoli 201l, p.l3l,r,ota4passim). Questa posizione, pro-seguc d'Angelo, è imprescindibile per la comprensione di ciò che intende Scoto per indi-uiduazione;..un qualcosa, cioè, che caratterizza un solo singolo e non un altro. Affinchèsi diano più individui, ciascuno di per sé'questo', è necessario che in qualche modo inter-venga di nuovo l'unia minore, owero che gli individui abbiano qualcosa in comune alquale non ripugni Ia molteplicid; è dunque...solo in virtu dell'unità minore che può darsiuna molteplicità di individui» (GroveNNr DuNs scoro,.I/ pincipio di Indiuiduazio-zr, a cura di Antonello d'Angelo, Società Editrice il Mulino, Napoli 201l, p. l3Z, nota6passim). Il passaggio che bisognerà afFrontare, e che condurrà anche il mio ragionamentoalla conclusione su ciò che individua per scoro, <<si fonda ancora sulla necessità che si diaI'unià minore aftnchè si dia anche quella numerica e che tale unità minore sia'reale'...enon una 'finzione' delfinrelletto. In caso contrario non si darebbe una molteplicità di in-dividui, dato che l'unità della natura sarebbe di per sé 'questa e mai quella (o ur' altrd)r,(GroveNNr DuNs Scoro, 1/ Principio di Indiuidaaziane, ecaradi Antonello d'Angelo,Società Editrice il Mulino, Napoli 2011, p. 132, noa 8 passim).
63 ..Quia si omnis unitas realis est numeralis, ergo omnis diversitas realis est numera-lis. Sed consequens est falsum, quia omnis diversiras numeralis in quannrm numeralis, est
aequalis, - et ira omnia essenr aeque distincta; et tunc sequitur quod non plus posset inrel-lectus a socrare et Platone abstrahere aliquid commune, quam a socrate er linea, et esset
quodlibet universalc purum fignrenum intellecrus>> (Ord.inatio II, d, j, p, l, q. l, n. 2j).
La non classicità della metodologia filosofica di Giovanni Duns Scoto 66J
l'unita minore stessa la causa del fato che ciascuno è sé stesso e diversodallaltro, dato che essa è soltanto ciò che hanno in comune >t&.
Ancora, f Unità Numerica è propria del mondo empirico6s, ma nonpuò essere designata da sola come strumento validoper l'individuazione.A talproposito, può €ssere utile considerare il duplice senso nel quale puòdarsi I universale: proprio earn?io.In particolare, l'universale - nel senso
ampio - <<è f intenzione' in sé stessa indifferente a ogni determinazio-ne universale o singolare. Tale distinzione...è in eflÈtd fondamentale pcrchiarire come Duns Scoto intenda la 'natura comune che non è di pcr sé
quesra'...essa non è luniversale in atto...bensì qualcosa cili ilniaersalitas
accidit, ed è perciò indifferente sia all'universalita sia alla singolarita, laquale ultima, tuttayia, non le ripugna>r66. Pertanto, <<l'univcrsalc'uomo'(o tavallo') è tale poiché vi è un'altra intenzione (l'umanità o la cavalli-nità) che lo precede e che è perciò una sorta di anum reah Pdrrr (l'unitàminore scoriana), indifferenre all'universalità (e alla singolarità)»67. An-cora, bisogna considerare che è attribuito ad ogni universale spccifico ilcarattere di essere 'uno'e che, olre a quest'unità, si aggiungono ad ognispecifico universale molte dtre proprietà. Per quanto conc€rne questo
uldmo aspetto, dAngelo si sofferma sulla distinzione tra attributi interniall universale e attribud ad esso aggiunti; riferisce il curatore del volumeche: .. se le iltre proprietài sono assimilabili a quella per la quale la caval-
linità è 'una', allora le apparrengono di per sé; se invece sono praeter baruc
(...) accidentes, allora sono esterne e non per sé1168.
Bisogna, dunque, prendere in esame fUnità Meno che Numerica,
che si è visto riguardare le forme (mentre le Numeriche concernono le
« GroveNNr DuNs Scoro, Il Principio di Indiaidtazione, a cura di AntonellodAngelo, Socierà Editrice il Mulino, Napoli 2011, p.134,rca23 passim.
65 <<Avicenna...vult quod tquinitas sit tantum equinitas, - nec est de se una nec
plures, nec universalis nec particularis'. tntelligo: non est tx se una'uniute numerali,
nec plures'pluritare opposita illi unitati: nec'universalis'actu est (eo modo scilicet
quo aliquid est universale ut est obiectum intellectus), nec est'particulariJ de ser, (Or-
dinatio II, d. j, p. 1, q. l, n. jI).66 GroveNNr DuNs Scoro, Il Principio di Indiaiduazione, a. anra di Antonello
dAngelo, Società Editrice il Mulino, Napoli 2011, p. 135, nota 30'passim.6'1 lbid., p. 135, nota 30. In que sta citazione viene evocata l'intenzione seconda; è
bene precisare come, in questo contesto specifico, deve esserc inteso comc il significato,68 GroverqNr DuNs Scoro, Il Principio di Indiuiduazione, a cura di Antonello
dAngelo, Società Editrice il Mulino, Napoli 201l, p. 135, nota 30.
rcaltà cmpirichc, owcro sostanziali). Sc consideriamo - ad esempio - la
proposlzlonc Quato è un tauolo possiamo immediatamente distinguere il
Wtmlnctauoh}tquesto,in quanto ilprimo termine ha uno statuto univer-
mlci infatti, sc I'iniclletto .on.onot..tse universalmente si limiterebbe ad
appcllarc oggcrti individuali6e. È utile, al chiarimento di questo concetto,
làss.rt"arion. di d'Angelo per il quale: <<secondo Duns Scoto, l'universale,
a differenza della natura comune, possieda l'unità numerica ma non l'uni-
tà reale. Si può allora stabilire una sorta digra^datin: l'universale ha lunità
numerica me non quella reale; la natura non ha quella numerica ma ha
quella reale, il singolo le possiede entrambe...il singolo_, infatti, è identico
all'universale mal'universale non è identico al singolo; l'asimmetria è spie-
gabile grazie alla scissione fra esse in re e esse in intelbctu: l'universale è solo
L prài.",o che non rocca per così dire la'realtài di ciò di cui si predica,
neli.nso che il singolo non è tale 'in quanrd di esso si predichi l'universa-
le, sebbene tale predicazione sia del tipo 'questo è questo; d'altra parte ilsingolo non è tale neanche in virtù della natura comune che pure'è irf lui
' e cÉe in un certo senso gli consente di essere il singolonTo. Pertanto, Scoto
rifiuta che <<intellectus agens facit universalitatem in rebus>r7r e, dunque,
che la separabilità sia criterio di disdnzione. lnoltre, viene anche rifiutata
la possibilità che sia la forma ad individuare in quanto:
<<idea non erit substantia Socratis, quia nec natura Socratis, - quia nec ex
se propria, nec appropriata Socrari ut tantum sit in eo, sed etiam est in alio,
secundum ipsum. Si autem subsrancia accipiatur pro substantia prima,
tunc verum est quod quaelibet substanda e$ ex se Propria illi cuius est, et
runc mulro magis sequiutr quod illa idea - quae poniur tubstantia per se
exsistens' - illo modo non posit esse substantia Socratis vel PlatonisrrT2.
666 Mattco Scozia
, 6e <<Quia licet alicui existenti in re non repugnet esse in alia singularitate ab illa
in qua est, non ramen illud vere potest dici de quolibet inferiore, quod'quolibet est
ipsum'; hoc enim solum cst possibile de obiecto eodem numero, actu considerato ab
inrcllcctu, - guod quidem 'ut intcllectum' habet unitatem eriam numeralem obiecti,
sccundum quam ipsum idern est praedicabile de omni singulari, dicendo quod'hoc est
hoc'u (Ordinatio II, d. j,P. l,q. l, n. il.70 GrOvlNNr DuNs SCoro, Il Principio di Indiuiduazione, a C]tte di Antonello
dAngclo, Societa Editricc il Mulino, Napoli 201l, p. 139, nota 40 passim'7t Ordinatio II, d. j, P. l, q. l, n. j872 Ordinatio I[, d. j, P. 1, q. I' n.41
La non classicita della metodologia 6loso6ca di Giorannl Dunr Scoto 667
Perranro, sembra che Scoto abbia creato una fraftura tra metcrlt c
forma, come se quesre due vivessero separammcntc c fosscro numcrrtc dlordini differenti (Unita Numeriche e Meno chc Numcrichc). Tirmrvlr,
anche qui sembra che il nostro ragionamcnto vcnga contraddctto drllostesso Scoto, il quale nello stesso paragrafo cvocato Prcccdcntcmcntc rl'fiuta una separabilità tra materia e forma.
Fermandoci qui, dunque, sembrerebbe esserci un impossibilita a['in'dividuazione, in quanto ad individuare non è né la materia c né la forma.
La soluzione, tuttavia, non tarda ad arrivare è può esscre comPresa
se chiamiamo in causa la teoria scotista dei trascendentali disgiuntiu{!.
Questa teoria rientra nell'insieme più generale della <<metaphysics as the
'scienc€ of the transcendenrals"rrT4. come sosriene §r0lter nel suo lavo-
ro, comprendere la teoria generale dei trascendentali permette di avere
accesso all'idea che ha Scoto della metafisica.
Premesso che non è l'intento di questo articolo studiare la meta-
fisica scotista, può essere utile - tuttavia - riferire come Scoto affronti
il problema della metafisica nelle Quaestiones saper libros Metaphysim'
rirn,4ristoali{5. Nello specifico, nella prima questione - interrogandosi
<<{Jtrum proprium subiectum metaphysicae sit ens in quantum ens vel
Deus et intelligentiae >176 - distingue tra lbpinione di Averroè, per il qua-
le lbggetto della merafisica è Dio come causa prima dell universo e le ln-
telligenze separate come cause seconde, e quella di Avicenna, per il quale
la mimfisica ha come oggetto l'essere in quanto essere - cioè l'esistente in
quanto esistente - e ciò che gli pertiene in quanto tale. Scoto opterà per
la posizione avicenniana, in quanto assicura alla metafisica uno statuto
sciintifico disdnto e peculiare; il Doctor Subtilis, infatti, dirà. chela the'
73 Il principale srudio su questa teoria filosofica scotista è stato compiuto in ma-
niera puntuale eà esauriente nel1946 da Altan\A'olter nel vofume The Transcendentak
and theirfunction in the Metapbysics of Duns Scotus (The Franciscan lnstitute, St. Bo-
naventure, N. Y. 1946).7{ A.B. W'orrpn, Tbe Transcend.entals and their function in tbe Metaphysks of
Duns Scotus (The Franciscan lnstitute' St. Bonaventure' N. Y. 1946, p. XI.75 IoeNNrs DuNs scorr, Quaesti-ones super libros Metaphlsicorum Aristotelis,
edited by R. Andrews, The Franciscan Insdrute, St. Bonaventure, N. Y. 1997.
76 IoeNNrs DuNs Scorr, Quaestiones super libros Metaphysicorarn Aristotelis,
edited by R. Andrews, The Franciscan lnstitute, St. Bonaventure' N. Y. 1997' p. l5'
668 Matteo Scozia
ologiaTT è una scienza particolare rispetto alla metafisica che è la scienza
generale; <<in questo modo la metafisica potrà anche parlare dell'essere
come Dio, ma senza per questo diventare portatrice di praearnbulaf.fuie senza dover essere sottoposra al vaglio della regukf.dei esterna alle sue
competenz€ e al suo ambiro di indagine. Potrà dunque dire su Dio tuttociò che è possibile indicare per via razionale come propri o del prirnurnrer urn o m n i urn p ri n c ip i urn >>7
I .
Il ragionamento sulla me tafisica scotista mi permetre di comprende-rc comc [a teoria dei uascendentali in generale sia lo srrumento specificopcr lo studio dell'essere in quanto essere; infarti, per analizzare lbggettoproprio dclla metafisica, il Doctor Subtilis ricorre a quatrro tipi di tra-sccndcntaliTe:
« l. Bcing (ezr), which Scotus calls the "6rsr of rhe uanscendentals".
2. 'Ihe properties or attributes coextensive with being as such @assio-nes entis simpliciter convertibiles), for instance, uniry, truth, goodness.
3. Thc disjunctive attributes, such as "infinite-or-6nire", "substance-or-
accident'l 'necessary-or-contingent", and so on. These atributes, whichin gencral are the primary differences of real being, are in disjuncdonproper to being and that sense coextensive with real being.4. Finally,
we have all those remaining "pure perfections" which have not been
included in one of the above types. The pure perfections Qterfectionssimpliciter) include being and its coextensive artribures as well as rhe
more perfect member ofeach disjuncdon. As a class, rhey have a special
function in the metaphysics of Scorus. The pure perfections are rran-scendental for the simple reason that they can be predicated ofGod andhence transcend the finite categories. They are ofrwo kinds, a. perfec-
tions predicable of God alone, such as omniporence, omniscience, erc.
' Ricordo come questa viene suddivisa in tbeolo§a in se, cioè la conoscenza che
lbggeno teologico, ossia Dio, è atto a suscitare in un intelletto che sia a esso propor-zionato e theolo§a in nobis (la teologia nosrra) che è la conoscenza relativa di questomedesimo oggetto che il nostro intelletto è idoneo a ricevere (Cfr. G. D'ONorruo,Storia del Pensiero Medieuale, Città Nuova, Roma 2011, p. 584).
78 G. D'Owor ruo, S toria fu I Pensbro Medieaale, CkràNuova, Roma 20 I 1, p- 590-59 l.'e La natura comune a questi quatro tipi di trascendenmli è: <<§Tharever cannot
be conrained under any genus is transcendental>> (A.8. rù7o trnp., Tbe Tianscendentals
and theirfunction in thc Metapbysics of Duns Scotus (The Franciscan Insritute, St. Bon-aventure N.Y. 1946, p. 8).
La non classicità della metodologia filosofica di Giovanni Duns Scoto 669
b. perfections predicable ofGod as well as ofcertain creatures, such as
wisdom, knowledge, free will, etc.>>80.
Riferire sui trascendentali in generale credo sia utile Per comPren-
dere come i trascendentali disgiurttiai siano una parte di una teoria Piùampia e, dunque, in questo articolo mi limito ad evocare ed esporre la
parie della teoria generale sui trascendentali che più si addice alla com-
prensione del discorso specifico sull'individuazione.
Ancora, è importante dire come in generale lo strumento dci tra'
scendentali - ucilizzato, come si è visto, Per Padare razionalmente
dell'essere in quanto essere, oyvero del primurn rerum zmnium princi'piurn - si pone in opposizione allo sffumento utilizzato da Tommaso
dAquino per parlare del medesimo oggetto; mi riferisco all analogia. Pcr
essere piri precisi, bisogna dire che ad opporsi all'analogia tommesiana è
la teoria scotisa dellunivocità, che - ilttaYia - trova il suo fondamcnto
nei trascendentali.Lo scarto tra i due approcci è ben evidenziato da'W'oltersr e credo sia
opportuno riportarne gli elementi PrinciPali.Per quanto concerne lhnalogia tommasiana, che ffova il suo fonda-
mento nelfilluminazionismo agosriniano (per il quale l'intelletto parte-
cipando della sua luce conosce l'essenza di Dio e si adegua alla sua-verità),
biìogna dire che lbggetto diretto ddff intelligere èla quidditas intelligibile
delle cose maceriali conosciuta mediante làstrazione. Lanalogia, secondo
la logica aristotelica, implica la possibilità di predicare di cose distinte uno
stesso nome per ragioni diverse, ma riconducibili a un fine semantico co-
mune. Tommaso aveva fatto ricorso all'analogia per descrivere laperfezio-
ne divina; il meccanismo era quello di parlare in modo analogico rispetto
alle capacità naturali, così da pote r discutere analidcamente della relazione
di Dio con il creato, come causa, come fine e come Promotore e termine
d'arrivo della redenzione Promessa al genere umano.
80 A.B. \X/orrrn, The Tianscendentals and theirfunction in the Metaphysics ofDuns Scotus (The Franciscan lnstitute, St. Bonaventure N.Y. 1946, p. l0-l l.
8' Cfr. A.B. §f'orrrn, The Transcendentak and theirfunction in tbe Metapb\sits
of Duns scotus (The Franciscan Instirute, st. Bonaventure N.Y. 1946, p. 3 l -55. tnoltrc,
sull'analogia tommasiana e sull'univocità scotista: Cfr. G. D'ONon-rUo ,,\torit dil l'tt-siero Medieuale, Città Nuova, Roma 2011, p.479-480;591'592'
670 Mattco Scozia
Scoto rifiuta qucsta posizionc per diversi motivi. Innanziturro,pcrchè riticnc chc un approccio di questo tipo precluda la possibiliàdi coglicrc scicndficamcntc la realtà delle cose individuali e corporeec (endendo allc fondamenta agostiniane dell'analogia) permette all'in-tclligcnza umana di cogliere l'essenza divina solo arrraverso rappresen-tazioni universali e mediate. Inolre, un discorso analogico è possibilesolo se si possiede una conoscenza adeguata e diretra dell'analogato;ma dal momento che ltssere di Dio è superiore a quello delle crearure,queste ultime non possono essere l'analogeto, a costo di introdurre inDio analogiche imperfezioni; dunque I'analogato dowebbe essere Diostesso, del quale non si ha una conoscenza sufficiente in partenza. Anco-ra, l'analogia non consente làrgomentazione sillogistica, perchè implicauna convenienza del termine medio secondo un significato non univoco(dunque, equivoco) che vanificherebbe la corrertezza diogni deduzioneimplicante l'essere di Dio e quello delle creatures2.
Rispetto a questa posizione, Scoto propone la teoria dell'univocitàdell'essere, che ha lbbiettivo di rivendicare per la metafisica la prerogativadi conoscere un oggetto che le è sempre e immediatamenre noro, in ognisuo atto di inrcllezione. Tirmo ciò che è intelligibile e oggefto di inrclle-zioni include in sé la nozione di ente (come i generi e le specie), oppureè virtualmente conr€nuro in essa (come le affezioni). Pertanto, l'essere è
esattamente coestensivo alla ragione: tutto ciò che la ragione conosce è
essere, e la ragione può conoscere tutro ciò che è, dunque lèssere non puòsfuggirle in alcuna sua manifestazione. Questo comporra necessariamenre
il riconoscimcnto che I'essere, oggetro della metafisica, sia univoco. Anco-ra, I'csserc colto univocamente è capace di sosrenere sia l'affermazione chela ncgazionc dcl proprio significato, e qundi è atto a fungere da medio sil-logistico scnza introdurre equivocità nellàrgomentazione. Tale univocità
n È lnrcrcssantc ltscmpio chc propone ìr)?'oltcr quando invita a considerare il sillo-ghmo: «Vhatcvcr is divinc is God; But dre Mosaic law is divine; Therefore the Mosaiclnw is Cod» (A.8. Worrnn,Thc Tianscendental.s and theirfanction in the Metaphysics ofl)uw Sconu (Thc Franciscan lnstirutc, St Bonavenure N X. 1946, p.36). Spiega sempre§?'oltcr conrc <<d-rc syllogism is obviously a fallacy of equivocation, for "divine" is used inen analogous scnsc when applicd to thc Mosaic law. [n the major premise it expresses anintrinsic formal pcrfection; in the minot an extrinsic perfection. For law is divine only byrcason of its source, ùe divine Lawgive » (Ibid.,p.36-37).
la non dessicirà della metodologia filosofica di Giovanni Duns Scoco 671
vale sia in campo fisico che in campo logico, in quanto appardcnc rllhucrcin quanto essere che è prima di ogni determinazionc spccificr.
Da questa ricostruzione della teoria de)l'wiuocità ddlbscru po$lr.mo comprendere la sffetta connessione con la tcoria dci traccndantahlngenerale e, in modo pardcolare, di quclli disgiuntiui,ll sostcncre, inf*ti,l'afiÈrmazione e la negazione dell'esscre è proprio di qucsti triuccndcnta'
lL Tuaavia, è opportuno andare più a fondo Pcr coglicrc la peculiarita diquesto ragionamento e la funzionalità con il discorso sull'individuazione.
Si è visto come i trascendmtali dis§untiui scrvano a Scoto Pcr ren-
dere conto dell'essere in senso coestensivo. Qucsti, cspressi delladno uel,
indicano la possibilità che si dia una cosa oppure l'alra. La disgiunzione
dice che non ci sono trascendentali, ma è I'alternativa presa nel suo com-
plesso che è un trascendentale. Il metodo proprio uùlizzato dai trascen-
dentali disgiuntivi è quello di assumere dodici coppie di contraddittori,che vadano a costituire la mappatura totale degli atribud coestensivi
dell'essere. Prima di esporre queste dodici coppie, ritengo oPPortuno
dire come la disgiunzione presa nel suo complesso è il risultato del ra-
gionamento per il quale <<one being, for example, cannot be prior unless
another is posterior. There cannot be a "before" without an "after" and
vice versar>s3. Queste disgiunzioni complessive, oYvero i trascendentali
disgiuntivisa, sono riferiti alltssere che è univoco e ..form the skelgton
of metaphysics as a natural theology, giving it strucural strength and
uniSing its otherwise disjointed members rr8s.
Per intendere schematicamente come vengono posti questi trascen-
dentali disgiuntivi possiamo assumere,la distinzione tra due schemi:
A)avbB)anbCircaloschemaB diremoche: 1) f ";
Z) f b; 3) f anb.
tr A.B. 'WorrsR, Tbe Transcendentals and theirfuneti.on in tbe Metapbysks ofDuns Scotus (Ihe Franciscan Institute, St. Bonaventure N.Y. 1946' p. 130.
8{ Mi limito a riferie, senza approfondimento - perchè dovrei dilungarmi oltre ilimid consentiti dalle norme cdiroriali e dal filo del discorso -, come §(olcer individua
in Bonaventura da Bagnoregio il precursore della teoria dei trascendentali disgiuntvi
(Cfr. A.B. §7orrun, The Transcendentals and tbeirfunetion in the Metapblsics of Duns
Scotas (TheFranciscan lnstirute, St. Bonavenure N.Y. 1946, p. 132-137).85 A.B. §7orrnn, The Transcendrntak and theirfunction in the Metaphysics of
Duns Scotus (The Franciscan Institute, St. Bonaventure N.Y- 1946' p. 130.
Mattco Scozia
I e 2 costituiscono il senso diuiso, mente 3 costituisce il senso corn-
?0st0. come viene messo in evidenza nel commento di vos ila LectaraI Distinctio xxxu (che ho analoz*o nella prima parte del presentearticolo), Scoro dice che solo il senso composro può essere ,rrrìr"r..rr-dentales6. Inoltre, solo nella disgiunzione si dà il uascendenmle e nonnell'addizione; pertanro, a V b (schema A) è un trascendentale, menrreaAbnonloè.
In entrambi gli schemi siamo di fronte ad una proposizione _ owe-ro: A) Lo stato di cose è'a' uel"biB) Lo stato di.ose è "i et"b,, - chedichiaracamente è composta da due elementi che possono essere a lorovolta proposizioni - owero, assumendo che "a" rti" p., stare seduto e"b" stia per stare alzato, diremo che : A) Lo stato di.ose concernente ilsoggctto X nell'isrante r0 è sta alzato o seduto:B) Lostato di cose concer-ncnre il soggetto X nell'istante t0 è sta alzato e seduto.
Per accerrare lo schema A devo dire che: 1) i" appartiene alra sinms-si del sistema;2) "b appartiene alla sintassi del sistema; 3) V appartiene
" alla sintassi del sistema. La cosa fondamentale, dunque, è che (a v b) siavero-funzionale, cioè sia'a" che "b" siano vero-funzionali e, dunque, iltrascendentale abbia un senso composto, ma non diviso (si capisce che ilproblema è ontologico).
Detto ciò è possibile pre sentare la classificazione scotista dei uascen-dentali disgiuntivi; quesri vengono divisi in: l) correlatiue Disjuruction, esono rre coppie di contraddittori: <<prior-posterior, cause-caused, excee-ding-exceeded. The second ofthese three is subdivided inro effecdng-ef-fecrcd,,fniers-f.niturn>>87 ; z) Disjunctiue Transcendentals contradiclorilyoppwed, individuati nelle seguenti nove coppie: ..acual or potendal,independent or dependenr, necessary or.orrting..rt, substantiar or acci-dental, finire or infinite, absolute or relative, simple or composed, one ormany, rhe same (equal) or different (nor equal) rr88.
86 Cfr. JonN Durvs Scorus, Contingency and Freedorn. Lectura I 39, KluwerAcademic Publishers, Dordrecht 1994, p. I2l-lZ3; l3Z-135.
87 A.B. §(orrs*, The Transeendentals and theirfanxion in the Metaphysics ofDuns Scotus (The Franciscan Insrirure, St. Bonaventure N.y. 1946, p. 140.nt lbid., p. 16l.
La non classicità della metodologia flosofica di Giovaoni Duns Scoro 673
W'olter si sofferma sull'andisi di ognuna delle dodici coppie ; rumavia,per i fini della mia trattazione recupero solo il ragionamenro sulla primacoppiadel secondo gruppo, owero il trascendentale atto-uel-potenza.
Wblter spiega come <<the disjunctive character of potendal and ac-
tual being is expressed by the axiom l.ctus et potentia diaidunt ens et qul-d.cumque erutis genas>>8e. Approfondendo il ragionamento scorista suiconcetti di atto e porenza, mi sembra correrto ribadire - in quanto l'hogià accennato sopra - che la portata di questi due concetti viene accoltadal Doctor Subtilis nell'accezione data da Aristotele. Nello specifico, loStagirita aveya indicato la potenza come la capacità di produrre muta-mento (potenza attiva) o di subirlo (porenza passiva) el'atto, il qualc -poichè attiene all'essere in quanto essere - non può definirsi, ma soltantocogliersi in esempi appropriati, come ltssere svegli rispetto al dormire, ilcostruire rispetto al porerlo fare e il vedere rispemo al semplicc posscdcrcla vista. Ancora, ciò che mi pare opporruno dire è che per lo Stagirita po-trerrza e atto costituiscono uno dei significati dell'essere. Questa dottrinadell'atto e della potenza, ancora, veniva messa in relazione consequen-ziale da Aristotele con la dottrina della materia e della fo rma. La rnateria,infatti, è sosrrato - ricettacolo di forme diverse e in particolare contrarie
- e quindi è in se sressa priva di forma, così da poterle accogliere tutte;pertanto, coincide con la pura potenza. Al contrario, l'atto - che indicaanche la compiutezzadi una cosa e non solo l'attivirà - esprime la mo-dalità propria della forma. Alla luce di questo riferimento, mi sembraevidente ed opportuna l'entrata in gioco del trascendenrale disgiuntivoatto-uel-potenzapr-lr spiegare quale sia il principio di individuazione.
Tirttavia, prima di proporre la soluzione scorista all'individuazione,vorrei insistere su un aspetto che concerne la portata innovativa dellateoria scotista dei rascendentali.
Innanzitutto, spero di essere riuscito a mostrare lèssenza della teoriadei trascendenrali disgiuntivi rispetto allhpproccio tradizionale udlizzatoda Tommaso per quanto conceme il discorso sul Primo principio, ma - pirìin generale - sulle proprietà dell'essere in quanto essere, olrrero dell'esistentein quanto esistente. Tirttavia, mi sembra opporruno insistere sul fatto che
questo oggetto filosofico scotista è rotalmente incompatibile con h logicirclassica. Questa mia sottolineatura non vuole esserc critica nci confì.onti tlcl-
8e lbid., p. 145.
la posizionc di Duns Scoto, ma - d contrario - vuole fornire un ukerioreclcmcnto di confrrma ddl'innovazione del pensiero scotisra nel panoramafilosofico, chc cra fortcmcnte radicato nella tradizione filosofica classica-
Ancora, è possibilc comprendere la portaa di quesa incompatibilità se sipcnsa, in generalq allàpproccio filosofico assunto da fumsuong nel volumeUniuersak. An Einionaad introduction (W'eswiew Press, Boulder 1989).L intento generale del filosofo australiano è quello di wiluppare un Realismoscientifico che proponga una teoria ddi universali compadbile con le istan-ze fondamenrali che animano l'empirismo. uintenro era quello & elaborareun realismo che risultasse accettabile agli empiristi, in modo ale da superarela dicotomia tra lo spirito a posteriori del nominalismo e lo spirito a prioridel realismoe'. << In generale, per Armstrong, le teorie realiste delle proprie-tà hanno un porere esplicativo neftamente superiore a quello delle teorieanti-realiste (ossia nominaliste e particolariste). In altri rermini iprobbruadell'uno sui rnobi,owero il problema del se e del comepirì individui possanopossedere una medesima proprietà, trova una risposta soddisfacenré solo in
r seflso realista. Adorare una prospettiva redista, però, non implica necess:r-riamente lhbbandono delle istanze empiristiche: secondo Armsuongla su-periorità esplicativa del realismo e làusterità dell'empirismo possono conci-liarsi facendo "discendere gli universali sulla rerra"r>er.
ln particolare, si può immediatamente collegare al discorso affron-tato, il quinro capitolo su {Jniuersals as attributes e - ancor piri specifi-camente - il paragrafo secondo su Disjunctiue, Negatiue and Conjunctiueuniuersals. Qui il trascendentale fa da sfondo nell'accezione di proprietàche tume le cose hanno in comune e che, perciò, eccedono o trrrì.rrdorrola diversità dei generi in cui le cose si distribuiscono. Ora, Armstrongsostiene aperramenre il rifiuto di un approccio disgiuntivo alle proprie-tà delle cose, in quanro afferma che <<I will being by giving reaions forrejecting disjunctive properry universals. By a disjunctive property Imeen a disjunction of (property) universalsr>e2. In particolare, sono duele argomentazioni a sosregno di questo ri6uto; turravia, credo che un
674 Mattco Scozia
e0 Cfr. D.M. AnrrlstnoNc, Tbwards a Theory of Properties: Work in progress onthc Problcm of{Jniuersals, in Philosophy 50 (t975), p. l4g.
er F. Cerpur, Dauid Malet Armstrong, in APhEx. portale ltaliano di Fitojofulnalitica s (z}tz), p. 3.
» D.M. ARusrnoNc, [Jniuersab. .4n opinionated introduction,§(cstvicw press,
Boulder 1989, p. S2.
la non classicita della metodologia filosoficr di Giovrnnl Dunr Scoto
ragionamento sulla portara argomentativa dcllc duc posizionc - rnzlchéla riproposizione parafrasata delle sressc - pcrmctccrà mlggiormcntc dlcogliere l'incompatibilirà con I approccio scotista.
Uno dei punti su cui Armstrong insistc con maggior tcnecir è I'lzc.ludibilità degli aniuersali. Come riferiscc Franccsco Crlcml, «p€r Arm.strong I Norninalisrno dei Predhati e I Concctnalismo costitviscono ilgruppo delle soluzioni "soggettivistc" al problcma dcgli univcrsali poi-ché le analisi proposte dai rispettivi sostenitori dipcndono crucialmcn-te dall'esistenza del linguaggio umano, o dall'csistcnza di menti umane.
Ma proprio per via di questo gli schemi di riduzione correlati a gueste
posizioni risultano insoddisfacenti>>e3. Da ciò ne consegue che per Arm-srrong, il soddisfare un cerro predicato non implica il possesso di una
proprietà corrispondente, in quanto vi sono proprieta fisiche ancora
ignote per le quali non disponiamo di alcun predicato o concetto. Vo-lendo offrire un'esemplificazione più rigorosa - in virtrì del f*to che è
sostenuta da Armsffong - possiamo considerare l'esempio per il quale :
..Let us assume that particular electric charges and particular masses are
universals. The havingcharge C or having mass M (with C and M dum-
mies for determinate, that is, definite values) would be an example of adisjunctive property. W'hy is it not a universah Consider two objects.
One has charge C but lacks mass M. The other lacks char§e C but has
mass M. So they have the disjunctive property having charge C or ha-
ving mass M. But surely that does not show that, in any serious sense,
rhey thereby have something identical? The whole point of a universal,
however, is rhat it should be identical in irs different instances>rea.
Si può ulteriormente esplicitare il ragionamento assumendo un altraesemplificazione : << questa mela., a, ad esempio, benché soddisfi il pre-
dicato disgiuntivo "è una mela o è una radice quadrata o è un trireme"(o cada sotto il corrispettivo concetto) non possiede una corrisponden-
e3 F. Canur, Daoid Malet Armstrong, in ,4PhEx. Portale ltaliano di Filosofw
An a litica 5 (20 12), p. 3.e{ D-M. AnIrrsrnor.Ic, (Jniuersab.,4n opininnated introduction, W'eswiew Prcss,
Boulder 1989, p.82.
676 Matteo Scuia
te proprietà poiché - e questa è una delle più profonde convinzioni diArmsrong - non esistono proprietà disgiuntiue>>e5.
Fatta questa precisazione possiamo andare ad analizzareil riscontrodell'intervento dei trascendentali disgiuntiui scotisti nel passo dell'Ordi-natio che riferisce come ad individuare non è solamente la materia o laforma (possibilità scartate in precedenza) - olrvero lamo o la potenzaassunto nel senso diviso - ma sarà l'alternatiya presa nel suo complesso,oyvero il trascendentale disgiuntivo diatto-uel-potenza - assunte, comesi è demo, nel senso composto - ad individuare:
<<Et si quaeras a me quae est isra'entitas individualis'a qua sumitur diÉferenda individualis, estne materia vel forma vel compositum, - respon-deo...Non est igirur'ista entitas' mareria vel forma vel composirum, inquanrum quodlibet isrorum est 'natura' - sed esr ulrima realias entisquod est materia vel quod est forma vel quod est composirum rre6.
e5 F. Cerrur, Daaid Maht ,lnnstrong in,4PhEx. Portale ltaliano di Fihsofa,:lnalitira 5 (2012), p. 4.
e6 Ordinatìo II, d. j, p. l, 4. 6, nn. 187-188 passim. Credo di aver mostrato la por-tata dei trascendentali disgiuntivi e come questi siano operanti - specie quello a*o-uel-potenza - nell'indiyfdt :zi6ns. Qome ogni r4gionamento, anche quello assunto in quesroardcolo ha una modalià dimostrativa specifica; peftento ho sviluppato un discorso inbase a come ho ritenuto opporruno argomenrare sulla questione. Tircavia, mi pare op-portuno rendere conto del commento di Antonello d'Angelo alla soluzione finale scotisapresentata in formula disgiuntiva. Il curarore del volume, proponendosi & voler andareolue l'interpetazione offera da Shibuya {Duns Seotas on 'uhima realitas formae', inM.Cenaeyo NÉÉaz (a cura d1), Giouanni Duns Smto,vol.l, Antonianum, Roma 2008, p.379-394) spiega come: <<Duns Scoto...ha affermato che I'unirà maggiore (quella indivi-duale), da rurd ammessa, consegue a un'entità per sé che è diaersa daquella della narura;tale affermazione è evidente, è in sintonia con quella zu citata, secondo la quale I'entitassingularis è addita. osservavo a tale proposito che (...) lo aliquid positiuum giustifica' siail fatto che la realitas indiaidui non è wnforrna addita, sia utche che è rientitas addita,ossia che è alra rispeao all'€ntitas dellenattrra. Duns scoto di conseguenza afferma che,sempre in virtù dello ali4uid positiaurn,le due unità cosrituiscono l'uno per sé, cosicchél'individuo stesso 'est per se unum, non per unitatem alterius generis"; tale a{fermazionedovrebbe escluderg coerenremenre, ogni composizione accidentale (olue che fra res eres), owero dowebbe anche escludere che il principio individuanre sia estraneo alla co-ordinazione dell'essenza...ln quesro senso, dunque, il principio individuante non è una
forrna aldita né è una parte delltssenza, così come è invece la differenza specifica rispet-to al genere. Senonché, essere parre dell'essenza significa, come è owio, essere compresonellèssenza, laddove non essere parre dell'essenza significa, come è altretento owio, esse-
La non classicità della metodologia Eloso6ca di Giovanni Duns Scoto 677
Conclusione
Mi pare, dunque, di aver reso conto - per quanto sia possibile nella
brevità che c aratterizzaanarticolo e, in modo particolare, quello presen-
te che si è posto un obiettivo ben preciso - della differenza di fondo che
intercorre tra un approccio di tipo classico ed uno di tipo non-classico.
Altresì, ho cercato di mostrare come un tale approccio non-aristoteli-
co sia presente in Scoto e non in maniera sporadica e superficiale, bensì in
re estraneo all'essenza stessa; se nel primo caso si dà un identità essenziale fra le parti, nel
secondo no; è necessario pertanto che I ubima realitasformae, sebbene non sia wafornaaddita,siatwavieuri entitas addita, akrimenti lanatura comune sarebbe di per sé'questa-
È evidente però che in un ceno senso è cosl..giacché è impensabile che findividuo non sia
compreso softo la natura comune e che essa stessa non gli 'appartenga'; come si è infaui
osservato a proposito dellaquaestio prirna, se non si dà l'unità minore non si dà nean-
che quella maggiore sicché è la narura stessa che in un certo senso consente il costituirsi
deffindividuelità e che consente a sé stessa di diventare 'quesal Tale è luhina realitas
-fo**, una realitas, cioè, che non esprime ttna res alia rispetto alla forma. Se tuttavia
fosse solo così, si ribadisca, la natura sarebbe di per sé 'questa, cosa impossibile rranne che
per quel che conceme Dio. LindMduo risulta perciò da qualcosa che contrae la natura,
ovvero datì entitas addita (...).Dnns Scoto afferma perciò...che l'entitàindi.viduale, alia
rispemo all'entità quidditativa, 'non Potest constituere totum (cuius est pars) in esse qui-
ditativo, sed in esse alterius rationis". In somma, seguendo ancora il paragon9 'razionale'
è divisibile in pirì'razionali'di numero e vale dunque per molti, laddove 'Socrate'vale
solo per sé sresso; tale è l' 'eccedenzi dellentitas indiùidualis e i suo esse aberius rationis.
Tirttavia ale statuto ontologico dell entitas indiuidualis non fa che ribadire il contrasto
e in un certo senso la contraddizione che si pone fralubima realitasformae, che non è
ddditd, e f entitas, che è necessariamenre addita...In altri termini, findividuo, rispetto alla
natura comune, è e insieme non è un use alterius generis; esendolo, è dentro la natura e
ne è una parte essenziale; non essendolo, ne è fuori ed è perciò un accidenten (GrovlN-
Nr DuNs Scoro, Il Principio di Inditiduazione, a cura di Antonello d'Angelo, Società
EdiuiceilMulino,Napoli20ll,p. 189-l9l,nota224passim). Ilporreinquestitermini
la questione, secondo d'Angelo, perme$e di comprendere linearmente Iindividuazione
scotista fondata dealiquid positiuum.Se,sempre per il curatore, questo positivo' non ha
altro fondamento se non sè stesso, non è del tuao arbitrario sostenere che è indicato dalla
disgiunzione che esclude solo la materia o solo la forma, Pet essumere il trascendentale
materia-uel-forma che è poi, come lo stesso Scoto riferisce (e d'Angelo coglie nel com-
menro, dandomi una conferma della mia posizi one), qrtelTl- ultinta realitas clte permetre
d'individuare (Cft. GroveNNI DuNs Scoro, Il Principio di Indiuiduazione, a cara di
Anronello d'Aagelo, Società Edirrice il Mulino, Napoli 2011, p. 196-197 'rcta234).
678 Matteo Scozia
modo sistematico. Una tale sistematicità viene, infatti, testimoniaa dagli
smdi storiografici diVos (prima) e di Knuuttila, Cross e Parisoli (poi).
lnolre, ho cercato di dare un breve riferimento applicativo di que-
sto metodo, mostrando - in modo volutamente essenziale, in quanto ilriferimento aveire caraftere esemplificadvo e non era, dunque, lbggetto
specifico della mia analisi - come sia oPerante nella trattazi one del Prin-
cip io di Indiu iduazi o n e.
Non mi aspetto, tuttavia, che un tale approccio Yenga accettato e
condiviso dalla totalità del pubblico di storici della filosoÉa; mi aspetto,
però, che nel rispetto della validità delle argomentazioni razionali (un
ragionamento è valido in virtu delle argomentazioni e non di chi lo pro-
nuncia), si riconosca l'introduzione - non per merito mio si intende -nel panorama filosofico, di una prospettiva che (per dirla parafrasando le
parole di Luca Parisoli, al quale devo il mio ingresso, la mia permanenza
i la mia crescita nell'universo stotista) difende la possibilità razionale di
una logica paraconsistente, allinterno del panorama culturale dominan-
te che ne nega la stessa possibilità'. In particolare, auspico il confronto
e l'apertura a nuove vie della razionalità, che permettano - a livello cul-
turale - la possibilità di approdare razionalmente a "lidi" piìr favorevoli
alle inclinazioni filosofiche di ciascuno, che dovranno essere sempre ilrisultato di una persuasione razionalmente fondata.
M.rmno Scozrl
s? Ck.L.P"p,asort, La contraddizione aera. Giouanni Duns Scon tra k necessrtà della
mctafuirae il discorso d.ellaflosofapratùaktiattoStorico dei Cappuccini, Roma 2005, p.8-
lntonianum L)(XXIX (2014) 679'699
A PHILOSOPHICAL ARGUMENTFOR THE CREATEDNESS OF THE VORLD
Sarnrnary: This paper presents a bitberto little-known argummtfor the existence of God
whkh goes back-ti tbe Germanfundarnmtal-tbeologian Peter Knater SJ Tbe central
dal.rn if b;s argurnent is tbat some uniaersal as well as fundarnental fa*s could not be
describid consistently {the world were not conceptualized as bntirely related to .../entirely
dlferentforn...L The paper depicts tbe basic stucture of the argurnent and points out sorne
ofits adaantages ouer well-hnown argaments in natural theologit.
Sonrnario: Que*o stadio ?resenta lbrgomentazione, f.nora poco conoseiuta, con la
quale in aologofondamentale tedesco Peter Knauer SJ intende sostenere razionalrncnte
ibrirt nro di bio. Lasserzione centrale del suo ra§onamento consiste nellhferrnare che
alcunifatti uniaersali efondarnentali non potrebbero essere destitti coereiltemente se ilmodo nonfosx cowettualizzato eome "interamente relazionato a.../interamente d.iaerso
da...I LlaiAcoto delinea k strattura basilare dellhrgomentazione e ne euidznzia alcune
oi§nalità rispetto ai bm noti argontenti proposti dalla teologia naturale.
l. Introduction
According to the reaching of the Church there are certain PresuP-positions of faith-traditionally called 'praeambula fidei'-which att-,
^tieast in principle, discoverable through human reason'1 One such pre-
supposition is the possibilityofapurely rational knowledge of God, also
kro*n as'natural theologyl Although the Magisterium of the Church
has never committed itself co a specific form of natural theology, it still
retains the presumption of its possibility and necessiry. Natural theol-
ogy is relevant both to the proclamation of faith as well as for its justifi-
cation. Since, if the Christian message is to be understood as the §(ord
of God, the proclaimers and witnesses of this message should be able to
' Cf. e.g. I VerrceN CouNcrr, DH 3004.