Cantanti d’opera a Napoli nell’età di Donizetti attraverso le fonti archivistiche: 1820-1840.
La memorialistica della Resistenza attraverso gli scritti di Giovanni Pesce
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of La memorialistica della Resistenza attraverso gli scritti di Giovanni Pesce
1
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
FACOLTÀ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
Corso di Laurea in
Lingue e Letterature Straniere
DISSERTAZIONE FINALE
La memorialistica della Resistenza
attraverso gli scritti di Giovanni Pesce
Relatore
Prof. Claudio Sensi
Candidato
Valentine Braconcini
matr. n. 238940
Anno Accademico 2007-2008
2
INDICE
INTRODUZIONE
3
1. LA MEMORIALISTICA COME GENERE LETTERARIO 6
1.1 Definizione 6
1.2 Il problema delle fonti 8
1.3 Tra racconto e silenzio: la memorialistica della
deportazione
11
2. STORIOGRAFIA, MEMORIA E CRITICA LETTERARIA
DELLA RESISTENZA
17
2.1 1946-2008: Le fasi della produzione resistenziale 17
2.2 Il “peso” della politica
24
3. DALLA RESISTENZA IN PIEMONTE AI GAP: APPUNTI
DI STORIA
3
3.1 I caratteri della Resistenza in Piemonte 27
3.2 Torino 29
3.3 I Gruppi d’azione patriottica (GAP) 35
3.4 Biografia di Giovanni Pesce
38
4. SENZA TREGUA: TRA STORIA, MEMORIA E
LETTERATURA
42
4.1 Due guerre, stesso nemico 42
4.2 Io narrante/io testimone 46
4.3 La morte di Dante Di Nanni
48
5. CONCLUSIONI
52
6. BIBLIOGRAFIA 54
3
INTRODUZIONE
Oggetto di questo lavoro è un’analisi e una riflessione degli aspetti
caratteristici del genere letterario definito “memorialistica”. In particolare
un’osservazione delle tappe e delle letture che a partire dagli anni ‘40 fino
ad oggi hanno caratterizzato la produzione riferita alla tematica
resistenziale.
Partendo da una più ampia analisi storico-letteraria mirata a individuare le
peculiarità di tale genere, successivamente ci si soffermerà a trattare uno
degli aspetti fondamentali che hanno caratterizzato la memorialistica che si
rifà alla seconda guerra mondiale, in altre parole il tema concentrazionario,
per anni accantonato e poi riscoperto con forza sia dagli storici che dai
curatori di memorie. Un ambito sicuramente difficile da delineare e che
presenta non poche questioni aperte sulle modalità di approccio e studio.
Si passerà poi all’altro grande corpus della memorialistica che costituisce
peraltro il nucleo di questo lavoro, la memorialistica della Resistenza,
fornendo poi un tentativo di analisi più specifica attraverso il principale
libro di memorie scritto dal gappista Giovanni Pesce, Senza tregua. Un
testo in grado di fornirci da un lato un esempio tangibile di memoria
resistenziale, inserita per altro in una cornice letteraria, e dall’altro lato
capace di costituire una sorta di “anomalia”, trattandosi di una
testimonianza per lo più non supportata da fonti storiografiche che possano
aiutarci ad avere un quadro più storico che epico della peculiare attività
svolta da questi “partigiani metropolitani”. Nello specifico le analisi più
accurate sono rivolte ai mesi della lotta in Piemonte e più in particolare a
Torino.
Questo lavoro vuole inoltre essere un modesto contributo a quanto
prodotto negli anni dal seminario su Il valore letterario e culturale della
memorialistica della deportazione, giunto nel 2008 al suo VII ciclo;
4
seminario che ha fornito i principali stimoli di avvio a questo tipo di
riflessione. Organizzato dalla Fondazione Istituto Piemontese “Antonio
Gramsci” e dagli italianisti delle Facoltà torinesi di Lingue e di Lettere,
sotto l’egida del Consiglio regionale del Piemonte – Comitato per
l’affermazione dei valori della Resistenza – e dell’Aned, il Seminario sulla
memorialistica della deportazione venne ideato e proposto nel 2002 dal
professor Marziano Guglielminetti.
L’intento era quello di
riflettere sulle specificità della scrittura che fissa quella particolare memoria,
che accoglie in sé l’offesa, lo sradicamento, la prevaricazione, la violenza e il
dolore inutili; col desiderio di comprendere, con delicatezza e lucidità, come la
penna abbia potuto tradurre esperienze d’intensità estrema.1
Inevitabili le riflessioni sulle peculiarità della memoria:
«Dobbiamo guardare – diceva Guglielminetti – alla testimonianza quale si
forma, quale è, nella sua origine immediata, come si deposita, che sforzo
comporta: con particolare attenzione ai meccanismi della memoria, della
memoria interrotta, o inceppata, o aperti su nuove dimensioni del tempo e dello
spazio».2
Premesse che hanno dato avvio a un intenso seminario che negli anni ha
tentato di affrontare i molteplici aspetti della letteratura concentrazionaria,
problematizzando l’uso della fonte orale come fonte storica, avviando un
percorso di riflessione sulla trasmissione della memoria, e dando voce ad
eccezionali testimoni che hanno tentato di raccontare quell’“esperienza
indicibile”, consci dell’importanza della loro parola e del loro ruolo nel non
permettere l’oblio di quell’evento tragico, inserito a pieno titolo nella
modernità, e pertanto non accantonabile dalle nostre coscienze.
1 C. Sensi, Presentazione del seminario, in Scrivere la memoria del lager: un confronto
internazionale, a cura di F.Uliana, Torino, Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci 2008,
p. 4. 2 Ibidem.
5
La scelta specifica del seminario non poteva per ovvie ragioni includere
l’altro grande filone della memorialistica, quello resistenziale. La
Resistenza costituisce l’aspetto della seconda guerra mondiale su cui per
anni la storiografia dominante è rimasta appiattita, il che, insieme ad altre
concause che verranno in seguito analizzate, non ha lasciato molto spazio
ad altre esperienze, tra cui la Shoah e le deportazioni nei campi di
concentramento.3
Il tema resistenziale costituisce una sorta di tappa obbligata per tutti gli
scrittori “maggiori” del secondo dopoguerra. Secondo disparate modalità si
sono confrontati con esso Italo Calvino, Beppe Fenoglio, Elio Vittorini,
Carlo Levi, Cesare Pavese e numerosi altri grandi autori.4 Tuttavia si
desidera qui far emergere due “generi” specifici che hanno dato un
contributo fondamentale alla costruzione di una memoria “letteraria”, colta
e popolare, della Resistenza, in altre parole la “letteratura
concentrazionaria” e la “letteratura resistenziale”.
Lungi dal tentare un raffronto o accostamento tra i due filoni di
testimonianze, questo lavoro mira a trattare gli aspetti più problematici e
caratteristici della letteratura resistenziale, quali l’uso politico della
memoria e della storia, il “giudizio storico”, l’uso della cornice romanzesca,
la stratificazione della memoria e l’aspetto didattico.
3 C. Spartaco, Aspetti e peculiarità del sistema concentrazionario fascista. Una ricognizione tra
storia e memoria, in Lager, Totalitarismo, Modernità, a cura dell’Istituto Ligure per la storia della
Resistenza e dell’età contemporanea, Milano, Bruno Mondadori 2002, p. 234. 4 Cfr. G. Falaschi, La resistenza armata nella narrativa italiana, Torino, Einaudi 1976;
www.novecentoitaliano.it
6
Capitolo 1
LA MEMORIALISTICA COME GENERE LETTERARIO
1.1 Definizione
Il termine memorialistica impone, anzitutto, una riflessione terminologica.
La parola memoriale, la “scrittura di memoria” per molto tempo nella
tradizione italiana del secondo dopoguerra è stata posta ai margini, come
scrittura di seconda qualità o sottoletteratura. Per molto tempo la
memorialistica è stata considerata come qualcosa che non poteva accedere
alla repubblica delle lettere. Anche nella manualistica scolastica, persino Se
questo è un uomo per molti anni è stato rubricato nella memorialistica, così
come Uomini e no di Vittorini.5
È con queste parole che Alberto Cavaglion6 apre la sua riflessione sulla
memorialistica, in un intervento che pone principalmente l’accento sulle
testimonianze riferite alla deportazione, le cui considerazioni possono però
ritenersi pertinenti per quanto riguarda l’intero blocco di memorie che si
rifanno in qualche modo all’esperienza della seconda guerra mondiale.
Egli individua come «atto iniziale della memorialistica scritta» gli scambi
di corrispondenze private, che precedono la memoria scritta pubblicata in
monografie o in articoli di riviste. Sono lettere scritte anche prima del
ritorno in patria dagli ex prigionieri i quali sono mossi dalla volontà di
cercare i loro compagni e cercare un confronto tra le proprie esperienze.
Cavaglion cita come esempio emblematico di primi esercizi di memoria e
scrittura i ricordi che Leonardo Debenedetti e Primo Levi affidarono ad un
memoriale (termine da cui deriva il conseguente memorialistica) per le
5 A. Cavaglion, Per una memorialistica mal nota, in Scrivere la memoria del lager: un confronto
internazionale, cit., pp. 13-16. 6 Alberto Cavaglion, storico e scrittore, lavora presso l’Istituto Piemontese per la storia della
Resistenza e della società contemporanea. Tra le sue pubblicazioni: Per via invisibile (Bologna
1998), Ebrei senza saperlo (Napoli 2002), La Resistenza spiegata a mia figlia (Milano 2005) ed
Notizie su Argon. Gli antenati di Primo Levi da Francesco Petrarca a Cesare Lombroso (Napoli
2006).
7
autorità sovietiche, le quali avevano richiesto un rapporto igienico-sanitario
sulle condizioni di Auschwitz. I primi testi che appaiono sono quasi sempre
pubblicati a spese dell’autore e da piccolissimi editori. Sono testi che
presentano caratteristiche molto differenti rispetto a quelli che verranno
pubblicati in seguito, fino all’oggi, in quella che viene definita “era del
testimone”.7 Le peculiarità risiedono in una scrittura piuttosto scarna, netta,
priva di artifici letterari, e nell’individuare come destinatario un compagno
di prigionia o una ristretta cerchia di amici. Un valido esempio è costituito
da Se questo è un uomo di Primo Levi, pubblicato per la prima volta nel ‘47
e in seguito nel ‘58, quando verranno aggiunti nuovi passi e assumerà uno
stile più “letterario”. L’importanza della figura di Levi si può intravedere
anche nel fatto che la sua morte costituisce un vero e proprio spartiacque
nella memorialistica in Italia. Al suo decesso infatti segue una fase in cui il
numero delle testimonianze subisce un incremento molto forte, che va di
pari passo con una trasformazione sul piano stilistico e un avvio della
testimonianza televisiva, teatrale, scolastica.
Levi resta sicuramente il più conosciuto “cronista” della tragedia dei lager.
Egli torna sulla sua esperienza di prigioniero ebreo ad Auschwitz in diversi
libri. Il già citato Se questo è un uomo è forse il principale punto di
riferimento per tutta la letteratura dei reduci. La cronaca, estremamente
lucida, ripropone l’intero soggiorno di Levi nel campo di concentramento,
insistendo sui singoli dettagli che impedirono la sua completa
disumanizzazione, e sottolineando nel contempo la casualità cui l’autore
deve la propria salvezza. A Se questo è un uomo si riallaccia il racconto
successivo, La tregua, che narra singolare viaggio di ritorno che il
protagonista dovette affrontare dopo la liberazione dal campo. Merita di
essere ricordato, anche se uscito molto più tardi, nel 1986, il volume in
forma quasi saggistica I sommersi e i salvati, un tentativo di analisi
7 A. Wieviorka, L’era del testimone, tr. it., Milano, Cortina 1999.
8
approfondita e distaccata dell’universo dei campi di concentramento, che
non cancella però i tratti autobiografici della propria esperienza.
Con estrema pertinenza, Cavaglion cita anche la questione messa in
evidenza da Pier Vincenzo Mengaldo,8 che risiede nel domandarsi dove
passi il confine tra la memorialistica pura e la letteratura. Per anni,
soprattutto in Italia, la memorialistica è stata vista come letteratura “di serie
B”, ma Mengaldo ha saputo dimostrare come ogni scrittura sulla
deportazione non sia distinguibile da una fonte in qualche modo letteraria.
Analizzando ogni forma di scrittura ha concluso che la letteratura
costituisce comunque un passaggio decisivo. I classici cui fanno riferimento
tutti gli ex-prigionieri sono un riferimento ben preciso nell’ambito di tutta la
letteratura italiana.
In questi anni il problema va ponendosi sempre più con forza, in quanto
con la sparizione dei testimoni diretti, saranno la letteratura e i nuovi
scrittori a costituire alcuni tra i principali veicoli di preservazione della
memoria; un passaggio inevitabile a cui abbiamo assistito durante tutto il
corso della storia.
1.2 Il problema delle fonti
Altra questione fondamentale è quella di «come interpretare la
memorialistica. 9 Le fonti cui lo storiografo può attingere sono numerose e
8 P. V. Mengaldo, La vendetta è il racconto. Testimonianze e riflessioni sulla Shoah, Torino,
Bollati Boringhieri 2007. 9 Cfr. Per non dimenticare. Bibliografia ragionata dell’internamento e deportazione dei militari
italiani nel Terzo Reich, Introduzione di G. Rochat, INSMLI-ANEI-GUIS.Co 1997, vol. I.
Interessante è la catalogazione delle fonti, sia scritte che orali, anche sul metro della maggiore o
minore affidabilità che possono avere per gli storiografi. Il discorso è riferito alla memorialistica
degli internati e dei deportati militari, ma risulta valido, con le dovute differenze, anche se
applicato alle altre categorie di deportati. Importante pure tutto il lavoro sulle cifre, che dimostra
come questo aspetto della deportazione sia stato e sia tutt’oggi considerato marginale e poco
indagato. A questo si aggiunge il particolare status dei testimoni, soprattutto gli internati, la
maggior parte dei quali (otto o nove su dieci) «hanno rimossa la memoria di un “internamento
9
diversificate, ma difficili da interrogare. Essi fanno affidamento prioritario
alle fonti scritte, cosiddette “d’archivio” o “ufficiali”, ma le fonti sia
tedesche che italiane sulla deportazione e l’internamento «sono scarse,
frammentarie e sovente enigmatiche»; inoltre ci rivelano principalmente gli
aspetti gestionali dei Lager (anche questi spesso volutamente falsati),
tralasciando totalmente gli aspetti riguardanti la “società del lager” e
l’uomo in quanto essere privato di ogni sua libertà.
Molto più numerose sono le fonti orali a cui gli storiografi guardano
spesso con una certa diffidenza. I diari coevi, scritti nei Lager anche sotto
forma di brevi appunti e rielaborati a “memoria viva”, subito dopo la
liberazione o nei primi anni seguenti, e le “relazioni” in particolare di
fiduciari, medici e cappellani, vengono considerate insieme tra le “fonti
scritte” valide per le ricostruzioni storiografiche.
Ciò che spingeva prigionieri e internati a scrivere era principalmente la
consapevolezza di trovarsi a vivere e subire eventi di portata storica e di alta
drammaticità. La volontà era quella di lasciare un segno di quanto stava
accadendo, per poter tentare di raccontare la disumana esperienza, nel
remoto caso in cui si fosse riusciti a sopravvivere, con l’intima speranza che
quanto vissuto e poi testimoniato non potesse più ripetersi.
Nei Lager era proibito scrivere ed era altresì difficilissimo recuperare
matite o fogli. Ciò che si è riuscito a salvare risiede principalmente in
appunti per lo più sintetici, telegrafici, enigmatici, omettenti nomi e fatti
che potevano essere compromettenti. Necessitano pertanto di essere
rielaborati da parte degli autori o dei loro compagni, il che costituisce un
rischio di inquinamento. Il testimone diretto rimane un fondamentale
collaboratore dello storico.
Le fonti orali sono costituite dalla memorialistica tardiva rielaborata e
dalle interviste e testimonianze antologiche “brevi” che per valide ragioni
volontario” incompreso, considerato inutile e che “non fa notizia”. E il reduce su dieci che
“ricorda” non vuole pensarci troppo!»
10
vengono guardate con diffidenza dagli storiografi. In questi casi sono
necessari i riscontri incrociati ma, in mancanza di altre fonti, diventano
essenziali, in quanto uniche e chiarificatrici.
Le memorie quindi rappresentano gran parte delle fonti che gli storici
hanno a disposizione, ma bisogna maneggiarle con grande accuratezza:
Sono anche convinto –dice Contini – che le fonti di memoria vadano affrontate
con una strumentazione metodologica adeguata alla loro complessità, alla loro
tendenza, per fare solo alcuni esempi, a condensare più fatti in uno, a spostare
o cambiare i soggetti degli aneddoti, a invertire l’andamento cronologico reale
della narrazione.10
Brunello Mantelli individua due rischi principali sull’uso della
memorialistica come fonte storica:11 da un lato il credere che la memoria sia
strettamente attinente alla realtà dei fatti, e ciò non può essere possibile in
quanto la memoria è sempre ricostruzione; dall’altro lato l’idea che anche il
documento scritto rappresenti la verità, mentre anch’esso è prodotto in un
ambiente preciso, in una determinata circostanza. Altro errore da non
commettere è di scartare a priori il documento che appare “falso”. Le stesse
omissioni, gli errori o la ricostruzione “inventata” di situazioni o eventi non
possono darci informazioni su quanto avveniva all’epoca, ma sono processi
che ci dicono molto sul modo di pensare e sul contesto sociale dei quali
quel documento è un prodotto.12
Pertanto mi pare opportuna la prospettiva dalla quale si pone Luisa
Passerini la quale dice:
[La memoria] la assumiamo come l’atto narrante di un individuo in un contesto
sociale, nel tentativo di conferire significati condivisibili a certi eventi o aspetti del
mondo ed eventualmente di metterne in secondo piano altri. L’atto narrante è sempre
nello stesso tempo memoria autobiografica, trasmissione di un’esperienza di vita, e
10 G.Contini, Memorie di guerra e di guerra civile, in Memoria/Memorie, Centro Studi Ettore
Luccini, 2006, 1, pp. 27-49. 11B. Mantelli, Prospettive storiche, in Il valore letterario e culturale della memorialistica della
deportazione, III ciclo, a cura di F. Uliana, Torino, Fondazione Istituto Piemontese Antonio
Gramsci 2004, pp. 106-109. 12 B. Wilkomirski, Frantumi, trad. it. di U. Gandini e L. Fontana, Milano, Mondadori 1996.
11
tradizione, cioè riformulazione e innovazione di qualcosa – se non altro il linguaggio –
che si è ricevuto da generazioni precedenti e che si vuol passare a generazioni future.13
Sempre la Passerini, a proposito dei silenzi che ricorrono nelle interviste,
ha evidenziato come, proprio attraverso un inventario dei silenzi, si possano
anche interpretare le fonti orali e ha invitato ad una maggiore
storicizzazione dei silenzi stessi. Per esempio, ha notato come «la storia di
vita fa spesso un salto dal periodo dell’avvento del fascismo fino alla sua
caduta [...]. Avevo inoltre notato che il ricordo del periodo fascista
sembrava comprendere soprattutto aspetti [...] legati alla quotidianità».14
Premesse queste necessarie per chiunque voglia tentare un approccio
corretto e non superficiale ad una tematica tanto complessa e delicata.
1.3 Tra racconto e silenzio: la memorialistica della deportazione
Quella dei campi di concentramento è da tutti considerata l’esperienza-
limite della Resistenza europea, nella quale le conquiste della modernità e
la scelta del terrore come arma politica, vengono utilizzate al fine di
distruggere l’uomo in quanto uomo. Uno dei caratteri che maggiormente
ricorre nei documenti di chi è sopravvissuto a questa esperienza è
l’agghiacciante testimonianza sul sistema di annientamento della
personalità umana. Da qui l’urgenza di dover raccontare ciò che l’uomo
stesso è stato in grado di fare all’uomo e in questa condizione di
“sottoumanità”. Lo scrivere costituisce un atto di riappropriazione dell’io,
della propria personalità. Primo Levi, nella prefazione da lui curata ne La
13 L. Passerini, Sette punti sulla memoria per l’interpretazione delle fonti orali, in Italia
Contemporanea, n. 143, 1981, pp.83-92. 14 Ibidem.
12
vita offesa15 rileva che tendenzialmente il bisogno di raccontare risale al
tempo stesso della prigionia e come esso sia talvolta quasi un voto, una
promessa che il credente fa a Dio ed il laico a se stesso. Raccontare è
necessario anche affinché la propria vita non sia priva di scopo.
E Levi aggiunge:
Per il reduce, raccontare è impresa importante e complessa. È percepita ad un
tempo come un obbligo morale e civile, come un bisogno primario, liberatorio,
e come una promozione sociale: chi ha vissuto il Lager si sente depositario di
un’esperienza fondamentale, inserito nella storia del mondo, testimone per
diritto e per dovere, frustrato se la sua testimonianza non è sollecitata e
recepita, remunerato se lo è.16
Prosegue più avanti:
ritorneremo, il mondo non saprà di cosa l’uomo è stato capace, di che cosa è
tuttora capace[…] se moriremo qui in silenzio come vogliono i nostri nemici,
se non: il mondo non conoscerà se stesso […].17
Un impulso a vivere e raccontare dunque, da cui molti hanno potuto trarre
la forza di resistere.
L’esigenza di raccontare si scontra però con l’incapacità di far capire la
drammaticità e la brutale crudeltà di quanto si è visto e vissuto, insieme alla
consapevolezza dell’impossibilità di capire e soprattutto del rischio di
essere fraintesi. La propria è un’esperienza di cui si rivendica l’unicità,
inspiegabile, «ma che dovrebbe tuttavia essere presa da chi ascolta come
paradigma di vera sofferenza».18
Nell’importante libro intitolato La vita offesa gli autori hanno raccolto le
testimonianze di duecento sopravvissuti, in un montaggio di più di
novecento brani tratti dalle diecimila pagine di trascrizione delle loro
15 La vita offesa, Storia e memoria dei Lager nazisti e nei racconti di duecento sopravvissuti, a
cura di A. Bravo, D. Jalla, Milano, Franco Angeli 1986, 20012, pp. 8-9. 16 Ibidem. 17 Ibidem. 18 www.novecentoitaliano.it
13
testimonianze. È una raccolta delle storie di vita degli ex deportati
fortemente voluta dall’Aned in Piemonte, che a quarant’anni di distanza si
propone di dare voce a tutti quelli che hanno subito la tragica esperienza
della prigionia, in particolare a coloro che non avevano mai trovato ascolto
al di fuori della famiglia e del piccolo gruppo di amici. Sono tanti – o
meglio la stragrande maggioranza – i testimoni che non hanno mai scritto o
raccontato la loro esperienza, e in questo testo ogni singola voce va a
formare un coro che ancora una volta denuncia la drammaticità della «vita
non vita nel Lager».19
Ma perché per più di quarant’anni sono rimasti in silenzio?
Sono loro a dircelo: «Raccontar poco non era giusto, raccontar il vero non
si era creduti. Allora ho evitato di raccontare, sono stato prigioniero e bon».
«Adesso cominciano a credere, ma c’è voluto degli anni». Frasi, queste, di
Temporini a cui si aggiungono quella di Mongarli: «Non ne parlo mai. Cioè
ne parlo quando sono coi miei compagni, perché loro possono capirmi.
Mica possono capirmi gli altri». E ancora quella di Franco: «Credo che la
deportazione in sé sia una cosa irriferibile nella sua integralità, nella sua
interezza».20
In queste frasi si legge il timore di essere fraintesi e la sensazione che
parlare porterebbe comunque a una riduzione o a uno spostamento dei
significati. Questo avviene soprattutto nei primi tempi del ritorno, quando ci
si accorge che l’esperienza è indicibile e non vale nemmeno la pena di
tentare di raccontarla perché si scontra con l’incredulità generale e con
l’impressione che non interessi a nessuno, poiché tutti vogliono solo
dimenticare e “andare avanti”.
19 Ivi, p.12. 20 Ivi, pp. 57-63.
14
Nei primi quarant’anni il ricordo dei sopravvissuti prende forme diverse:
deposizioni processuali, racconti, scritti autobiografici, discorsi
commemorativi. Ma Anna Bravo e Daniele Jalla ci fanno notare come
questo ricordo non sia diventato patrimonio comune, non si sia visto
riconosciuto uno spazio certo e definito nella memoria nazionale, quasi
come se la deportazione e lo sterminio non fossero un “affare italiano”, ma
di pertinenza della Germania, della Polonia, di un imprecisato est europeo;
insomma una realtà lontana.
A tal proposito Spartaco Capogreco parla di “vuoto di memoria”:
Parlando dei campi fascisti, una questione appare ineludibile: quella del “vuoto
di memoria” che ha accompagnato quei fatti per così lungo tempo nel
dopoguerra: gli italiani “brava gente” si sono adagiati per anni nella
presunzione che i campi di concentramento li riguardassero solo in quanto
vittime, e non anche nel ruolo attivo di deportatori e costruttori di lager,
cosicché quella realtà è rimasta sostanzialmente estranea alla memoria pubblica
nazionale del dopoguerra.21
E prosegue:
Diversamente che in Germania, dove la riflessione e l’elaborazione sulle
responsabilità del nazismo hanno interessato profondamente larghi settori della
società, in Italia i conti col passato sono stati fatti in misura molto trascurabile,
Peraltro, l’eccessiva insistenza sul radicamento sociale della Resistenza – come
sottolinea Anna Bravo – «ha finito per avvalorare l’idea di un popolo
unanimemente antinazista e perciò riabilitato in massa. Un popolo nella
sostanza incolpevole, quando non vittima».22
21 S. Capogreco, Aspetti e peculiarità del sistema concentrazionario fascista, in Lager,
totalitarismo, modernità, Milano, Bruno Mondadori 2002, p. 233. 22 Ibidem.
15
Sono diverse e molteplici le cause di una rimozione tanto forte, ma
un’iniziale problematicità nel raccontare era sicuramente data
dall’indisponibilità del mondo del dopoguerra a far propria un’esperienza
così in contrasto con il tentativo di riprendere una parvenza di “vita
normale”, in cui non fosse lo spettro della guerra a farla da protagonista. A
questo si aggiungeva anche il fattore della dimensione sociale della
deportazione, che in Italia non è un fatto di massa come nell’est, qualcosa
con cui ogni individuo e ogni famiglia ha un rapporto di qualche natura.
Una questione, questa, che non può tuttavia essere considerata come
determinante, in quanto resta il fatto che ben 45000 furono i prigionieri
italiani e 40000 non ritornarono, e oltretutto non bisogna dimenticare che
l’Italia stessa ospitò sul suo suolo campi di concentramento e di transito in
cui venne anche messo in atto lo sterminio.
Il nodo cruciale sta quindi in ciò che avvenne nell’immediato dopoguerra.
Nessuno parve particolarmente interessato a rendere esplicite tutte le
esperienze e le sfaccettature che in un certo senso travalicavano la guerra
ma che avevano comunque coinvolto un numero impressionante di esseri
umani e migliaia di italiani. L’antifascismo vincente aveva come principale
riferimento la lotta armata e stentava ad accogliere su un piano di parità i
deportati politici, mentre la classe politica, proiettata verso la pacificazione,
era più attenta al peso numerico e istituzionale della Resistenza. Dal canto
suo, l’opinione comune aveva in mente ciò che la guerra aveva comportato
nel proprio quotidiano e si mostrava più ansiosa di fornire solidarietà ai
pochi ebrei sopravvissuti che affrontare il peso dei tanti, deportati per
ragioni razziali o politiche, spariti nei campi tedeschi. Un peso minore
ebbero i fattori internazionali legati alla rapida stabilizzazione dei “blocchi”
e allo sforzo dell’Italia di costruirsi un’immagine il più possibile slegata dal
nazismo.
16
Anche la letteratura e la storiografia hanno avuto un ruolo particolare,
dimostrandosi – per dirla con Cavaglion – «singolarmente pigre»,23
lasciando che per lungo tempo vi si sostituisse la memorialistica composta
da diari, autobiografie, corrispondenze private, manoscritti rimasti inediti
ma trasmessi agli eredi, interviste registrate, memorie rilasciate a fini
processuali. Infatti è solo con gli anni ’60 che sembra rompersi la cortina di
riserbo e forse anche di rimozione che circondava la questione della
deportazione.24
23 www.como.istruzione.lombardia.it 24 Vd. ad esempio V. Morelli, I deportati italiani nei campi di sterminio 1943-1945, Milano,
Scuola grafica pavese 1965.
17
Capitolo 2
STORIOGRAFIA, MEMORIA E CRITICA LETTERARIA
DELLA RESISTENZA
2.1 1946-2008: Le fasi della produzione resistenziale
Si è ormai soliti distinguere gli oltre cinquant’anni di storia bibliografica
della Resistenza in diverse fasi o periodi.25 Questa abitudine lascia
trasparire la convinzione diffusa, anche se sottaciuta, che la ricostruzione
storica del periodo resistenziale sia soggetta a sollecitazioni politiche e
ideologiche prima ancora che storiografiche. Questo elemento deve essere
considerato non come un limite, in quanto il confronto politico e ideologico
sotteso agli studi sulla Resistenza ha sospinto, motivato e valorizzato più
che frenato le ricerche . Un interesse che si è tenuto sempre molto alto e ciò
è dimostrato dall’elevata – quantitativamente parlando – produzione
storiografica.
La prima fase, che va dal 1943 al 1955, può essere definita come quella
della costruzione della memoria collettiva, tra la sorpresa e la
straordinarietà dell’evento e la nostalgia per un’esperienza così intensa e
coinvolgente quale è stata per molti giovani ventenni quella della
partecipazione, anche avventurosa, al movimento. È però una costruzione
contrastata, conflittuale, tesa più a inserire la Resistenza come discrimine
nel dibattito e nel confronto politico che stanno dando configurazione alla
“nuova” democrazia italiana e all’Italia “nata dalla Resistenza”, che a
definirne contorni e caratteri storici. Si spiegano così le oscillazioni tra
memoria individuale, rivendicazione psicologica e riflessione politica delle
25 A. Ballone, Bibliografia della Resistenza, in Dizionario della Resistenza, a cura di Enzo
Collotti, Renato Sandri e Frediano Sessi, Torino, Einaudi 2001, pp. 719-734.
18
numerose pubblicazioni di dirigenti politici e di “semplici” partigiani che
caratterizzano questo decennio.
È una fase ricca e intensa soprattutto di “memorie” e di raccolte
documentarie, non sempre fedeli e attendibili, ma comunque utili a
ricostruire un clima se non una vicenda. Ma sono anche numerose le
monografie locali, i diari, le lettere e vi sono le prime riflessioni con intenti
più propriamente storiografici, come gli scritti di Longo, Valiani e
Cadorna,26 tutti e tre alti dirigenti politici della Resistenza ma di ascendenze
politiche diverse (comunista il primo, azionista il secondo, moderato il
terzo). In questi testi si ritrova una rappresentazione più distaccata,
l’interpretazione politica della vicenda storica e dunque l’esplicitazione di
differenziate tendenze che si profilano nella storiografia resistenziale, pur
senza rinnegare la dimensione soggettiva, individuale, talora esistenziale
dell’esperienza partigiana.
In questo stesso periodo si colloca la nascita del progetto di Ferruccio
Parri di creazione dell’Istituto nazionale per la storia del movimento di
Liberazione in Italia (Insmli), affiancato dalla rivista Il Movimento di
Liberazione in Italia che andrà pubblicando una documentazione sempre
più ricca e puntuale e da una collana di studi storici. L’obbiettivo di Parri,
ma anche di tutti i più attenti uomini della Resistenza, è quello di sottrarre
la memoria e la vicenda stessa all’oblio, alla rimozione collettiva e alla
sottovalutazione politica. Ci si trova però di fronte ad un “clima” politico
diverso che vede prevalere il distanziamento istituzionale dall’esperienza di
consenso e partecipazione al movimento partigiano e che porta quindi
all’asprezza del confronto politico e ideologico che coinvolge non solo il
giudizio sulla Resistenza, ma anche quello sull’operato dei singoli
partigiani, tanto da legittimare la convinzione che studi, ricerche e
26 L. Longo, Un popolo alla macchia, Milano, Editori Riuniti 1947; L. Valiani, Tutte le strade
conducono a Roma. Diario di un uomo nella guerra di un popolo, Firenze, La Nuova Italia 1947;
R. Cadorna, La riscossa. Dal 25 luglio alla liberazione, Milano, Rizzoli 1948.
19
testimonianze possano in quegli anni mirare soprattutto a un riconoscimento
stesso della Resistenza.
Anche per contrastare questo ridimensionamento della “portata storica”
dell’evento si organizzano i primi importanti convegni di studio e
soprattutto si pubblicano le prime ricostruzioni storiche complessive che
hanno il merito di accentuare l’approccio più propriamente “scientifico”.
Una seconda fase può essere collocata tra il 1956 e il 1964, cioè tra i primi
segnali di crisi del momento “caldo” della “guerra fredda” e l’inizio della
“svolta” degli anni sessanta. Cinque sono gli aspetti più interessanti della
bibliografia sul tema resistenziale di questo decennio: il primo è di ordine
quantitativo in quanto gli studi si moltiplicano e “per spinta dal basso”,
prevalentemente cioè a opera di studiosi non accademici e neppure
professionisti. Accanto a questi studiosi si affaccia però anche una
generazione di storici nuova, formatasi all’università e in quelle facoltà
dove è significativa l’azione di studiosi che dopo brillanti carriere
accademiche, per lo più di storia moderna e risorgimentale, rivolgono la
loro attenzione a temi di storia italiana più recenti (come ad esempio Piero
Pieri, Leo Valiani e Guido Quazza).
Significativa comincia ad essere anche la presenza di studiosi e di studi
stranieri grazie ai quali i rapporti tra la Resistenza italiana e gli alleati
diventa un tema di approfondimento.
D’altra parte con i primi anni sessanta prendono avvio anche studi
sull’occupazione nazista stimolati dalla Terza conferenza di storia della
Resistenza in Europa, tenutasi a Karlovy Vary il 2-4 ottobre 1963 con il
titolo L’occupazione nazista in Europa.
Con questi studi e questi studiosi si spostano gli accenti e gli approcci alla
tematica antifascista e resistenziale: intanto nella direzione di un
inserimento della Resistenza nell’alveo della ventennale tradizione
antifascista e poi nell’accentuazione dell’interesse per le questioni più
propriamente sociali, rispetto a quelle militari e politico-istituzionali.
20
Un ulteriore aspetto innovativo è rappresentato dalla crescita esponenziale
di lavori di storia locale e dalla memorialistica legata a esperienze
circoscritte (da ricordare B. Ceva, Tempo dei vivi 1943-1945, Milano,
Ceschina 1954). I lavori di storia locale, che si avvalgono anche di
testimonianze orali, di documentazione inedita e dispersa, di fonti diverse,
sono veramente molti. Tanto da motivare alcune prime, importanti
riflessioni sulla metodologia, globale e analitica, della ricerca e
ricostruzione storica.
Ultimo aspetto, ma non meno rilevante, è l’avvio degli studi sulla
deportazione, a cominciare dalla traduzione del volume di L. Poliakov e J.
Sabille Gli ebrei sotto l’occupazione italiana (Milano, Comunità 1956), e
più in generale sul razzismo fascista e sulla vicenda ebraica in Italia. È però
soprattutto dalla comunità ebraica, anche attraverso la rivista «La rassegna
mensile di Israel», che viene approfondito questo filone di ricerca,
sollecitato anche dalle polemiche accesissime attorno al «dramma teatrale
in cinque atti» di Rolf Hochhuth Il Vicario (tradotto da Feltrinelli nel 1964).
Come già detto, la svolta si avrà con il libro di V. Morelli I deportati
italiani nei campi di sterminio 1943-1945.
Questo decennio vede inoltre la crescente attenzione al cosiddetto “mondo
cattolico”. Numerosi saranno gli studi sulla partecipazione dei cattolici alla
Resistenza contro il fascismo e il nazismo e sul contributo del clero e delle
gerarchie ecclesiastiche. Elementi tutti questi che indicano un processo di
legittimazione della Resistenza e dell’antifascismo e anzi, a giudizio di
rigorosi critici, persino di istituzionalizzazione e di ufficializzazione, un
processo che i fatti del luglio 1960, la “distensione” tra le “superpotenze” e
il dinamismo della società italiana hanno contribuito in misura determinante
ad avviare e consolidare.
D’altra parte l’introduzione, nel 1957, dell’educazione civica tra le materie
di insegnamento nella scuola italiana, coniugandosi con le conseguenze
delle trasformazioni sociali e con la consapevolezza circa l’affacciarsi di
21
una nuova generazione “post-resistenziale”, solleciterà l’impegno di case
editrici e autori, più che al rinnovamento dei manuali scolastici, alla
pubblicazione di sintesi, testi narrativi e antologie destinate all’uso
didattico.
Con la metà degli anni sessanta comincia una fase, definibile come di
transizione, che va circa fino al 1972. Si può dire che il periodo abbia
inizio, dal punto di vista delle ricerche storiche, con due opere che, pur con
i loro limiti e difetti, rappresentano i due estremi entro i quali si collocherà
il dibattito successivo: il riferimento è all’ampia sintesi divulgativa, dovuta
a due autori, già partigiani e dirigenti politici, da tempo impegnati sul
versante della ricostruzione scientifica e della raccolta documentaria, Pietro
Secchia e Filippo Frassati (Storia della Resistenza. La guerra di
Liberazione in Italia. 1943-1945, Roma, Editori Riuniti 1965), e sul
versante opposto e ideologico, la Storia della guerra civile in Italia, (3
voll., Milano, Mursia 1965-66) di Giorgio Pisanò, monumentale opera nata
per contrastare il più efficacemente possibile il punto di vista di sinistra sul
biennio di fine guerra. L’esito del confronto propenderà in favore della
prima interpretazione.
In questa breve fase si assiste sin dall’inizio ad un massiccio e
determinante contributo di Secchia che darà l’avvio ad un dibattito con altri
due dirigenti comunisti, Giorgio Amendola e Luigi Longo. Ciò che questo
confronto metterà in rilievo sarà il fatto che la ricostruzione storica della
Resistenza costituisca un terreno di confronto, talora aspro e inconcludente,
all’interno dello stesso schieramento di sinistra, anche in conseguenza
dell’emergere di una generazione giovanile e soprattutto di una militanza
politica che non mira a rifiutare o a superare quell’esperienza, ma a
rileggerla secondo altri criteri e a riappropriarsene con altre, più radicali,
finalità. Da questa sensibilità, presto collettiva grazie alle vicende che
coinvolgono il mondo universitario e studentesco, nascono proposte,
progetti, ricerche, ambizioni di revisioni e di reinterpretazione della vicenda
22
resistenziale, revisioni che hanno come comune denominatore la
constatazione che lo spunto esclusivamente politico, ideologico e patriottico
e l’evoluzione dell’antifascismo nel ventennio non siano sufficienti a
spiegare natura, ragioni ed esiti della Resistenza italiana, e che sia
necessario un esame individualizzato e specifico per i diversi soggetti del
“fronte antifascista”. Anni fecondi, questi, che segnano un passaggio
definitivo al prevalere di un approccio storico e storiografico, con un
gruppo di opere talvolta anche spigolose e rigide, ma capaci di sollecitare
ripensamenti e riproblematizzazioni.
Importante diventa sempre più a partire da questi anni l’attività di
promozione, di aggregazione, di raccolta documentaria, di sollecitazione
teorica degli Istituti storici della Resistenza, sotto i cui auspici nascono
contributi rilevanti.
L’intenso, breve periodo si conclude con l’acquisita convinzione che sia
ormai necessario uscire, dopo un trentennio, dalla mera descrizione dei
tratti caratteristici della Resistenza come “fatto in sé” e vedere i risultati
positivi e i limiti del suo “passaggio” nella storia italiana e internazionale.
Nel 1972 Guido Quazza di fatto prende la direzione dell’Istituto nazionale
per la storia del Movimento di Liberazione in Italia e avvia un “piano di
lavoro” per la rete degli Istituti che darà i suoi frutti nei quasi vent’anni
successivi, al termine dei quali la vitalità del “paradigma antifascista”
comincerà a mostrare limiti e insufficienze e lo stesso tema della Resistenza
verrà letto con crescente distacco dalle giovani generazioni, oramai “figlie”
di padri che si sono avvicinati all’argomento attraverso il Sessantotto e la
“contestazione studentesca”.
Importante è ciò che avvenne in quegli anni anche in base alle polemiche
che li attraversarono. La Resistenza cessò di essere considerata un evento a
sé, inquadrabile, ben definito e pigramente accettato, e si fece anzi un
“problema” storico, politico, culturale da inserire in un “contesto” di
vicende e in una dinamica di eventi, alcuni dei quali di portata assai più
23
vasta, come è appunto il caso dei diversi fronti della seconda guerra
mondiale.
Sono anni, questi, in cui si dispiega un’intensa attività da parte degli
Istituti storici della Resistenza e in cui si fanno sempre più massicce le
monografie locali, che spaziano su tutti gli aspetti della storia sociale,
culturale, politica e istituzionale del decennio 1938-48 e le opere di
memorialistica, ad esempio Dalla clandestinità alla lotta armata a cura di
Aldo. Agosti e Giulio Sapelli (Torino, Musolini 1977), che contiene il
diario di Luigi Capriolo.
Nel complesso è tutta la storia dal 1930 al 1950 circa che viene
attraversata da numerose ricerche monografiche. Pare utile qui sottolineare i
quattro aspetti che più d’altri hanno interessato da ultimo gli storici: la
questione della deportazione, la partecipazione dei cattolici e la soluzione
da essi offerta ai problemi della “nuova” Italia, l’occupazione tedesca e i
problemi derivati, infine il problema della resistenza all’estero, fuori dal
territorio italiano. Per quanto riguarda il primo aspetto, dopo un lungo
periodo di sottovalutazione della questione, gli studiosi han preso a prestare
sempre maggiore attenzione al tema della Shoah.27
L’ultima fase viene fatta iniziare con la seconda metà degli anni ’90, e più
propriamente nel 1994 per quel che riguarda il profilo politico e il dibattito
ideologico, ma che era stata anticipata, per ciò che riguarda studi e ricerche,
dal fortunato lavoro di Claudio Pavone,28 che già nel titolo sottolinea il
lungo e contrastato percorso di questo ambito storiografico nel momento in
cui recupera, con altro significato e con forte valenza politica, una
definizione di Resistenza invero condivisa nei primi anni del dopoguerra e
poi rifiutata dagli antifascisti in quanto percepita come nozione ambigua e
in qualche misura legittimante del nemico fascista: la nozione di «guerra
civile».
27 Vd. ad esempio il già citato La vita offesa, 1986. 28 C. Pavone, Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza, Torino, Bollati
Boringhieri 1991.
24
Per quanto concerne i futuri percorsi di ricerca, essi saranno
probabilmente indirizzati verso gli approfondimenti di storia locale e vita
quotidiana nella realtà drammatica della guerra; resistenza non armata e
antifascismo consapevole e infine puntualizzazione e definizione del
concetto di guerra civile.
2.2 Il “peso” della politica
Le riflessioni storiche sulla Resistenza e la stessa produzione di memorie,
nel corso di tutti questi anni sono spesso state utilizzate (più o meno
consciamente) dalla politica per favorire interpretazioni storiche piuttosto
che altre, per attribuirvi un proprio peso specifico e per consolidare simboli
presenti nell’immaginario collettivo.
Un aiuto in questa riflessione ci viene dato dalla relazione a cura di Anna
Favaro del convegno dal titolo I fondamenti dell’Italia Repubblicana:
mezzo secolo di dibattito sulla Resistenza, tenutosi il 28 e 29 gennaio 2000
a Vercelli con l’obiettivo di
affrontare il tema del rapporto tra politica militante e storiografia della
Resistenza, come una sequenza di “revisioni”, fino alle ultime e più
provocatorie, inquadrando storicamente le forme prese dalla discussione
nel cinquantennio repubblicano, evitando di subordinare questo esame ai
suoi esiti attuali, ma senza rifiutare il confronto con le ultime revisioni e
negazioni.29
La tesi di partenza era che parlare di Resistenza significa parlare dei
“fondamenti” dell’Italia repubblicana. Francesco Traniello vi sottolineava
come la Resistenza non possa essere interpretata esclusivamente come
fenomeno di rottura, soprattutto in considerazione degli elementi di
continuità dello Stato che attraversarono indenni gli anni 1943-45. Tuttavia
è evidente che in passato siano state date rappresentazioni della Resistenza
29 http://www.storia900bivc.it
25
che avevano lo scopo di storicizzarla in modo da renderla fenomeno
simbolico e legittimante la Costituzione e la Repubblica e garantendo la
sopravvivenza dei partiti che più avevano avuto un peso in quel contesto
storico.
Gianfranco Petrillo, che si è occupato delle interpretazioni della
Resistenza da parte di esponenti del Partito comunista italiano dal 1945 al
1970 circa, ha individuato alcuni aspetti permeanti la storiografia di matrice
comunista: l’estrema semplificazione dei rapporti di forza tra gli attori in
campo, la sottovalutazione del fascismo, la pretesa continuità tra la lotta
antifascista e quella resistenziale, il ruolo epico del popolo nella guerra
patriottica, nel “nuovo Risorgimento” italiano.
Come hanno evidenziato sia Gianpasquale Santomassimo, sia Claudio
Dellavalle, negli anni sessanta e settanta ci fu una profonda revisione della
storiografia “di partito”: Battaglia individuò la non –continuità tra
antifascismo di partito e spontaneità, infatti la partecipazione fu espressione
del concetto privato di patria posseduto dalle masse, e almeno inizialmente
non si articolò sulle direttive dei partiti. Concetto invece da altri rivalutato a
favore della riaffermazione di un legame tra antifascismo e Resistenza.
Anche il Sessantotto contribuì portando nuova linfa al dibattito:
nonostante il passato e la storia fossero sostanzialmente estranei alla
contestazione, proiettata nel futuro, l’aspetto della partecipazione popolare
e spontanea alla lotta resistenziale fu riabilitata dal dibattito di quegli anni.
Come ha sottolineato Mimmo Franzinelli, questa fase storica ebbe il merito
di dare avvio all’importante periodo di ricerca sulle fonti orali e
politicamente si assistette a duna visione della lotta di resistenza
essenzialmente come lotta operaia, e quest’interpretazione parziale
contribuì a un’involuzione di una parte della storiografia, che in quegli anni
recuperò enfasi e retorica “su misura” per il Sessantotto: l’ideale della
Resistenza andò così a colmare il vuoto di ideali contestato.
26
Gianni Perona ha affermato che, in cinquant’anni di revisioni, i partiti
hanno pesato a volte più delle fonti stesse, in forma di sottomissione
spontanea degli storici ai partiti: se è vero che il senso comune della storia e
della memoria si accompagna all’antifascismo e si nutre dei suoi valori, è
purtroppo vero anche che a volte etichette ed abitudini mentali si sono
sovrapposte alle fonti primarie: è indiscutibile comunque che furono i
partiti a parlare di Resistenza per primi, con le evidenti conseguenze di
deformazione dovuta all’impronta ideologica.
L'affrancamento della storiografia dalle forzature di partito, che ha sostenuto
l'ampliamento dello studio di aspetti emblematici della guerra civile e il crollo dei
miti sull'antifascismo, ha dato adito a nuovi sviluppi storiografici: la disponibilità
ad occuparsi anche di aspetti controversi, come la complessità dei rapporti dei
partigiani con la popolazione (spesso deteriorati a causa di violenze e requisizioni
forzate, oltre che le rappresaglie antipartigiane subite), o il carattere di spontaneità
e non politicizzazione delle bande partigiane, o ancora l'effettiva consistenza di
queste ultime, dimostra che la storiografia si è orientata negli anni novanta verso
la direzione da tempo auspicata.
Sorge spontaneo il confronto tra la storiografia prodotta in ambienti di sinistra e la
storiografia neofascista. Come esposto da Francesco Germinario, un primo
elemento che risalta è la narratività di quest'ultima, la semplicità delle forme e dei
contenuti.
E se quest'approccio è più memorialistico che storiografico, è certamente
auspicabile un moderato rinnovamento del metodo di scrittura nel senso di una
maggior fiducia nell'autonomia del racconto storico, collocato all'interno di una
storiografia aperta e in trasformazione che nasce dal confronto, dallo sforzo non di
produrre la certezza, ma di ricostruire la fluidità dei fenomeni, per capire come si
sono manifestati, cosa hanno manifestano.
Raccontare la memoria della percezione della Resistenza è la chiave per
comprenderne le cause, i motivi di quella partecipazione, di quelle scelte e del
valore simbolico della Carta costituzionale, i cui princìpi furono dettati dalle forze
che durante la Resistenza avevano combattuto insieme, e che di lì a poco si
sarebbero frammentate e in alcuni casi dissolte.
27
Capitolo 3
DALLA RESISTENZA IN PIEMONTE AI GAP: APPUNTI DI
STORIA
3.1 I caratteri della Resistenza in Piemonte
Prima di addentrarci nell’analisi di un testo di memorie che si rifanno in
gran parte all’esperienza partigiana torinese, è necessario aver ben presente
il contesto storico in cui esso ci proietta.
Mario Giovana ritiene che i profili salienti della resistenza armata e
clandestina nella regione possano essere individuati in quattro ordini di
grandezza.30 Il primo è sicuramente l’immediatezza con cui, al domani
dell’armistizio dell’8 settembre 1943 e del crollo delle Forze armate regie,
ebbe avvio l’organizzazione partigiana. Il secondo connotato che emerge
risiede nella diffusione che essa assunse rapidamente, sviluppandosi
soprattutto nella primavera del ’44 in una fitta trama di bande in crescita
numerica che riuscirono a estendersi capillarmente in tutto il territorio,
stendendovi una rete di forze combattenti pressoché senza soluzione di
continuità. Ed è in questo quadro che si inserisce il terzo elemento di rilievo
che consiste nell’impiego di tutti i moduli di lotta armata e clandestina in
ogni condizione ambientale. La lotta partigiana si attuò in montagna, in
pianura, nelle zone collinari e negli ambienti urbani. Il quarto fattore sta
nell’elevato tasso di protagonisti, il più alto in assoluto nel centro-nord, che
coinvolgeva uomini e donne di diversa estrazione sociale e sensibilità
politica.
Ciò che concorse ad attuare un tempestivo e piuttosto ordinato sviluppo
della Resistenza in Piemonte fu sicuramente la costituzione a Torino del
30 In Dizionario della Resistenza, cit., pp. 500-518
28
Cln, il Comitato di Liberazione Nazionale, costituitosi con l’accordo di tutte
le correnti politiche antifasciste. A partire dal 1943 esso assunse pratiche
funzioni di organo di direzione regionale del movimento avvalendosi della
collaborazione di un nucleo di ufficiali effettivi. Il Cln regione Piemonte
(Clnrp) si dotò di un comitato finanziario, di un corpo di ispettori e, a
partire dal maggio del ’44, di un proprio organo di stampa, «La Riscossa
italiana». Il marzo ’44 vide la cattura della maggioranza dei suoi
componenti e la condanna a morte per otto di loro. In giugno venne quindi
ricostituito un organo di direzione militare regionale, il Cmrp, Comando
militare regionale piemontese, composto da comandanti regionali delle
formazioni differenziate.
L’azione delle bande armate partigiane vide l’alternarsi di diverse fasi,
dall’estate del ’44 – che corrisponde al periodo di massima espansione della
resistenza e alla creazione delle “zone libere” – al difficile autunno-inverno
che seguì, con l’arrestarsi delle spinte alleate verso il nord Italia e la
rinnovata serie di cicli di rastrellamenti su tutto l’arco della regione. Con
difficoltà nel complesso l’impalcatura partigiana resse, ma si scontarono
perdite elevate.
Ai primi avvisi della ripresa offensiva alleata sui fronti e con la fine
dell’inverno, il fronte partigiano ripartì all’attacco accelerando la
dissoluzione dell’apparato fascista e incalzando i tedeschi.
Allo scadere del marzo ’45 tutte le misure per la fase insurrezionale erano
pronte e da qui gli eventi si susseguirono in maniera incalzante. La svolta fu
segnata dallo sciopero del 18 aprile indetto a Torino dalle cellule sindacali
clandestine e dal Cln. Di fronte all’imponenza della dimostrazione i fascisti
registrarono un completo crollo dei loro apparati. Nei giorni successivi le
squadre di fabbrica delle Sap occuparono gli stabilimenti e iniziò l’assalto
alle cellule residuali fasciste. I tedeschi nel ritirarsi dovettero sfilare ai
margini della città, non senza compiere un massacro di sessanta civili e
volontari a Grugliasco.
29
Il 26 aprile, il Clnrp redasse il manifesto che annunciava l’assunzione dei
poteri e recava le firme di suoi componenti appartenenti alle diverse sigle:
Pli, Dc, Pda, Psiup, Pci. Il primo maggio una ristretta avanguardia alleata
entrò in Torino già presidiata dai partigiani.
Alla liberazione, lo schieramento partigiano piemontese comprendeva
cinquanta divisioni, nove brigate “indi visionate” (una Autonoma, sei di Gl,
due di Rinnovamento), i nuclei dei Gap e delle Sap delle diverse
formazioni. La struttura di questo organico presentava: dodici divisioni
Autonome, sedici Garibaldi, dodici di Gl, sette Matteotti, tre Rinnovamento
nel Cuneese, di orientamento democratico-repubblicano.
In totale in Piemonte sono stati riconosciuti dalle apposite commissioni
43685 partigiani.
3.2 Torino
Un approfondimento a parte merita la città di Torino.31
La cronaca e la storia dei venti mesi dal ’43 al ’45 ruotano principalmente
attorno al clima di rivolta della città operaia, al vuoto di consenso che
l’opinione pubblica creava alla parvenza di autorità del regime della Rsi,
alla paura che incutevano i tedeschi senza tuttavia riuscire a frenare una
diffusa omertà e collaborazione con la ramificata organizzazione della
Resistenza e, comunque, con le manifestazioni della sotterranea reazione al
binomio fascisti-nazisti.
Mario Giovana ha tentato di delinearne la situazione sociopolitica. Sin dal
ventennio della dittatura in città si respirava un clima di freddezza verso il
regime, un distacco dalle manifestazioni più rumorose del fascismo, e un
persistere nelle masse lavoratrici di atteggiamenti di non curanza, quando
non di ostilità nei suoi confronti.
31 Ivi, pp. 511-518.
30
Nel giugno del ’40, in cui si colloca la dichiarazione di guerra alla Francia,
gli organi di controllo fascisti registravano profonde contrarietà
dell’opinione pubblica all’avventura militare, crescenti malumori per le
difficoltà degli approvvigionamenti, l’accentuarsi di indizi di generale
distacco dal regime, accanto all’affiorare dei primi germogli di
un’opposizione politica non limitata alle attività clandestine comuniste.
A metà del ’42 si assistette ad un acutizzarsi del malcontento dovuto
principalmente alle sempre più pesanti condizioni di vita in cui versava la
popolazione. Tra la fine dell’agosto e il settembre si verificarono episodi di
blocco della produzione in alcune fabbriche; proteste che vennero ripetute
nel gennaio e febbraio del ’43. Il primo marzo ebbero inizio i blocchi delle
produzioni alla Fiat Mirafiori, estesisi poi ad altri grandi complessi cittadini
e del resto della regione. A ciò si affiancano gli scioperi spontanei, con
rivendicazioni salariali e di approvvigionamenti alimentari, in cui riuscì ad
inserirsi l’iniziativa comunista per caricare le proteste di significato
politico, propagandando la parola d’ordine della pace accanto a quelle delle
rivendicazioni economiche. Nemmeno la dura repressione fascista riuscì a
placare gli animi.
Il colpo di stato del 25 luglio ’43 sopravvenne in quest’atmosfera
surriscaldata: gli operai scioperarono per tre giorni, folle di cittadini si
riversarono nelle piazze inneggiando alla caduta del regime, cinquecento
detenuti politici furono liberati a forza dalle carceri cittadine e la Casa del
Fascio venne assalita e saccheggiata. In quegli stessi giorni si costituì il
comitato dei partiti antifascisti (Pci, Psiup, Gl-Pda, Dc, Pli), sotto la
denominazione di Fronte nazionale.
L’annuncio dell’armistizio dell’8 settembre precedette di poco l’arrivo in
città di una modesta avanguardia tedesca, che prese possesso dei punti-
chiave urbani e ricevette la resa incruenta dell’apparato militare.
Da qui fino all’inizio primavera del ’44 la realtà resistenziale torinese fu
contraddistinta dall’azione incalzante e spettacolare dei Gruppi d’azione
31
patriottica (Gap) comunisti, comandati dapprima da Ateo Garemi e poi da
Giovanni Pesce, detto “comandante Visone”, a cui succedette Walter
Nerozzi. I Gap ripetevano un’esperienza mutuata dalla Resistenza francese
e “importata” dai militari comunisti italiani che vi avevano partecipato: essi
attuarono una serie di sabotaggi e di attentati che costrinsero il nemico a
sentirsi assediato e a barricarsi nelle proprie sedi. Essi però dovettero anche
subire una dura repressione che li portarono a sostenere ingenti perdite e
nella primavera del ’44 si ritrovarono praticamente in crisi e costretti a
ridurre drasticamente le proprie incursioni.
Le agitazioni operaie furono uno degli aspetti preminenti della resistenza
torinese. Le officine della Fiat rimanevano l’epicentro delle contestazioni di
massa, ed è proprio qui che nel novembre-dicembre ’44 presero corpo
imponenti scioperi che si estesero alle altre maggiori fabbriche cittadine e
della provincia, anche se con meno successo. Questi furono a carattere
fortemente autonomo e spontaneo: il legame con il Pci, seppur persistente,
era piuttosto labile e il Cln era attraversato da numerose contraddizioni
rispetto ai problemi delle rivendicazioni operaie.
In realtà , la situazione del movimento dei lavoratori e delle sue agitazioni
si svolgeva tra complesse manovre in cui fascisti, tedeschi e industriali
perseguivano ciascuno obiettivi propri, e l’attivismo comunista spingeva a
posizioni di scontro frontale e di endemica rivolta tese a forzare una massa
operaia stretta dalle immediate esigenze di ottenere miglioramenti salariali,
ottenere soccorsi in viveri e generi di prima necessità. Questo “estremismo”
dalla Federazione del Pci torinese verrà condannato dalla direzione del
partito. Ne derivano incertezze e pause di riflessione nella massa dei
lavoratori dinanzi alle parole d’ordine di sollecitazione a incessanti azioni
di lotta; né la conduzione dell’azione sindacale da parte dei dirigenti
comunisti pareva adeguata alle difficoltà obiettive in cui essi si dibattevano
quando il nemico offriva piattaforme di trattativa salariale e avanzava
promesse di rifornimenti di beni indispensabili.
32
Da qui l’andamento non lineare delle agitazioni, che dal novembre al
dicembre ’43 e poi nel gennaio ’44 si produssero nelle fabbriche, segnando
in pratica sconfitte delle rivendicazioni operaie e disorientamenti nel
movimento. Tuttavia, il permanente atteggiamento di ostilità della massa
lavoratrice, il ripetersi delle agitazioni, l’evidente incapacità del sindacato
fascista di accreditarsi come interlocutore credibile e i limiti che
puntualmente rivelavano le concessioni dei tedeschi, accompagnate da
minacce e repressioni sempre più violente, facevano salire la temperatura
della protesta e indicavano un radicalizzarsi della situazione.
Le agitazioni scattarono in febbraio, e culminarono nel marzo ’44, con il
concomitante appoggio di forze partigiane esterne che prolungavano dalle
basi di montagna le loro azioni fino alla periferia della città. Se i risultati
sindacali della lotta non potevano dirsi soddisfacenti, l’esito politico della
manifestazione di forza del movimento dei lavoratori fu senza dubbio più
che significativo: il nemico toccava così con mano l’isolamento nel quale si
trovava e anche la sua relativa impotenza, malgrado la durezza delle
repressioni, di fronte a masse popolari che non si piegavano.
L’occupazione alleata di Roma nel giugno ’44 aprì nuove prospettive
all’azione della Resistenza intensificando la guerriglia partigiana ma
contemporaneamente affacciando il rischio che i tedeschi, in vista di una
ritirata generale verso i confini, decidessero di trasferire in Germania il più
possibile gli impianti industriali e intensificassero le deportazioni di
manodopera.
Il 12 giugno iniziò la mobilitazione a Mirafiori. Il 21, il commissario
prefettizio decretava la serrata a tempo indeterminato degli stabilimenti di
Mirafiori, con il risultato di estendere le agitazioni anche ad altri
stabilimenti, unendo rivendicazioni salariali e lotta contro i trasferimenti
degli impianti.
Dal 17 al 27 luglio le industrie torinesi erano in gran parte bloccate; il 22
gli aerei alleati colpivano con estrema precisione l’officina 17, sgombra di
33
maestranze per la serrata, tanto da far pensare che la stessa direzione della
Fiat avesse sollecitato l’incursione. Tedeschi e industriali capirono di essere
in netta difficoltà: furono accantonati sia i piani di smantellamento generale
dell’apparato industriale del paese, sia il progetto di deportazione degli
operai.
L’agitazione aveva quindi conseguito un risultato di fondo; e, del resto,
nelle fabbriche si lavorava ormai a smontare e a nascondere pezzi dei
macchinari più importanti, e si preparavano i nuclei della Squadre di azione
patriottica (Sap) destinati a difendere gli stabilimenti nella fase
insurrezionale. Il movimento, infatti, si poneva ora in un’ottica di
preparazione dello scontro conclusivo.
A partire dal febbraio ’45 furono accelerati tutti i preparativi in vista della
scadenza finale della lotta. Si insediò il Cln cittadino, destinato a diventare
Giunta popolare della liberazione, composto da esponenti delle diverse
forze presenti nel fronte antifascista.
Il 10 febbraio, raggiunta l’intesa unitaria sulle modalità per la liberazione
di Torino, fu emanato dal Comando militare regionale piemontese (Cmrp) il
piano di movimento delle forze partigiane foranee destinate a convergere
sul capoluogo.
Il 20 aprile il Cmrp avvertì i comandi partigiani che stavano per iniziare le
operazioni conclusive scandite in tre fasi, di cui la seconda, liberate le varie
zone, contemplava la liberazione di Torino, e la terza l’aiuto da fornire alle
operazioni alleate. Il 18 aprile, lo sciopero proclamato come prova generale
dell’insurrezione da attuare aveva paralizzato la città e dato il segnale del
completo isolamento della autorità della Rsi, le cui strutture erano di fatto in
piena dissoluzione. I fascisti avevano reagito con rabbia, con una dura
repressione nei confronti dei civili.
Accanto al comando regionale del Cln si insediava il comando piazza di
Torino, preposto ai cinque settori militari in cui era stata suddivisa la città e
del quale assumeva il comando un esponente delle formazioni Garibaldi,
34
Italo Nicoletto detto “Andreis”. In questo frangente si dispiegò anche la
manovra, intessuta dal comandante della missione alleata, tenente
colonnello John Stevens, paracadutato in Piemonte nell’inverno, con lo
scopo evidente di bloccare i movimenti verso Torino delle unità foranee, di
isolare le forze cittadine e quindi far fallire l’insurrezione, in attesa che le
avanguardie alleate precedessero nel capoluogo la marcia partigiana. Un
falso ordine di sospendere il movimento verso la città raggiunse le forze
della VII Zona dopo che il Cmrp aveva emanato, la sera del 24 aprile,
quello di eseguire il Piano insurrezionale.
I comandi partigiani, dopo breve esitazione, subodorando l’inganno non ne
tennero conto e l’avvicinamento alla città fu ripreso. Ma, nel frattempo, le
forze cittadine avevano iniziato l’insurrezione, le Sap presero possesso delle
fabbriche da difendere e i combattimenti si svilupparono nella cerchia
urbana.
Le truppe tedesche furono costrette al ritiro e sfilarono ai bordi di Torino.
Quando, il primo maggio, una esigua avanguardia alleata si affacciò alla
città, Torino era libera: funzionavano i principali servizi pubblici così come
gli impianti e gli stabilimenti produttivi erano stati salvati. In prefettura si
era insediato il socialista Piero Passoni, in questura l’azionista Giorgio
Agosti, a Palazzo civico il sindaco della città, il comunista Giovanni
Roveda.
Un quadro, questo, che ci permette di comprendere meglio il contesto in
cui si inseriva l’azione dei Gap, per poi procedere alla comprensione del
fondamentale ruolo che essi ebbero nell’incutere un sentore di isolamento
nel nemico e nel saper riaccendere gli entusiasmi della popolazione civile.
35
3.3 I Gruppi di Azione Patriottica (GAP)
Chi furono i gappisti?
Potremmo dire che furono “commandos”. Ma questo termine non è esatto. Essi
furono qualcosa di più e di diverso di semplici “commandos”. Furono gruppi di
patrioti che non diedero mai “tregua” al nemico: lo colpirono sempre, in ogni
circostanza, di giorno e di notte, nelle strade delle città e nel cuore dei suoi
fortilizi.
Con la loro azione i gappisti sconvolsero più e più volte l’organizzazione
nemica, giustiziando gli ufficiali nazisti e repubblichini e le spie, attaccando
convogli stradali, distruggendo interi parchi di locomotori, incendiando gli
aerei sui campi di aviazione. Ancora non sappiamo chi erano i gappisti.
Sono coloro che dopo l’8 settembre ruppero con l’attendismo e scesero nelle
strade a dare battaglia, iniziarono una lotta dura, spietata, senza tregua contro i
nazisti che ci avevano portato la guerra in casa e contro i fascisti che avevano
ceduto la patria all’invasore, per conservare qualche briciola di potere.32
È con queste parole piene di enfasi che Giovanni Pesce, il gappista che più
ha contribuito a lasciarci una testimonianza dell’attività svolta da questi
“commandos” metropolitani, tenta lui stesso di dare una definizione dei
Gap. Un aiuto a comprenderne meglio la natura ci viene dato da quanto
riportato dal Dizionario della Resistenza33 che spiega come essi fossero
nuclei partigiani creati per la guerriglia urbana, anche nelle sue forme
estreme, quali l’uccisione di esponenti della Rsi o di ufficiali tedeschi.
Un’importante questione storica, non ancora risolta, riguarda la data della
loro creazione. Secchia34 scrive che «nei Gap del Pci venivano arruolati
esclusivamente comunisti» e che l’istituzione dei Gap avvenne, su iniziativa
del Comando generale delle brigate Garibaldi, verso la fine del 1943.35
32 G. Pesce, Senza tregua, Milano, Feltrinelli 1967, pp. 7-8. 33 Voce GAP, in Dizionario della Resistenza, cit., pp. 209-212. 34Pietro Secchia (Occhieppo Superiore, 19 dicembre 1903 – Roma, 7 luglio 1973) è stato un
politico e antifascista italiano, importante dirigente del Partito Comunista. Liberato dai partigiani
nel 1943, partecipò alla Resistenza in qualità di commissario generale delle Brigate Garibaldi,
comuniste. Come Longo e altri partigiani comunisti, sosteneva una politica rivoluzionaria che
preparasse la prospettiva di un’insurrezione armata, ma aderì nell’immediato dopoguerra alla
cosiddetta svolta di Salerno di Palmiro Togliatti, che spingeva il PCI alla collaborazione con gli
altri partiti di massa e con le istituzioni. Togliatti nominò Secchia vicesegretario del PCI, carica
che mantenne dal 1948 al 1955. Nel 1946 fu deputato all’Assemblea Costituente mentre nel 1948
fu eletto senatore nelle file dei Fronte Democratico Popolare; rimase senatore fino alla morte. 35 Voce GAP, in Enciclopedia dell’antifascismo e della Resistenza, Milano-Roma, Edizioni La
Pietra 1971, vol. II, pp. 475-79. Essa era diretta dallo stesso Secchia.
36
Secondo lo storico Ernesto Ragionieri il Pci ne aveva invece disposto la
creazione già con una circolare del maggio 1943.36
Questo problema di datazione è indice della scarsità – o meglio della quasi
totale inesistenza – di documenti e comunicati ufficiali che caratterizzino le
attività di queste formazioni. Elemento questo che non deve destare stupore
in quanto la natura stessa – cospirativa – dei Gap, imponeva il massimo
riserbo sulle azioni, sui componenti e sugli spostamenti; nessun particolare
doveva trapelare.
La struttura dei Gap è consequenziale agli scopi: rigidamente separato da
tutte le altre organizzazioni della Resistenza, ogni nucleo è collegato al
gradino superiore di comando esclusivamente attraverso il sistema dei
“recapiti”. Non può contare su più di quattro componenti, compresi
comandante e vicecomandante; tre Gap costituiscono un distaccamento
guidato da comandante e commissario (responsabile soprattutto del
controllo sulla vita privata e sul morale dei membri) entrambi tenuti a
partecipare alle azioni più rilevanti.
Nelle grandi città italiane, tra l’autunno del ’43 e la successiva primavera,
i Gap non superarono mai la cinquantina di appartenenti per zona, con
riduzione anche a poche unità per lunghi periodi dopo operazioni repressive
particolarmente efferate.
Molto discussa è stata la tipologia della loro azione sia durante il biennio
’43-’44, ma anche dopo, sia pure senza dissociazioni pubbliche da parte
degli organi rappresentanti il fronte antifascista di quel periodo. La
rappresentanza della Dc si opporrà per ragioni di principio (non a Genova);
quella liberale per considerazioni politiche. La scelta operativa dei
comunisti è presto condivisa anche da Gl, mentre l’approvazione socialista
–spesso con riserve – a Roma si concretizzerà nell’organizzazione di un
nucleo d’azione.
36 Cfr. E. Ragionieri, La terza Internazionale e il Partito comunista italiano. Saggi e discussioni,
Torino, Einaudi 1997, pp. 328-329.
37
Alla primavera del ’44 quasi tutti i combattenti che hanno costituito i Gap
sono caduti, uno dopo l’altro. Ad esempio per quanto riguarda Torino
possiamo ricordare: Dario Cagno, Ateo Garemi, Giuseppe Bravin, Dante Di
Nanni. Nonostante la gravità delle perdite subite, dovute a tradimenti o
confessioni estorte sotto tortura, nelle piccole e grandi città del Centro-nord
i Gap mantengono ed estendono la loro iniziativa.
Il loro sviluppo – con le Sap dall’estate ’44 – avviene in interazione con la
crescita della mobilitazione sociale, mentre l’autunno-inverno 1944-’45
segna il periodo della massima difficoltà per l’azione gappista. Un esempio
può essere dato dalla città di Milano. Qui dall’autunno ’43 i Gap sono
protagonisti della resistenza nascente. Forse per l’eccesso di sicurezza
derivante dall’esito del ciclo di operazioni intenso e cruento dei primi mesi,
un anello dell’organizzazione si rompe. La polizia segreta della Rsi penetra
fino al vertice. Il comandante Egisto Rubini, garibaldino di Spagna e
organizzatore dei Ftp francesi, arrestato e sottoposto a interrogatorio riesce
a impiccarsi in cella; Vittorio Bardini, commissario politico del comando, e
Cesare Bruno Roda, capo di stato maggiore, anch’essi combattenti della
Repubblica spagnola, sono catturati e deportati a Mauthausen. Altri gappisti
vengono arrestati o uccisi.
A fine maggio il comando generale garibaldino chiama da Torino a
Milano Giovanni Pesce perché ricostruisca la III brigata Gap. Egli riesce a
riorganizzare il gruppo e tra fine giugno e settembre la guerriglia urbana
riprende con ritmo incalzante (distruzione di locomotori e attrezzature fisse
alla stazione e deposito di Milano-Greco e di due aerei al campo militare di
Cinisello, imboscate ad automezzi sulle arterie che collegano Milano a
Torino e Varese, attacchi ai militari tedeschi o di Salò).
38
3.4 Biografia di Giovanni Pesce
Come già accennato, le testimonianze di Giovanni Pesce costituiscono una
delle principali fonti a cui attingere informazioni sull’attività dei Gap.
Le memorie della sua vita e della sua attività politica si possono
rintracciare in diversi libri,37 ma il fondamentale rimane sicuramente Senza
tregua,38 che costituisce il nucleo d’analisi di questo lavoro. Pubblicato per
la prima volta ne La clessidra nel marzo 1967, è poi arrivato alla settima
edizione nel marzo 2006. Ma è in Soldati senza uniforme39, scritto nel 1950,
che rintracciamo il fulcro di memorie che poi troveremo ampliato in Senza
tregua e su cui sarà necessario svolgere un confronto.
Prima di intraprendere un viaggio nel testo è necessario innanzi tutto
comprendere cos’è che ha permesso a Giovanni Pesce di diventare una sorta
di “eroe” della Resistenza e per farlo è doveroso volgere uno sguardo alle
esperienze di vita che più hanno contribuito a “forgiare il suo animo
gappista” , in primis la partecipazione alla guerra di Spagna.
Egli nacque il 22 febbraio 1918 a Visone (da qui il soprannome datogli a
Milano di “comandante Visone”), in provincia di Alessandria. Dopo pochi
anni la sua famiglia dovette emigrare in Francia alla ricerca di
un’occupazione e di una condizione migliore. Alla Grand’Combe, dopo
avere frequentato le scuole elementari, iniziò subito a lavorare per aiutare la
famiglia. A 14 anni scese in miniera, dove coltivò il suo desiderio di
indipendenza e il piacere di condividere la fatica con gli altri lavoratori.
Ben presto prese a frequentare la "Jeunesse communiste", l’organizzazione
giovanile del PCF, il Partito Comunista Francese. Nel 1935 aderì al Partito
Comunista d’Italia e, nel 1936, in febbraio, si recò in gita a Nîmes con gli
amici e, più tardi, per festeggiare la vittoria elettorale del Fronte Popolare, a
37 Vd. bibliografia. 38 G. Pesce, Senza tregua, Milano, Feltrinelli 1967. 39 G. Pesce, Soldati senza uniforme, Roma, Edizioni di Cultura Sociale 1950.
39
Parigi, ove visitò la sede del giornale del PCF, «L’Humanité», che da
giovane minatore comunista diffondeva ogni domenica alla Grand’Combe.
Qui raccolse i volantini a favore del governo repubblicano spagnolo firmati
ed illustrati da Joan Miró e ascoltò l’appello della Pasionaria, Dolores
Ibárruri, ad arruolarsi nelle Brigate Internazionali per prendere parte alla
guerra civile di Spagna. Egli si arruolò e si recò in Spagna insieme a
numerosi altri giovani antifascisti d’origine italiana. Infatti a partire
dall’ottobre del 1936 si vennero costituendo delle formazioni armate di
volontari a sostegno della Repubblica di Spagna, le "Brigate
Internazionali". Formate soprattutto da antifascisti provenienti dalle
Americhe e da tutt’Europa, giunsero a contare circa 40.000 uomini di ben
70 nazionalità diverse, con prevalenza di francesi, italiani e tedeschi,
animati non solo da spirito di solidarietà verso i repubblicani spagnoli, ma
anche dalla speranza di porre un freno all’espansione del fenomeno fascista
anche nei propri Paesi d’origine.
Pesce, tra i primi a giungere in Spagna, come gli altri volontari fu, una
volta arrivato sul posto, aggregato ai volontari italiani organizzati nella
"Brigata Garibaldi", costituita ad Albacete nel novembre del 1936, sebbene
fosse nel frattempo divenuto quasi di madre lingua francese.
Il suo primo impiego in battaglia si ebbe il 17 dicembre nei pressi di
Madrid, a Boadilla del Monte. Impegnato spesso in prima linea durante
tutta la durata dell’impiego delle Brigate Internazionali nel conflitto, rimase
più volte ferito in combattimento (riportandone lesioni anche serie e rose di
schegge mai rimosse dalle sue carni), prima a Brunete, quindi due volte
presso Saragozza e in occasione dell’offensiva sul fiume Ebro.
Sul finire del 1938 la Repubblica congedò le Brigate internazionali e di lì a
pochi mesi crollò. Il 1° aprile 1939 Franco annunciò la fine della guerra e
l’inizio di una dittatura di stampo fascista, il Franchismo, conclusasi di fatto
solo con la sua morte, il 20 novembre 1975.
40
Lasciata la Spagna e poi la Francia, Pesce rientrò in Italia nel 1940 ma fu
subito arrestato e inviato al confino sull’isola di Ventotene, ove conobbe
alcuni tra i massimi rappresentanti politici dell’antifascismo italiano.
Liberato nell’agosto del 1943, si unì alle prime formazioni partigiane e fu
tra i fondatori dei GAP di Torino. Qui svolse, con il nome di battaglia
"Ivaldi", numerose azioni di sabotaggio contro l’occupante nazifascista e
uccise diversi esponenti del regime fascista, spie e collaborazionisti, tra i
quali il maresciallo della Milizia e amico personale di Benito Mussolini
Aldo Mores, e il giornalista fascista Ather Capelli (31 marzo 1944). A
Torino, il 18 maggio 1944, avvenne anche la morte di Dante Di Nanni,
membro del GAP comandato da Pesce, subito dopo l’attentato contro la
stazione radio dell’Eiar che disturbava le trasmissioni di Radio Londra.
In seguito a questi ultimi avvenimenti, nel mese di maggio 1944 Pesce si
trasferì a Milano, dove riorganizzò la formazione locale. Qui operò con la
staffetta partigiana "Sandra", Nori Brambilla, che dopo la Liberazione, il 14
luglio 1945, divenne sua moglie.
Dopo la seconda guerra mondiale è stato consigliere comunale a Milano
nelle file del Partito Comunista Italiano, dal 1951 al 1964, e consigliere
nazionale dell’ANPI fin dalla fondazione. Nel 1991 entrò nel Partito della
Rifondazione Comunista, continuando sino alla fine la sua attività politica e
di testimonianza sulla Resistenza e i suoi valori, riconoscendosi nelle
posizioni dell’area Essere comunisti. Ha firmato con Claudio Grassi il
secondo documento congressuale all’ultima assise nazionale del PRC.
Per le sue attività nella Resistenza italiana, il 23 aprile 1947 è stato
insignito della Medaglia d’Oro al Valor Militare per decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri Alcide De Gasperi. Un’iniziativa per nominare
Giovanni Pesce Senatore a Vita ha raccolto 2450 firme fino al 26 luglio
2007, e continua a ricevere firme come omaggio postumo alla figura del
"Comandante Visone".
Giovanni Pesce è morto a Milano il 27 luglio 2007, all’età di 89 anni.
41
La miniera alla Grand’Combe, la partecipazione alla Guerra di Spagna, il
confino a Ventotene sono tutte esperienze che si riveleranno indelebili nella
sua memoria e che spesso si sovrapporranno ai ricordi della guerra di
liberazione che combatté in Piemonte e Lombardia.
42
Capitolo 4
SENZA TREGUA TRA STORIA, MEMORIA E
LETTERATURA
4.1 Due guerre, un solo nemico
Abbiamo già detto come Senza Tregua sia il libro di memorie di Giovanni
Pesce che racconta la sua esperienza come gappista prima in Piemonte e a
Torino e poi in Lombardia e a Milano. Esso si apre in data 9 settembre
1943, all’indomani dell’armistizio, giorno in cui Pesce si trova ad Acqui, in
provincia di Alessandria, e si chiude con il 25 aprile a Milano. Tra queste
due date si sviluppa un racconto primo, narrato al presente, che è costituito
dalla lotta partigiana che egli, insieme ai suoi compagni, compì nelle
metropoli, a cui si inframmezza un racconto secondo, narrato al passato,
costituito dalle memorie della guerra spagnola.
Perché questa scelta?
Bisogna innanzi tutto considerare cosa ha significato per molti italiani
antifascisti combattere quella guerra.
Luigi Ganapini ha provato a spiegarlo argomentando che la guerra civile
di Spagna fu il terreno di prova e il grande momento di diffusione
internazionale per l’antifascismo unitario prospettato dai Fronti popolari.40
Fu una guerra dai caratteri complessi, che coinvolse anche la
partecipazione internazionale. Le grandi potenze si erano formalmente
accordate su un patto di non intervento, ma l’Italia e la Germania inviarono
ugualmente truppe e materiale bellico a sostegno dei fascisti spagnoli,
facendo le prime prove della strategia terroristica che caratterizzerà pochi
40 L. Ganapini, Antifascismo, in Dizionario della Resistenza, a cura di Enzo Collotti, Renato Sandri
e Frediano Sessi, Torino, G. Einaudi 2001, pp. 15-16.
43
anni dopo la guerra mondiale. In soccorso alla repubblica spagnola
accorsero combattenti volontari da tutti i paesi, che costituirono le Brigate
Internazionali, per un totale di circa quarantamila uomini.
La guerra di Spagna fu un banco di prova decisivo: da una parte
dimostrava la determinazione feroce e la gratuità dell’intervento delle
potenze fasciste, dall’altra denunciava la totale incapacità delle potenze che
si dicevano democratiche di reagire con efficacia. Fu l’antifascismo
internazionale che tra gli uni e gli altri trovò la strada per opporsi con forza
e dignità alla violenza del totalitarismo nazista e fascista.
Per l’antifascismo internazionale e per quello italiano in particolare la
Spagna rappresentò dunque un momento decisivo di presa di coscienza
internazionalista, antifascista e antimperialista. Inoltre per l’antifascismo
italiano la guerra di Spagna fu la prima occasione di scontro armato contro
il fascismo.
E a proposito della pagine dedicate alla Spagna inserite nel suo libro è lo
stesso Pesce a dire:
Se è vero che in terra spagnola il fascismo fece la prova generale della
successiva aggressione all’Europa è altrettanto vero che in Spagna si
formarono, si temprarono i valorosi combattenti della Resistenza italiana ed
europea. Combatterono il fascismo in Spagna gli organizzatori e i comandanti
gappisti come Barontini, Garemo, Rubini, Bonciani, Leone, Bardini, Roda,
Spada ed altri. Ed è proprio in virtù degli antifascisti italiani delle Brigate
Internazionali che la Resistenza italiana poté contare, fin dall’inizio, su molti
uomini politicamente e militarmente preparati, pronti cioè ad affrontare con
mezzi di fortuna un nemico bene organizzato.41
Ed è proprio la struttura stessa del libro che permette a Giovanni Pesce
quest’alternarsi – e a volte quasi sovrapporsi- delle due memorie.
In esso sono presenti 14 capitoli all’interno dei quali vengono utilizzati –
non sempre- gli asterischi per gli stacchi temporali (spesso i flash-back) e/o
situazionali. 41 G. Pesce, Senza Tregua, , Milano, Feltrinelli 1967, p. 9.
44
Un vero e proprio impianto cinematografico, per cui il lettore viene
continuamente catapultato dall’una all’altra dimensione (guerra civile
spagnola-guerra di liberazione a Torino o Milano), vi si ritrova immerso, la
vive con il protagonista-narratore.
Ma come affiorano i ricordi della guerra combattuta in Spagna?
La risposta non è univoca. Spesso si tratta di un vero e proprio salto
improvviso nel tempo, come avviene in questa pagina in cui troviamo
inizialmente il racconto che fa Pesce della terza azione compiuta dai Gap
torinesi, la quale si conclude così:
Nel pomeriggio si riunirà il Comitato di liberazione piemontese per discuterne
e per fronteggiare le rappresaglie dei nazisti. Approverà o sconfesserà la mia
iniziativa? Saprà che un garibaldino, un gappista, ha giustiziato gli ufficiali
nazisti.42
A questo punto compare il segno dell’asterisco (altrove potrà non
esservi), e così riprende:
La battaglia di Guadalajara: verso la fine di dicembre giunse l’ordine di
partenza per il fronte di Mirabuena. Il Battaglione Garibaldi che al primo
scontro con i franchisti a Madrid, era arrivato il prima linea senza fucili, era
equipaggiato completamente. Partimmo un mattino presto, con buio fitto.43
Altrettanto spesso sono pensieri, sensazioni, che sopraggiungono
soprattutto nei momenti di solitudine, a farlo tornare indietro nei ricordi.
Frequenti sono i flash-back nei momenti in cui Pesce si rende conto della
solitudine a cui è costretto il gappista. Seppur diverse, sia quella combattuta
a Torino, sia quella combattuta in Spagna, sono entrambe guerre; guerre in
cui egli si trova comunque in prima linea, in cui fronteggia il medesimo
nemico. Far parte dei gap, combattere in città, in quel momento e con quelle
modalità, significa essenzialmente vivere la sensazione di lottare in
42 G. Pesce, Senza tregua, cit., p. 48. 43 Ibidem.
45
solitudine, il che rimanda – inevitabilmente – alla “moltitudine” dei
compagni di guerra in Spagna.
Quando Pesce non trova il coraggio di uccidere il maresciallo Aldo
Mores, spiega così la sua paura:
Ora so perché sono scappato dal negozio. Mi ha paralizzato l’impressione di
essere solo a combattere una guerra diversa, ho sentito la mancanza dei
compagni che corrono attorno a me all’assalto. Mi ha bloccato il silenzio al
posto del grido che esce insieme da cento petti. Non ci sono bandiere spiegate
in questa guerra, non c’è l’eroismo del bel gesto in faccia alla moltitudine degli
amici e dei nemici. Ma la guerra è la stessa.44
E ancora qualche pagina prima sempre in relazione al mancato omicidio:
È difficile definire quello che ci sta accadendo. Paura, rabbia, tensione si
mescolano ad un odio profondo verso un nemico che ci costringe a metodi di
lotta ben diversi da quelli a cui eravamo abituati. In Spagna ed in montagna il
nemico si affrontava in combattimento: faccia a faccia. 45
Ogni cosa pare portare alla memoria la guerra di Spagna: le ferite che
ancora fanno male, un treno che ricorda l’inizio dell’avventura della guerra
civile, il sentimento di paura, ma persino le macchie del soffitto che Pesce
spesso si trova a fissare nel suo nascondiglio, nelle interminabili ore – se
non giorni – di solitudine e isolamento.
È così che piano piano «quella grande [la macchia] diventa la Casa del
Campo»,46 dove poi si scoprì si nascondevano i fascisti, mentre «quell’altra
macchia, quella lunga e contorta che taglia in due il soffitto, può diventare
una strada; la strada di Jarama».47
I ricordi di Spagna avranno sempre un grande peso nel corso di tutta la sua
vita. Chiunque abbia conosciuto il “comandante Visone”, nota come nei 44 Ivi, p. 39. 45 Ivi, p. 35. 46 Ivi, p. 107. 47 Ivi, p. 108.
46
momenti in cui tornava indietro nel tempo con la memoria, egli
privilegiasse sempre i racconti che si rifacevano all’esperienza lì vissuta,
lasciando agli uditori la sensazione che il periodo gappista rimanesse quasi
in secondo piano.
Forse questo non è poi così strano. La Spagna rappresenta il primo
momento di contatto con la guerra, il combattere in prima persona,
un’esperienza tremendamente forte, in cui anche la morte diviene una
presenza drammaticamente vicina. Va poi ricordato che quando Pesce si è
affacciato a quell’esperienza aveva solamente diciotto anni; pertanto viverla
ha permeato completamente la sua visione della vita e inciso nella sua
crescita. Resta poi l’elemento di quelle schegge che gli rimasero conficcate
in corpo per tutta la vita, un dolore incessante che lo accompagnò fino alla
fine dei suoi giorni, quotidiano rammentatore dei giorni passati.
4.2 Io narrante/io testimone
Pesce narra praticamente sempre in prima persona (vedremo più avanti le
significative eccezioni). L’“io narratore” e l’“io testimone” sono
sovrapposti, un espediente questo spesso condiviso con la narrativa della
deportazione. Lui è il testimone diretto di quello che accade, partecipa agli
avvenimenti, vede con i suoi occhi.
La questione dell’uso dell’io è antichissima: già Tucidide lo poneva alla
base della trattazione sulla Guerra del Peloponneso:
Ho ritenuto mio dovere descrivere le azioni compiute in questa guerra non sulla
base di elementi d’informazione ricevuti dal primo che incontrassi per via; né
come paresse a me, con un’approssimazione arbitraria, ma analizzando con
infinita cura e precisione, naturalmente nei confini del possibile, ogni
particolare dei fatti cui avessi di persona assistito, o che altri mi avessero
riportato.48
48 Tucidide, La guerra del Peloponneso, tr. it. di Ezio Savino, Milano, Garzanti 1974, vol. I, p. 16.
47
E prima ancora sosteneva:
Gli argomenti invece e gli indizi da me addotti assicurano la possibilità di
interpretare i fatti storici, quali io stesso ho passato in rassegna, con una
certezza che non si discosta essenzialmente dal vero.49
Lo status di testimone diretto dei fatti costituisce quindi una sorta di
garanzia di veridicità per il lettore. Ciò che noi sappiamo sui Gap lo
sappiamo in ultima analisi grazie a Giovanni Pesce.
Egli ci narra con stile scarno, netto, con un ritmo sempre incalzante, le
continue azioni messe in atto dai Gap, la meticolosa preparazione che vi
stava dietro, e la tensione che li accompagnava costantemente, la “febbre
dell’azione”.
A ciò si aggiungono straordinari momenti di intima riflessione, pieni di
drammaticità, in cui Pesce riflette sul significato del proprio operato
quotidiano, sul senso di angoscia provocato dall’isolamento forzato, ma
soprattutto sulla paura. Una paura che ritroviamo come protagonista nel
secondo capitolo. Qui terrore, tensione, angoscia fanno da filo conduttore
alla narrazione, una sorta di Leitmotiv; sono sentimenti che pervadono
infiniti aspetti del vivere quotidiano, dell’agire politico e dell’atmosfera
delle due guerre. In poco più di dieci pagine questi termini appariranno ben
ventidue volte. Se riferiti alla guerra spagnola li ritroviamo nella paura dei
volontari in partenza, che si lasciavano per sempre alle spalle quella che era
stata fino a quel momento la loro vita, ma c’è anche il terrore sul volto del
nemico che, prima orgoglioso e prepotente, quando poi si trova di fronte
alla morte perde ogni controllo della propria persona, trasfigurandosi per la
paura e supplicando per la vita.
La paura è ancora più presente nella guerra che Pesce combatte a Torino.
L’intera città è permeata da questo sentimento: paura delle rappresaglie,
49 Ivi, p. 15.
48
timore che il proprio vicino sia una spia, terrore del plotone tedesco. Ma
anche “Visone” ha paura, molta. Una paura legata indissolubilmente al
senso di solitudine che si prova a sentire di essere soli nel combattere una
guerra, solo tu e il nemico. È un sentimento che fa perdere il controllo di se
stessi e che comincia appunto dal senso di abbandono e impotenza:
La paura mi ha tolto il controllo di me stesso, ma a gradi, non all’improvviso. È
cominciata da quel senso di solitudine e di impotenza. Mi sono sentito braccato
prima di cominciare e, quando ho deposto la bicicletta presso il negozio,
immaginavo già i repubblichini che mi inseguivano.50
E la paura, il terrore è proprio la strategia messa in atto dall’oppressore
nazi-fascista, uno dei suoi strumenti di guerra privilegiati, che i gappisti
sapranno fare loro e usare contro il nemico: «Risponderemo al terrore con il
terrore»51, «Colpire il terrore con il terrore».52
4.3 La morte di Dante di Nanni
Un’analisi a parte merita il capitolo sesto, dal titolo Morte e
trasfigurazione, dedicato alla morte di Dante Di Nanni, giovane gappista
torinese, percepito come un vero e proprio eroe della Resistenza dalla
memoria cittadina.
Innanzi tutto bisogna notare come queste pagine siano le uniche in cui si
parla in terza persona. Qui Giovanni Pesce non si pone più nell’ottica
dell’io testimone, bensì in quella del narratore onnisciente, in grado di
conoscere gli intimi pensieri del compagno Di Nanni e persino quelli della
madre di questi.
Il capitolo prende avvio dall’ordine ricevuto di far saltare la radio che
disturba le frequenze di Radio Londra. È un’operazione che “Ivaldi” (il
50 Ivi, p. 37. 51 Ivi, p. 32. 52 Ivi, p. 32.
49
nome di battaglia che Pesce aveva a Torino) fin da subito percepisce come
complessa in quanto presenta dei problemi per la ritirata dopo l’azione, ma
alla fine concluderà così: «Ci ritireremo risalendo lo Stura: se rischio di
essere scoperti c’è, perché saranno in allarme, è un rischio che dobbiamo
correre. D’altra parte non vedo altre vie d’uscita».53
Il capitolo è costellato da continue anticipazioni. In un punto del capitolo
Pesce narra l’avvicinamento all’obiettivo. Nel paragrafo successivo invece
ci troviamo già dopo il compimento dell’azione (che ci verrà poi narrata in
un successivo paragrafo) e “Ivaldi” è vicino al letto sporco del sangue delle
ferite di Dante Di Nanni.54 Da qui prendono avvio alcune pagine altamente
drammatiche in cui Di Nanni, in un dialogo con Pesce, vede avvicinarsi la
morte e capisce che non potrà vedere la fine della guerra. In lui si
susseguono sensazioni di paura, rabbia, sofferenza e orgoglio. Il loro
discorso riprenderà poi qualche pagina dopo assumendo la forma di un
dialogo intimo, amichevole, affettuoso, in cui emerge tutto l’eroismo dei
personaggi. L’intensità dello scambio di parole è molto forte e ne escono
fuori due eroi pieni di umanità, con le loro paure e insicurezze.
Le ultime parole di Di Nanni sono domande tese a dare un senso a quanto
compiuto fino a quel momento. Egli vuole quasi essere rassicurato sulla
grandezza del loro partito e sul fatto che per il dopoguerra esso punti sui
giovani. Domande che rispecchiano una forte incertezza per ciò che avverrà
quando tutto sarà finito.
Dal momento in cui Pesce se ne va dicendo che presto arriveranno i
soccorsi, prende avvio un vero e proprio racconto epico che ha come
protagonista Dante di Nanni. Egli è rimasto solo, ha voluto accanto al letto
due mitra, uno sten e il sacco degli esplosivi con le micce a strappo già
pronte e infilate nei detonatori. Sente arrivare i tedeschi che presto
aumentano di numero, fanno sgomberare l’edificio e lo circondano da ogni
53 Ivi, p. 113. 54 Ivi, p. 117.
50
lato. Le pagine che seguono vedono l’estrema supremazia di Di Nanni
rispetto al nemico, in una sorta di “uno contro tutti”. Egli riesce ad uccidere
un numero altissimo di soldati tedeschi (in Soldati senza uniforme Pesce li
quantifica in più di trenta)55 fino a quando non gli rimane più nessun’arma a
disposizione e decide di suicidarsi.
Così Pesce descrive il momento della morte del compagno:
Adesso non c'è più niente da fare: allora Di Nanni afferra le sbarre della
ringhiera e con uno sforzo disperato si leva in piedi aspettando la raffica. Gli
spari invece cessano sul tetto, nella strada, dalle finestre delle case, si vedono
apparire uno alla volta fascisti e tedeschi. Guardano il gappista che li aveva
decimati e messi in fuga. Incerti e sconcertati, guardano il ragazzo coperto di
sangue che li ha battuti. E non sparano.
È in quell'attimo che Di Nanni si appoggia in avanti, premendo il ventre alla
ringhiera e saluta col pugno alzato. Poi si getta di schianto con le braccia aperte
nella strada stretta, piena di silenzio.56
Da notare la differenza con cui lo stesso episodio si conclude nelle prime
memorie scritte da Giovanni Pesce, Soldati senza uniforme:
I vigili si erano ritirati mentre i tedeschi, sempre più furibondi, facevano
arrivare sul posto i due carri armati e riprendevano a sparare all’impazzata.
Così, il 18 marzo 1944, Dante Di Nanni moriva da eroe: la popolazione del
rione, attirata nella strada dalla battaglia, salutava con commosso silenzio la
morte di questo glorioso combattente.57
Pare quindi non esservi traccia del coraggioso suicidio di Di Nanni.
Questo elemento, insieme ad altri, ha portato lo storico Nicola Adduci a
svolgere alcune ricerche, ancora inedite, circa le circostanze della morte del
giovane gappista. Non entreremo qui nel merito dei dati da lui rilevati, in
quanto in questa sede non ci interessa fare una ricostruzione storica degli
eventi, bensì osservare come a distanza di anni, gli stessi ricordi, le stesse
55 G. Pesce, Soldati senza uniforme, Roma, Edizioni di cultura sociale 1950, p. 100. 56 G. Pesce, Senza tregua, cit., p. 145. 57 G. Pesce, Soldati senza uniforme, cit., p. 101.
51
memorie, possano subire variazioni, anche in base alle nuove circostanze e
alle scelte che si operano.
Quanto riportato sopra costituisce un esempio del rischio di accostarsi ai
testi di memoria attribuendo loro la stessa validità di una fonte storica in
senso tradizionale.
Come già osservato precedentemente, il ruolo della letteratura non è
quello di fornire una precisa ricostruzione storica degli eventi, bensì di
fornirci altri elementi, donandoci il senso complessivo dell’esperienza.
L’intento di Pesce, come quello di molti altri memorialisti, è pedagogico.
È lui stesso a dircelo:
“Senza Tregua” ha una morale profondissima valida oggi come ieri. È un
insegnamento che gli uomini, i giovani che furono impegnati in drammatiche
battaglie, hanno consegnato ad altri uomini, ad altri giovani, oggi impegnato
nel lavoro o nello studio, perché sappiano lottare per le libere istituzioni, la
giustizia, la libertà, la democrazia.58
Quindi si tratta di raccontare affinché le nuove generazioni sappiano ciò
che è stato, perché non si ripeta, nella speranza che, con la scomparsa di
coloro che hanno combattuto per la libertà della gente, ci sia qualcuno
disposto a “raccogliere il testimone”.
58 G. Pesce, Senza tregua, cit., p. 9.
52
CONCLUSIONI
Uno degli scopi che si prefiggeva questo lavoro era di tentare di “mettere un
po’ d’ordine” nel variegato mondo di tutta quella memorialistica che in qualche
modo scaturisce dagli eventi che si verificarono in Europa e soprattutto in Italia
negli anni ’43-’44. Una memorialistica composta essenzialmente da due filoni,
quello resistenziale e quello che si rifà alla deportazione sia politica che razziale,
che in un certo senso fanno parte di una più ampia produzione a carattere
antifascista.
La memorialistica concentrazionaria è però in un certo senso “una scoperta
recente”, infatti solo negli ultimi anni si è iniziato a studiarne le peculiarità, ad
analizzarlo come “evento a sé”. Non è che non vi fossero scritti lasciati dai
sopravvissuti, al contrario vi erano molte memorie, ma non vi era stato l’interesse
da pare della letteratura e della storiografia ad analizzarne le specificità e gli
elementi più problematici.
Per anni infatti il tema dominante è stato appunto quello della Resistenza,
intorno alla quale l’acceso dibattito prosegue fino ai giorni nostri. Un dibattito che
spesso è stato alimentato da “spinte politiche” che però non hanno intralciato la
qualità della produzione, bensì concorso ad una maggiore volontà di
approfondimento e comprensione dell’evento,.
La memorialistica è per sua definizione un genere “spurio”, in cui vi si
incrociano e sovrappongono storia e letteratura, pertanto richiede degli strumenti
di analisi particolari e adeguati alla sua natura.
Si è visto come da un lato essa per anni sia stata catalogata come letteratura di
“serie b”, considerata una sorta di sottogenere, ma fortunatamente negli ultimi
anni è stata riabilitata, grazie anche all’alta attenzione ricevuta da uno degli
scrittori-testimoni simbolo della tragedia di quegli anni, Primo Levi, le cui opere
sono ormai universalmente viste non più solo come “splendidi testi di memorie”,
ma anche come prodotti letterari di un certo spessore, che meritano di essere
analizzati e confrontati: infatti intercorrono diversi cambiamenti tra Se questo è un
uomo (1947) e I sommersi e i salvati (1986) rispetto al suo approccio a quanto
vissuto nel passato.
53
Si è visto come uno degli aspetti principali di cui tener conto sia il problema
dell’utilizzo della memoria come fonte storica. Infatti uno dei rischi maggiori in
cui si è incorsi in questi anni è che da testimone, il supersite rischi di essere
trasformato in testimone coatto della propria eccezionalità. Ma non si può
delegare ad egli la ricostruzione storica di ciò che ha vissuto. Questo è compito
della storia che saprà analizzare le fonti, anche attingendo alle memorie, ma
procedendo secondo una “gerarchia”. Infatti la memoria è per sua natura soggetta
a stratificazioni, a privilegiare certi aspetti piuttosto che altri e anche a
dimenticare.
Si è scelto poi di utilizzare il libro di memorie scritto dal gappista Giovanni
Pesce, Senza Tregua, come esempio di memoria resistenziale. Un testo che
presenta diverse problematiche e peculiarità rispetto all’utilizzo della memoria e
che rappresenta una sorta di “anomalia” nel mondo della memorialistica in quanto
ciò che racconta, a causa della natura stessa –cospirativa- dell’organizzazione
gappista, per lo più non può essere supportato da fonti storiografiche.
È stato necessario svolgere quindi un confronto con le memorie precedenti di
Pesce, fare attenzione agli espedienti letterari e cinematografici utilizzati, alla
costruzione del racconto e appoggiarci ai pochi elementi storici reperibili. Un
lavoro necessario per chiunque non voglia rimanere appiattito sul mito eroico dei
personaggi e delle vicende, e desideri comprendere davvero cosa è stata
quell’esperienza e il senso profondo che ha avuto nel concorrere alla liberazione
di Torino –e non solo- dal nemico nazi-fascista.
Un lavoro propedeutico insomma, utile anche in vista dell’imminente esaurirsi
dei testimoni diretti di quel periodo, il che porterà inevitabilmente a nuovi
interrogativi rispetto alla preservazione di quella memoria, di cui principale carico
si faranno la storia e la letteratura.
Tutte queste riflessioni e proposte di metodo possono anche rendersi utili per
una corretta “pedagogia della memoria”, affinché coloro che sono preposti a tale
compito e vogliano esaurirlo in maniera approfondita e non superficiale, possano
trovarvi degli spunti di approccio alla questione.
54
BIBLIOGRAFIA
1. Opere di Giovanni Pesce
Soldati senza uniforme: diario di un gappista, Roma, Edizioni di cultura sociale
1950
Un garibaldino in Spagna, Roma, Editori Riuniti 1955
Senza tregua: la guerra dei GAP, Milano, Feltrinelli, 1976
Quando cessarono gli spari: 23 aprile-6 maggio 194, la liberazione di Milano,
Milano, Feltrinelli 1977
Il giorno della bomba: racconti, Milano, Mazzotta 1983
Un uomo di quartiere, Milano, Mazzotta 1988
G. Pesce, F.Minazzi, Attualità dell'antifascismo, Napoli, La città del sole 2004.
2. Su Giovanni Pesce e i GAP
M. De Micheli, 7. GAP, Roma, Edizioni di cultura sociale 1954
G. Speroni, Mussolini deve morire. Dicembre 1944 quando Giovanni Pesce tentò
di uccidere il duce, Milano, Bompiani 2004
A. e D. Fontanesi, Volti di libertà: partigiani che raccontano la Resistenza,
Reggio Emilia, Edizioni Bertani & C. 2005
F. Giannantoni, I. Paolucci, Giovanni Pesce "Visone", un comunista che ha fatto
l'Italia, Varese, Edizioni Arterigere-EsseZeta, 2005
3.Sulla Resistenza: saggi e memorie
L. Longo, Un popolo alla macchia, Milano, Editori Riuniti 1947
L. Valiani, Tutte le strade conducono a Roma. Diario di un uomo nella guerra di
un popolo, Firenze, La Nuova Italia 1947
55
R. Cadorna, La riscossa. Dal 25 luglio alla liberazione, Milano, Rizzoli 1948
R. Luraghi, Il movimento operario torinese durante la resistenza, Torino, Einaudi
1958
R. Battaglia, Storia della Resistenza italiana, Torino, Einaudi 1964
P. Secchia, F. Frassati, Storia della Resistenza. La guerra di Liberazione in Italia.
1943-1945, Roma, Editori Riuniti 1965
G. Pisanò, Storia della guerra civile in Italia, Milano, Mursia 1965-66, 3 voll.
AA.VV., Enciclopedia dell'antifascismo e della Resistenza, Milano-Roma,
Edizioni La Pietra 1968-1989, voll. I-VI
P. Secchia, Il Partito comunista italiano e la guerra di Liberazione 1943-1945,
Annali Feltrinelli, anno XIII, 1971
L. Valiani, G. Bianchi, E. Ragionieri, Comunisti, azionisti e cattolici nella
Resistenza, Milano, Angeli 1971
A.Agosti, G. Sapelli (a cura di), Dalla clandestinità alla lotta armata, Torino,
Musolini 1977.
G. Carocci (a cura di), Le Brigate Garibaldi nella Resistenza. Documenti, Milano,
Feltrinelli 1979
G. Oliva, La resistenza alle porte di Torino, Milano, F. Angeli, 1989
C. Pavone, Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza,
Torino, Bollati Boringhieri 1991
M. Rendina, Dizionario della Resistenza italiana, Funo, Editori Riuniti 1995.
G. Perona, Formazioni autonome nella Resistenza. Documenti, a cura dell'Insmli,
Milano, Franco Angeli 1996
E. Ragionieri, La terza Internazionale e il Partito comunista italiano. Saggi e
discussioni, Torino, Einaudi 1997
E. Collotti, R. Sandri, F. Sessi, Dizionario della Resistenza. Storia e geografia
della Liberazione, Torino, Einaudi 2000-2001, voll. I-II
P. Malvezzi, G. Pirelli (a cura di), Lettere di condannati a morte della resistenza
italiana 8 settembre 1943-25 aprile 1945, Torino, Einaudi 2005
B. Maida (a cura di), ’40-45 : guerra e società nella provincia di Torino, Torino,
Blu 2007
56
4. Sulla deportazione: saggi e memorie
P. Levi, Se questo è un uomo, Torino, De Silva 1947
B. Ceva, Tempo dei vivi 1943-1945, Milano, Ceschina 1954
L. Poliakov, J. Sabille, Gli ebrei sotto l’occupazione italiana, Milano, Comunità
1956
P. Levi, La tregua, Torino, Einaudi 1963
H. Arendt , La banalità del male [1963], tr. it., Milano, Feltrinelli 1964
R. Hochhuth, Il Vicario, tr. it., Milano, Feltrinelli 1964
V. Morelli, I deportati italiani nei campi di sterminio 1943-1945, Milano, Scuola
grafica pavese 1965
P. Levi, Se non ora quando?, Torino, Einaudi 1982
A. Bravo, D. Jalla (a cura di), La vita offesa. Storia e memoria dei lager nazisti
nei racconti di duecento sopravvissuti, Milano, Franco Angeli 1986
P. Levi, I sommersi e i salvati, Torino, Einaudi 1986
Z. Bauman, Modernità e olocausto, Bologna, Il Mulino 1992
B. Wilkomirski, Frantumi, tr. it., Milano, Mondadori 1996
G. Rochat (a cura di), Per non dimenticare. Bibliografia ragionata
dell’internamento e deportazione dei militari italiani nel Terzo Reich, Milano,
INSMLI/ANEI/GUISCO 1997, Vol. I
D. Rousset, L'universo concentrazionario, tr. it., Milano, Baldini & Castoldi 1997
R. Breitman, Il silenzio degli alleati: la responsabilità morale di inglesi e
americani nell'Olocausto, tr. it., Milano, Mondadori, 1999
A. Wieviorka, L’era del testimone, tr. it., Milano, Cortina 1999
P. V. Mengaldo, La vendetta è il racconto. Testimonianze e riflessioni sulla
Shoah, Torino, Bollati Boringhieri 2007
57
5. Prospettive
M. Corti, Il viaggio testuale, Torino, Einaudi 1978
L. Passerini, Sette punti sulla memoria per l’interpretazione delle fonti orali, in
Italia Contemporanea, n.143, 1981, pp.83-92
E. Traverso (a cura di), Insegnare Auschwitz. Questioni etiche, storiografiche,
educative della deportazione e dello sterminio, Torino, Bollati Boringhieri 1995
A. Casadei, Romanzi di Finisterre: narrazione della guerra e problemi del
realismo, Roma, Carocci 2000
M. Guglielminetti, Dalla parte dell'io: modi e forme della scrittura
autobiografica nel Novecento, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane 2002
6. Riviste e pubblicazioni varie
A. Asor Rosa, L'epopea tragica di un popolo non guerriero, in Storia d'Italia -
Annali 18 - Guerra e pace, a cura di W. Barberis, Torino, Einaudi 2002
G. Contini, Memorie di guerra e di guerra civile, in Memoria/Memorie, Centro
Studi Ettore Luccini, 2006, 1, pp. 27-49
R. Battaglia, La storiografia della Resistenza: dalla memorialistica al saggio
storico, in Il movimento di liberazione in Italia, a. XI, n. 57, ottobre-dicembre
1959
F. Uliana (a cura di), Il valore letterario e culturale della memorialistica della
deportazione, cicli I-VII, Torino, Fondazione Istituto Piemontese Antonio
Gramsci, 2002-2008
7. Filmografia
Giù la testa, di Sergio Leone (1971) vd. per uso flashback
Senza tregua di Marco Pozzi (2003)
58
8. Sitografia
www.como.istruzione.lombardia.it
www.memoriedispagna.org
www.novecentoitaliano.it
www.storia900bivc.it




























































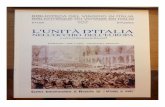


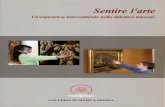











![Campagne e agricoltura attraverso il «Magazzino toscano» (1770-1782) [RSA 2010-2]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6318fbd765e4a6af370f9947/campagne-e-agricoltura-attraverso-il-magazzino-toscano-1770-1782-rsa-2010-2.jpg)



