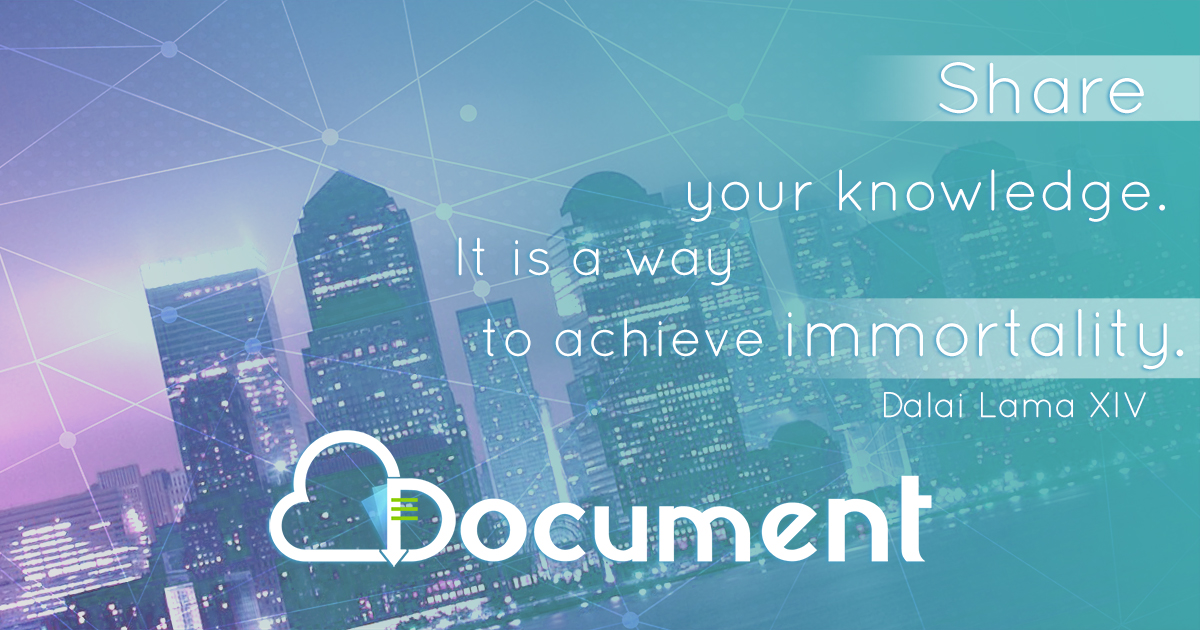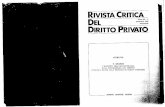Diritto di resistenza e legittimità del potere
Transcript of Diritto di resistenza e legittimità del potere
Indice
Evento e storia. Introduzione p. 1 Merio Scattola
1 2. Cartografia politica 5 3. Prima 6 4. Durante 12 5. Dopo 40 6. Alla fine 56
Alcune osservazioni su Il libro del Cortegiano di Baldassarre Castiglione p. 57 nel sistema del dialogo rinascimentale Giacomo Comiati
Per una epistemologia delle dottrine politiche europee p. 73 Merio Scattola
1. Punto di partenza. Linguaggio e politica 73 2. Ragione e forza nel Novecento 74 3. Storia del pensiero politico e storia dei concetti 76 4. Storia del linguaggio politico e repubblicanesimo 80 5. Forma e contenuto 81 6. Definizione formal 84 7. Una comunità di discorso esemplare. La scuola di Salamanca 85 8. terpretazione formale dei testi 88 9. Le 90
10. La relazione tra le forme e i contenuti politici 94 11. Anche le forme possono determinare i contenuti 95 12. Gli scambi tra le comunità di discorso 101 13. La forma e il suo significato storico 106
IV
Iconografia del Leviatano. p. 109L’importanza del frontespizio nelle opere politiche del SeicentoFederica Poletti
1. Introduzione 1092. Leviatano. Iconografia del frontespizio 1103. Il corpo politico nell’immaginario aristotelico.
Caspar Faccius e John Case 1114. La teoria della sovranità di Hobbes 1165. Il Leviatano e la tradizione 1216. Conclusioni. La filosofia politica tramite le immagini 124
Le parole e le cose nella lingua del Leviatano p. 127Marco Malvestio
1. Introduzione 1272. La teoria del linguaggio di Hobbes prima del Leviatano 1283. La teoria del linguaggio nel Leviatano 1334. Motivazioni e conseguenze
di una teoria del linguaggio nel Leviatano 1375. Il Leviatano e le teorie del linguaggio dell’antichità classica 1416. Conclusione 149
Diritto di resistenza e legittimità del potere p. 151Paolo Scotton
1. Un’aporia nel dispositivo del Leviatano 1512. Il diritto di resistenza. Interpretazioni a confronto 1593. L’autorevolezza a servizio dell’autorità 1684. Individuo e legittimità del potere. Considerazioni finali 176
Dal teatro allo scacchiere. La concezione del potere di Bernard Mandeville p. 181Giacomo Gambaro
V
Tirranide e stato di natura. Sul rifiuto d p. 193 nelle Tragedie Cinque di Gian Vincenzo Gravina Enrico Zucchi
1. Diritto naturale e stato di natura da Grozio a Rousseau 193 2. Giusnaturalismo in Italia.
Tempi e modi della ricezione italiana tra Sei e Settecento 202 3. La riflessione graviniana sul giusnaturalismo moderno tra punti
di contatto e prese di distanza. D ius sapientioris 210 4. Oltre Machiavelli.
le Tragedie Cinque di Gravina e il diritto naturale moderno 215
Kant. Politica, morale e storia p. 227 Silvia Gabbatore
1. Introduzione 227 2. Idea per una storia universale dal punto di vista cosmopolitico.
Storia e diritto 229 3. 236 4. La collocazione intermedia del diritto 241
244 6. Conclusioni 249
La statistica. L Università di Padova p. 251 Francesca Garbin e Clara Silvano
1. Introduzi 251 2. Un nuovo approccio ai fenomeni sociali 256 3. atistica 257 4. La formulazione probabilistica
261 5. La stati 266 6. Una figura tra mondo politico e accademico. Luigi Bodio 275 7. Gli oppositori della statistica 279
Appendice p. 283
Indice dei nomi p. 287
Paolo Scotton
Diritto di resistenza e legittimità del potere
1. Un’aporia nel dispositivo del Leviatano
Uno degli snodi più problematici dell’intero dispositivo predisposto da Hobbes all’interno del suo Leviathan è, e lo fu già agli occhi dei sui primi critici, quello concernente lo spazio che nella sua teoria politica è lasciato o meno aperto ad un diritto di resistenza al potere costituitosi attraverso il contratto sociale e al conseguente pactum subiectionis stipulato tra i sudditi nei confronti del sovrano. Di certo, una delle caratteristiche di tale testo è la chiarezza espositiva e il rigore quasi scientifico con i quali Hobbes procede nel corso di tutto il suo trattato, specificando il senso di ogni parola ed espressione da lui usate e dedicando, come noto, un intero capitolo - il quarto - ad una puntuale analisi del linguaggio interpretato quale strumento basilare di comunicazione intersoggettiva. Tuttavi-a, nonostante tale accortezza metodologica, il suo disegno sembra essere non privo di ambiguità e possibili incongruenze proprio laddove esso esigerebbe la più inequivocabile limpidezza. Così in un primo momento, nel delineare i limiti dell’obbligazione e dell’ubbidienza dovute al sovrano Hobbes sembra, in un primo momento, esprimersi con estrema chiarezza. Infatti, nel momento in cui il potere comune, espresso nella persona del sovrano, viene ad essere costituito esso prevede la sua entrata in vigore:
Mediante il patto di ciascuno con tutti gli altri in modo tale che è come se cia-
scuno dicesse a ciascun altro: do autorizzazione e cedo il mio diritto di governare
me stesso a quest’uomo, o a quest’assemblea di uomini a questa condizione, che tu,
nella stessa maniera, gli ceda il tuo diritto e ne autorizzi tutte le azioni1.
In tal modo, attraverso quindi questo processo di volontaria sudditanza ad un potere esterno e vincolante, ciò che ad ogni individuo viene richiesta è una esplicita rinuncia, o meglio una totale e irrevocabile cessione del proprio diritto al governo di sé, ad una persona artificiale la quale nel suo esercizio del potere
1 Thomas Hobbes, Leviatano, a cura di Arrigo Pacchi, Roma-Bari, Laterza, 2008, p.
143.
152 Paolo Scotton
eccede la somma dei singoli individui che hanno contribuito a crearla2. Tale persona artificiale, proprio in virtù di tale autorizzazione sarà quindi legittimata a compiere qualunque azione ritenga opportuna al fine di garantire la pace e la difesa comune a tutti coloro i quali hanno a lei trasferito il loro potere d’agire e la loro forza nell’agire. In tal modo, i sudditi, in seguito a tale decisione, non de-tengono più il potere di esprimere una voce dissonante rispetto a quella del so-vrano senza, nel far ciò, commettere un’ingiustizia meritevole per se stessa di essere punita3. In altre parole, il dispositivo hobbesiano d’istituzione della so-vranità espresso nel celeberrimo capitolo XVIII del Leviathan sembra essere, stando a questa prima approssimazione, assolutamente inattaccabile e per nulla equivocabile:
Infatti, posto che chi fa qualcosa con l’autorità di un altro, non fa in ciò torto a
colui con la cui autorità agisce; e posto che in seguito a questa istituzione dello Sta-
to, ogni singolo è autore di tutto ciò che fa il sovrano; ne consegue che chi si lamen-
ta di un torto del sovrano, si lamenta di ciò di cui egli stesso è autore e non deve
perciò accusare altri che se stesso - anzi, neppure se stesso, perché è impossibile fare
torto a se stessi4.
Seguendo il ragionamento del filosofo inglese sembra pertanto evidente co-me il cittadino non soltanto si arroghi la responsabilità delle azioni del sovrano, ma sia anche costretto allo stesso tempo ad accettare di esimersi da una qualsia-si forma d’intervento o manifestazione di dissenso nei confronti di ogni sua de-
2 Scrive a tal proposito Carlo Altini, Potenza come potere. La fondazione della cultura mo-
derna nella filosofia di Hobbes, Pisa, ETS, 2012, p. 103: «[I]l patto istitutivo della società po-
litica è più che il semplice consenso: è creazione dell’unità reale di tutti in una sola e me-
desima persona, dotata di volontà propria e autonoma, distinta da tutti gli individui par-
ticolari». 3 Hobbes, Leviatano, cit., p. 146. 4 Ibidem, p. 148. Cfr. Thomas Hobbes, Leviathan, a cura di Peter Berkowitz, Wash-
ington, Regnery Publishing, 2009, p. 154: «For he that doth anything by authority from
another doth therein no injury to him by whose authority he acteth: but by this institu-
tion of a Commonwealth every particular man is author of all the sovereign doth; and
consequently he that complaineth of injury from his sovereign complaineth of that
whereof he himself is author, and therefore ought not to accuse any man but himself;
no, nor himself of injury, because to do injury to oneself is impossible».
Diritto di resistenza e legittimità del potere 153
cisione. Opporsi a se stessi risulterebbe infatti incoerente, come sarebbe illogico affermare allo stesso tempo e di una stessa cosa sia che essa è che essa non è. Violerebbe, quindi, il principio basilare della logica aristotelica, vale a dire il principio di non contraddizione. Attraverso una rigorosa argomentazione logica Hobbes sembra quindi in grado di salvaguardare l’assoluta inviolabilità e non impugnabilità delle decisioni del sovrano senza dover ricorrere, per giustificare ciò, alla tradizionale legittimazione del potere istituito gratia Dei. In questo mo-do, mantenendosi all’interno di un ragionamento che in termini moderni po-tremmo definire laico, Hobbes si oppone allo stesso tempo anche alle insidiose tesi dei monarcomachi5. Tuttavia appare subito evidente, qualora si ponga que-sto passaggio a confronto con altri luoghi dell’opera del filosofo inglese, la dif-ficoltà di accettare senza ulteriori precisazioni tale univoca interpretazione del suo pensiero. Così, nel corso del capitolo XIV Hobbes aveva infatti già sosten-to che:
Esistono alcuni diritti rispetto ai quali non è concepibile che un uomo li abbia
abbandonati o trasferiti né con parole, né con segni. In primo luogo, non è possibile
che un uomo abbandoni il diritto di resistere a chi lo assale con la forza per toglier-
gli la vita, perché non è concepibile che aspiri con questo mezzo ad un qualunque
bene per se stesso6.
Affermando l’esistenza di alcuni diritti inalienabili, Hobbes sembra dunque lasciar spazio alla possibilità che l’autorità del singolo non sia totalmente rap-presentata dal sovrano e che in qualche misura essa sia irriducibile a un qualsiasi soggetto terzo. La ragione per cui tali diritti sono considerati inalienabili poggia sul fatto che è manifestamente illogico e quindi assurdo adottare un comporta-mento che non porti alcun beneficio all’adottante. Inoltre, tale assunto di fondo implica l’esistenza di altri casi in cui l’autorità del singolo sembra entrare in con-flitto con quella del sovrano. Infatti, è lo stesso Hobbes in un capitolo successi-
5 Su questo si veda Quentin Skinner, Hobbes on Representation in «European Journal of
Philosophy», XIII, 2, 2005, pp. 155-184. 6 Hobbes, Leviatano, cit., pp. 107-108. Cfr. Hobbes, Leviathan, cit., p. 114: «And
therefore there be some rights which no man can be understood by any words, or other
signs, to have abandoned or transferred. As first a man cannot lay down the right of
resisting them that assault him by force to take away his life, because he cannot be un-
derstood to aim thereby at any good to himself».
154 Paolo Scotton
vo, il XXI, a sostenere in primo luogo che vi sono non solo motivi invalidanti il patto, ma anche, in secondo luogo, che esistono valide ragioni per disubbidire al volere del sovrano. Per quanto concerne la prima eventualità, un patto è da considerarsi ipso facto nullo qualora esso implichi la non difesa del proprio cor-po. Riguardo alla seconda, pur concedendo che la società sia stata istituita a se-guito di un contratto sociale ritenuto valido, Hobbes non negherebbe però l’esistenza di diritti e libertà individuali assegnate a tutti e a ciascuno dei sudditi facenti parte dello Stato e che non possono essere tralasciati nel momento in cui esso esige ubbidienza. È proprio la pratica di tali libertà, quindi, che può tal-volta entrare in conflitto con il volere e il comando del sovrano. In questi casi, il suddito sarà pertanto legittimato a disubbidire al volere di questi. Tale libertà di disubbidire, nello specifico, è concessa in tutti quei casi in cui: a) il sovrano co-mandi ad un individuo di uccidersi o di fare del male a se stesso; b) il sovrano richieda a un individuo di confessare riguardo un crimine da quest’ultimo com-piuto; c) al suddito sia imposto uno stato di detenzione contro il suo volere; d) al suddito venga ordinato di arruolarsi tra le fila dell’esercito senza che ve ne sia assoluta necessità; e) in tutti quegli altri casi non contemplati tra i precedenti in cui il comando del sovrano metta in pericolo l’incolumità del suddito7. Al di là di ogni possibile classificazione di questi diversi casi in cui al suddito è concessa la libertà di disubbidire8, ciò che sembra emergere dalla mera giustapposizione di questi luoghi interni alla riflessione di Hobbes è una possibile incongruenza nell’apparentemente coerente teoria politica del filosofo inglese. Infatti, se da un lato i sudditi sono tenuti al rispetto assoluto del volere del sovrano da essi istituito per il proprio tornaconto, dall’altro a questi stessi sudditi sembra talvol-ta concessa la possibilità di opporsi a tale volere sulla base di alcuni principi det-tati dall’indagine razionale e che prendono il nome di leggi di natura9. In altre
7 Hobbes, Leviatano, cit., pp. 181-186. 8 Susanne Shreedhar, per esempio, sostiene che le prime tre espressioni delle libertà
soggettive si possano ritenere delle unconditional liberties of subjects – in quanto a simili co-
mandi i soggetti hanno sempre la libertà di disubbidire poiché essi sono in manifesta
opposizione con la legge di natura – mentre le ultime due sarebbero da ritenere delle
conditional liberties in quanto dipendono in primo luogo dal variare delle circostanze.
Shreedhar, Hobbes on Resistance: Defying the Leviathan, Cambridge, Cambridge University
Press, 2010, pp. 59-76. 9 Nella definizione fornita da Hobbes, legge di natura è «un precetto o una regola
generale scoperta dalla ragione, che proibisce ad un uomo di fare ciò che distruggerebbe
Diritto di resistenza e legittimità del potere 155
parole, il sovrano sembra essere istituito al fine di garantire le condizioni di base che rendono in grado ogni uomo di godere – senza causare con questo alcun detrimento ad altri individui – di quei diritti che egli chiaramente non possiede nello stato di natura, ma che aspira ad ottenere all’interno dello Stato nella mi-sura in cui ciò non risulta irrazionale. Tuttavia, sembra ammettere Hobbes, esi-stono delle circostanze in cui il potere delle leggi entra in conflitto con il detta-me delle leggi di natura. L’intera questione può quindi essere riformulata, usan-do il lessico dello stesso Hobbes, come un possibile conflitto tra legge di natura (chiamata legge solo in senso improprio) e legge civile. La preservazione di sé non ha infatti a che fare con l’esercizio delle libertà naturali e quindi con il diritto naturale, ma ha a che fare con la leggi di natura, quindi non può essere mai ac-cantonata o abbandonata volontariamente dal soggetto10. Tuttavia Hobbes, in diversi luoghi del Leviathan, sembra esprimersi in maniera netta ed inequivocabi-le in favore di una sorta di impossibilità logica del verificarsi di tale conflitto tra le due leggi. Non solo egli sostiene, come è lecito aspettarsi, che «il sovrano […] in quanto egli stesso è suddito di Dio, è perciò vincolato ad osservare le leggi di natura»11, ma addirittura che «la legge di natura e la legge civile si contengono reciprocamente e sono di pari estensione»12. È però proprio la presenza e l’accettazione di quest’ultima premessa che sembra senza alcun dubbio esclude-re la possibilità stessa che i sudditi siano posti nella condizione di esprimere la propria libertà di disubbidire ai voleri del sovrano, poiché in tal caso violerebbe-ro la legge civile, che altro non sarebbe che la legge di natura13. Proprio la stessa
la sua vita o che gli toglierebbe i mezzi per conservarla, e di non fare ciò che egli consi-
dera meglio per conservarla».Cfr. Hobbes, Leviatano, cit., p. 105. 10 Diversamente da quanto accade per il diritto naturale, infatti, scrive Hobbes in i-
bidem, p. 222, che «Il diritto naturale, cioè la libertà naturale dell’uomo, può essere ridot-
to e limitato: anzi, il fine del fare le leggi non è altro che tale limitazione; senza la quale
non possibile pace veruna». 11 Ibidem, p. 178. 12 Ibidem, p. 221. 13 Sulla difficoltà di accettare questa tesi si veda lo scritto di Locke, polemicamente
indirizzato proprio contro questo assunto hobbesiano. John Locke, Saggi sulla legge natu-
rale, Roma-Bari, Laterza, 2007, p. 11-12: «In quale situazione si troverebbero mai gli in-
teressi umani, se non esistesse un’altra, superiore legge di natura alla quale anche i go-
vernanti devono obbedire dal momento che non sono, e non possono essere, vincolati
alle proprie leggi positive, né da quelle degli altri?».
156 Paolo Scotton
legge di natura in base alla quale i sudditi, in quanto impossibilitati a farsi o a lasciarsi fare del male14, ritengono possibile disubbidire al sovrano. Di fronte a tale non sequitur infatti, ciò che emerge dall’esistenza dei casi sopracitati, in cui ai sudditi è concessa la libertà di esprimere apertamente, e talvolta pure in modo violento, il proprio dissenso, è pertanto un insanabile conflitto tra la legge di natura nella sua espressione individuale e la legge civile che, in quanto tale e per sua stessa definizione, non può che rivolgersi all’interezza del corpo sociale. La legge di natura che si esprime attraverso le leggi poste dal sovrano lo fa nel suo carattere universale, il quale è talvolta dimentico della e in opposizione alla sua espressione individuale15. I cittadini, infatti, pur essendo vincolati al rispetto del-le leggi come a «catene artificiali»16 e pur potendo manifestare la propria libertà solo entro i limiti da esse imposti loro (infatti, come visto, compito della legge altro non è che porre limiti ai diritti naturali) conservano tuttavia il diritto di re-sistere alle obbligazioni del sovrano in tutte quelle occasioni in cui la violazione di tale diritto comporta una violazione della legge di natura per l’individuo. Sembra quindi che nell’istituzione stessa del regnante e attraverso il patto con lui stipulato, gli individui non cedano a lui interamente, in quanto impossibilitati a farlo, i propri diritti. Segnatamente, poiché un uomo «non può mai abbando-nare di difendere la propria vita e i mezzi necessari alla vita stessa»17, l’autoconservazione di sé sembra configurarsi non solo come una tendenza na-turale, ma pare anche dar vita, contrariamente alle intenzioni esplicitamente e-spresse da Hobbes, ad un diritto di autodifesa non totalmente alienabile all’interno del contratto sociale. Ciò sembrerebbe però lasciare aperta, anzi spa-lancata, la porta al dissenso dei cittadini nei confronti del sovrano e, quindi, al rischio di un conflitto autolesionista tra poteri legittimi all’interno del commonwe-alth; scenario, quest’ultimo, che Hobbes sembra voler esorcizzare in ogni modo.
Tali possibili incongruenze e difficoltà, presenti specificatamente all’interno del Leviathan, hanno dato vita a interpretazioni tra loro molto diverse e talvolta
14 Hobbes, Leviatano, cit., p. 105. 15 Così, ad esempio, Perez Zagorin traccia una distinzione tra legge civile (o positi-
va) e legge di natura intesa come espressione d’un dovere morale che trascende i limiti
della mera legge civile. Essa, si identificherebbe con un richiamo all’equità, ovvero a una
giustizia distributiva che proprio a singoli casi si rivolge. Cfr. Zagorin, Hobbes and the
Law of Nature, Princeton, Princeton University Press, 2009, in particolare alle pp. 84-98. 16 Hobbes, Leviatano, op cit., p. 177. 17 Ibidem, p. 111.
Diritto di resistenza e legittimità del potere 157
incompatibili. Il filosofo tedesco Carl Schmitt, per esempio, ha escluso in modo categorico la possibilità di leggere le parole di Hobbes come l’espressione di uno spazio lasciato aperto al diritto di resistenza18. Egli, anzi, ha sostenuto addi-rittura che nello scritto di Hobbes vi sarebbe una lucida difesa della totale arbi-trarietà delle decisioni del sovrano indipendentemente da ogni giudizio ad esso contrapposto19. Più recentemente, anche Philip Pettit ha argomentato in favore di una interpretazione che vede in Hobbes un difensore del potere assoluto del sovrano, senza il quale non si potrebbe dare alcuno Stato e, di conseguenza, al-cun diritto reciprocamente riconosciuto20. Seppure a tale tesi non si possa tro-
18 Carl Schmitt, Sul Leviatano, Bologna, Il Mulino, 2011, p. 82: «Nello stato assoluto
di Hobbes, un diritto di resistenza, come «diritto» sullo stesso piano del diritto statuale,
è, da ogni punto di vista, sia pratico sia giuridico, un controsenso e un’assurdità. Il ten-
tativo di resistere al Leviatano, meccanismo tecnicamente perfetto di comando, strapo-
tente e capace di annientare ogni opposizione, è praticamente del tutto privo di speran-
za. Ma la formulazione giuridica di un diritto a una siffatta resistenza è impossibile già
come questione o come problema. Manca ogni possibilità di impostare un diritto di re-
sistenza, non importa se debba essere un diritto soggettivo oppure oggettivo: per esso
non c’è assolutamente posto nello spazio dominato dall’irresistibile grande macchina». 19 Carl Schmitt, I tre tipi di pensiero giuridico, in Le categorie del “politico”, in Saggi di teoria
politica, a cura di Gianfranco Miglio e Pierangelo Schiera, Bologna, Il Mulino, 1972, pp.
245-275, in particolare alle pp. 263-264: «Tutto il diritto, tutte le norme e le leggi, tutte
le interpretazioni di leggi, tutti gli ordinamenti sono sostanzialmente, per lui [Hobbes],
decisioni del sovrano, e sovrano non è un monarca legittimo o un’istanza competente,
ma esattamente colui che decide da sovrano. […] Auctoritas, non veritas facit legem».. 20 Philip Pettit, Made with words, Princeton, Princeton University Press, 2008, pp.
123-125: «The fact that the people exist as a body only in and trough the sovereign also
has a related implication, bearing on rebellion. […] By Hobbes’ analysis the political
incorporation found in the commonwealth is implicit, voluntary, and valid under natu-
ral law, and the source of an absolute obligation of obedience to the sovereign». Su una
linea simile si era già attestata l’interpretazione di Giuseppe Duso, La logica del potere,
Monza, Polimetrica, 2007, p. 104: «Con il concetto di sovranità […] scompare l’idea di
un agire che rapporti i cittadini tra loro, quale era l’agire di governo, così come la re-
sponsabilità e la guida che erano proprie di tale agire. Si determina un rapporto di co-
mando-obbedienza che ha carattere formale; e tale aspetto appare fondamentale, perché la
pace non può essere frutto di un qualche accordo temporaneo, esposto al rischio della
158 Paolo Scotton
vare nulla da eccepire, essa tuttavia sembra non tenere in debita considerazione l’esistenza di tale diritto di autodifesa, del resto non esplicitato da Hobbes, ma che sembra, come dimostrato, poter essere inferito come conseguenza del suo ragionamento. Al contrario, altri studiosi contemporanei, segnatamente di area anglosassone, hanno recentemente messo in discussione tale interpretazione tradizionale, finendo per parlare non solo di un diritto di resistenza, ma addirit-tura di un ‹diritto di ribellione›21 e finanche di un ‹diritto di rivoluzione›22. Che la questione sia molto dibattuta e al centro delle riflessioni sul Leviathan è un dato di fatto che accompagna quest’opera fin dalla sua ricezione al tempo di Hobbes, già poco dopo la sua pubblicazione. È infatti noto che, tra gli altri, il vescovo John Bramhall nel suo The Catching of the Leviathan, testo del 1658, si riferisse all’opera di Hobbes come a un ‹rebel’s catechism›, e al suo autore come a un empio ateo, proprio per via di quella che veniva giudicata come un’eccessiva
sua dissoluzione, ma deve dar luogo ad una struttura stabile, che elimini la fonte di con-
flitto consistente nel fatto che ognuno esercita la sua forza». 21 Secondo Susanne Sreedhar, come si vedrà meglio in seguito, il Leviathan mostra
come «there is an identifiable and coherent Hobbesian right of rebellion and, moreover,
this right is consistent with Hobbes’s stated rejection of rebellion in the cases that he
addresses». In Sreedhar, Hobbes on Resistance, cit., p. 136. 22 In questi termini si esprime Clare Finkelstein, A puzzle about Hobbes on self-defense,
in «Pacific Philosophical Quarterly», 82, 2001, pp. 332-361, in particolare alle pp. 356-
357, in cui sostiene che: «[I]t is the right of self-defense that grounds the entitlement to
disobey the sovereign when he is unable to protect them. The subjects have a right to
reject the sovereign’s authority if, for example, he were to refuse on a consistent basis
to tend to their well-being. By retaining a right of self-defense, citizens give themselves
the right to reject the sovereign’s authority in the event that he no longer rules with
their welfare as his primary guiding principle. In other words, by retaining the right to
self-defense, they have retained a natural right of revolution». Il diritto di autodifesa
viene interpretato dall’autrice in maniera radicale, tanto da essere visto come un diritto
collettivo e non individuale, pertanto capace di scatenare un insanabile conflitto di po-
teri tra il sovrano e i suoi sudditi intesi come moltitudine autodisciplinata. Tale scenario
sembra però in manifesta contraddizione con l’antropologia delineata da Hobbes nei
capitoli iniziali della sua opera.
Diritto di resistenza e legittimità del potere 159
libertà concessa ai singoli cittadini facenti parte dello Stato23; libertà che i realisti dell’epoca guardavano con molto sospetto. Così, sebbene risulti evidente come l’intenzione dichiarata dall’autore stesso sia quella d’impedire la legittimità di ogni opposizione al potere costituito, il modo con cui egli cerca di dimostrare la necessità di questa tesi presenta una difficoltà intrinseca al ragionamento stesso, una possibile contraddizione che rischia di inficiarne la validità stessa. Tale dif-ficoltà può sembrare apparentemente trascurabile, ma come un sassolino inca-stratosi tra gli ingranaggi, rischia di bloccare l’intero dispositivo della teoria poli-tica hobbesiana. Di fronte a tale possibile aporia molteplici sono state le letture offerte dagli studiosi anche in epoca recente.
2. Il diritto di resistenza: interpretazioni a confronto
L’esistenza di un eventuale diritto di resistenza all’interno del Leviathan deve pertanto la sua condizione di possibilità a quello che sembra configurarsi come il carattere inalienabile del diritto di autodifesa. Infatti, qualora la vita stessa di un individuo sia messa in pericolo, è proprio appellandosi a tale diritto, messo sotto accusa dalla legge positiva ma dettato dalla legge naturale, che il soggetto può legittimamente opporsi al potere costituito. A sua volta, il carattere di ina-lienabilità del diritto di autodifesa non si presenta nella riflessione di Hobbes come un diritto simpliciter. Infatti, esso deve la sua esistenza al fatto di rappre-sentare quella che è una sorta vestigio del diritto di natura, pur essendo da esso radicalmente distinto24. È chiaro, infatti, che il diritto naturale (Ius naturale), ov-vero quello secondo cui ogni individuo è legittimato ad usare il proprio potere in modo del tutto arbitrario25, esiste solo laddove gli uomini vivano nello stato di natura nel quale esso rappresenta l’unico mezzo per sopravvivere a quella condizione di continua conflittualità in cui «non esiste proprietà, né dominio, né distinzione tra mio e tuo, ma appartiene ad ogni uomo tutto ciò che riesce a
23 Si veda l’efficace ricostruzione di Quentin Skinner, Vision of Politics, vol. III: Hobbes
and Civil Science, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, in particolare alle pp.
264-286. 24 Sreedhar, Hobbes on resistance, cit., pp. 11-16. 25 Hobbes, Leviatano, cit., p. 105.
160 Paolo Scotton
prendersi e per tutto il tempo che riesce a tenerselo»26. In un simile contesto, è evidente come ciascuno abbia la possibilità «di usare il proprio potere a suo ar-bitrio per la conservazione della sua natura, cioè della sua vita e conseguente-mente di fare qualsiasi cosa che, secondo il suo giudizio e la sua ragione, egli concepisca come il mezzo più idoneo a questo fine»27. Pertanto il diritto natura-le di autodifesa così concepito esisterebbe solo laddove non vi fosse uno Stato civile in grado di garantire a ciascun individuo sicurezza e protezione. Nel con-tratto sociale, invece, ognuno, in seguito al patto, è obbligato a obbedire al vole-re del sovrano, privandosi così della libertà di autogovernarsi come meglio ri-tiene opportuno. Pertanto, la chiara distinzione di queste due sfere di potere sembra portare con sé la dissoluzione stessa del problema tratteggiato in prece-denza28. Non vi sarebbe dunque alcuna contraddizione possibile all’interno del-la argomentazione di Hobbes che sembrerebbe concedere l’esistenza fattuale di un diritto naturale di rivoluzione, o meglio di autoaffermazione – in quanto di-ritto proprio dell’uomo – diritto il quale sarebbe illegittimo mettere in pratica, però, all’interno dello Stato. Tuttavia, come già messo in evidenza, la cessione del proprio diritto ad autodifendersi non è totale, poiché anche nello Stato di diritto permangono «cose il diritto alle quali non può essere ceduto per patto»29 e tra queste Hobbes inserisce le circostanze della difesa della propria persona già elencate in precedenza. Per tale motivo, il diritto di autodifesa nell’espressione che ad esso viene concessa all’interno dello Stato in quanto non del tutto riducibile alla sfera pubblica– espressione che prevede la cessione di tale diritto al sovrano – sembra essere racchiuso nella legge naturale, la quale lo comprende senza però esaurirsi in esso e pertanto causando quella già menzio-nata mancanza di identità tra legge civile e legge naturale. L’obbligazione del suddito nei confronti del sovrano e, reciprocamente, i doveri di quest’ultimo nei
26 Hobbes, Leviatano, cit., p. 103. Cfr. Hobbes, Leviathan, cit., p.109: «[T]here be no
propriety, no dominion, no mine and thine distinct; but only that to be every man’s that
he can get; and for so long as he can keep it». 27 Ibidem, p. 105. In Hobbes, Leviathan, cit., p. 111: «To use his own power as he will
himself for the preservation of his own nature; that is to say, of his own life; and con-
sequently, of doing anything which, in his own judgement and reason, he shall conceive
to be the aptest means thereunto». 28 Questa tesi sarà analizzata in seguito, con riferimento all’interpretazione proposta
da Peter J. Steinberger. 29 Hobbes, Leviatano, cit., p. 183.
Diritto di resistenza e legittimità del potere 161
confronti del primo, costituiscono quindi un rapporto più complicato di quanto possa apparire in un primo momento30, poiché l’obbligazione reciproca sembra non riuscire a circoscrivere interamente la sfera dei diritti naturali.
Rimane tuttavia da comprendere se e per quale motivo tale diritto di autodi-fesa costituisca all’interno dell’ordinamento positivo un diritto inalienabile. A tal proposito, una delle argomentazioni comunemente accettate e recentemente riprese a favore dell’esistenza del diritto di resistenza in Hobbes fornisce, in e-strema sintesi, due motivazioni per le quali, a partire dal capitolo XIV del Levia-than, risulterebbe comprensibile come tale diritto non possa essere trasferito in toto al sovrano. Vi sarebbero, infatti, sia una ragione concettuale, sia una ragione psicologica che ne renderebbero impossibile l’alienazione31. La prima emerge dal fatto che il concetto di trasferimento di un diritto è l’espressione, secondo le parole di Hobbes, di ‹un atto volontario›. Poiché l’oggetto proprio di questo ti-po di atti «di ciascun uomo è qualche bene per se stesso»32 risulta evidente co-me non sia logicamente possibile che qualcuno compia un atto volontario ri-nunciando a difendere se stesso, la propria vita, la propria libertà e i mezzi che gli consentono di vivere in modo soddisfacente. La motivazione psicologica, invece, dipende dal fatto che «l’uomo sceglie per natura il male minore, che consiste nel rischio di morte nell’opporre resistenza, piuttosto che il maggiore, cioè la morte certa e immediata se non resiste»33. Questa motivazione viene pre-sentata da Hobbes come in se stessa evidente a partire dal dato empirico del comportamento tipico dei criminali che, pur riconoscendo la validità della legge
30 Alan Ryan, Hobbes’s political philosophy, in The Cambridge Companion to Hobbes, a cura
di Tom Sorell, New York-Cambridge, Cambridge University Press, 1996, pp. 208-245,
in particolare p. 239: «It is a complex operation to analyze the ways in which we do and
do not leave the state of nature in our relations with the sovereign. [...]Ex hypothesi, the
sovereign is the fount of law and “absolute” in the sense of not being bound by those
he promulgates, nonetheless, he ought to consider himself bound in foro interno and by
the law of nature». 31 Sreedhar, Hobbes on resistance, cit., p. 30-32, presenta queste tesi come espressione
della «standard intepretation of Hobbes’s argument for the inalienability of the right of
self-defense». 32 Hobbes, Leviatano, cit., p. 107. 33 Ibidem, p. 113. In Hobbes, Leviathan, cit., pp. 119-120: «For man by nature
chooseth the lesser evil, which is danger of death in resisting, rather than the greater,
which is certain and present death in not resisting».
162 Paolo Scotton
e accettandola, non possono esimersi dall’opporsi in tutti modi al boia al mo-mento dell’esecuzione. Entrambi questi argomenti sembrerebbero dunque di-mostrare come, per Hobbes, il trasferimento del diritto di autodifesa nel con-tratto sociale (e quindi la totale inesistenza di un certo margine di inalienabilità per quanto concerne il governo di sé) non possa che essere solo apparente, dal momento che se una persona si privasse di tale diritto contraddirebbe di conse-guenza sia la propria indole (motivazione psicologica) che il senso stesso del concetto di trasferimento (motivazione concettuale). Questa affermazione rischie-rebbe quindi d’invalidare l’intero edificio costruito da Hobbes, il quale si regge sul fatto che nell’entrare in società ciascun individuo dichiara implicitamente: «do autorizzazione e cedo il mio diritto di governare me stesso a quest’uomo, a quest’assemblea di uomini, a questa condizione, che tu, nella stessa maniera, gli ceda il tuo diritto e ne autorizzi tutte le azioni»34. Tuttavia, affermare a partire da questa apparente contraddizione l’inconsistenza della teoria politica di Hob-bes è sicuramente espressione di un giudizio frettoloso e avventato.
Contro queste letture in un certo modo estreme – e a favore di una lettura più conciliante – ha argomentato ad esempio Peter Steinberger35. Secondo la sua lettura, Hobbes ammetterebbe senz’altro che vi siano dei casi in cui il con-tratto stipulato tra i cittadini e il sovrano cessa di essere valido. Questo avver-rebbe in tutti i casi in cui l’ordinamento sociale fallisca nel portare a termine il compito per il quale è stato creato, vale a dire quando non fosse più in grado di garantire ai cittadini la loro sicurezza, incolumità e possibilità di vivere una vita soddisfacente. In questi casi, il contratto verrebbe abrogato e i cittadini sarebbe-
34 Hobbes, Leviatano, cit., p. 143. In Hobbes, Leviathan, p. 145: «I authorize and give
up my right of governing myself to this man, or to this assembly of men, on this condi-
tion; that thou give up thy right to him, and authorize all his actions in like manner». 35 Peter J. Steinberger, Hobbesian Resistance, in «American Journal of Political Sci-
ence», XLVI, 4, 2002, pp. 856-865, in particolare p. 857: «They [tali interpretazioni] fail
to examine closely enough Hobbes’s account of that particular idea to which we give
the name of “state”, and from which his theory of obligation is derived. With such an
account firmly in hand, I believe it can be shown that citizens have both an absolute
obligation to obey the sovereign in every respect and without any exception whatsoever
and, at the same time, certain inalienable rights of self-defense; further, that Hobbes
can argue this without any contradiction whatsoever; and finally, that the right of self-
defense is, in Hobbes’s thought, very broadly indeed, and forms the basis for a full-
scale theory of legitimate revolution, or at least its functional equivalent».
Diritto di resistenza e legittimità del potere 163
ro pertanto liberi di disubbidire al sovrano senza con ciò commettere alcuna ingiustizia. Infatti, l’abrogazione del patto porta di conseguenza ad una ricaduta immediata nello stato di natura in cui, per usare le parole di Hobbes «le nozioni di diritto e torto, di giustizia e di ingiustizia non vi hanno luogo»36. Pertanto, la dissoluzione del contratto produrrebbe inevitabilmente anche la dissoluzione dell’autorità del sovrano, e infine la ricomparsa di quello stato di guerra di tutti contro tutti che contraddistingue la condizione dell’uomo pre-sociale. Per que-sto motivo, potere del sovrano all’interno della società e diritto di resistenza al di fuori della stessa sembrano poter essere conciliati in quanto momenti distinti e quindi reciprocamente escludenti.
Di conseguenza, Steinberger ritiene plausibile affermare che «absolutism and resistance coexist in Hobbes without the slightest contradiction». Infatti, «the right to resist is never a right to resist the state. There is no such right. The state’s authority is absolute, and this means that the right to resist is and can on-ly be a right against individuals or groups in the condition of nature»37. Questa interpretazione sembra salvaguardare la coerenza interna al pensiero Hobbesia-no distinguendo in maniera netta tra Stato civile e stato di natura senza possibi-lità di sovrapposizioni tra queste due distinte condizioni. Tuttavia, a mio avviso, tale argomentazione non riesce a dare ragione di come il diritto di resistenza, avente le proprie basi nella legge naturale, possa essere mai concretamente eser-citato, in che modo quindi possano verificarsi le condizioni necessarie perché un potere possa essere considerato a ragion veduta illegittimo e pertanto deca-duto dalla sua funzione di regolazione del rapporto sociale tra individui attra-verso il contratto sociale e la sottomissione di singoli individui ad un’autorità esterna e ad essi superiore. Infatti, dal momento che la condizione naturale si configura come una condizione assai rischiosa pressoché per la totalità degli in-dividui, una semplice valutazione dei pro e contra comporterebbe una perenne salvaguardia dello status quo, anche sotto un governo ritenuto dalla maggioranza tirannico38. Infatti, posto pure il caso in cui il sovrano attentasse alla vita di un
36 Hobbes, Leviatano, cit., p. 103. 37 Steinberger, Hobbesian Resistance, cit., p. 860. 38 Per Hobbes, infatti, la sola differenza tra monarchia e tirannia giace nel giudizio di
chi ad essa è sottomesso, cfr. Hobbes, Leviatano, cit., p. 155: «Nei libri di storia e di poli-
tica ricorrono altri nomi di regimi come tirannia e oligarchia [per monarchia e aristocra-
zia]; ma sono i nomi non già di altre forme di governo, bensì delle stesse quando sono
considerate con avversione».
164 Paolo Scotton
singolo o anche di più persone legate tra loro, sembrerebbe del tutto contrad-dittorio pensare che queste si rivolterebbero contro di lui, seppur legittimamen-te (secondo il dettame della legge di natura), poiché in tal modo contribuirebbe-ro a rompere ogni vincolo sociale e provocherebbero così la ricaduta in quello stato di natura in cui essi stessi rischierebbero parimenti di essere sopraffatti da ogni altro individuo39. All’alta probabilità di essere uccisi si sostituirebbe un’altrettanto elevata possibilità di fare la stessa fine. Individui in una condizio-ne simile potrebbero accettare di ritornare nello stato di natura, mettendo così probabilmente a rischio la loro esistenza, solo perché, chiedendo il sovrano la loro morte, essi sanno di condurre un’esistenza in cui sarebbero comunque in grave pericolo, o addirittura sarebbero certi di perdere la loro incolumità qualo-ra sottostessero alle leggi civili. Questo può risultare tutt’altro che problematico, come sostiene Steinberger40, nei casi in cui ad essere coinvolto in questo atto di ribellione sia un singolo individuo. Tuttavia nei casi in cui questa possibilità sia messa in atto da gruppi composti da individui che si ritengono parimenti in pe-ricolo di vita di fronte ad un potere a loro esterno, risulta evidente come il pro-blema si riproponga in toni molto più drammatici per la tenuta stessa e per la legittimità di ciò che, secondo Steinberger, proprio perché messo in discussione cesserebbe di essere considerato Stato per essere invece ritenuto meramente un potere illegittimo: «when the same questions arise for large groups […] we have the basis for a full-fledged thoery of revolution – a revolution not against the state but against an entity that has ceased to be a state, if in fact it ever was
39 Proprio con questa argomentazione, in maniera retoricamente molto persuasiva,
Hobbes difende la necessità all’obbedienza nei confronti del sovrano. Hobbes, Leviata-
no, cit., p. 260: «Infatti la ribellione altro non è che rinnovare la guerra». Ancora una vol-
ta, però, la possibile contraddizione esplicitata in apertura del presente testo non trova
soluzione e pertanto la tesi sostenuta da Steinberger va, a mio avviso, messa in discus-
sione. 40 Steinberger, Hobbesian Resistance, cit., p. 861: «The social contract is an agreement
among the citizens in which each acts as an individual, and there’s no reason to doubt
that an agreement of this kind might work out for some of the citizens and not for the
others. The upshot is that the legitimacy of a state can never be in dispute. the same must
always be obeyed, its authority absolute. But the actual existence of a state can be, and
often is, a matter of the most intense dispute, since the terms of the contract can be
violated for some and not for others».
Diritto di resistenza e legittimità del potere 165
one»41. Accettando tali considerazioni verrebbe quindi a prodursi una condizio-ne di estrema conflittualità in grado di mettere in discussione la stabilità del po-tere politico stesso. Pertanto, l’intera opera di Hobbes fallirebbe l’obiettivo di offrire una solida base scientifica ad una teoria del potere legittimo, in grado di durare nel tempo e di resistere ai giudizi sommari dei suoi sudditi. La possibilità logica della rivoluzione avanzata da Steinberger sulla base di una distinzione linguistica e, di conseguenza, di una netta distinzione di ambiti, sembra quindi assai problematica. Essa, infatti, pur non consentendo una realizzazione pratica della ribellione all’interno dello Stato tuttavia presenta la stessa come una even-tualità sempre percorribile e contro cui non vi è modo di erigere alcuna forma di argine da parte delle istituzioni politiche. La distinzione correttamente opera-ta sul piano linguistico sembra quindi, sul piano ontologico, essere in se stessa inconsistente; quindi, in ultima analisi, inadatta a sostenere la tesi secondo cui il pensiero di Hobbes formerebbe «the basis for a full-scale theory of legitimate revolution42. Infatti essa non prevede la messa in atto di alcuna rivoluzione le-gittima all’interno del sistema politico, limitandosi a non escluderne l’evenienza a livello fattuale, con conseguente crollo del sistema politico stesso.
Un’interpretazione alternativa sia a quella comunemente accettata e descritta in precedenza sia a quella solo in apparenza più conciliante proposta da Stein-berger, è stata avanzata da Susanne Sreedhar in un volume piuttosto recente in-teramente dedicato alla questione dell’esistenza del diritto di resistenza nel Le-viathan di Thomas Hobbes. Secondo l’autrice, il cosiddetto diritto di autodifesa non sarebbe alienabile all’interno del contratto sociale, mentre lo sarebbe in al-tre forme di contratto. In particolare, vi sarebbero tre differenti ragioni per le quali tale diritto si potrebbe configurare come inalienabile all’interno del rap-porto suddito-sovrano. Esse fanno capo a tre principi generali: quello della ‹ra-gionevole aspettativa›, della ‹fedeltà› e della ‹necessità›43. Il primo riguarda non tanto il tornaconto che ogni contraente all’interno del patto pensa di ricevere con la sottoscrizione dello stesso, quanto piuttosto la ragionevole attesa di ve-der rispettato e messo in atto il patto da tutte le parti che lo sottoscrivono, in-cluso il sovrano. Il secondo concerne invece il fatto che il trasferimento di un diritto debba essere fedele allo scopo per cui il patto è stato sottoscritto – nello
41 Steinberger, Hobbesian Resistance, cit., p. 865. 42 Ibidem, p. 857. 43 Traduco con queste parole quelli che Sreedhar chiama “reasonable expectations
principle”, “fidelity principle” e “necessity principle”. Cfr. Sreedhar, Hobbes on resistance,
cit., p. 40.
166 Paolo Scotton
specifico esso deve garantire ad ogni contraente la necessaria protezione contro gli altrui soprusi. Infine, il principio di necessità limita la quantità di diritti ceduti al sovrano a quelli necessari affinché il patto possa essere istituito e messo in atto in modo tale da raggiungere il fine per cui esso fu originariamente sotto-scritto. A partire da questi principi, Sreedhar cerca di dimostrare come il diritto di autodifesa sia mantenuto e non ceduto all’interno del contratto sociale poi-ché in questi a) non vi è certezza che ognuno rispetti il patto; b) qualora vi fosse una simile promessa il patto stesso ne sarebbe indebolito; c) lo Stato di Hobbes non richiede che una tale promessa sia sottoscritta. La prima e la terza conside-razione sembrano senza dubbio essere quelle dotate di una maggior cogenza, mentre la seconda di queste non sembra, a mio avviso, rappresentare un auten-tico scoglio nei confronti della teoria Hobbesiana.
Essa è resa possibile solo a partire dall’accettazione dell’assunto, esplicita-mente dichiarato dall’autrice e, a mio avviso, forse non pienamente condivisibi-le, secondo cui l’intero progetto politico disegnato da Hobbes «intended to show that political obligation coincides with rational or enlightened self-interest»44. Un’interpretazione di Hobbes questa, forse anacronisticamente troppo segnata dal consequenzialismo, seppure sia indubbiamente vero che la legge di natura tratteggiata da Hobbes possa essere intesa per certi versi in un sottofondo marcatamente utilitarista45. Secondo la linea argomentativa tratteg-giata da Sreedhar per vie tuttavia diverse si giungerebbe ad una conclusione molto simile a quella caratterizzante lo studio di Steinberger ma capace di tene-re in considerazione anche il momento della messa in moto all’interno dello sta-to di tale diritto: all’interno del Leviathan sarebbe esplicitata una teoria della di-sobbedienza politica coerente con l’intera struttura dell’opera stessa. Secondo tale teoria, qualora la sicurezza dei singoli cittadini non fosse garantita dal so-vrano, non vi sarebbe alcun obbligo di obbedienza nei suoi confronti. Sreedhar arriva addirittura a compendiare in una semplice formulazione quello che lei chiama un vero e proprio diritto di ribellione che sarebbe a suo avviso incluso in nuce all’interno del diritto di resistenza delineato in alcuni passaggi del testo di Hobbes:
44 Sreedhar, Hobbes on resistance, cit., p. 51. 45 E proprio su tale tema la teoria di Hobbes fu attaccata duramente da John Locke,
Saggi sulla legge naturale, cit., pp. 81-90.
Diritto di resistenza e legittimità del potere 167
a subject has the right to rebel if and only if that subject judges that the sover-
eign is not providing adequately for his security and that rebellion is the best means
to his self-preservation46.
La tesi enunciata da Seedhar implica che, qualora da essi ritenuto necessario, i soggetti abbiano il diritto di fare tutto ciò ritengano opportuno al fine di ga-rantire la propria sopravvivenza, ivi compreso, in casi estremi, unirsi con altri soggetti e ribellarsi in maniera organizzata al potere del sovrano47. Quindi, que-sti soggetti non solo sono giudicati essere in possesso del diritto di non obbedi-re agli ordini di un sovrano incapace di garantire loro pace e sicurezza (secondo la clausola presente nell’accordo stipulato con il sovrano), ma hanno inoltre la possibilità di armarsi contro di esso qualora lo ritengano opportuno. Tuttavia, il secondo aspetto di questa interpretazione del Leviathan sembra in contraddizio-ne con alcuni passaggi salienti del testo48 e, in generale, con lo spirito stesso dell’opera. In essa, infatti, l’intento esplicitamente dichiarato da Hobbes è quel-lo di edificare una teoria politica in grado di privare di ogni legittimità qualsiasi movimento sovversivo che possa aver luogo all’interno di una società scossa da continui conflitti e lotte civili49. In particolare per opporsi a quei movimenti che, spinti da motivazioni religiose, cercavano al suo tempo di sovvertire il po-tere legittimo creando una condizione di perenne conflittualità all’interno dello Stato50.
46 Susanne Sreedhar, Hobbes on resistance, cit., p. 137. 47 Ibidem, p. 139. 48 Così, ad esempio, nel capitolo XXII del Leviathan Hobbes trattando della regola-
mentazione tra conflitti di poteri all’interno dello Stato - tra singoli sudditi e sovrano;
tra partiti,fazioni e sovrano; tra partiti e partiti - sostiene che in tutti quei casi in cui que-
sti diversi sistemi si oppongono direttamente al volere del sovrano essi vengono imme-
diatamente ritenuti illegittimi e quindi paragonati a «tumori, bile e ascessi, generati
dall’innaturale coagularsi di cattivi umori». Hobbes, Leviatano, cit., p. 199. 49 In particolare per la violenza delle guerre di religione che dilaniavano l’Inghilterra
del XVII secolo. Infatti, scrive Hobbes, in ibidem, p. 570: «Chi rivendica un diritto di
natura a preservare il proprio corpo, non può rivendicare [anche] un diritto di natura ad
abbattere colui dalla cui forza dipende la propria conservazione; questa è una palese au-
to contraddizione». 50 Eccederebbe i fini di questo articolo, che intende limitarsi ad analizzare in partico-
lare la portata teoretica di alcune delle tesi espresse da Hobbes nel Leviathan, prendere in
168 Paolo Scotton
3. L’autorevolezza a servizio dell’autorità
Da quanto fin qui detto, si potrebbe ormai concludere che, anche qualora si conceda che Hobbes lasci spazio ad una forma di resistenza nei confronti del sovrano, egli allo stesso tempo escluda una via legittima alla ribellione. Infatti, non essendoci spazio all’interno dello Stato per alcuna legge al di fuori di quella posta dal sovrano, risulta di conseguenza assurdo e impossibile che vi possa es-sere una legge positiva che vada a ledere l’autorità stessa di colui che ne sancisce la validità. L’unica porta che sembra essere lasciata ancora aperta alla ribellione è legata quindi alla reazione istintiva che ha luogo di fronte all’imminente peri-colo di morte, reazione che è giustificata dalla legge naturale, ma che è in con-traddizione rispetto alla legge positiva. Solo in questo caso si verificherebbe in-fatti, per Hobbes, il tentativo di opporsi in tutti i modi e con tutte le proprie forze alla volontà espressa dal sovrano. Va però sottolineato il fatto che questo comportamento apparentemente istintivo, in realtà, rappresenta il frutto di un vero e proprio ragionamento di calcolo in cui vengono pesate con attenzione le ragioni a favore e quelle a sfavore della messa in atto di una tale condotta sov-versiva. In questa chiave, l’antropologia negativa tratteggiata da Hobbes nei ca-pitoli iniziali del Leviathan è funzionale a giustificare non solo l’entrata dell’uomo in società quanto piuttosto, in misura forse maggiore, la necessità di conservare per il più lungo tempo possibile il potere istituito al fine di garantire l’agognata condizione di pace. Infatti, il rischio di perdere quello che nei limiti del contratto sociale di Hobbes si identifica con l’unico orizzonte di senso pro-prio dell’uomo laicamente inteso, costituito dalla mera conservazione della pro-pria esistenza51, impone ad ogni singolo cittadino di sottomettersi completa-
considerazione le pur fondamentali controversie religiose all’interno delle quali lo stesso
Hobbes si trovò inserito e che contribuirono a definirne le posizioni. Su tale tema ri-
porto in particolare al lavoro di Nicholas D. Jackson, Hobbes, Bramhall and the politics of
liberty and necessity: a quarrel of the Civil Wars and Interregnum, Cambridge, Cambridge Uni-
versity Press, 2007. 51 È questa la condizione dell’uomo nel mondo perfettamente immanente descritto
da Hobbes; secondo le parole di Merio Scattola, Teologia politica, Bologna, Il Mulino,
2007, p. 118: «La duplice condizione, secondo la quale da un lato non è possibile nes-
sun intervento diretto di Dio nella natura e dall’altro lato l’anima dell’uomo è ridotta al
solo piano della sopravvivenza fisica, è quel processo che abbiamo definito come “se-
colarizzazione”».
Diritto di resistenza e legittimità del potere 169
mente al sovrano qualunque decisione questi prenda – fatto salvo, ovviamente, il caso limite in cui egli, nel far ciò, finisca col condannare se stesso a una morte certa. Sembra pertanto che al sovrano sia dovuta un’ obbedienza quasi totale da parte di coloro i quali a lui si sono sottomessi al fine di essere protetti dall’aggressività degli altri uomini. È infatti solo il timore di ricadere in una condizione peggiore ciò che rappresenta la garanzia che tale obbedienza non potrà venire meno52. Allo steso tempo, però, a questa che potremmo definire come la ragione pessimistica da cui scaturisce la decisione di istituire il sovrano, la quale rappresenta la motivazione principale che consiglia ai sudditi di non opporsi al suo volere, fa da contraltare anche una ragione positiva. Tale ragione che soggiace al contratto stesso, infatti, lascia spazio all’esercizio del proprio giudizio personale che è chiamato a valutare privatamente la convenienza che si determina nel rimanere o meno all’interno dello Stato. Bisogna pertanto sotto-lineare come, per Hobbes, questo principio possa essere letto anche in una ver-sione che si potrebbe definire ottimistica, dal momento che al timore del verifi-carsi di un evento fa inevitabilmente da contraltare la speranza che esso non si verifichi. In altre parole, l’obbedienza nei confronti del sovrano palesa allo stes-so tempo la fiducia riposta in esso dai sudditi, la quale è tale che ogni cittadino ritiene non solo che non vi possa essere nessuna condizione di vita migliore ri-spetto a quella regolamentata dalle leggi istituite da colui al quale sono stati alie-
52 Thomas Hobbes, Elementi di legge naturale e politica, Milano, La nuova Italia, 1989,
p.124: «Se non fosse valido alcun patto che derivasse dal timore della morte, non po-
trebbero aver vigore, né condizioni di pace tra nemici, né alcuna legge; poiché a tutte si
acconsente a causa di quel timore». Così nel Leviathan, Hobbes, Leviathan, cit., p. 411:
«Temporal and spiritual government are but two words brought into the world to make
men see double and mistake their lawful sovereign.[…] There is therefore no other
government in this life, neither of state nor religion, but temporal; nor teaching of any
doctrine lawful to any subject which the govern both of the state and of the religion
forbiddeth to be taught». La figura stessa rappresentata dal mostro biblico del Levia-
than, la cui metafora viene presentata da Hobbes in maniera ambigua e non chiara nel
corso del testo dimostrerebbe del resto, come argomentato puntualmente da Tralau in
un suo recente articolo, come anche attraverso tale immagine egli volesse incutere nel
lettore e cittadino la necessità del terrore interna alla sua teoria, necessità che, «nella sia
dottrina, diventa una componente teoretica». Si veda a tal proposito John Tralau, L’icona
del terrore e dell’ambiguità. Il legame mancante tra Hobbes e il suo Leviatano, in «Lo sguardo. Ri-
vista di filosofia», 13, III, 2013, pp. 183-196.
170 Paolo Scotton
nati i propri diritti, ma anche che in tale condizione essi possano migliorare nel futuro la loro vita53. Il giudizio autonomo dei sudditi che in qualche modo sem-bra garantito all’interno della logica hobbesiana lascia quindi socchiusa una por-ta in apparenza rischiosa ma allo stesso tempo salutare per il mantenimento del-lo Stato in un ottica di legittimità non solo imposta dall’ordinamento giuridico e dallo ius positum ma anche dalla speranza fiduciosa nei confronti del sovrano. L’obbedienza dovuta al sovrano è quindi indissolubilmente connessa alla fidu-cia, o per meglio dire alla fede, riposta in lui54. Questa fede, in quanto tale, è di-sposta a rinunciare a porre ogni cosa sotto l’attento scrutinio della ragione cal-colatrice, ed è disposta ad accettare senza condizioni il volere del sovrano. Non può del resto essere passato sotto silenzio il fatto che l’intera terza sezione dell’opera di Hobbes abbia come fine quello di dimostrare che la fede nella pa-rola di Dio, nella sua derivazione soprannaturale e profetica, si trova in perfetta armonia con l’argomentazione razionale da lui stesso svolta in precedenza per mezzo della sola ragione naturale. È quindi possibile arrivare alla medesima conclusione in favore dell’obbedienza anche attraverso la pura fede, compiendo una «resa dell’intelletto». Infatti, «compiamo una resa del nostro intelletto e del-la nostra ragione, quando ci asteniamo dal contraddire, quando parliamo come ci è comandato (dall’autorità legittima), e viviamo conformemente a questi co-mandi, il che, insomma, è riporre la fiducia e fede in colui che parla, nonostante
53 Hobbes, Leviatano, cit., pp. 103-104: «Le passioni che inducono gli uomini alla pa-
ce sono la paura della morte, il desiderio di quelle cose che sono necessarie a una vita
piacevole e la speranza di ottenerle con la propria operosità ingegnosa». E ancora, in
ibidem p. 273: «La funzione del sovrano (monarca o assemblea che sia) consiste nel fine
per il quale gli è stato affidato il potere sovrano, cioè procurare la sicurezza del popolo;
a ciò è obbligato dalla legge di natura e di ciò deve rendere conto a Dio, autore di quella
legge, e a nessun altro fuorché a lui. Inoltre, per sicurezza qui si intende non una mera
sopravvivenza, ma anche tutte le altre soddisfazioni della vita che ognuno possa pro-
cacciarsi con lecita industria senza pericolo o danno per lo Stato». 54 Zagorin, Hobbes and the law of nature, cit., pp.71-72: «The Hobbesian sovereign is
not merely a secular ruler but also the supreme pastor of the Christian church, by
whose authority all other pastors, religious teachers, and church officials were appoint-
ed. […] Hobbes […] also contended that it is the legislative authority of the sovereign
by means of the civil law that makes God’s laws and the precepts of the Bible binding
upon men»
Diritto di resistenza e legittimità del potere 171
che la mente sia affatto incapace di ricavare alcuna nozione dalla parole dette»55. Così, il potere autoritario del sovrano si salda senza soluzione di continuità al suo aspetto spirituale. Infatti, il legame tra potere temporale e potere spirituale è tanto forte da costituire, per Hobbes, un’unica sostanza indissolubile56. Per tale ragione Hobbes si riferisce al Leviathan come «(per parlare con maggior rispet-to) a quel dio mortale, al quale dobbiamo, sotto il Dio immortale, la nostra pace e la nostra difesa»57. È, in parte, proprio tale venerazione e rispetto nei confronti dell’autorità quasi divina che caratterizza lo Stato civile a rendere per Hobbes una vera e propria pazzia il disobbedire al volere di chi in esso detiene il potere, e una forma di perniciosa eresia ogni opposizione violenta al sovrano. Per tal motivo, nel presentare l’eventualità che una persona consideri vantaggioso venir meno al patto per il proprio tornaconto, dal momento che il significato del concetto di giustizia sarebbe il prodotto di un giudizio meramente personale e soggettivo, Hobbes si riferisce a colui che sostiene tale tesi come a un ‹pazzo›58. Nel far ciò, egli fa peraltro uso di quella che sembra essere un’evidente analogia
55 Hobbes, Leviatano, cit., p. 304. Cfr. Hobbes, Leviathan, cit., p. 326: «But by the
captivity of our understanding is not meant a submission of the intellectual faculty to
the opinion of any other man, but of the will to obedience where obedience is due.
[…]We then captivate our understanding and reason when we forbear contradiction;
when we so speak as, by lawful authority, we are commanded; and when we live ac-
cordingly; which, in sum, is trust and faith reposed in him that speaketh, though the
mind be incapable of any notion at all from the words spoken». 56 Su questo si veda, tra gli altri, l’articolo di Luigi Alfieri, La spada e il pastorale.
L’unità del potere sovrano nella teologia politica di Hobbes, in La filosofia politica di Hobbes, a cura
di Giulio Maria Chiodi e Roberto Gatti, Milano, FrancoAngeli, 2009, pp. 125-141. 57 Hobbes, Leviatano, cit., p. 143. 58 Ibidem, p. 117. Quale può essere allora lo spazio lasciato da Hobbes al diritto di self
preservation e fino a che punto può essere concesso agli individui disobbedire al potere
sovrano se nel far ciò non si può che essere dipinti come eretici dal consorzio civile?
Secondo Gianfranco Borrelli, Il lato oscuro del Leviathan. Hobbes contro Machiavelli, Napoli,
Cronopio, 2009, p. 125: «Questi individui si pongono contro l’istituzione dell’ordine
civile e quindi contribuiscono in permanenza a produrre conflitti civili: contro di loro
deve intervenire allora la legge civile che li esclude dalla società». Tale interpretazione,
pur motivata da questo passaggio, sembra però non considerare il problema posto dal
fatto che è lo stesso Hobbes ad affermare l’irriducibilità e inalienabilità del diritto di au-
todifesa nel contratto sociale.
172 Paolo Scotton
con il celebre testo anselmiano del Proslogion, di ascendenza biblica: «lo stolto ha detto in cuor suo “Dio non esiste”»59. Infatti, per Hobbes, il folle che nega l’esistenza della giustizia si pone in una condizione analoga a colui che nega l’esistenza di Dio. Sembra dunque accentuarsi il carattere intrinsecamente teo-logico della teoria politica hobbesiana, la quale si apre alla trascendenza al fine non tanto di rafforzare il timore nei confronti del sovrano, quanto di rendere più salda la speranza in un miglioramento della propria condizione di vita, in una giustizia equamente distribuita60. In tal modo, alle motivazioni puramente terrene che invitavano ad evitare ogni forma di ribellione, si aggiunge l’esplicitazione di una motivazione extramondana.
Il rischio di conflittualità o per lo meno di non perfetta coincidenza tra legge civile e legge naturale, che si è cercato di analizzare finora, trova qui una nuova articolazione, più problematica e forse proprio per questo motivo più interes-sante. La legge civile che esige dai cittadini una mera ubbidienza formale, poi-ché «nessuna legge umana è intesa ad obbligare la coscienza dell’uomo, ma solo le azioni»61 è una condizione necessaria, ma non sembra riuscire a configurarsi anche come una ragione di per sé sufficiente a garantire che i cittadini evitino di ribellarsi al sovrano qualora essi incorrano in sanzioni che limitino la loro liber-tà di movimento e/o che siano di detrimento alla propria persona. Le leggi civi-li, infatti, vietano qualsiasi forma di resistenza attiva nei confronti del sovrano, ma non si preoccupano direttamente delle possibili forme di resistenza passiva che possono aver luogo nell’intenzione delle persone.
In altre parole, l’edificio costruito da Hobbes attraverso il ricorso a un ra-gionamento esclusivamente mondano di giustificazione del potere istituito sembra non essere in grado di impedire in maniera assoluta il verificarsi di ribel-lioni ai danni del sovrano, le quali rischierebbero addirittura di potersi amman-tare di un nobile riferimento alla coscienza individuale, espressione di una supe-
59 Anselmo fa qui riferimento al passo biblico corrispondente al Salmo 14. 60 Per la riflessione sul ruolo costitutivo e pertanto centrale della speranza, intesa
come idea di un futuro in quanto tempo del benessere «resa possibile all’uomo dall’idea
di una potenza che supera il tempo» si vedano le considerazioni molto interessanti e
puntuali di Michele Nicoletti, La Teologia politica di Hobbes e il problema della secolarizzazione,
in La Filosofia politica di Hobbes, cit., pp. 109-123. 61 Hobbes, Elementi di legge naturale e politica, cit., p. 211.
Diritto di resistenza e legittimità del potere 173
riore legge di natura62. Infatti, solo la coincidenza di questa con la legge civile può garantire un rispetto della legge non solo formale ma anche autenticamente interiorizzato e fatto proprio, quindi immutabile ed incrollabile nel tempo63. Del resto, il fatto stesso che un cittadino possa formulare un giudizio difforme da quello del sovrano sembra lasciar adito a qualche forma di ribellione nei suoi confronti. Che tale rischiosa evenienza possa essere impedita, secondo Hobbes, è reso possibile solo in virtù del riferimento alla trascendenza e a una cieca fede nella verità di ciò che essa prescrive e comanda, accettazione che, come detto, avviene a seguito di una ‹resa dell’intelletto›. Per tale motivo, l’obbedienza do-vuta al sovrano poggia non solo sulla ragione naturale ma anche, in ultima ana-lisi, sul fatto che esso altri non sia che il luogotenente di Dio, colui che è chia-mato a farne le veci in Terra. Alla luce di tale precisazione sembra dunque pos-sibile tematizzare secondo una duplice accezione la questione concernente la possibilità o meno di un diritto di resistenza nell’opera di Hobbes, tenendo tut-tavia presente come per l’autore tale doppiezza sia solo apparente e non sostan-ziale, e vada pertanto ricomposta in unità. Da una parte, infatti, il potere nella sua espressione esclusivamente mondana lega i cittadini tra loro e i cittadini al loro sovrano attraverso il saldo nodo che è rappresentato dalle leggi civili con le quali i sudditi hanno vincolato loro stessi «con patti reciproci, [che] hanno fissa-to, per una estremità, alle labbra di quell’uomo, o di quell’assemblea, cui hanno dato il potere sovrano e, per l’altra, alle proprie orecchie. Questi legami, ancor-ché ancora deboli per loro natura, possono nondimeno essere resi resistenti dal pericolo (ma non dalla difficoltà) di infrangerli»64. In questa prospettiva, l’ ob-
62 A questa problematica, risolta solo grazie al richiamo all’obbedienza dovuta a Di-
o, sono dedicati due tra i più densi capitoli degli Elementi, segnatamente i capitoli VI e
VII, parte II. 63 Con chiarezza tale problema viene posto infatti all’interno del Leviatano, infatti, in
Hobbes, Leviatano, cit., pp. 128-129: «Le leggi di natura obbligano in foro interno: vale a
dire, vincolano a desiderare che abbiano attuazione. Ma non obbligano sempre in foro
externo, cioè a porle in atto. […] Ogni legge vincolante in foro interno può essere infran-
ta non soltanto da un’azione contraria alla legge medesima, ma anche da un’azione a
essa conforme, ove l’uomo [che la compie] la ritenga contraria. Sicché, sebbene la sua
azione in questo caso sia conforme alla legge, tuttavia il suo proposito è contro la legge,
e ciò – dato che l’obbligazione è in foro interno – rappresenta una violazione». 64 Hobbes, Leviatano, cit., p. 177. In Hobbes, Leviathan, cit., p. 185: «Artificial chains,
called civil laws, which they themselves, by mutual covenants, have fastened at one end
174 Paolo Scotton
bedienza dovuta alla leggi si configura, pertanto, come un legame fondato sulla paura, sulla già menzionata ragione pessimistica; legame in cui solo il timore – ora della ricaduta in una condizione pre-sociale, ora della pena per un’ infrazio-ne alla legge – porta ad un mero rispetto formale della volontà del sovrano. In tale condizione la ribellione è senza dubbio possibile in foro interno, mentre non trova alcuna cittadinanza in foro externo. Tale condizione può forse apparire co-me sufficiente e auspicabile da parte di un potere costituito in quanto la pace sembra poter essere di fatto sempre garantita. Tuttavia, il fatto che tale pace non possieda delle solide basi poggianti sull’accettazione della legge imposta in quanto ritenuta intrinsecamente valida, rischia di porla, di fatto, in continua di-scussione65. Infatti, qualora il suddito avverta le imposizioni del sovrano come per lui troppo gravose, la sua ribellione interna rischia di sfociare in aperto con-flitto con il potere costituito. Pertanto, tale vincolo sembra potersi spezzare e venir dunque meno qualora il sovrano privi i propri sudditi di ciò che spetta lo-ro per natura: il diritto ad autodifendersi. A ciò si aggiunge anche, seppur in se-condo piano, che la stessa sottomissione al patto presenta un forte carattere di rischio, segnatamente per quanto concerne quello che abbiamo visto essere de-finito da Sreedhar come l’argomento della ‹aspettativa razionale›. Non vi sono infatti garanzie riguardo al fatto che ogni contraente rispetterà il patto sotto-scritto, né per quanto concerne il singolo cittadino e nemmeno, drammatica-mente, per quanto concerne il sovrano il quale non è neppure direttamente le-gato ad esso. Pertanto, ancora una volta, all’interno di questa insostenibile in-certezza riguardo al proprio futuro sembra poter emergere con decisione lo spazio per un’eventuale resistenza al tiranno. Per far dunque fronte a tutte que-ste difficoltà, come accennato pocanzi, i cittadini devono essere quindi legati tra loro e con il sovrano anche da leggi divine. Tale legame, a differenza del primo, è inoltre bidirezionale, poiché anche il sovrano è obbligato da tali leggi nei con-fronti dei propri sudditi66. Così, mentre le leggi civili impongono quella che po-
to the lips of that man, or assembly, to whom they have given the sovereign power, and
at the other to their own ears. These bonds, in their own nature but weak, may never-
theless be made to hold, by the danger, though not by the difficulty of breaking them». 65 Basti pensare al rilievo dato da Hobbes, negli Elementi, alla forza destabilizzante
dello scontento, enunciata come prima tra le possibili cause di ribellione. Hobbes,
Elementi, cit., p. 238. 66 Hobbes, Leviathan, cit., p. 293: «The office of the sovereign, be it a monarchy or
an assembly, consisteth in the end for which he was trusted with the sovereign power,
Diritto di resistenza e legittimità del potere 175
tremmo definire una pura obbedienza di facciata, sempre esposta al rischio che, senza contraddizione alcuna in termini puramente logici, si possa verificare una ribellione capace di distruggere l’ordine sociale; le leggi divine persuadono ad un’obbedienza cieca e totale, poiché chiamano in causa il senso religioso della fede, quindi di una totale fiducia nell’operato e nelle decisioni del sovrano verso il quale il pensiero stesso di ribellarsi viene negato dal rispetto che gli si deve e dalla speranza futura che viene in lui riposta, senza necessità di chiamare in cau-sa il carattere coercitivo della sua volontà. Se l’aspettativa razionale alla base del-la stipulazione del contratto rischia di venir meno, la speranza fiduciosa non ha bisogno di appellarsi al calcolo dell’utile per ripercuotersi in obbedienza nei confronti del sovrano. Questo aspetto della teoria di Hobbes è inoltre rafforza-to dal fatto che sia proprio il sovrano il vicario di Cristo, e pertanto sia proprio in tale figura che ogni cittadino debba vedere rappresentata la volontà stessa di Dio il quale, seppur assente dal mondo naturale, è reso presente in esso attra-verso l’interpretazione dei suoi comandamenti che si opera mediante l’azione legislativa del sovrano67. A differenza delle leggi civili, le leggi divine sono infatti impossibili da abrogare, e dai loro nodi non è possibile sciogliersi in alcun caso. Per tale motivo, contro il sovrano, da Hobbes rivestito tanto di un potere tem-porale quanto di un potere spirituale, non vi può essere alcuna forma di ribel-lione, né legittima – ossia possibile all’interno delle leggi civili – né giustificabile – vale a dire in opposizione alle leggi civili, ma tuttavia in accordo con quelle divine – dal momento che nel far torto al proprio sovrano si farebbe al tempo stesso, secondo Hobbes, torto nei confronti di Dio. Per tale motivo il sistema politico definito da Hobbes, se considerato nel suo complesso e non soltanto nelle sue premesse e per quella parte del suo ragionamento che oggi definirem-mo laico, sembra a mio avviso costituire un compatto e coerente insieme di re-gole che vieta in maniera netta e categorica ogni forma di ribellione nei con-fronti del sovrano.
namely the procuration of the safety of the people, to which he is obliged by the law of
nature, and to render an account thereof to God, the Author of that law, and to none
but Him». 67 Per tale ragione sembra possibile contestare la tesi di Susanne Sreedhar e la sua
compendiosa definizione di diritto di ribellione nel Leviathan, dal momento che ciò che
l’apertura alla trascendenza determina è una sorta di limitazione della capacità individua-
le di fare libero uso del proprio giudizio privato.
176 Paolo Scotton
4. Individuo e legittimità del potere. Considerazioni finali
Questo è dunque quanto si può concludere al termine dell’analisi del diritto di resistenza così come svolto, in modo più o meno esplicito, nella teoria pro-posta da Hobbes all’interno del suo Leviathan. Tuttavia, ai fini del ragionamento qui intrapreso, sembra inoltre utile cercare di valorizzare, seppur brevemente, la portata teoretica e le implicazioni politiche che la riflessione hobbesiana com-porta proprio laddove essa presenta alcuni problemi. In particolare riguardo all’esercizio della libertà personale non in quei casi, privi in ciò di problemi e contemplati nella teoria di Hobbes, in cui essa è garantita dal silenzio della leg-ge, bensì in quelle circostante in cui essa si trovi in conflitto con la legge positi-va. Come esposto più sopra, infatti, Hobbes nel trattare dei limiti all’interno dei quali l’individuo sarebbe posto nelle condizioni di valutare se sia o meno nel suo interesse mantenersi in una condizione di sottomissione al potere istituito per mezzo del contratto sociale egli assegna di fatto una funzione fondamentale alla razionalità propria del singolo individuo, inteso quale soggetto autonomo che valuta la correttezza del potere a cui decide di sottomettersi volontariamen-te. Ora, che tale sottomissione si fondi sulla mera base del patto sociale sembra essere una tesi assai difficile da sostenere poiché il dispositivo di autorizzazione del potere che permette al sovrano di non dover rendere conto delle proprie azioni68 a coloro i quali hanno stipulato tra loro e con lui il contratto sociale in realtà, come suggerito da Hobbes stesso, non garantisce di certo il rispetto in foro interno dell’autorità politica. Pur non potendo di certo arrivare per tale ra-gione a sostenere che Hobbes sia stato considerato a torto come il massimo e-sponente del paradigma filosofico e giuridico di creazione e giustificazione del potere su base contrattualistica69, va comunque evidenziato come per il pensa-
68 Sulla cosidetta nonaccountability e sulla conseguente impossibilità di esercitare un di-
ritto di resistenza al potere in virtù del dispositivo di autorizzazione del potere in Hob-
bes si vedano in particolare le pagine a ciò dedicate da David Baumgold, Contract Theory
in historical context. Essays on Grotius, Hobbes and Locke, Leiden-Boston, Brill, 2010, in
particolare alle pp. 59-65. 69 Hobbes è stato infatti considerato il miglior rappresentante di tale tendenza non
soltanto da chi ne ha fatto oggetto di critica al fine di presentare un progetto alternati-
vo, come ad esempio Michel Foucault, si veda, ad esempio Bisogna difendere la società, Mi-
lano, Feltrinelli, 2009 [1976], ma anche da chi, come notoriamente ha fatto John Rawls,
A Theory of Justice. Revised Edition, Harvard, Harvard University Press, 1999, ha cercato di
Diritto di resistenza e legittimità del potere 177
tore inglese tale forma di instaurazione del potere politico sia di fatto una ragio-ne necessaria ma non sufficiente per garantire la costituzione di un potere legit-timo, come ha aiutato a dimostrare il caso in cui l’individuo si trovi in disaccor-do, in maniera radicale – si potrebbe dire letteralmente vitale – con il potere e-sercitato su di lui da quella società che per sua stessa decisione ha contribuito a creare. Ciò ha permesso di mettere in evidenza come per Hobbes alla coerci-zione imposta dalle leggi positive si debba necessariamente aggiungere il deside-rio di obbedire ad esse e di conformare la propria libertà fattuale alla libertà da loro concessa70. In virtù di ciò pare possibile, astraendo dalla rigida logica hob-besiana che relega il diritto di resistenza ai soli casi in cui sia posta in gioco la difesa della vita e dell’esistenza personale, cogliere l’importanza di tale riflessio-ne in un dominio più ampio, ossia in termini di difesa di tutte quelle libertà ina-lienabile in foro interno, vale a dire di quelle libertà che ragionevolmente – vale a dire in base alla legge di natura intesa come «a set of logical and purposive a-xioms»71 – ogni persona desidera esercitare e non può alienare in alcun modo a soggetti terzi. Infatti, nonostante Hobbes cerchi di dimostrare come il dominio della legge civile e di quella naturale siano di pari estensione e quindi non pos-sano logicamente dare adito ad alcuna forma di conflitto, si è in precedenza a-vuto modo di mettere in luce come tale assunzione sia di fatto smentita dall’autore stesso. In altre parole, sebbene di fatto le leggi naturali non possano diventare davvero leggi se non per mezzo del potere politico che le rende ob-
rintracciare proprio nel paradigma contrattualista la migliore teoria esplicativa e norma-
tiva per garantire i presupposti della giustizia sociale. 70 Quentin Skinner, Liberty Before Liberalism, Cambridge, Cambridge University Press,
2003, p. 8: «We can now see the sense in which you remain free according to Hobbes
when you act in obedience to law. When the law coerces you into obeying by activating
your fears about the consequences of disobedience, it does not do so by causing you to
act less than freely. It always does so by inducing you to deliberate in such a way that
you give up your will to disobey, acquire a will to obey, and thereafter act freely in the
light of the will you have acquired». Skinner sembra poi ritenere che in Hobbes la mera
paura sia da ritenere sufficiente a tale fine di persuasione, mentre, come più sopra espo-
sto, sembra a mio avviso giocare un ruolo assai rilevante anche il riferimento alla spe-
ranza. 71 Così, in maniera efficace, sintetizza nel suo saggio Martin Loughlin, The political ju-
risprudence of Thomas Hobbes, in Hobbes and the Law, a cura di, David Dyzenhaus e Thomas
Poole, Cambridge, Cambrige University Press, 2012, pp. 5-21.
178 Paolo Scotton
bligatorie in foro externo, tuttavia sembra possibile affermare che esse non si e-sauriscono in una serie di leggi positive che valgono generalmente per tutti e che non prendono in considerazione gli individui concreti che popolano la so-cietà. Del resto, non solo esse possono differire quanto a contenuto rispetto alle leggi positive, ma anche quanto alla capacità di esercitare potere su coloro che ai rispettivi tipi di legge sono sottoposti72.
Così, se è vero che leggi obbliganti in foro interno non sono tali anche in foro externo poiché non legittimate dal potere istituito, in una certa misura è vero allo stesso tempo anche il contrario. Per comprendere tale affermazione è necessa-rio operare tuttavia un cambio di prospettiva che pone al centro dell’attenzione non più il momento che sta alla base della fondazione e creazione della legge, bensì il successivo processo di mantenimento e legittimazione del potere istitui-to. Inoltre, da una visione sulla società nel suo complesso il punto focale di tale problema dirige lo sguardo all’interiorizzazione del dettato della legge compiuta dal singolo individuo. Così, si comprende la ragione per cui, secondo Hobbes, affinché le leggi siano non solo accettabili, ma anche condivisibili da tutti e da ciascuno, ci vuole altro rispetto al puro rispetto esteriore: ci vuole la speranza che cresce all’interno del singolo individuo e non solo il timore imposto dall’esterno. Entrambe le condizioni sono necessarie, ma nessuna delle due può fare a meno dell’altra73. La possibilità di tale fondamentale rispetto interiore, non sempre sufficientemente sottolineato, sembra essere determinata dal fatto che il sovrano, oltre al potere secolare, è rivestito allo stesso tempo del potere religioso, che gli conferisce l’autorevolezza e la credibilità necessarie, in breve la
72 Tale doppia distinzione di legge naturale e civile sia per quanto riguarda contenu-
to che potere effettivo è stata tratteggiata con estrema chiarezza in un recente saggio di
Ross Harrison, The equal extent of natural and civil law, in ibidem, pp. 22-38. 73 Interessante, a tal proposito, non solo per ragioni teoretiche ma anche per la con-
testualizzazione storica lo studio di Eric Brandon, The Coherence of Hobbes’s Leviathan,
London, Continuum, 2007. In tale testo l’autore sostiene che il progetto di Hobbes
debba essere considerato nella sua interezza e intrinseca coerenza riguardo alla necessità
tanto della legge naturale che di quella divina. Infatti, come sostiene nell’introduzione
del suo libro: «The secular and the religious halves of Leviathan are both necessary for
the achievement of the goal of lasting internal peace, yet each side, by itself, is insuffi-
cient for the creation of such a peace. Thus, in terms of the work as a whole, one half
cannot be subordinated to the other».
Diritto di resistenza e legittimità del potere 179
legittimità di cui abbisogna, per essere mantenuto saldo nel suo regno74. Il pro-blema quindi che il Leviathan pare sollevare ancora oggi all’interno di una socie-tà, però, ormai secolarizzata quale quella attuale – in cui il richiamo alla religio-ne non risulta pertanto più sufficientemente persuasivo al fine di garantire la legittimità (nel senso ampio qui delineato) dell’esercizio del potere – è quindi quello concernente il modo attraverso cui il potere può giustificare se stesso agli occhi dei singoli individui tanto da essere da loro interiormente considerato giu-sto e desiderabile. Rispetto alla religione serve dunque altro, segnatamente serve altro in quanto elemento aggiuntivo rispetto al mero contratto sociale, vale a dire un accordo volto allo stesso tempo a tracciare i confini del progetto che la società nel suo insieme deve e vuole perseguire così da offrire anche al singolo individuo un motivo tale da rendere interiormente vincolante la sua adesione alla società. Sembra dunque che l’insegnamento hobbesiano indichi come ne-cessario per la legittimità del potere un punto di riferimento ulteriore per garan-tire la convivenza sociale rispetto al mero patto iniziale. Un punto di riferimen-to che tenga in debito conto il valore dell’individuo all’interno del corpo civile. Si tratterebbe, in altre parole, del recupero del valore positivo dell’ideologia qua-le principio basilare, ma non pervasivo, che regola in modo tacito la convivenza all’interno della società75. In questa direzione sembra dunque che il testo di Hobbes, e le conseguenti implicazioni teoretiche che da esso emergono, abbia-no rappresentato e possano ancora rappresentare un’interessante e fruttuosa eredità per la riflessione politica.
74 L’obbedienza alle leggi positive sarebbe infatti motivata anche sulla base
dell’obbedienza dovuta a Dio per la propria salvezza. Brandon, The Coherence of Hobbes’s
Leviathan, cit., in particolare alle pp. 94-98. 75 L’importanza di un sistema di idee ed abitudini condiviso all’interno della società
non interpretato in chiave esclusivamente negativa è stato messo in luce in maniera sin-
tetica ma acuta ad esempio da Massimo Cacciari, Ideologia, in Enciclopedia Filosofica, Mila-
no, Bompiani, 2006, VI, p. 5487, secondo cui: «Una concezione realistica del politico
deve, invece, riconoscer il ruolo che l’ideologia vi svolge. Non solo in quanto “tecnica”
di persuasione, non solo in quanto distorsione della realtà in funzione dei fini da perse-
guire o contraffazione deliberata, ma in quanto e anzitutto creatrice di miti. […] L’agire
politico è sempre, costitutivamente, anche “mito poietico”; e soprattutto nei momenti
di transizione e di crisi deve esserlo, se vuole essere efficace».